dedicatoapaveseBlog senza pretese dedicato a Cesare Pavese: il maestro di una vita. "Altrettanto noto è che uno quando non dorme vorrebbe dormire e passa alla storia come l'eterno sognatore." C.P. |
Saprò diventare come vuoi. Devo diventarlo, perché non voglio che la nostra storia somigli alle altre che ho bruciato.
(dal carteggio tra Cesare Pavese e Bianca Garufi)
CONSIGLI DI LETTURA
Nelle prime pagine di questo blog sono contenuti i post che svelano l'uomo, oltre che il poeta. Essendo questo un blog letteraio-sentimentale...


CHI SONO
Amantedicesare: un modo aulico per definirmi ma in realtà è l'omaggio a chi, morendo, ha insegnato ad amare e apprezzare la vita.
Scriverò di lui e pubblicherò ciò che è lui. Senza pretese, più per me che per gli altri, con l'intento di raccogliere questa mia passione in un click.
MUSIC
AREA PERSONALE
TAG
MENU
I MIEI BLOG AMICI
HAI UN SANGUE, UN RESPIRO.
Hai un sangue, un respiro.
Sei fatta di carne
di capelli di sguardi
anche tu. Terra e piante,
cielo di marzo, luce,
vibrano e ti somigliano -
il tuo riso e il tuo passo
come acque che sussultano -
la tua ruga fra gli occhi
come nubi raccolte -
il tuo tenero corpo
una zolla nel sole.
Hai un sangue, un respiro.
Vivi su questa terra.
Ne conosci i sapori
le stagioni i risvegli,
hai giocato nel sole,
hai parlato con noi.
Acqua chiara, virgulto
primaverile, terra,
germogliante silenzio,
tu hai giocato bambina
sotto un cielo diverso,
ne hai negli occhi il silenzio,
una nube, che sgorga
come polla dal fondo.
Ora ridi e sussulti
sopra questo silenzio.
Dolce frutto che vivi
sotto il cielo chiaro,
che respiri e vivi
questa nostra stagione,
nel tuo chiuso silenzio
è la tua forza. Come
erba viva nell'aria
rabbrividisci e ridi,
ma tu, tu sei terra.
Sei radice feroce.
Sei la terra che aspetta.
PAESI TUOI
« ... andavamo come i buoi senza sapere dove, lui col suo fazzoletto rosso al collo, il suo fagotto, e le sue brache di fustagno. Questi goffi di campagna non capiscono un uomo che, per quanto navigato, messo fuori un bel mattino si trova scentrato e non sa cosa fare. Perché uno poteva anche aspettarselo ma, quando lo rilasciano, lí per lí non si sente ancora di questo mondo e batte le strade come uno scappato di casa.»

|
Senza pensarci due volte - Tina Pizzardo Il 25 gennaio ’34 ritrovo Pavese in casa di Barbara. Mi ero ricordata di lui in quei mesi? Penso di sì: per rimproverargli d’aver troncato sul nascere un’amicizia che prometteva tanto bene. Se avessi avuto la sua amicizia non sarei andata a cercare altro e non mi sarei ridotta a ispirare pietà. L’incontro è da parte sua sorprendentemente vivace e caloroso. Si offre di aiutarmi a perfezionare l’inglese che leggevo senza saperlo parlare. (Sì, sempre voglia di studiare, d’imparare anche se infine non imparo mai niente.) Dal 27 gennaio, dapprima ogni due giorni, poi tutti i giorni ci troviamo da me o da lui, per le lezioni d’inglese. (Mi sentivo eccezionalmente spregiudicata nell’andare a casa di un giovanotto, anche se viveva con la famiglia, mentre in casa di un compagno, anche se viveva solo, ero sempre andata con naturalezza.) Mi faceva leggere l’Hemingway di Addio alle armi, e Spoon River, ma sempre più volentieri trascuravo l’inglese per parlare di noi e scoprirci ora eguali ora diversi, con lo stesso incanto. Il dialogo mi si confà, con Henek ero costretta al monologo. Il dialogo, la simpatia ch’egli mi mostrava, mi facevano tornare quella di sempre: allegra, vivace, con subitanee bizzarre idee che meravigliavano me più ancora degli altri. Mi sentivo rinascere, mi pareva di tornare in piedi alla luce dopo aver rampato nel buio senza speranza. Una volta Pavese viene da me con S. (22 febbraio) e mi capita di raccontare due tra le mie avventure di treno, quella finita con il regalo di un corrispondente per la dottoressa di Igea e l’altra che riferirò più sotto. Pavese si diverte moltissimo di entrambe. Dice che gli piacciono le ragazze come me, scanzonate; ciò mi lusinga assai. Anni dopo riporterà nel suo diario, travisandola, una di queste storie per trarne amare considerazioni, sulle donne o su di me, non ricordo. (Non posseggo altro libro di Pavese che le poesie. I miei riferimenti a ciò che dice nelle sue opere sono sempre un po’ vaghi, ricordi di affrettate rabbiose letture.) Dunque dopo aver detto della clausura a Igea ‒ solo donne, sempre donne ‒ dico dell’incontro in treno con un giovane dall’aria onesta e schietta, simpatico, e del piacere di discorrere con lui. Finisce che gli do il mio biglietto da visita dove c’è nome, titoli, direttrice della colonia tal dei tali; ciò che in un incontro in treno non ho mai fatto né prima, né poi. Più tardi ci ripenso e decido che è meglio lasciar perdere. Arriva puntualmente la sua lettera. Non è un capolavoro, ma garbata, carina, sì. E adesso che fare? Prendo un foglio di carta intestata e, a macchina, in stile da direttrice scrivo all’incirca: «Ricevo con sorpresa la sua del... dalla quale mi pare di capire che una giovane scervellata s’è servita del mio biglietto da visita per prendersi gioco dei miei capelli bianchi ecc. Voglia avere la cortesia di descrivermi la signorina in questione che ha preso in giro lei oltre che mancare di rispetto a me, perché se, come ho ragione di credere, si tratta di una mia dipendente non deve passarla liscia. E in quanto a Lei caro signore, impari a non fidarsi delle ragazze che con tanta leggerezza attaccano discorso in treno con sconosciuti...». Era proprio l’onesto giovane che avevo creduto perché mi risponde chiedendomi scusa dell’incidente: colpa sua, avrebbe dovuto capire che la signorina era troppo giovane per essere direttrice di una colonia. In quanto a descriverla, no, si rifiutava, una bella ragazza ha diritto di prendersi un pochino gioco degli uomini e forse anche delle direttrici. Ho dimenticato tanti episodi della mia vita (quando Carlottina me li racconta mi meraviglio e mi diverto), queste due avventure mi sono rimaste nella memoria perché le ho raccontate a Pavese e perché il suo modo di accoglierle ha contribuito alla falsa immagine che dapprincipio mi sono fatta di lui. Scanzonato, pensavo di Pavese, perché gli piacevano le ragazze scanzonate e perché nel regalarmi un libro ci scrive su qualcosa e ridendo me lo porge. Leggo: «Con passione. C», e rido anch’io. Il 25 febbraio era domenica, ma non ero andata in montagna e non c’ero andata per distaccarmi da Henek. Quel pomeriggio mia sorella e Nina erano fuori, ci troviamo soli io e Pavese. Siamo nella mia camera‒studio, dove ricevo allievi e amici, io semisdraiata sul divano‒letto, lui ai miei piedi, su uno sgabello. Il discorso scorre facile e divertente come le altre volte. Qualcosa che ho detto gli piace tanto che mi guarda ridente, incantato e subito si butta giù, nasconde il viso nelle mie mani. Indugia e io devo afferrargli il ciuffo per tirarlo su. Ancora ridente dice: «Ho paura che sto innamorandomi di lei». E io sullo stesso tono: «Credevo lo fosse già. E in agosto c’è mancato poco che capitasse a me». Gli racconto che per tutta la gita al Gran Paradiso ho continuato a pensare a lui come... come a un dio. «Come a un dio» (m’è venuto così, per scherzo) dà avvio al dialogo tenero e malizioso di due troppo sagaci per cedere al frusto linguaggio delle solite schermaglie amorose. Un dialogo felice, spiritoso, punteggiato ‒ per scherzo! ‒ di qualche leggero rapido bacio. Quando verso le sette ci lasciamo con l’intesa di rivederci di lì a due ore, io mi sento rinata: un uomo forte, deciso, sicuro di sé che non chiederà mai il mio conforto, la mia guida, la mia energia come gli altri tutti, amici, amiche, innamorati. Dopo la canina adorazione dei miei soliti flirt ho trovato un mio pari, pensavo. Scambio di baci, ma anche di sincere spietate confidenze, buone per analizzare e distruggere lo strano e malinconico mio legame con Henek. La sera chiacchieriamo per strade buie (dove lui cerca di baciarmi, e questo mi sembra infantile oltre che scandaloso), poi in un caffè dove si resta fino a tardi; per le cose che è andato dicendo per tutta la sera comincio a sentirmi un po’ meno sicura, gli chiedo: «Quanti anni hai?». Ne ha ventisei. Che io ne abbia trentuno lui lo sapeva: «Nel vero amore la differenza d’età non conta», enuncia. Vero amore? Io pensavo a una sorta di scanzonato flirt. Sono stata lì per dirglielo, no, avrei fatto la figura della stupida, «vero amore» valeva quanto quel «Con passione» sul libro, di qualche giorno prima. Però non ero più tanto sicura di dirgli: «Tu lo avrai già capito, se c’è un pasticcio da starci alla larga io mi ci butto a capofitto, poi per uscirne son dolori». E dirgli (senza fare il nome) di Henek, dirgli: «Mi aggrappo a te per salvarmi, giuro che sarà un salvataggio piacevole per tutti e due». Aiuto lui me ne dà lo stesso, riflettevo, per il vivo interesse che ha per me, perché mi è affine, mi è pari e posso star con lui quanto voglio senza mai annoiarmi, senza più pensare all’altro. Me la sbroglierò da sola, come ho sempre fatto. Non ero delusa, ero esaltata di lui e, s’intende, del nuovo pasticcio in cui m’ero cacciata. Il giorno dopo, saltando il pasto per arrivare nell’intervallo di mezzogiorno, correvo da Henek. Raccontare ciò che era accaduto tra me e Pavese: rompere il nostro malinconico legame, farla finita. Il viso di Henek era sempre dolcemente triste, riesce a farlo severo e triste, dice che gli dispiace, che non approva, che sono una sciocca bambina, chessò. M’avesse risposto secco: «Lo lasci perdere, a lui ci penso io», mi sarebbe piaciuto molto anche se, per il mio carattere, mai avrei accettato il suo intervento. Ma a lui forse non importava gran che di me e d’altra parte di uomini savi e energici, se pur ce n’è, a me non ne è toccato neanche uno. Nei giorni seguenti continuo a incontrarmi or con l’uno or con l’altro al caffè, e entrambi, coi soliti amici, vengono a casa mia. Con Pavese che mi considerava vissuta e teneva in gran conto la mia esperienza ‒ «la tua saggezza di vita», diceva ‒ io mi sentivo giovane, estroversa, brillante, allegrissima. E anche dimentica irresponsabile come se fossi un po’ bevuta. Con l’altro che mi diceva «sciocca bambina» mi sentivo veramente sciocca e un poco triste anche quando scherzavo, e sempre vigile, cosciente di me, cosciente della lotta cui entrambi da anni eravamo impegnati. Fa ridere a ripensarci che povera cosa era in quegli anni la lotta: un po’ di soccorso rosso, non cedere, scambiarsi o distribuire in giro libri, giornali proibiti e notizie delle carceri, notizie dall’estero e soprattutto discutere a non finire. Niente di più, ma bastava a mandarti in galera. Henek (come vorrei fare a meno di parlare di lui) esercitava su di me una sorta di fascino che non sono mai riuscita a spiegare. Forse solo se è misterioso è vero fascino. Il 5 marzo, esattamente otto giorni dopo il 25 febbraio (data dell’inizio), al tavolo di un caffè che c’è ancora all’angolo di piazza Statuto con via Cibrario, dico a Pavese che il nostro amore, come lui lo chiama, è stato un colpo di follia, tocca a me di cinque anni più vecchia aver testa per due: siamo fatti per esser amici e spero che non sia troppo tardi. O amici, o niente. O amici, o rinunziare ai nostri incontri. Ed ecco che l’uomo forte a cui una settimana prima pensavo di chiedere aiuto, l’uomo scanzonato che avrebbe dovuto chiedere: «Chi è l’altro?», ecco che Cesare Pavese si mette a piangere come un bambino. Ricordo la delusione, il fastidio, l’imbarazzo per quei lacrimoni che venivano giù a pioggia e rotolavano sul bavero del paltò. «Piuttosto amici che niente», diceva remissivo e lacrimante. Fidava nella mia pietà. Sperava ancora. Se non avesse avuto speranza si sarebbe ammazzato. Si sarebbe ammazzato. Era capace di farlo, da commediante che recita fino in fondo la sua parte. Ancora uno che mette la sua vita nelle mie mani. Me lo sono voluto e adesso mi tocca vigilare e assisterlo finché non gli sia passata ‒ mi dicevo. Patto d’amicizia, dunque. Vedersi una volta la settimana. Neanche un bacio? No, neanche uno. E così mi sono trovata ad avere due amici per andare al caffè: uno parlava poco di sé e si lasciava amare con ironica indulgenza. L’altro, purché mi lasciassi amare, parlava molto e bene. E tra l’uno e l’altro, alzandomi alle cinque, coricandomi dopo l’una di notte, con la scuola delle suore a Ivrea, la scuola serale in fondo a via Nizza, i bambini Nasi in via Principe Amedeo e infine gli allievi privati, riuscivo a impartire dieci‒dodici ore di lezione al giorno; e correggere i compiti; e tre volte la settimana alla piscina dell’ymca; e scrivere a Altiero, andarlo a trovare appena messi insieme i soldi; e le domeniche in montagna o in barca; e le serate politico‒mondane in casa di Barbara, dei Carrara, di altri; e infine arrabattarmi con mille ripieghi e trovate per non esser tanto malvestita. In marzo, con altri, viene arrestato Leone Ginzburg. «Almeno, adesso che è in prigione, non potrà ficcare il naso nei miei affari», dice allegramente Pavese, ed è tutto. Poco tempo prima s’era vantato di avere, per la stessa ragione, spinto l’ancor dubbioso M. verso una che cercando marito lo concupiva. Quando è accaduto non lo so, perché in realtà non è accaduto niente; e Pavese che aveva il culto degli anniversari, quest’anniversario non l’ha mai celebrato. Può essere accaduto verso fine aprile, se in questo mese trovo la nota cifrata: X π mépriseur des femmes et pour cause!». È stato una sera a casa sua. Luce spenta, finestra aperta sul cielo. Baci che rompono il patto d’amicizia (e mi vendicano dell’altro). E poi un momento, solo un momento di lucida follia, d’abbandono. E mentre, rinsavita, mi rallegro che non sia successo niente, lui è già in ginocchio e dice che ora dobbiamo sposarci e saremo tanto felici. Se i patti d’amicizia si rinnovano (ce ne saranno altri) è perché, nel timore che lui faccia una pazzia e per distaccarmi dall’altro, mi lascio indurre a infrangerli. Inutile che continui, è una storia vecchia: il cuore può dividersi con alterna sincerità tra un amore che ti dà solo tristezza, eppure è il solo che conta, e un amore che con un vendicativo senso di riscatto ti fa sentire giovane bella ineguagliabile. Proprio la solita storia, con una piccola variante: scoprire che l’amore che ti dà il senso di riscatto ecc. è irrimediabilmente... be’, diciamo elusivo. Il mio amore elusivo mi diceva «Tina», «tesoro», «ho‒ney». «Cesarino», gli dicevo io e Ebe si meravigliava che il diminutivo non lo offendesse. Cesarino: a quei tempi era un bel ragazzo alto, snello, un gran ciuffo sulla fronte bassa, il viso liscio, fresco, di un leggero color bruno soffuso di rosa, i denti perfetti. Mi piacevano i suoi occhi innamorati, le sue poesie, i suoi discorsi tanto intelligenti che diventavo intelligente anch’io, mi piaceva il senso di fraternità che ci veniva dalla stessa origine bottegaio‒contadina, da un’infanzia vissuta nei nostri paesi delle Langhe, e per tanti versi simile. Ma come prenderlo sul serio quando parlava di matrimonio e poi piangeva perché gli dicevo di no, quando per fare l’uomo forte smaniava, imprecava, ma da cattivo commediante sbagliava tutto ed era solo ridicolo, quando per indurmi a rompere il patto d’amicizia minacciava d’ammazzarsi. S’era messo ciecamente nelle mie mani e io non volevo fargli del male. M’ostinavo a farne un amico, non ci riuscivo, ma chissà, un patto d’amicizia dopo l’altro, alla fine si sarebbe persuaso. E poi le ore che passavamo assieme noi due, al caffè, in barca sul Po, oppure a casa mia con Carlottina, con Ebe, qualche volta Estella, erano le uniche ore felici della mia vita affannosa e senza speranza. Chi l’ha conosciuto più tardi lo ricorda taciturno, pieno di sé, sprezzante; non può immaginare com’era facile e incantevole stare con lui giovane. Ricordando l’incanto dei nostri dialoghi tante volte mi sono chiesta di cosa mai si parlasse noi due. Uno spunto qualsiasi, fosse pure solamente: «che bella giornata» oppure «hai un nuovo cappellino» bastava a dar l’avvio a una conversazione intessuta di fantasia di ricordi di scoperte. E perché eravamo giovani ognuno provava genuino interesse, e meraviglia, e ammirazione per ciò che passava per la mente dell’altro. Avevo un bel ripetermi: in amore tutto è permesso, non devo render conto a nessuno, provavo ‒ non rimorso, solo un senso di fastidio, di sconforto, e solo ogni tanto. Ricordo che più di tutto mi dispiaceva non poter affrontare Altiero a tu per tu e spiegare a lui ciò che a me pareva tanto chiaro, logico, giusto. Gli avrei detto: «Ho rinunziato a te perché voglio il tuo bene e un giorno me ne sarai grato. La finzione del fidanzamento che ci permette di scriverci, vederci, devi accettarla come una forma di soccorso rosso. E adesso, dopo tanti anni vissuti nell’attesa di collaborare assieme, dimmi tu che cosa posso fare della mia vita che senza questo miraggio non ha più senso. Ricordati che devo guadagnarmela la vita e se non voglio chiedere grazia e tessera mi tocca lavorare dodici ore al giorno. Non mi resta voglia energia per studiare come vorresti tu. Non che non mi piaccia studiare, ma non sono ancora abbastanza vecchia per farne il mio solo conforto. Non puoi esigere che ancora adesso, in questi pochi anni di gioventù che mi restano, io mi rifiuti l’altro grande conforto di amare e essere amata. Si dà il caso ‒ su, rìdine con me ‒ che per amare e essere amata, di presenza e non solo per lettera, io debba ricorrere a due persone diverse». Intanto continuavo a mandargli lettere sbrigative e amichevoli. Qualche volta tornavo a rivolgere il mio pensiero a lui come al solo capace di mettere ordine e pace nella mia vita affannosa, e allora mi lasciavo andare fino a scrivergli: «quando uscirai di carcere decideremo della mia vita secondo il grado di amicizia e di amore che ci sarà tra di noi». Ma lui non poteva capire. E venne «la bella estate» il cui ricordo, mi pare, pervade alcune opere di Pavese, e che anch’io ricordo come un’estate felice. Tra la metà di luglio e ferragosto avevo pochissime lezioni e mi godevo il senso di vacanza che dà Torino d’estate quando, nell’afa, la città operosa pare fermarsi e solo le colline e le acque ‒ Po, Stura, Dora, Sangone ‒ fervono di vita. Intere giornate in barca a punta. Risalire il Po fino a Moncalieri. Vincere i correntini e imboccare il Sangone. Sosta meridiana e, quando il sole è basso, giochi sportivi sulle rive boscose. Letture a due sotto gli alberi centenari del Parco Michelotti al mattino, o al pomeriggio a casa mia con le persiane calate e la corrente d’aria che fa volare le tende. A casa c’erano a volte con noi amiche, amici, più spesso la sola Carlottina, anche lei in vacanza dopo la scuola a Valtournanche. Se c’era lei, che pareva un ragazzino e non lo intimidiva, Pavese dava il meglio di sé, tornava a essere quale lo avevo creduto prima dei lacrimoni e delle tirate istrioniche. Era il tempo che lui rivedeva, riordinava, sceglieva le sue poesie per darle alle stampe. Ero lusingata e molto imbarazzata quando chiedeva il mio giudizio. Dovevo decidere se una poesia andava o no inserita nella raccolta (decisione tormentosa; da quel momento è caduto il mio interesse per la poesia che era sempre stato vivo). Dovevo scegliere tra due aggettivi o il posto di una parola nell’ordine del verso, poiché accettava la mia scelta a occhi chiusi mi sentivo responsabile davanti ai posteri; non capivo che lui s’affidava a me quando una scelta valendo l’altra avrebbe potuto decidere a testa e croce. Ore felici perché bastava girare il discorso sulla bellezza delle sue poesie, sul suo «genio», sulla sua gloria futura per distoglierlo dalle velleità amorose. Era molto vanitoso Cesarino, io e le altre ne sorridevamo un po’ dicendoci: forse gli artisti sono tutti così. Stavo tanto bene con Pavese e le sue poesie, quell’estate, ed ero sempre tanto infelice con l’altro che a volte, in un impeto di ribellione, dicevo a Carlottina: «Sposo Cesarino e la faccio finita». (A lui però non l’ho mai detto.) Adorata in ginocchio nei primi tempi poi, quando gli fosse passata, una vita d’inferno. Questo m’attendevo e mi respigeva quasi quanto mi disgustava l’amore elusivo. |
|
Senza pensarci due volte - Tina Pizzardo
Per raccontare di Pavese comincio dal suo amico: Leone Ginzburg. Il più intelligente, ma soprattutto il più buono, più fraterno, più caro dei nuovi amici, quello che più si era dato da fare per noi dopo la morte di papà, era Leone Ginzburg. Amico con cui potevi parlare di tutto, della scelta di un cappellino come di filosofia e di politica, dei tuoi soucis d’argent come dei tuoi amori. E della tua infanzia, della tua famiglia, delle tue letture, di tutto. Ricordo le volte che tornando a casa (abitava vicino a me) dopo i suoi numerosi impegni serali, come un medico che vuol terminare il giro dei pazienti saliva da me. Mezzanotte era passata da un pezzo, ma lui era capace di restare lì a discutere per due ore. (E il giorno dopo la signora Vera mi telefonava pregandomi, che dico, ordinandomi di non trattenere suo figlio tanto tardi.) Discutere con lui voleva dire subire un serrato interrogatorio e trovare, col suo benevolo aiuto, le risposte. Non so se per vincere la leggera balbuzie o per farsi meglio capire dall’allieva, parlava lentamente con lunghe pause di meditazione. E io, vorticosa di solito nella conversazione, rispondevo con pari lentezza, cercando le idee, le parole giuste, con impegno, con fatica, con una sorta di fredda esaltazione che mi lasciava spossata. A parte le discussioni lui parlava spesso di sé, dei suoi amori, dei suoi amici, ma sempre senza far nomi, con accenni misteriosi se pur vari e frequenti. Tanto che, senza volerlo, d’ognuno mi è a poco a poco venuto in chiaro l’intero personaggio e il nome. Nell’inverno del ’32 leggevo con rapimento Moby Dick: ebbene quel Cesare Pavese a cui ero tanta grata e della scoperta e della traduzione del libro era un suo amico, un poeta. La volta che gli dico che vorrei trovare un amico per andare al caffè, ride e, senza fare il nome, dice che lui ha un amico che passa le giornate al caffè a scrivere poesie, fumare la pipa, tormentandosi il ciuffo: peccato che sia un gran dispregiatore delle donne. Sono innamorata delle nostre colline? Un suo amico poeta scrive bellissime poesie sulle colline, le fa leggere a pochi eletti e non certo alle donne, perché «le donne non contano», e cita alcuni versi de I mari del Sud e poi di un’altra poesia: «... la donna che m’ingombra la barca». Quando in casa di Barbara incontro Pavese: ciuffo, pipa, scontrosità me lo fanno riconoscere prima che mi sia presentato. Penso che di lui so tutto e che ci piacciono le stesse cose. Più tardi scoprirò che ciò che so di lui è tutto un po’ sbagliato. Ha tradotto Moby Dick, quindi ama il mare. No, odia il mare. I mari del Sud li ha scoperti risalendo a punta i correntini del Po. (Ma anch’io amo il Po, e ho cominciato anch’io a portare la barca con la punta.) Il nuoto? Poco e solo nelle acque sporche del Po, che alle donne fa schifo. (Nient’affatto, ho imparato a nuotare in Po, e solo in Po che non costa un soldo ho nuotato quest’estate.) Le sue colline sono mica quelle di Torino, quelle delle Langhe sono. (Mie anche quelle delle Langhe, dove ho passato tutte le estati fino alla laurea, mie perché mio nonno era delle Langhe. Tutti contadini di padre in figlio, su un podere di loro proprietà.) Che sia un uomo forte e un dispregiatore delle donne, questo continuo a crederlo e mi fa voglia di essere amica di un tipo così: fargli vedere che non tutte le donne sono lagne. Sul Po credo che saprei tenergli testa. Non so quante volte lo vedo in casa di Barbara, certo poche perché non ci veniva volentieri: si parla troppo di politica... e tutte quelle smorfiose... e il the... roba che non fa per lui. Il 31 luglio del ’33 sono in barca a remi con Giulio Muggia, gli ho appena detto che vorrei imparare bene a punta, chissà se tra gli amici c’è qualcuno capace d’insegnarmi ed ecco, tornando all’imbarcadero, troviamo Pavese su un barcone a punta. Mi pare ancora di vederlo: alto, corpo d’adolescente annerito di sole, mutandine da bagno e cappellaccio di feltro calcato fino agli occhiali. (C’era solo lui sul Po a portare il cappello con le mutandine da bagno, lui e i sabbiatori.) Deve aver accostato per parlare con amici comuni perché, quando gli chiedo di salire sulla sua barca, Muggia non è il solo che, prevedendo un rifiuto, sogghigna. Lui fa il viso seccato, si capisce che non osa ma vorrebbe rifiutare: «Su svelta, salti». E io pronta spicco un salto che se mi fosse fallito gli avrei dato un gran gusto. Obbedisco senza fare storie ai suoi ordini, imparo subito a tener diritta la barca, e dove la punta mi resta incagliata, ci manca poco ma il volo in acqua non lo faccio. Sono allenata agli sport, il palo non mi pesa. Quel ritmico flettersi per puntare, rialzarsi portando il palo in avanti mi riesce tanto bene da strappargli un mezzo sorriso: «Per ora se la cava, voglio però vederla coi correntini». Coi correntini pur mettendocela tutta non ce la faccio, ma non mi do per vinta, ci provo, ci riprovo fino allo sfinimento, ed è lui a impormi di smettere. Mortificata d’aver fallito non mi viene in mente che se avessi superato la prova non avrei più avuto bisogno di lezioni, e io ci tenevo a rivederlo. Forse lui, malignamente, desiderava vedermi ancora fallire perché, lasciandoci, mi dà appuntamento per il 5 agosto. Solo a fatica ho potuto mantenere l’impegno perché ero impegnata con Bastiano per un’escursione al Gran Paradiso, combinata improvvisamente. Quest’escursione è stata molto importante per me e anche per altri. Non possedendo un sacco da montagna sono andata, indirizzata da Anita Longo, a farmene prestare uno da un compagno che non conoscevo. Più tardi Anita dirà d’avermi mandata da Henek per farmi conoscere il più intelligente, il più colto dei compagni torinesi, l’unico capace di distogliermi dalle nuove amicizie disapprovate dal partito, e sostituirle in meglio. E così che alla vigilia dell’escursione conosco Henek. Mi è parso vecchio (mentre aveva solo ventinove mesi più di me), malandato in salute (tubercolotico?), goffo, timidissimo e, per i libri in varie lingue che riempivano la sua camera, un compagno di vasta cultura. L’indomani sono partita con il sacco da montagna di Henek (che poi si lagnerà che io glielo restituisca macchiato di vino) e con una camicia azzurra prestata da Pavese (sarà la sorella a lagnarsi che la camicia torni indietro tutta scolorita dal sole). Il Gran Paradiso è giudicato facilissimo, ma noi, io novellina, Bastiano alpinista provetto, per non aver preso una guida e per circostanze varie ci siamo trovati in grave pericolo due volte. E tutte e due le volte, sebbene fossi alla mia prima prova, mi sono comportata ‒ a detta di Bastiano ‒ con singolare freddezza e grande coraggio. Lo dico perché ciò ha accresciuto, se mai ce ne fosse stato bisogno, quel senso di forza, di fiducia in me stessa, di sicurezza di sapermela sempre cavare che mi ha spesso indotta a infrangere a cuor leggero le regole della vita, di morale corrente e di prudenza. Per il gusto di percorrere a piedi, sia all’andata che al ritorno, la Valsavaranche, la nostra gita è durata quattro giorni e per quattro giorni, mentre camminavo in silenzio dietro all’infaticabile Bastiano, ho continuato a pensare a Pavese. (Più tardi gliel’ho confessato: di qui le allusioni al Gran Paradiso nel suo diario e nelle lettere di lui che possiedo.) Dopo Altiero per la prima volta trovavo un uomo che aveva tutti i pregi: intelligenza, coltura, carattere, prestanza fisica, ma lui era un poeta mentre Altiero mi rimproverava sempre di interessarmi più di arte che di filosofia. (Adesso aggiungo: e più di Altiero Pavese aveva in dispregio le donne.) Non che io facessi confronti e neanche progetti, pensavo a Pavese con rapimento, perché un poeta, un artista era per me una sorta di superuomo che mai avevo pensato di poter conoscere. Tornata il 9 sera [sic], il giorno dopo correvo all’appuntamento con Pavese. Come la volta precedente ci siamo imbarcati da Töfö (un vecchio sabbiatore del Po) percorrendo a piedi un lungo pezzo dopo il capolinea del tram. Credo che quando nel Mestiere di vivere dice (all’incirca): «ricordo di lei la volta che alzava il braccio... sulla strada asfaltata...» si riferisca proprio al secondo incontro, perché al terzo ho avuto la sorpresa di trovare con lui Sturani che viene anche nei due successivi e ultimi, il 16 e il 18. Davanti a Sturani Pavese si divertiva a comandarmi come se fossi un mozzo e io obbedivo pronta abile allegra, solo per fargli vedere che non ero come le altre. Ricordo il suo sguardo divertito, compiaciuto quando davo prova di agilità, di coraggio; come un uomo guarda un ragazzotto che grazie ai suoi insegnamenti si sta facendo. Una volta sola m’ha fatto un complimento, un po’ ambiguo. Ha detto che avevo delle belle gambe da giovanotto. Non so in quale di questi tre incontri, presente Sturani, capita che sbarcati sulla riva sinistra del Po ci accorgiamo di non aver comperato da bere all’unica rivendita che si trova sulla riva opposta. Vengo scherzosamente comandata a tornare indietro a nuoto per comperare le gazose. Obbedisco di slancio. Quest’episodio della donna che attraversa come niente il Po è stato da alcuni citato per provare che tipo sportivo (troppo) io fossi allora. In verità non c’è nulla di straordinario a traversare a nuoto il Po se non è in piena, ricordo d’averlo fatto quando sapevo appena tenermi a galla. Con il Po normale, la sfida era: traversare il Po a nuoto tenendo in mano all’andata i soldi, al ritorno, tre bottiglie. Il 18 agosto, scendendo col tram a Porta Nuova per tornare a casa (Sturani era sceso prima), aspettavo che Pavese, come di consueto, dicesse: «E allora, quand’è che può venire?». Sta per parlare, si trattiene, non dice niente. Rimango male, ma non voglio prendere io l’iniziativa. Non si è più fatto vivo. Mi dispiaceva, ma appunto perché era un superuomo non ho osato cercarlo io, come forse avrei fatto con un altro. Quante volte, poi, ho pensato che quell’attimo di esitazione ha deciso le nostre vite. Se avessimo continuato a vederci non sarei andata a cercare il compagno Henek e le nostre vite avrebbero avuto chissà quali svolte. Dopo ferragosto, l’inatteso e graditissimo arrivo di nuovi allievi mi obbligava a restare tutto il giorno in casa per acchiappare al volo chi si fosse presentato. Pur rimpiangendo l’amicizia così bene avviata con Pavese, mi rallegravo che lui e la barca non mi distogliessero dal lavoro. Tra una lezione e l’altra il chiassoso andirivieni di amiche, amici non m’appagava, tornava il desiderio di un’amicizia esclusiva e fraterna come con Velio negli anni felici. Tra quanti conoscevo, solo Bruno Maffi avrebbe potuto prendere il posto di Velio, ma abitava a Milano, anche Pavese forse avrebbe potuto se non fosse scomparso. I nuovi amici gli erano di un livello sociale troppo elevato, avevano troppi impegni mondani e, salvo i grandi personaggi, erano tutti più giovani di me di qualche anno e presi dai loro amori e da altre amicizie. Solo con un compagno mi sarei trovata a mio agio, un compagno colto, intelligente in grado di capire quanto doloroso e ineluttabile era il mio distacco dal partito: capire, consolarmi, assolvermi. La sera del 5 settembre sono andata a cercare il compagno Henek a casa sua. Per il sacco (macchiato di vino!) restituito alla padrona di casa, senza una riga per lui, era rimasto male. Ma come era andata la gita? Se m’aveva creduta della razza di quelli che vanno in montagna per sbevazzare e cantare («i selvaggi»), il mio racconto deve averlo rassicurato perché m’ha subito proposto di unirmi a lui e a una sua compagnia per andare a sciare la domenica. Io, di rimbalzo, ho accettato e con entusiasmo perché gli altri amici, sull’esempio di Leone, snobbavano la montagna. Dalla montagna siamo subito passati alla politica. Nel lontano ’25, appena conosciuti i compagni, avevo timidamente proposto che si facesse lega con i socialisti. Mi ero sentita rispondere: faremmo lega coi socialisti se volessimo abbattere il fascismo per tornare alle condizioni anteguerra, ma noi miriamo più in alto, noi vogliamo una rivoluzione che come quella russa spazzi via il capitalismo. Adesso il compagno facendo l’analisi della vittoria di Hitler riconosceva l’errore dei comunisti che invece di unirsi ai socialisti li avevano combattuti ‒ socialfascisti ‒ come e più dei nazi. Grazie alle mie solite «folgoranti intuizioni» (pretesto per non studiare, approfondire) io mi stavo allontanando dal partito mentre lui, con ben altra esperienza della mia (aveva militato nel partito polacco e poi in quello tedesco), pur riconoscendo e analizzando gli errori del partito, era rimasto a esso fedele, e me ne spiegava le ragioni. Troppo ignorante per ribattere o essere persuasa, ero però vivamente interessata. Un compagno che non si contenta delle parole d’ordine, ma critica e spiega. Forse avevo trovato l’amico ideale! Ma, con vergogna, devo confessare (e sempre nel ricordarlo mi sono data della stupida) che mi è venuto questo pensiero: purché non s’innamori di me! Per il suo aspetto di bossu sans bosse, per il suo dolce sguardo azzurro mi pareva destinato al grande fedele amore non corrisposto. E perché nell’adolescenza un amore silenzioso non corrisposto m’aveva suscitato una gamma di intense emozioni mai più provate, magari avrò anche pensato: be’, tanto meglio per lui! Abbiamo continuato a vederci, solo di sera perché anche lui come me era legato a un lavoro, mentre gli altri disponevano a piacere delle loro giornate, e questa era una delle ragioni per sentirmi esclusa. Più tardi, alle prime nevi, sono andata, la domenica, a sciare con lui e la sua compagnia, che era composta di gente del tutto insignificante. Presto ho scoperto che in fatto di cultura raffinata nessuno poteva stargli a paro. Per di più era anche un matematico (nel cerchio delle nuove amicizie la matematica era crocianamente tenuta in dispregio). E la sua era una cultura europea al cui confronto quella degli altri era decisamente provinciale. Diceva che m’avrebbe volentieri insegnato il tedesco e intanto mi faceva conoscere musiche, quadri, scrittori di cui nessuno m’aveva mai parlato. Timido, goffo sì, ma distaccato, ironico pur nella sua squisita cortesia. Non parlava mai di sé, smontava le mie fanfaronate con una battuta da levarmi la pelle, m’istruiva con buona grazia senza trovarmi così intelligente come gli altri, persino Leone, mi stimavano. E non era affatto innamorato di me: per lui ero una compagna, in crisi ma pur sempre fidata. La mia vivacità a volte lo infastidiva, a volte, bontà sua, lo divertiva. Diceva che ero giovane ‒ e, se non giovane, immatura mi sentivo con lui; mentre i nuovi amici, tutti più giovani di me e nuovi alla cospirazione, mi consideravano e mi facevano sentire esperta vissuta più di quanto in verità io fossi. Non mi piace parlare di Henek, presentato come era o come lo vedevo allora e non come è adesso. Dirò solo che a un certo momento mi sono accorta d’essere innamorata di lui e questa volta tutto era diverso: l’amore mi riempiva di tristezza, di sfiducia in me, di smarrimento. Lo avevo d’un subito giudicato capace di un grande amore non corrisposto. Giusto. Solo che lo provava per un’altra. L’ho indovinato assai prima che lui, per togliermi ogni illusione, me lo dicesse brutalmente: sono innamorato di un’altra. Ho pensato che fosse lontana, ma più tardi da altri ho saputo che viveva a Torino (e che era bellissima). Ancor oggi, questo ‒ d’aver indovinato ‒ mi è misterioso e conturbante. Qualche volta, lealmente, lui proponeva: «Meglio non vederci più. Sei giovane, non perder tempo con me che sono un rottame umano». Al mio diniego rispondeva stancamente: «Come vuoi, io ti avevo avvertita», e con tenera pietà mi sfiorava la guancia con un dito. Pietà! per me! Non potevo sopportarla. Gli avrei fatto vedere io se avevo bisogno di pietà. Sempre di fronte a una disillusione, un tradimento il mio impulso è: agire, punire, vendicarsi, far qualcosa e non star lì a piangerci su. |
|
Post n°115 pubblicato il 04 Settembre 2012 da amantedicesare0
"Il vizio assurdo" in scena a Santo Stefano Belbo in prima nazionale Si inserisce nel programma delle manifestazioni per il centenario di Davide Lajolo la rappresentazione di Assemblea Teatro e della Banda Dell’Unione Musicale Condovese di “Il vizio assurdo”, dramma di Diego Fabbri e Davide Lajolo. Verrà portata in scena in prima nazonale sabato 8 settembre alle 21 a Santo Stefano Belbo, Anfiteatro i Mari del Sud. I più curiosi potranno assistere alla prova generale sulla piazza del Municipio di Vinchio alle 21 di giovedì.
|
|
Post n°114 pubblicato il 27 Luglio 2012 da amantedicesare0
|

ULTIMI COMMENTI
CERCA IN QUESTO BLOG
AMORE STRAZIATO
...Siete un mucchio di fottuti. Me ne importa tanto a me di Frassinelli, di quel bischero di Franco, e se mangio all'albergo!
Quando la finirete di far finta di non ricevere che chiedo notizie,notizie, notizie, e una cartolina firmata, di *?
E avete ancora il becco di scrivermi se ho bisogno di qualcosa. Da un mese non chiedo altro.
Il confino è niente. Sono i parenti che costringono uno a lasciarci la pelle.
Che vi venga il cancro a tutti.
CHI PUÒ SCRIVERE SUL BLOG
CITAZIONI
La strategia amorosa si sa adoperare solo quando non si è innamorati.
Gli uomini che hanno una tempestosa vita interiore e non cercano sfogo o nei discorsi o nella scrittura, sono semplicemente uomini che non hanno una tempestosa vita interiore.
I grandi poeti sono rari come i grandi amanti, non bastano le velleità, le furie e i sogni; ci vuole di meglio: i coglioni duri.
Tutto il problema della vita è dunque questo: come rompere la propria solitudine, come comunicare con gli altri.
Le cose si ottengono quando non si desiderano più.
È bello svegliarsi e non farsi illusioni. Ci si sente liberi e responsabili. Una forza tremenda è in noi, la libertà. Si può toccare l'innocenza. Si è disposti a soffrire.
Bacca: Qui si dice che fu per amore.
Orfeo: Non si ama chi è morto.
Leggendo non cerchiamo idee nuove, ma pensieri già da noi pensati, che acquistano sulla pagina un suggello di conferma.
La vita non è forse più bella perché da un momento all'altro si può perderla?
L'amore è la più a buon prezzo delle religioni.
Ogni lusso che ci si concede si deve pagare e tutto è un lusso, a cominciare dallo stare al mondo.
L'idea del suicidio era una protesta di vita. Che morte non voler più morire.
Chiodo scaccia chiodo, ma quattro chiodi fanno una croce.
Ciò che ci rende villani e violenti è la sete di tenerezza.
E CANTA...
E Cesare, perduto nella pioggia, sta aspettando da sei ore il suo amore, ballerina. (Francesco De Gregori)
LA CASA IN COLLINA
Già in altri tempi si diceva la collina come avremmo detto il mare o la boscaglia. Ci tornavo la sera, dalla città che si oscurava, e per me non era un luogo tra gli altri, ma un aspetto delle cose, un modo di vivere. Per esempio, non vedevo differenza tra quelle colline e queste antiche dove giocai bambino e adesso vivo: sempre un terreno accidentato e serpeggiante, coltivato e selvatico, sempre strade, cascine e burroni. Ci salivo la sera come se anch'io fuggissi il soprassalto notturno degli allarmi, e le strade formicolavano di gente, povera gente che sfollava a dormire magari nei prati, portandosi il materasso sulla bicicletta o sulle spalle, vociando e discutendo, indocile, credula e divertita.

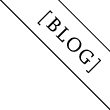

Inviato da: cassetta2
il 12/10/2020 alle 09:19
Inviato da: scampipercena77
il 01/02/2016 alle 11:46
Inviato da: amantedicesare0
il 30/09/2012 alle 21:56
Inviato da: Roberta_dgl8
il 30/09/2012 alle 17:04
Inviato da: margherita88
il 17/08/2012 alle 11:27