Schwed RaccontaSu e giù per la tastiera |
C'ERA UNA VOLTA MONTALCINO

JIGA MELIK E IL SIG. SCHWED
Jiga Melik è l'alter ego intermittente dello scrittore Alessandro Schwed. Il signor Melik nasce nel 1978 nella prima e provvisoria redazione del Male, un ex odoroso caseificio in via dei Magazzini Generali a Roma. Essendo un falso sembiante di Alessandro Schwed, Jiga Melik si specializza con grande naturalezza nella produzione di falsi e scritti di fatti verosimili. A ciò vanno aggiunti happening con Donato Sannini, come la consegna dei 16 Comandamenti sul Monte dei Cocci; la fondazione dell'Spa, Socialista partito aristocratico o Società per azioni, e la formidabile trombatura dello Spa, felicemente non ammesso alle regionali Lazio 1981; alcuni spettacoli nel teatro Off romano, tra cui "Chi ha paura di Jiga Melik?", con Donato Sannini e "Cinque piccoli musical" con le musiche di Arturo Annecchino; la partecipazione autoriale a programmi radio e Tv, tra cui la serie satirica "Teste di Gomma" a Tmc. Dopo vari anni di collaborazione coi Quotidiani Locali del Gruppo Espresso, Jiga Melik finalmente torna a casa, al Male di Vauro e Vincino. Il signor Schwed non si ritiene in alcun modo responsabile delle particolari iniziative del signor Melik.
MIO FIGLIO MI HA AGGIUNTO SU FACEBOOK - ROMANZO


LA SCOMPARSA DI ISRAELE - ROMANZO
LINK DOVE VIVO
- Fahrenheit
- Il Tizio della Sera
- romanzo LO ZIO COSO
- La Scomparsa di Israele
- Corriere della Sera
- Critica letteraria
- libri su libri
- i suoni della memoria
- IBS
- settimanale L'AZIONE p. 7
- Il Piccolo - recensione teatrale "Alla ricerca dello zio Coso"
- Il Messaggero Veneto - Giornata della Memoria Intervista ad Alessandro Schwed
- anobii
- libero di leggere
- articolo sul Foglio
- roma
- IL MALE
- il Male su facebook
AREA PERSONALE
TAG
MENU
I MIEI BLOG AMICI
|
Post n°121 pubblicato il 05 Giugno 2017 da Jiga0
Io bene, ho girato, sì, Roma, poi in campagna. Mi sono sposato, un figlio. Uno. Tredici anni. Diciamo editoria. Tu? Ah, ah, interessante. Guarda, è un caso che sono a Firenze, sì, non ci volevo più venire, poi a febbraio sono tornato, e oggi di nuovo. Ma per parecchio pensavo di non tornare più, mi era successa, beh, una cosa. Tre anni fa. No, non è una cosa razionale, è che, no niente… - vorrei dire che ci sono zone sottili, al di fuori del normale controllo, e che a questo punto devo stare in guardia - Sembra fatto apposta, vero, esserci incontrati proprio alla stazione di Firenze? che siamo tutti e due di questa città, e tutti e due ormai lontani da qui. Ricordi che trentanni fa la mia famiglia poi è partita, e anche io me ne sono andato?…come? no, morti. Grazie. I tuoi?… ah…Non lo so, è un guscio vuoto. E’ rimasta come una sospensione. Passo per le strade, e quello che…no, no, vai! ci mancherebbe - ecco, sei andato a comprare il giornale, sono nella libertà a metà di essere soli, e penso che il tuo volto è sparito e che quando ti ho visto, volevo dirti: come, ma sei tu? Prima, se non avessi smesso di parlare, ti avrei detto che qui, per le strade, ho timore. Quello che era, si risveglia, e devo stare in guardia. Il tempo di una volta si avventa. Nel perimetro delle porte e dei ponti viene il passato, ha proprio la voce, e ha proprio una lama. E io ho il buon senso di avere paura. Sei dal giornalaio, ti guardo essiccato comprare i cruciverba. Il tempo è onnipotente: siede, e regna con sprezzo - Allora, c’erano i cruciverba? Lo sai che ti trovo benissimo? Sì, ti stavo dicendo che a Firenze sto in guardia. Vado a San Niccolò e controllo che la porta della città sia lì - ti guardo, ma penso a quella porta di legno che stupisce, inverosimile in una casa e piccola per una città, porta reale davanti alla torre, che girerebbe sui cardini, col chiavistello, e a sera, ci fossero sentinelle, chiuderebbero a chiave la città. Alla stazione le voci rimbombano, e penso a questa città della misura di una casa, per salotto il centro, e divani le colline. Controllo se ancora si vada a pranzare ai capannoni di ferro dei mercati, nella pioggia dei ganzo. E che ai ponti sulla ferrovia giunga il boato dello stadio. Vedo che tutto sia in ordine, dentro di me e fuori di me. Le mura dell’Erta Canina sono pur sempre quelle, ma la campagna forse è in disordine. E penso che dopo va bene che ci salutiamo con una stretta di mano, e la promessa di sentirsi presto. Non so se ti parlerò per davvero, mi devo pure difendere. Ti dovrei raccontare che tre anni fa, un mattino, mi sono preso paura sotto al disegno bianco e nero del Battistero. Ero stato imprudente, ero solo. In piazza San Giovanni, accanto al portone dello studio di mio padre, a un tratto, come un proiettile, in un impulso crudo, mi infilai per quel portone come fossi stato risucchiato da una corrente - da un potere. Da trentanni, non varcavo quella soglia. Da quando mio padre era partito e aveva lasciato il secondo piano - dalla piazza guardo ancora la finestra. Mi trovai a quei primi gradini bianchi, appena filati di rosso, come capillari sotto la pelle delicata del marmo. Salivo, prima del mezzanino, e assaggiavo il ricordo. A un tratto sento un odore acre, miscela di materia e sentimenti, trattenuta nell’aria, e vengo a sapere. Qualcuno, per generazioni, ha continuato a lavare le scale con la segatura, l’ha mescolata allo stesso sapone, una marca che passa da un millennio all’altro, e a momenti finivo con le narici ricolme dentro al tempo di prima, un cosmo inerte. Brusca partenza, da astronauti. Vacillai sino al muro, mi appoggiai alla ringhiera. Le pareti oscillavano. Pensai: muoio solo, in questo purgatorio di candeggina. Al mezzanino, c’era l’ascensore di legno scuro, e fui in cabina, al riparo. C’era la scatola per le monete con scritto Lire 10, e l’avviso ai fornitori di fare uso delle scale. Lunga la vecchia corda, l’ascensore si issava. Mi trovai sul pianerottolo di mio padre, sfocato dallo stesso neon, a quei tempi si saliva in penombra. Invece di studio dentistico, c’era scritto società di assicurazioni. Meglio perché stavo per bussare alla porta e vedere se mio padre fosse lì, non morto, ma vivo di nascosto. Occultato da decenni nel centro di Firenze. Scesi di corsa, passando dall’ombra al guizzo, e nel folto della piazza pensai di non tornare più. Che non avrei fatto ritorno sui passi di prima, e avrei vissuto come tutti nel semplice dopo. Che se davvero mio padre fosse venuto alla porta, cosa gli avrei detto? ah, eri qui. E’ questo il regno dei morti? - Sicchè ti dicevo che a fine di febbraio ci ho ripensato e sono tornato a Firenze. E una mattina ero in centro, hai visto, che ho quell’andatura a testa china: che hai da ridere? lo so come cammino, mi sono visto in un filmino - potrei dirti che sembro uno che mentre cammina, cerca qualcosa per terra. Ma sto zitto. Non dico che quella mattina per la strada stavo pensando a voce alta, e muovevo un po’ le labbra. Che se mi accorgo che mi vedono mentre parlo da solo, faccio finta di stare al cellulare, e che parlo con qualcuno. Non mi va che credano che sono uno solo. E come ci cascano. Invece, quando non c’erano i cellulari, mi mettevo a fischiettare. E ti direi che quando penso è come se stessi a casa. Penso per queste strade di prima e sono in una casa dentro alla mia casa. Penso e sono in pace, parlo e sono in pericolo - e sicché, a febbraio arrivo in piazza San Giovanni, sai, alla farmacia, accanto al portone dello…studio di mio padre, sì…come fai a saperlo? ah i tuoi erano clienti, e ci andavi da studente, non lo sapevo, e che ti diceva mio padre? Era gentile, ti sorrideva, bene, sono contento, sì mio padre era così, era gentile. Ma ora ascoltami, perché io…niente…Quando ce l’hai il treno? Allora va bene, ascoltami: ce la facciamo. Ero lì sotto il portone di mio padre, no, e sento questa voce lontana: “Biondooo!”. Smetto di andare, e guardo in giro per vedere se vogliono proprio me, perché d’accordo, io prima ero biondo, ma ora si vede molto meno, e non si capisce se sono biondo oppure ho una certa età e basta. Non sono uno da chiamare biondo. E allora guardo se cercano me, e non vedo nessuno. A parte che con tanti biondi che camminano in giro perché devono gridare biondo proprio a me? Ti confesso: ho pensato che era un equivoco - ma non è vero, non confesso nulla. Se no direi che avevo paura perché ero sotto al portone di mio padre e mi stava di nuovo succedendo qualcosa. A te dico quello che fa comodo, per lasciarsi senza essersi toccati. Tu non vieni da quel meraviglioso prima, sei arrivato poi. Hai studiato, sei emerso, fai avanti e indietro con Londra, e quando parli, non capisco. Perciò mi sono fatto furbo, limito i miei discorsi. Prima sì, dicevo tutto. Ora penso tutto, e quando parlo, dico la metà della metà. E non ti dico che quando ho sentito biondo, oltre alla paura di un’altra imboscata, un’imboscata ancora, nella città sospesa, in me si era formato un soldo di speranza. No, non te lo posso dire – E così, no, attraversavo via de’ Cerretani. A parte, scusa, che una volta mi chiamavano spesso biondo, ma prima: capisci, prima. Ora però chi poteva essere, ora? E dai, che risento quella voce: “Biondooo!”. Mi fermo. Guardo a destra, guardo a sinistra. Niente. Poi, non so perché, guardo l’orologio - invece lo so: lo guardo sempre perché ho paura che succeda qualcosa di importante e io non so che ora sia. Nei libri di Storia ci sono le date delle battaglie, nella vita delle persone ci sono le ore. L’ho scoperto a un certo punto, prima non era così, prima un giorno alzavo la testa e avevo finito di leggere un romanzo. O c’era l’odore del caffè, e mia madre si era alzata. Poi mi sono accorto che le cose succedevano non di mercoledì o lunedì, ma alle cinque, alle sette, e quando è nato mio figlio, ho guardato l’orologio. Non era proprio il 1994, erano le quattordici e ventisette - Guarda, te lo giuro su quello che vuoi: non so affatto perché ho guardato l’orologio. Certo, era mezzogiorno meno quattro. La gente faceva la fila per camminare, e al semaforo c’era una siepe di teste. Aspettavano di attraversare in punta al marciapiede. E al chioschetto dei giornali, c’era la fila. E mi pareva che in quella piazza universale fossi l’unico fermo perché l’aveva scelto. Ero fermo e guardavo chi avesse detto biondo proprio a me, e anche nelle macchine che passavano, guardavo, però c’era il rumore del traffico, e pensavo a come avrei fatto a sentire se uno avesse di nuovo detto biondo. Ma di nuovo: “Biondooo!” - e qui c’è un’altra cosa mia, che il rumore del traffico sembrava un ultrasuono, e sembrava che la terra si stesse per aprire sotto alle scarpe, e mi veniva la nausea come sulle scale di mio padre tre anni fa, e pensavo sono accanto al portone, quel potere sconosciuto sta su di me, e non posso farci niente - e insomma niente, avevo attraversato via de’ Cerretani. Ma appena sento la voce, “Biondooo!”, torno indietro, riattraverso, e mi fermo all’angolo, sai, davanti a mio padre - e lì, un’altra oscillazione, le porte del Battistero sembravano occhi, e il Battistero sembrava la testa di mio padre, e per calmarmi ho dovuto guardare la gente che entrava e usciva dal tabaccaio - E di nuovo: “Biondooo!”. Ero lì, la borsa piantata tra le gambe, che dentro c’era il portatile, e ho aspettato. Non arrivava nessuno. E questa voce mi è arrivata addosso, in faccia, e ha detto biondo da un metro - Non era una cosa reale, era più interiore che esteriore. Me lo ha detto come da dietro un vetro blindato, come dal fondo di una valle, ma come faccio a spiegare, ridi, non puoi sapere che ho guardato in alto, in cima al Duomo, dove c’è la palla d’oro, che io guardavo brillare nella primissima luce - prima - quando alla fine della notti tornavo a casa a piedi, e all’alba si sentiva il respiro delle pietre, e amavo questa città come una fidanzata - …e questa persona, sputata dalla folla, mi abbraccia…aveva una forza tremenda, e non sapevo chi fosse. E senza smettere di abbracciarmi, sento che mi dice: “Biondo!...Non mi riconosci eh?”, io facevo di no con la testa, a questo uomo sbucato dal nulla e che gridava biondo. Che in effetti io lo ero stato, il biondo, e poteva essere che ci conoscessimo: prima però. Ma se non era così, se era un equivoco, io mi dovevo tutelare. Lasciare una porta aperta, mostrare contegno. La voce la conoscevo. Ma lui, questo tale che mi stringeva, chi era? Uno con il mongomeri blu, gli occhiali quadrati, e l’alito sapeva di menta. Poi mi guarda bene, come se ci pensasse, e a un dato momento si mette a cantare: “…Alè alè Fiorentina, quando senti negli stadi una canzone… - lo guardavo, questo qui cantava fortissimo, questo qui era emozionato, chissà se questo qui era pazzo - …alé alé, Fiorentina”. Poi ha smesso di cantare. Mi guarda serio, e fa: “Pirimpallino! O quanto tempo, ma che siamo scemi davvero? - aveva il fiato grosso, come se avesse corso - …s’aveva quindici anni…Eh, ma ti ricordi qualcosa, in quella scatolona? - mi scuoteva la testa, come se volesse farmi uscire i ricordi dalla fronte - che si andò a Torino a vedere la Fiore che vinceva lo scudetto…Ricordi o no? il viaggio in treno, la gente alle stazioni che faceva ciao, a Bologna applaudirono, sembrava che fosse finita la guerra e l’avesse vinta Firenze - qui gli si incrinò la voce - … migliaia di ragazzi ai finestrini con le bandiere, ma quanto era bello questo viola? Biondo, ma te lo ricordi porca miseria, quello sepolto sotto la bandiera col giglio, una bandiera enorme, che la stoffa usciva dallo scompartimento, e non smise ma di cantare. La notte, stavamo tornando a Firenze, si era zittito, era venti ore che urlava: vi-o-la, vi-o-la. Invece si alzò in piedi, rinvispito, e cominciò a grattare con la voce: “E la portai dal Vivoli, a prendere iggelato, la mi disse gliè marmato, la mi fece scomparir”, e noi a rispondere in coro: ‘Teresina un ti ci porto più, un ti ci porto più, quanto è ver che c’è Gesù’. Biondo, ma te lo ricordi, chi sono sì?” – E adesso, caro conoscente incontrato oggi alla stazione, è tardi: non mi sento di dire che mentre lui, quello che gridava biondo, era sul marciapiede, e mi raccontava di quel treno, e del giglio che usciva dallo scompartimento, anche io ero sul marciapiede e giravo tutti gli scompartimenti di quel treno, per ritrovare il ragazzo di prima - Lo so, è buffa forte la canzone, ah non la conosci?...sentimi bene però, senti…questo si passa una mano sugli occhi, rapida: “Ora però - mi fa - devo andare. Stai bene, sai - mi fa - biondo”. E va. Aveva anche lui una cartella, però di pelle, di quelle modeste, parecchio di una volta, con tutte le grinze. Uno che avevo conosciuto benissimo, e adesso chissà chi era. E si è allontanato per il marciapiede, e quando quasi è arrivato all’angolo, si è girato e mi ha fatto di nuovo: “O biondo”. Con la testa ho fatto cenno, come dire: sì? E lui ha detto, non gridato, ha detto, e l’ho sentito benissimo in mezzo a tutta quella gente, ha detto: “E un t’ho più visto in curva”. Era lì fermo, che aveva parlato, e non se ne andava, non si decideva. E io ho detto piano: Osso. E più forte: Osso! E poi ho gridato: ”Osso!!”. Si chiamava Osso? Sì. Era il nome da stadio. Osso. Perché era magrissimo, e poi alla partita recitava una parte che lo aveva reso popolare. Faceva uno laconico, che diceva l’essenziale dell’essenziale. La Fiorentina passava in vantaggio, si alzava e diceva: “Uno”. Giocavamo bene: “Inaudito”. Giocavamo male: “Turpi”. E adesso era lì sull’angolo e mi ha fatto un gran sorriso. Ha alzato un braccio, e dopo l’altro, come quando finiva bene una partita, prima un braccio, e poi l’altro. Stava in mezzo al marciapiede, con le braccia alzate: non si muoveva. E’ stato lì parecchio. Il proprietario della farmacia è uscito in strada, il camice bianco gli sventolava. Osso ha indicato il farmacista tutto bianco, e ha detto: “Gli astronauti”. E poi? Poi niente, se n’è andato. Ecco, guarda, giusto in tempo, c’è il treno. Vieni, diamoci una stretta di mano. Ci sentiamo, auguri. Ti vedo andare - per te il racconto è finito. Ma io e Osso no. Ci siamo raggiunti. Ci siamo messi a correre e ci siamo abbracciati. Anche io. Ma forte. E lui ha detto: “Madonna come sei lento”. E io ho detto che parlava molto più di prima. Si piangeva e si rideva, la palla del Duomo brillava, respirava tutto, e ho smesso di pensare. Osso delle mie ossa.
|
|
Post n°120 pubblicato il 12 Agosto 2016 da Jiga0
Poco prima di pranzo, a passeggio dentro una brezza piacevole. Alle mie spalle un tonfo nel ferro, forse il ferro di una cancellata. Alzo la testa, l'uomo con i capelli brizzolati e lo sguardo chiuso che di solito spazza le vie, oggi ha gli occhi spalancati. Accanto a lui, un bambino con la maglia numero dieci di Messi. Non stanno facendo niente, ma è chiaro che hanno un segreto. Giro l'angolo e mi metto a guardarli di nascosto. Lo sapevo. Tirano sassi su un cancello, e infatti un altro tonfo. Poi ridono come monelli. Il fatto è che si avvicinano le ferie di agosto e ogni uomo è come potrebbe essere sempre. Libero. |
|
Post n°119 pubblicato il 03 Agosto 2016 da Jiga0
Tag: attentati, Charlie, Chiesa, conformismo, don, glamour, Kabul, like, parrocchia, sinistra, solitudine Appunti sulla solitudine di un prete anche dopo sgozzato Non ho mai amato l'ossessione di scrivere siamo tutti Charlie, siamo tutti questo e dopo una settimana siamo tutti quello, peccato perché deriverebbe dallo striscione che apriva il corteo del maggio dove fu scritto siamo tutti ebrei, quando della Shoah non parlava nessuno e la fratellanza era una bandiera vergine, tenuta bella alta. Ora che essere di sinistra è lontano e indistinguibile, e restiamo umani è una parola d'ordine fresca e già opaca, noto due silenzi consecutivi dei siamo tutti charlisti: quello sugli 80 morti di Kabul e quello su don Jacques. Quanto ai morti di Kabul, non sono percepiti per via del nostro razzismo atavico, le loro grida sono un rumore di fondo che si perde tra le urla delle persone trucidate a Nizza e la pubblicità dell'estate di quello sulla spiaggia che corre verso una ragazza e una voce canta sei lentissimo. Monaco, Charlie, quello sulla spiaggia sono spot che piacciono, Don Jacques no. Può darsi che ci sia dell'imbarazzo estetico a dover scrivere quel parrocchiale "don" prima di Jacques, ad avere proprio sentimenti per un prete. È questo che ci condanna a sparire, non l'Isis. La pochezza. Viene in mente il silenzio assoluto sui cattolici trucidati nelle chiese di Mossul o Bagdad, gente di serie b, irakeni e poi cattolici. Cosa c'è di meno glamour? Curiosamente, il povero Jacques non è percepito anche se è francese come i poveretti di Charlie Hebdò. In effetti, noi stiamo pagando le conseguenze della nostra solidarietà a corrente alternata, che non può riguardare i cristiani la cui morte non fa guadagnare uno straccio di like. Ma a chi volesse scrivere siamo tutti Jacques, senza don, vorrei ricordare che lui era don Jacques ed è stato sgozzato perché era un prete. Il silenzio sulla sua morte è uno scandalo laico. Restiamo umani. |
|
Post n°118 pubblicato il 29 Luglio 2016 da Jiga0
A zonzo con Hicks (28 luglio 2016, Huffington Post) Due volte al giorno io e il cane Hicks ce ne andiamo a camminare per Montalcino dove vivo da molti anni. Si va lungo il muretto ombreggiato di un viale che costeggia la Valdarbia e la Valdorcia. Uno cammina e vede il mondo come durante un volo a bassa quota. Piccolissime case, i fili sono vie che traversano i campi e le righe sui poggi vigne. Se poi la giornata è tersa, si vede Siena tremolare. Il fatto di camminare, l'ho appreso a Firenze dove sono nato. Me lo insegnò mia madre che mi portava a camminare a Piazzale Michelangelo, alle Cure Alte o al mercato di Sant'Ambrogio tra il meraviglioso odore delle patate e delle cipolle. Ora poi camminare mi sottrae alle immagini cupe che escono dal televisore, entrano in noi e rimangono. Infine, camminare rende allegro Hicks e così sono allegro io. Come tutti i cani uniti alla vita del diciamo così padrone, Xicks sa di me ogni cosa. Se ho una malinconia, anche se lui fosse in un'altra stanza, arriva di corsa e mi bacia. Sa tutto di chi vive in casa, delle abitudini, e poco prima di uscire, inizia ad accucciarsi, alzarsi, andare avanti e indietro. Presagisce. Il fatto è che noi due abbiamo un accordo non scritto in base al quale andiamo a passeggio due volte al giorno - dove dico io, non in fondo ai calanchi come vorrebbe lui. Sa il significato di frasi come ora esco e di domande assurde come "vuoi un osso"? Certo che lo vuole. Sa cosa significhi che appoggio gli occhiali sul tavolo e poi mi alzo: significa che sta entrando in vigore l'accordo e usciamo. Ma non voglio idealizzare Hicks. Se una volta usciti lui rispetta l'accordo, è solamente perché sta al al guinzaglio, altrimenti lo sa Iddio cosa succederebbe. Poi lui rispetta l'accordo in quel suo modo implicito che significa "sì va bene", ora però muoviamoci. La meta è il viale Roma, detto viale della Madonna, o con familiarità la Madonna per via del santuario a metà del viale. La passeggiata non è affatto facile solo perché Hicks ha le dimensioni di una valigetta. Il mio socio è buono e gentile, ma quando si mette per strada e va, getta la maschera e rivela chi è davvero: un rimorchiatore che mi porta in giro come un piroscafo ingolfato. Uno sconosciuto che ci vide da lontano sul viale della Madonna, quando fu giunto alla nostra altezza, si fermò e disse: "Vi osservo da duecento metri e non si capisce chi porta chi". In effetti, durante il tragitto d'andata le forze di Hicks sono dirompenti. Mi trascina, si pianta, riparte di scatto. Che devo fare, lo assecondo. È il suo momento. Annusa con estrema attenzione certi tronchi, ispeziona ciuffi di erba. Si strofina mugolando contro certi alberi suoi amici e di recente controlla sempre un paletto di ferro. Intanto, io mi godo un colpo di vento e se no sono raggiunto dalla faccia di quel ragazzo di Monaco che si è messo ad ammazzare la gente che faceva la spesa. Vorrei che mio figlio vedesse un tempo diverso e non questo, avesse una giovinezza rock come la mia. Nel frattempo non è così, succede sempre qualcosa, e mi domando quando finirà la guerra anche se per fortuna la guerra non c'è, ma purtroppo neanche la pace. Il cane riparte con uno strattone, nonostante io sibili: "Chi comanda?". Neanche mi guarda. È chiaro chi comanda, io no. È inutile sgridarlo, sta osservando un tordo, annusando un punto dell'aria e in certi momenti per stare tranquillo fa come me: finge di occuparsi d'altro. Inizia a guardare da un'altra parte. Dopo un po' gira la testa e mi guarda arrendevole: ha negli occhi lo struggimento di quando siamo nel bosco ed è proprio nella natura. Poi il tragitto d'andata giunge al giro di boa, la fermata dell'autobus in fondo al viale. Hicks decelera. È sfinito. Ha offerto tutti i suoi doni alla madre terra, è oggettivamente svuotato. A un tratto, è il fratello buono del cane d'andata. Va al passo, srotola la lingua sorprendentemente lunga e rosa e mi lancia rapide occhiate per sapere se io stia apprezzando il suo nuovo comportamento. Cosa mi stia dicendo, è chiaro: che comando io e che mi seguirà a questo ritmo blando da debosciato a costo di affrontare in piena notte il mastino nero dell'orologiaio. Comunque, adesso che è quieto, posso divagarmi. Osservo fin dove si allunghi l'ombra degli alberi, sento il colpo di una racchetta su una palla da tennis e la voce del maestro dire "bravo". Le auto sono rade, passa qualcuno con un altro cane e ci sorridiamo. Ed è una piccola pace. E così, giorni fa ero al giro di boa, la fermata d'autobus, e spirava un piccolo vento fresco. Mi giro per iniziare il ritorno e mi accorgo che sotto la pensilina c'è una sedia di formica marrone, parte organica della mobilia da cucina dei primi anni '60: una sedia integra, le gambe di metallo ancora lucenti. Del tempo in cui le credenze di legno furono sostituite da cucine con i ripiani nel nuovo materiale che cambiava il mondo, la formica. Non saprei da quanto, ma ormai le sedie di formica stazionano nei ripostigli, dietro gli sci; o riemergono alle tavole apparecchiate, quando ci sono tanti ospiti e le sedie non bastano. A riconsiderare gli anni della formica insorgente, oggi quella mobilia così lavabile non mi sembra granché, per quanto io ammetta di avere avuto un debole per la formica celestina e ancora oggi per quella verdolina. Sì, la verdolina mi piace. Ma a prescindere, che cosa ci fa alla fermata del bus quella sedia? Non è stata buttata via, è sotto alla pensilina dove mancano i sedili. È un tacito invito a sottrarsi alla fatica di aspettare in piedi, e chiunque sia stato a portare la sedia è stato gentile. Anche se poi è inutile e in giornata la porteranno via, la sedia. Perché è così che va: si pulisce, si separa, si mette ordine. Si butta quello che non combacia. Invece il giorno dopo la sedia è lì, e anche i successivi: immobile, sotto la pensilina. Come ce l'avessero disegnata. Sta lì, tacitamente accettata da tutti. Ci incontriamo alla fine del tragitto d'andata, io la guardo, lei non so cosa faccia, e devo dire che la pensilina le dona, anzi, che è lei a donare alla pensilina. È la sedia di Montalcino. Prima non c'era da sedersi e ora sì. E da oggettivamente bruttina che era, la sedia di formica marrone comincia a essere discreta. La stimo. Mi commuove. Emana una gran vita di provincia, emana pace. Perché scusa, mi chiedo mentre torniamo e Xicks va quieto sotto gli alberi della Madonna, cos'è la pace se non piccole cose che tutte insieme formano un quid che non sappiamo, ma c'è, ed è positivo. E faccio il volo pindarico baggiano di un tale che se ne va a zonzo col cane, ne imita l'istinto e sente l'odore di un mondo dove alla fermata del bus hanno messo una sedia per non stare in piedi, e magari da qualche parte sotto a una grondaia c'è un ombrello nel caso piovesse. Questo tale scrive che l'ha visto, una sedia alla fermata del bus, e un ombrello sotto a una grondaia, e la notizia gira. Forse è un'idea, forse una parola d'ordine. Allora altri fanno la stessa cosa, lasciano una sedia alle fermate degli autobus, un ombrello alle grondaie. Sedie e ombrelli per tutti. Comunque oggi quando sono passato dalla pensilina, lo schienale della sedia era messo tutto di sghimbescio, si era rotto. Speriamo che regga ancora. E poi senti, se non reggesse mettiamo un'altra sedia: anche non fosse di formica. E questa è la scuola sentimentale della pace.
|
|
Post n°117 pubblicato il 26 Novembre 2015 da Jiga0
Caro amico di Fb che critichi i ragazzi di ora per l'ignoranza crassa, per non saper scrivere un rigo, distinguere questo da quello, essere arroganti, e la lariciunferalillallero lariciunferalillallallà. Ecco, credo che né tu né io, e nessuno purtroppo, abbia gli strumenti per sapere cosa stia succedendo e tantomeno che succederà nel nuovo mondo che viene. Ma sui ragazzi ti sbagli per eccesso. Fustighi e cannoneggi perché la lettura e la cultura non sono il loro orizzonte, ma solo il software, la playstation e il web che noi invece ignoriamo. Forse è davvero così, loro non sanno che poco, ma poi dimmi, amico di Fb, noi che sapevamo all’inizio, a parte la Vergine Cuccia del Parini e qualche terzina di padre Dante? Sapevamo dell’antifascismo, e non tutti lo sapevamo. Leggevamo, o pareva che noi leggessimo, che noi andassimo al cinema proficuamente a vedere Bergman nei cineforum che erano stati fondati dai nostri fratelli maggiori, delle volte dai preti che criticavamo tanto, o dai nostri padri che lavoravano per noi senza farsene accorgere. Ma non è di questo che dico: quando si parla dello sconvolgente abisso, del non sapere totale dei giovani, stiamo parlando di questo ipnotico umanesimo nuovo, che però non pare umanesimo, e chissà cosa è, o di quello precedente? Di Dante, Boccaccio e Tasso, o dei fake e di YouTube, sia orridi che meravigliosi? Bisognerebbe sapere cosa stiano diventando oggi la cultura e la lettura, e cosa si intenda nominandole, perché stanno cambiando in modo vertiginoso. Tutto è a disposizione. Troppo o non troppo? E poi dimmi, quando mai cultura e lettura sono state veramente in primo piano presso le generazioni, del resto quando mai gli adulti o gli anziani hanno lesinato critiche e brontolii ai figli e ai nipoti, quando mai li hanno trovati indenni da imperfezioni? Soprattutto, rifletti: l'umanesimo e il pensiero hanno sempre riguardato alcuni, non la folla. Basta leggere mitopoieticamente il Genesi, o l'Eneide, o anche Robinson Crusoe, per capirlo. I giovani sbagliano, bene, è il loro meraviglioso lavoro! La nostra generazione è stata fortunata, è cresciuta in mezzo al miracolo di adulti come Calvino, Moravia, Gadda, Pasolini, Fenoglio, Sciascia, Buzzati, Parise, Moravia, ha solo sfiorato Pavese per ragioni tragiche. Noi facevamo mostra di leggerli dato che li tenevamo in vista sugli scaffali, ma quanto poi fosse vero che erano letti da tutti non lo so. Del resto mentre li leggevamo, o sembrava che li leggessimo, avevamo le Br per la strada, e se non le Br l'eroina. Invece questi ragazzi di adesso, sociologicamente (e orribilmente) chiamati "nativi digitali", hanno attitudini di pensiero, modalità, che noi non avevamo affatto, una mole di informazioni immediate che noi non avevamo, in sintesi una capacità di elaborare diversa, rapida e molteplice. Meglio, peggio? Ci stiamo inabissando o stiamo entrando in una strada sconosciuta e abbiamo paura? È come criticare l'invenzione della ruota o la scoperta del fuoco. Per fare un esempio conosco assai bene un ragazzo che ora ha sui ventanni e che ha studiato la chitarra molto più sul web che con i suoi maestri, guardando Clapton ed Hendrix centinaia di volte, cosa che noi non potevamo fare né come gli appassionati di musica che fummo, né come musicisti, che io certo non fui. I deprecati ragazzi sanno tutto in questo stesso momento. È sbagliato? Beh, correggeranno questo magnifico errore. Dovranno farlo da soli perché tra noi non ci sono Calvino, Moravia, Buzzati, Parise, Gadda, Pasolini, Fenoglio, Moravia, Sciascia e Pavese. |
|
Post n°116 pubblicato il 17 Novembre 2015 da Jiga0
Qualcuno deve sbucciare le patate di Alessandro Schwed (l'Unità, 14-11-2015) Per i notiziari non stop è un’era faraonica. Non smettono mai - è la tv. Noi siamo qui, rapaci, pronta ad afferrare la notizia e masticarla. Il rischio di quest’attenzione dilatata è che la giornata si disfi sotto i piedi e dimentichiamo di sbucciare le patate – e se non le sbucciamo noi, chi le sbuccerà? Patate, carote, tutto passa in secondo piano quando il serpentone annuncia le dimissioni di una giunta. Siamo rapiti dal misterioso flusso dei Fatti Dappertutto. Per dire, giorni fa era annunciato nel golfo del Messico un tornado con esiti biblici. Naturalmente l’evento è stato illustrato come se fosse avvenuto da un pezzo. Grazie ai satelliti e ai disegnatori di cartoni animati il montare certosino del cataclisma è stato preconizzato con animazioni che rendono la morte un gioiello estetico. E dire che all’inizio quasi non si vedeva. Senza offesa, era una caccola grande come il Belgio. Sembrava un temporaluccio, però attenzione: in poche decine di minuti si sarebbe trasformato in una furia da non parlare d’altro per generazioni. In quel giorno e in quei minuti il signor Tale è davanti a un chilo e trecento di patate da sbucciare, stese sul tavolo di cucina. Intende realizzare un morbido purè. Ma non sbuccia una patata. La faccia è una smorfia di determinazione: il tiggì deve dare frutti. È pronto a ghermire la calamità, e ingoiarla. Sulla rete all news, a girare il rullo del racconto sono i conduttori. Si alternano alle notizie nel piccolissimo studio: uno parla, gli altri non si vedono, ma ci sono. Discutono, guardano Al Jazeera, Cnn, Bbc: scelgono. E ora facciamo un salto dall’altra parte del televisore. A casa. La sera della prevista sciagura messicana il Tale è in cucina con le patate da pelare. C’è tensione tra i fornelli: se la sciagura risultasse inferiore alle aspettative, la sua delusione di telespettatore sarebbe forte, anche se trattenuta per non fare brutta figura. Lui non direbbe mai: “Sono tutti vivi, che noia”. E d’altra parte, quando non c’è neanche un sinistrato, di che si parla, delle zucchine? E poi, senza notizie continue, buone o cattive, è dura. Al massimo si può fare una scappata alla posta e leccare un francobollo. Quella della teorica sciagura messicana, era una serata da buongustai. Le patate da sbucciare erano sul tavolo di cucina dal tamponamento a catena del mattino. Ed ecco l’aggiornamento: tra poche ore il mare davanti al Messico si alzerà. Ci saranno onde alte decine di metri. Venti a trecento chilometri orari. Anche lo sbucciapatate è sbalordito. La catastrofe è prevista intorno alle ventitré italiane. È una sciagura di quelle comode, non c’è bisogno di restare svegli fino all’alba. Uno guarda i primi flash dell’apocalisse, poi va a letto. Ma regna una grande incertezza: come sbucciare un chilo e tre di patate quando sta per scomparire l’America Centrale? Sai cosa, le patate verranno sbucciate con tranquillità subito dopo la sciagura. Stasera non ci sarà una cena vera e propria. Il Tale non ha il cuore di mettere sul fuoco l’acqua per gli spaghetti, c’è rischio di perdere i primi crolli mentre sta scolando la pasta. No, stasera si digiuna in ricordo delle future vittime. Mezzanotte. Tra tutte le notizie, arriva la più inammissibile: la furia degli elementi cala. Mentre l’inaudita perturbazione stava raggiungendo la costa del Messico, ha avuto inizio un miracolo che non aveva chiesto nessuno. In due minuti i venti si sono afflosciati da trecentocinquanta a duecento chilometri orari, poi a novanta. Roba da ventilatore. In bocca, un atroce gusto di speranza. L’unica consolazione viene dal nord della Polonia. Una frana ha fermato il treno di Danzica, bloccando la consegna di due tonnellate di pesce fresco, e domani è venerdì. Sul tavolo di cucina giacciono le patate, la buccia sfacciatamente intonsa. Sul teleschermo transita un altro serpentone. La scritta è esplicita: “Scusate, ci sarebbero da sbucciare le patate”. Il Tale va a dormire. È stanco, con tutto quello che non è successo.
|
|
Post n°115 pubblicato il 06 Novembre 2015 da Jiga0
Pasolini è conosciuto. Muccino ha dovuto farsi riconoscere di Jiga Melik (Huffington Post, 6 novembre 2015) Basterebbe quella memorabile camminata senza respiro, così lunga e poi così fortunatamente lenta, non televisiva, lo so, non demenziale, certo, non gelida alla Brian De Palma, d'accordo, senza il nostro rock'n'roll, lontano da Woodstock, d'accordo di nuovo, distante anni luce dall'epica di Sergio Leone e del suo grande western all'italiana, vero, con attori presi dalla feccia del mondo, dalla Suburra, dall'inferno che non ha fine, da una vita in canottiera, e la canottiera è stracciata, filmando le vite passate in strada, perché non c'è una casa dove vivere, vite intere ad arrangiarsi, e a tutto questo accostare la solennità della Passione secondo Matteo di Johann Sebastan Bach. Ecco, basterebbero queste anomalie meravigliose messe insieme, accostate appunto, per renderlo immortale. E ti domando perché tu abbia continuato a distrarti quando Totò giganteggiava in Uccellacci e uccellini e parlava con quel merlaccio nero, e a quell'immenso Totò santo e comico alternava i funerali di Togliatti e ci diceva cos'era l'Italia, paterno e materno com'era lui, Pier Paolo Pasolini, con dolcezza serafica, e diceva chi fossimo noi di questo Paese, gente privata della parola e spinta ai margini della vita, migranti senza arte né parte. Dimmi quando mai è stato fatto almeno un'altra volta qualcosa di simile in Italia e nel mondo. Del resto questo è il Paese dove nessuno parla più di Michelangelo Antonioni, che basterebbe La notte per far rimanere il suo nome nei libri di Storia. Ma forse non ti piace neanche lui. Ti sono vicino. |
|
Post n°114 pubblicato il 04 Novembre 2015 da Jiga0
Ai miei amici fiorentini di Alessandro Schwed Avevo quasi quindici anni. C'era da giorni una pioggia fine, non che fosse allarmante, perché avrebbe dovuto, ma non smetteva. Quella mattina ho l'impressione che fosse festa, ma tutti riportano che era venerdì, insomma eravamo a casa e la mia impressione è che fosse una festa. Sul presto ci telefonò un amico di mio padre, si raccomandava di stare attenti ed essere pronti a lasciare subito casa perché si era rotta la diga di Levane e sul Ponte Vecchio i gioiellieri avevano sgombrato tutte le botteghe. Mio padre era assonnato, e ridacchiò. Guardò fuori dalla porta del giardino e disse: "Grazie, ma qui da noi va tutto bene". Dopo avere riattaccato però gli venne lo scrupolo, parlò con mia madre e mi mandarono in via Gioberti in drogheria a comprare due bottiglie di acqua minerale. Via Gioberti era vicina, andai. Nel tempo di sette, otto minuti mi trovai a tornare con l'acqua alle caviglie. Era gelida. Mi parve strana, tutta quella rapidità. Non sapevamo quello che si preparava, cosa fare, se salvare qualcosa oppure non c'era bisogno. Mia madre si mise a fare la carne macinata, dopo che l'ebbe cucinata, la mise in una pentola da portare via, ma via dove? pensai. Guardavamo fuori dalla finestra. L'acqua saliva. Cominciammo a pensare a salvare un po' di cose. Io salvai i libri di Salgari, i vocabolari di italiano, quello di latino e poi quello di greco. Vale a dire che li spostai sul pianerottolo del primo piano. A un certo punto l'acqua saliva ancora più in fretta e fu deciso di lasciare la casa, di andare al terzo piano, dai vicini, e rifugiarci da loro. Venne fuori che loro, non so per quale motivo, avevano la chiave del secondo piano dove per qualche motivo i Bandini non c'erano. Entrammo e si stette lì. Passai tutto il giorno alla finestra, all'incrocio si era formata una barricata di macchine contro la quale cozzava qualche nuova auto in arrivo. Sul viale, passavano barche dei pompieri col motore fuoribordo e camion che rotolavano su se stessi come scatole di fiammiferi. Era divertente e allo stesso tempo pazzesco. Nel pomeriggio mi affacciai sullo stradino che portava al nostro garage e vidi il servizio delle nostre tazzine da caffè uscire dalle inferriate della cucina e poi andarsene in in giro come fossero delle barchette graziose. E se tutto era grazioso, non capivo come potesse essere tremendo. La notte dormimmo sopra dei materassi sistemati sul pavimento di quella casa estranea ma potentemente salvifica. Eravamo nel buio e non avevamo pensato a prendere le candele. Sentivo mia madre piangere, il babbo la consolava. Mammai aveva paura che la casa crollasse e saremmo tutti morti. Da fuori veniva uno strano risciacquo, come se abitassimo in un piccolo porto. A me veniva da ridere, ma avevo paura e la cosa migliore era che venisse giorno e quella fiaba nera finisse. Il mattino dopo alle otto, si guardò fuori: l'acqua si era ritirata. Le strade erano coperte di nafta e mota. Agli angoli c'erano auto ammonticchiate a gruppi di sette, otto. Per qualche mese fu come un dopoguerra senza guerra, l'acqua razionata, le candele, il freddo e i cappotti regalati a chi non aveva più niente, ed eravamo in tanti. Due o tre giorni dopo che l'Arno si era ritirato, ero passato con la mamma per Borgo la Croce. Su una saracinesca divelta la mano del proprietario aveva scritto a caratteri cubitali "CHIUSO PER NERVOSO".
|
|
Post n°113 pubblicato il 31 Ottobre 2015 da Jiga0
Dopo la parodia, il ritratto (l'Unità, 31-10-2015) di Alessandro Schwed Premiata dagli ascolti, arriva in Tv un nuovo modello di imitazione, vicino al ritratto. Quasi sempre lontana dalla comicità, al massimo ironica, quest’imitazione restituisce il cuore alla Tv, ed è il “Tale e quale show” di Carlo Conti. L’idea: ricostruire le vibrazioni dei cantanti, viventi o scomparsi, facendo cantare gli attori, a parte Karima, autrice di un’Aretha Franklin al tritolo. L’interpretazione prende dunque il posto della parodia, puntando più all’imitazione dei sentimenti che della voce, fino a ritrovare il cantante. A partire dal titolo, “Tale e quale show”, la promessa è la realizzazione della verità, non la caricatura. All’impresa concorrono la ripresa televisiva, la fotografia e una trasformazione delle sembianze che sta più alla fantascienza che al teatro, all’iperrealtà che alla realtà. Al di là di uno spettacolo televisivo che un tempo sarebbe stato di gusto nazionalpopolare e la cui formula – imitazioni e un conduttore - corrisponde in astratto a un programma di Baudo, le puntate scorrono su un palcoscenico e su volti che la Tv guarda da vicino. Osserviamo da casa, viso a viso con loro, le trasformazioni prodotte dalla cosmesi, lo spettacolo nello spettacolo dei falsi menti, dei nasi adunchi, e ogni particolare induce a chiedersi dove siano finiti i veri lineamenti. Poi dipende dagli attori. È il caso del De Gregori di Massimo Lopez, artista di versatilità, umiltà e un’anima non conosciute dal grande pubblico. Ricorderemo la levatura attoriale e quell’esalare la voce fine nel “generale dietro la collina”, un De Gregori visto da vicinissimo. Lo stesso per l’Edith Piaf di Giulia Luzi in "Non, je ne regrette rien". Del resto al “Tale e quale show” il solo e unico autore è l’attore. In certi casi, come per Piaf-Luzi, alla vertigine di quanto si vede e si sente, una voce bellissima in sé, si unisce la malinconia per un’epoca resa irripetibile e remota dalla canzone e da quella cantante irripetibili. Ad alimentare la tensione quasi insopportabile di troppa bellezza, si unisce il ripensare quella generazione, la gioia di Parigi libera dal nazismo, la giovinezza sfrontata - che pure ci fu. La verità è che per restituire la magia di "Non, je ne regrette rien" servono, sorpresa! grandi ritrattisti più che cantanti, uno sguardo di attrice che è la messa a fuoco di Edith Piaf e degli stracci di una povertà luminosa. Se no, la stranezza: dopo una serie di prove fiacche, un attore spicca il balzo una sola volta ed è la luce, Si parla di Walter Nudo e della sua Cher di “Strong enaugh”, esibizione al limite di un travestitismo elegante, sfiorando il cabaret berlinese degli anni Trenta. Qui Nudo si è rivelato attore fantastico, sensibile, cui sarebbero necessari un cinema e una Tv plausibili e forti proposte artistiche – che si aspetta? È incoraggiante che questo accada in televisione, luogo d'elezione dell’usa e getta. Bello, questo teatro di emozioni, nuovo e al tempo stesso primario, ne abbiamo bisogno, e dire che sembrava perduto. Per affacciarsi alla finestra umana del vero intrattenimento è necessario uccidere la falsa comicità, il vacuo, le risate preregistrate, ricostruire quello che fa battere il cuore. A proposito, c’era del buono nel vecchio varietà, saperla lunga sui sentimenti. Era il teatro popolare emigrato in Tv nella seconda parte del Novecento. Quando la gente andava a teatro a spensierarsi e a commuoversi della verità. La lunga assenza televisiva di un autentico intrattenimento è stata coperta dalla presenza della comicità senza comici e artisti, i Cochi e Renato, Villaggio, Iannacci e l’anomalia chiamata Gaber. La sola capacità è stata il cinismo, la brevità estrema, pelo sullo stomaco, il raddoppio di spazi pubblicitari - mai il cane con i capelli di Iannacci, ma risate epilettiche, malate, più per sopravvivere che per vivere. Le battute-tormentone dette per lanciare i programmi. Il successo, la sola meta. Più una forma di comunicazione pubblicitaria che di arte. E ora in tv piovono pezzi di cuore. Bene no?
|
|
Post n°112 pubblicato il 17 Ottobre 2015 da Jiga0
L'umorismo liceale (l'Unità, 17-10-2015) di Alessandro Schwed Ne hanno parlato a “Tv talk”. Crozza, re solitario della televisione satirica e parodistica, ha fatto il verso a un performer della comicità eccessiva, sovrabbondante, goliardica, Frank Matano. Vale a dire, il canone e la sbrodolatura: Crozza, elegante, attore teatrale, grande successo a La 7; Matano, scherzi basati su cose che non andrebbero fatte ma lui le inscena: linguacce, rumori corporali, salto acrobatico della sintassi. E allora vediamo come è questa maschera di Matano: morbidamente esagerato, poggiato su una sciatteria distratta, questo accento di qualche periferia campana, diseredato della grammatica e dell’educazione. In realtà, bella faccia di ragazzo del sud, elegante, capelli ricci, neri, il volto delicato attraversato dal lampo di un riso sguaiato. Frank è di Santa Maria Capua Vetere, ha ventisei anni, la prima parte della vita trascorsa in America. E dell’America in lui si rintraccia qualcosa del comedian sregolato che fu Robin Williams, di Jim Carrey, il primo Jerry Lewis. A diciotto anni, nel 2007, diventa famoso su YouTube italiano con i suoi scherzi telefonici, insistenti “persecuzioni” a gente pescata nel buio dell’anonimato. Nickname underground: lamentecontorta. Poi, per sommi capi, inviato delirante delle Iene, poi un giudice arbitrario, sia severo che buonissimo coi concorrenti di Italia’s Got Talent. Poi dei film senza esiti particolari. In un suo video su YouTube, dodici milioni e trecentomila visualizzazioni, Frank vaga in città, un elfo spilungone che si ferma ed emette brevi rumori corporali, creatura fiabesca che soffre di rapidi meteorismi che sottopone alla gente per strada, come farebbe un bambino piccolo e non consapevole di quello che sta facendo. Le vittime, gente sovrappensiero che passa, ragazze sole, anziani in panchina in mezzo ai quali lui si siede e rumoreggia appena, come se stesse sbadigliando. In comicità, l’uso dei rumori corporali è una scorciatoia. Risale alle antiche farse romane, i Fescennini che noi studiammo a scuola senza sapere che stessimo sfiorando. Con Frank l’esagerazione serve a fare una tv di piccole provocazioni assurde, una candid camera che a volte è irresistibile e a volte intollerabile. Si tratta di ridere del disagio della gente in situazioni imbarazzanti. È una scelta accidentata. In Italia, l’apice è stato con Nanni Loi. È un umorismo da progettare, ci vuole un niente a esagerare. E a Matano piace esagerare, sproloquiare in quella sua lingua tortuosa, fatta di esitazioni e incidenti pacchiani. Frank inquieta, perché inquietante è ciò che non dovrebbe apparire e invece appare. Brilla, e a un tratto stona. Fa ridere e poi cascare le braccia per mancanza di misura, le regressioni repentine nel mondo dell’adolescenza, il mancato senso delle proporzioni che coltiva con generosità. Però in Matano vive qualcosa di raro. In occasione della cinquantacinquesima edizione del Premio Regia 2015, una giuria di giornalisti e critici televisivi lo ha nominato rivelazione del 2015. Non che un premio della critica sia dirimente, ma questa popolarità di Frank a trecentosessanta gradi, sul Web, alle Iene, ospite a una prima serata di Rai 1, dice che c’è qualcosa di bello in quella musica stonata. Matano arriva. Giorni fa Frank era da Carlo Conti, faceva il giudice al “Tale e quale show”, trasmissione di Rai 1 con le imitazioni dei cantanti fatte da cantanti, comici, attori. Invece di limitarsi a giudicare i concorrenti, ma questo fa parte del gioco, Matano chiede a un’anziana signora del pubblico perché guardi di continuo un gradino. Una minuzia che Matano trasforma all’impronta in un personaggio ossessionato dal fatto di sapere le cose intime del prossimo, quelle che restano dentro. Per fare un esempio, cosa si pensi mentre noi siamo tra gli altri. Idea eccellente, risultato esilarante. Poi in giuria Gigi Proietti accenna un numero tratto dal bagaglio della commedia dell’arte, il vecchietto sdentato e senza memoria. A due metri da lui, Frank ride così forte che disturba l’audio, come succede nello schiamazzo tra amici. Ma lì siamo in diretta, è la prima serata di Rai 1. La risata rumorosa copre Proietti e tutta la bellezza di poco prima se ne va in soffitta. Matano: da irresistibile a insopportabile. Un adolescente, a ventisei anni. Alla fine del XIX secolo, Alfred Jarry, creatore teatrale del leggendario re Ubu, indicò l’irresistibile esistenza dell’umorismo liceale, fatto di mostruosità esilaranti: cose inguardabili e bellissime. Voleva svelare l’aura irregolare della giovinezza, che contiene, inestricabili tra loro, il genio e la bestialità - e a volte nuove prospettive. Sotto il video di YouTube dove Crozza fa il verso a Matano, che fa il verso a chissà chi, qualcuno ha scritto: “Frank Matano è un gigante! Ha trasformato l’età della stupidera in una professione!”. Jarry va sino in fondo, dove non siamo più abituati ad andare: “Sarete liberi di vedere in Ubu le molteplici allusioni che vorrete, o un semplice fantoccio, la deformazione creata da un liceale di uno dei suoi insegnanti, che per lui rappresentava tutto il grottesco che esistesse al mondo”. |
|
Post n°111 pubblicato il 10 Ottobre 2015 da Jiga0
Tag: alleniano, assurdo, canovaccio, clown teatrali, improvvisazione, libertà, scrittura, teatro, yiddish Zoppia e risate di Igor Vazzaz ( 09/10/2015, Lo sguardo di Arlecchino) (Ovvero quando il critico è vispo) È sbiellato, ma non ingrippa, claudicante, ma non sbanda, afflitto da sinistri scricchiolii, fiaccato da maligne sciancature: potremmo però fargliene colpa? Men che mai, naturalmente. Del resto, sin dal titolo, paradossale, umoristico, beffardo, Andrea Kaemmerle denunzia la natura precaria e malferma del suo nuovo lavoro. E poi, nuovo: delicato eufemismo che, nel teatro corrente, indica il debuttare a marzo per snocciolar qualche replica nei mesi, sino a un totale che permane sotto la doppia cifra. Va da sé che la poetica s’intrida di sghembaggini e, in tal senso, si deve riconoscere una gran maestrìa al saltimbanco riccioluto di Guascone Teatro, comico non spaventato e guerriero, da anni in trincea tra gestione e produzione. Lo accompagna, di nuovo, quel bel tomo di Riccardo Goretti (li ricordiamo nel niente male Zona torrida, testo dell’indimenticabile ma dimenticato Sannini, due stagioni orsono), fisico e ghigna da working class, tempi da clown bianco scoglionato, spalla sicura su cui poggiare un testo folle di per sé che, nella rinunzia alla tornitura, alla perfezione, al nasino all’insù del “ben fatto”, individua buona parte dei propri massicci punti di forza. La storia, del resto, è l’ennesimo parto di quel geniaccio falsario a nome Alessandro Schwed, il temibile Jiga Melik ammirato (fuori tempo massimo per colpevolissima anagrafe) sulle colonne di “Il Male”, l’importante (anzi fondamentale) rivista satirica italiana che, come “La Settimana Enigmistica”, ha vantato innumerevoli (e sempre vani) tentativi d’imitazione. Si pesca nell’ebraismo d’Oltreoceano, tra le pagine lepide di Bernard Malamud. Dimenticatevi Moni Ovadia, le lezioncine didascaliche sullo spirito yiddish: pure Schwed ne condivide il credo, ma ha uno humour ben più absurdista e, nell’intersezione con lo scrittore newyorkese, quasi alleniano. La storia, si diceva: un diavoletto in cerca di “sistemazione” (Kaemmerle) ha il compito d’indurre in tentazione e peccato l’Extravergine, vivente modello più unico che raro di probità il quale, difatti, calca il mondo una volta ogni mezzo millennio. A illustrar l’argomento è lo stesso autore della commedia, nella metafisica proiezione video che punteggerà via via il dettato, sino al lieto fine impreziosito dalla bella Agostina Cassini, strumento del diabolico (e romantico) esito da commedia. La scena ha struttura tripartita, ambientiazioni separate da pareti con porte disposte in diagonale, a mettere ulteriormente in crisi ogni principio di linearità, foss’anche visiva. Kaemmerle è ubuesco per forma, mercuriale per disposizione, uno spiritello furbetto e spaesato, col suo slavo macchiato di toscano, una lingua liquida e irresistibile; Goretti un aspirante rabbino che mai nella vita, a pochi giorni dal termine dell’apposito settennato di studi, è mai stato sfiorato da tentazioni sensuali. L’incontro tra i due è spassoso: una strana coppia che non lesina fioretto e clava, tempi comici ben oliati sulle caratteristiche di ognuno, nel naturale adattamento d’una partitura da piegare, eseguire, persino manomettere, con una certa libertà. E proprio in virtù di tale disinvoltura, limite o qualità a seconda dell’impiego, spettacoli come questo avrebbero bisogno d’agio e tournée, per rodare ancor più andamento e interpreti. La sala del Lux, gremita e stipata alla bell’e meglio, apprezza comunque e, anche in questo caso, non potremmo fargliene una colpa. Naturalmente.
|
|
Post n°110 pubblicato il 29 Settembre 2015 da Jiga0
Secondo un’interpretazione che ha fondamento solidissimo e pieno di radiosa speranza, Don Chisciotte è invincibile, un vincitore incontrastato. Il suo sogno sgangherato e il suo mondo sentimentale sono eterni, nessuno li può abbattere. Ma nel dirlo col cuore in gola, bisogna fare attenzione a non trascinarsi dentro la metafora senza scrutarla, ad affogare in una pozzanghera e diventare dei bigotti della letteratura, o delle talpe: egli è invincibile in quanto personaggio romanzesco che incarna la figura del sognatore, riscattandola dal pregiudizio quotidiano della sconfitta. È solamente così che Don Chisciotte, che nella vita sarebbe uno sconfitto - solo vedendolo da lontano sarebbe un pazzo, un altro inadeguato, un barbone col sacchetto di plastica che ciondola e grida sui marciapiedi, nessuno sa a chi, uno sconfitto senza appello, uno che si è dimenticato da solo e si dimentica a ogni istante - ebbene costui invece, nel romanzo che per titolo memorabile porta il suo nome, è un vincitore che la grande letteratura umoristica si appresta a salvare, ché l'umorismo è il racconto delle inadeguatezze supportate e sopportate con felicità. Il nostro, quanto nostro!, Don Chisciotte è il protagonista della metafora sublime che Cervantes ha scolpito nella letteratura di tutti i tempi. Altrettanto vincitori, sono i grandi sognatori raccontati dalla letteratura, appunto gli Inadeguati, gli sconfitti baldanzosi e farneticanti sorretti dalla mediazione dell’umorismo. Penso ad esempio a Oblomov, o al buon soldato Sv’eik, o anche all’infanzia a dir poco ardua di Tom Sawyer e Huckleberry Finn. Che poi Don Chisciotte è un sognatore proprio come nella vita lo sono quelli che offrono devozione, totale credito all’immaginazione: per primi gli artisti, e temporaneamente i bambini – anche loro sconfitti appena diventano adulti e cessano di giocare, e come disse Freud i bambini che non smettono di giocare, fanno gli artisti. Tra i sognatori inserisco per primi i musicisti, che neanche parlano, ma pensa un po’, emettono dei suoni senza un significato verbale preciso, suoni che attengono eventualmente a un sentimento o a un concetto, un’idea, che scrivono nel cifrario numerico del pentagramma che non ha altra traduzione che il suono stesso, una sintesi sensibile e poi però totalmente astratta. E se no ci sono gli scienziati che rincorrono la scoperta senza darsi requie, o i poeti a oltranza come Marina Cvetaeva che lavava i pavimenti per mantenersi a Parigi, sola e in miseria mentre il suo amore, il marito Sergej, era disperso in Russia, perseguitato da Stalin, internato da qualche parte. E io chiedo: fu però Marina la sognatrice, che immaginava versi inginocchiata sui pavimenti lerci di Parigi, fu questa donna una vincitrice nella vita, l’unico spazio che abbiamo a disposizione, quando dovette impiccarsi perché era stanca della sola sofferenza? È dunque possibile, se ci poniamo fuor di metafora, affermare che Don Chisciotte nei suoi duelli con i mulini a vento è un vincitore assoluto? Non credo: la fiaba non esiste solamente per intrattenere, suo compito è indurre a pensare, suo compito è svelare. Chisciotte è eroe irrealistico della letteratura fantastica, non certo un padre Sergio di Tolstoi che, per quanto romanzesco, è il ritratto al naturale di un uomo, nelle giornate un monaco, votato al sacrificio, o se visto cristianamente, al martirio. Per far trionfare il cavalleresco Don Chisciotte, o per far sopravvivere la cavalleria che moriva disprezzata e priva di realtà, fu appunto necessaria la mediazione del grande umorismo, della satira e dell'arte di Cervantes. Fu così che il cavaliere squinternato e il suo scudiero furono felici: in quanto incoscienti, impalpabili e candidi come due nuvole. Fu sublime, fu arte, ma sotto la traccia solcata a ogni rigo, fu pur sempre, e ancora è, amarezza. Questo svela facendoci ridere e sorridere generosamente, e commuovere, Don Quijote de la Mancha.
|
|
Post n°109 pubblicato il 25 Settembre 2015 da Jiga0
Tag: Carlo Magno, confini, domande, guida, la porta, montalcino, padre Sergio, risposte, romanico, Tolstoi Diario dai confini delle giornate (Huffington Post, 23-09-15) di Jiga Melik Nella Toscana del sud, a dodici chilometri da Montalcino, si trova un gioiello dell'architettura romanica, la chiesa abbaziale di Sant'Antimo. Il viaggiatore la vede apparire sul fondo di una piccola conca, una navicella appena inclinata nell'erba. La leggenda riporta che venisse fondata da Carlo Magno come ringraziamento a Dio per l'epidemia di peste scampata dal suo esercito, ma a determinarne l'esistenza furono nel 770 i longobardi, i quali progettavano di erigere nell'area un monastero benedettino. Per ammirarla quale è oggi, fu necessario arrivare al tredicesimo secolo e costruirla. Di quest'abbazia, posizionata per esaltare le energie della natura e la corsa del sole al suo interno, parla una guida che dire insolita è poco. Il libro, breve come un lampo, e bello, guida appunto il lettore alla scoperta della strada di luce tracciata dall'architetto, e poi, cosa insolitissima, alla scoperta della via invisibile posta dentro l'abbazia, che esiste se la troviamo, proprio come quando troviamo un tesoro se lo cerchiamo, altrimenti giace da qualche parte ed è come se non esistesse. Chiesa o apparizione? Il libro "Una finestra aperta, la chiesa abbaziale di sant'Antimo", è stato scritto da Jean Charles Leroy, padre priore della comunità dei premostratensi che dal 1992 vivono nel casolare apprestato come convento accanto all'abbazia, la quale fu da loro riaperta nel 1992 dopo la lunghissima chiusura avviata nel 1439 per decisione di papa Pio II. Da allora la chiesa era rimasta deserta, incontro occasionale di viaggiatori, di appassionati della bellezza e dei montalcinesi in gita come in un proprio giardino incantato, o se preferite in visita da un familiare. Il testo del padre priore è il reportage di un viaggio che inizia nell'abbazia e conduce ad una porta che si erge con evidenza invisibile a pochi passi da noi - attraversata la porta, c'è il regno. "Una finestra aperta", potrebbe essere definito un insolito testo profetico, scritto nel XXI secolo e originato dalla professione monastica di padre Jean Charles Leroy, che dalla sua vita quotidiana a Sant'Antimo enuclea la mappa delle luci che solcano le mura e accompagnano pensieri che solitamente non pensiamo. Sant'Antimo è la casa di padre Jean Charles, lui l'ha esplorata senza sosta: all'ora sesta e nona; in grandi come normali occasioni liturgiche; nel cuore della notte; in inverni rigidi; digiuno; in piedi; seduto; oscillando nella preghiera; tossendo; pronunciando un'omelia; nel gregoriano, dove i "sanctus" mimano la possibilità di volare coi nostri corpi. Dagli acquerelli accanto al testo affiorano il crocifisso di scuola senese, la trabeazione vertiginosa, i colonnati trapassati dal sole, quegli animali fiabeschi accovacciati tra i capitelli che scalpellini insigni tracciarono. E il testo è il colloquio di Padre Jean Charles col suo fedele compagno di vita, il tempo, e il dialogo con qualcuno che pare lasciarlo solo, e a un tratto viene e risponde. Il testo è lo scavo di un minatore. Il mercanteggiare abramitico di chi vuole strappare uno sconto alle peripezie nomadiche dello spirito. Quasi possiamo vedere la dislocazione di quei mercanteggiamenti e delle invocazioni. Tra le navate; proni davanti all'altare; imploranti giù nella minuscola cripta - davanti alla Resurrezione del Sodoma; gridati nella vastità del matroneo; sussurrati nel torace di Jean Charles. A scrutare il testo contro l'argento abbaziale, traspaiono microscopiche densità. Crepe sottilissime: la lotta con un'immanenza sovrumana. E a ogni rigo, il confine che a scavalcare scortica, quello tra la materia e lo spirito. Traspare il chiarore dell'intuizione che appare un giorno e si completa un altro giorno di due inverni dopo. Si vede dove trasporti l'architettura e come sia possibile approdare, nel viaggio si scivola, si cade, ci si rialza da una via che appare-scompare e non afferri mai sino in fondo: solamente durante l'intuizione. Per utilizzare il libro, vi proporrei di operare una sorta di regia sulla scrittura: prendete una matita e separate i pensieri di Jean Charles Leroy. Tracciate una barra tra i periodi, frazionate il testo. Recuperate i silenzi tra mezzo rigo e mezzo rigo, tra i giorni, le stagioni. Ricollocate la massa del silenzio nella vostra lettura; meditate al ritmo di chi ha meditato: setacciate il vostro cuore che assomiglia a quello di ognuno, e la paura è paura, la gioia gioia, così come acqua è acqua e giallo e verde sono giallo e verde. E ci rimarranno i respiri, i lamenti, le attese, le esultanze, forse risposte arrivate - e le risposte furono davvero risposte? Ci fu più delusione o più speranza? Dunque, mentre siete lì che setacciate, appare la frazione della parola divisa coi lettori. "Ma appena varcata la soglia/ ti accorgi/ che il tempo/ si è fermato/ sei entrato/ nell'eternità". Trasformate le vostre barre in giorni, ore, decenni, e vi appaiono le frazioni del tempo monastico, e forse anche le frazioni del vostro tempo. Vagliate questo tempo che scorre per tutti, e solo dopo leggete, pensando a che possa essere lasciarsi macinare dalla pretesa di conseguire Dio, come accade in Tolstoj alla vita di Padre Sergio: "Appena varcata la soglia/ ti accorgi/ che il tempo/ si è fermato". Guardiamo dunque la prima stazione: "Appena varcata la soglia", il ricordo di un lontano ieri, quando spinto dalla scelta di lasciare il mondo, tu padre priore arrivasti sulla soglia della chiesa e apparve tutta la vita nuova; allora, nel ricordo, nel varcare la soglia un'altra prima volta, viaggiando nel tempo, senti solamente adesso che in quell'ora stavi entrando in un'altra vita, imponderabile. Dopo "Appena varcata la soglia", seconda stazione del testo: "ti accorgi". Che succede quando si capisce tutto?
|
|
Post n°108 pubblicato il 16 Settembre 2015 da Jiga0
Avere tutto di Alessandro Schwed (l'Unità, 16 settembre 2015) Las Vegas, capitale del gioco. È qui che si comprano e vendono oggetti di ogni dimensione ed epoca ogni giorno: in un gigantesco negozio, pronipote dell’antico banco dei pegni, il Pawn Stars, regno delle collezioni. Tre generazioni di Harrison: il vecchio, che a quanto pare è il Vecchio; poi suo figlio, che ha tutte le responsabilità, eppure è detto la Volpe; e il giovane nipote, lo Smilzo, che smilzo non è, ma figlio e nipote. La gente entra qui dentro per vendere un cappello alla David Crokett, dei calzoni usati da John Wayne o un carretto per gli hot dog. Di solito fai il tifo per la gente che entra, ma a volte gli Harrison sono così simpatici che tifi per loro. Il negozio è un corridoio infinito di vetrine stracolme di oggetti. Sembra la collezione di un mostro onnipotente: archibugi, antichi frigoriferi, idranti, collane d’oro, la prima edizione americana di “Ventimila leghe sotto i mari”. L’eccentrico commerciabile. Una rarissima bottiglia di birra, una Buick station vagon celeste e bianca del 1956, i suoi paraurti sono ancora lucenti. È qui che trasporta da anni la Tv, ora con Cielo, ad “Affari di famiglia”, dal lunedì al venerdì alle 20.10. Alla direzione del negozio, con gli Harrison, c’è anche un ragazzo, l’aria di uno capitato per caso: tra il commesso e uno scugnizzo infastidito dalle regole. È Chumlee, compagno di scuola dello Smilzo. L’hanno tirato su e gli vogliono bene. Poi trenta commessi e gli uffici per firmare i documenti. Qui, entrano tipi qualsiasi, star, casalinghe, gente rovinata mezz’ora prima al tavolo verde. Nessuno si scandalizza. Il Vecchio è un bucaniere sornione. Scortica il figlio, il nipote e Chumlee con battute al vetriolo. Ne ha viste. Ricorda Walter Matthau nei film di Billy Wilder. Ogni tanto il figlio lo ammorbidisce regalandogli una Chevrolet restaurata. Perchè la Volpe, poveretto, è tra due fuochi: il Vecchio, pronto a segare ogni affare che non sia un guadagno crudo, e gli azzardi dello Smilzo (100.000 follower su Twitter), alla caccia ad esempio di una partita di centinaia di scarpe da ginnastica di gran marca, vendute le quali tra due tre anni, secondo lui, ci sarà un guadagno di duecentomila dollari. Chumlee osserva, sconcertato che la vita non passi i soldi automaticamente e lui debba lavorare. La Volpe intanto manda avanti la baracca: compra, insegna ai ragazzi e sa la storia degli Stati Uniti: il cinema americano, la musica americana, la storia delle auto americane e delle armi americane. Ma anche delle chitarre elettriche e delle monete. Gli spiace dire no a chi entra per vendere, ma lo dice anche se con la faccia contratta: no. Conserva in sé qualcosa della giovinezza e in una puntata suona, male, la chitarra elettrica col cantante degli Who. Spiega gli oggetti, lo fa per i telespettatori, ed è difficile non notare il tempo breve della storia americana. Quanto per noi comincia con Achille e Patroclo dipinti su un’anfora di tremila anni, a Las Vegas inizia col primo modello di pistola a tamburo, ottomila dollari se la canna non è rovinata. Ma ci sono parametri diversi anche tra gli Harrison. Magari per il Vecchio il vertice è la battaglia di Alamo, 1836, contro i messicani, per lo Smilzo uno skateboard degli anni ‘90. Per lui ciò che è, o è stato trendy, zainetti, una scatola di wafer, vale come uno scudo della battaglia delle Termopili. La sola asprezza è quella sui margini di guadagno, una dialettica civile ma cruda. La gente reagisce elastica. Chi entra qua dentro, fa il suo gioco senza problemi. “Questo antichissimo calamaio è del 1941. Era del nonno e ha un enorme valore affettivo. Lo vendo solo per regalare una vacanza a mia moglie”. “A quanto lo vuoi vendere?”. “7000 dollari”. “Capisco, ma è sbrecciato. Ti posso dare 700 dollari”. “Va bene”. Nei casi difficili, arrivano gli esperti: periti di pittura cubista, di napalm, di bottiglie di bibite. A stabilire se una giacca era o no di Nixon come attesta la foto in bianco e nero allegata alla giacca, e sul mercato valga i 15.000 dollari di chi colleziona i vestiti dell’ex presidente. Una cravatta di prima dell’impeachment può valere una fortuna.
|
|
Post n°107 pubblicato il 27 Agosto 2015 da Jiga0
Un fantasma si aggira per viale Mazzini (L’Unità, domenica 23 agosto 2015) di Alessandro Schwed Sono molte estati che alle venti e trenta, appena sfuma la sigla di coda del Tg 1, nelle case sferraglia per decine di minuti il fantasma dei magazzini Rai. Trascina lunghe catene di scenette arrugginite, un vampiro digitale che gozzoviglia coi resti dei comici del secondo dopoguerra e le corde vocali dei cantanti sanremesi in fila. Prima, il mostro della sera si faceva chiamare Da da da, poi venne la grande non-idea della Rai: riciclare. Nacque, per così dire, Supervarietà, che assieme a Da da da è una coppia di titoli shakespeariani, se messi a confronto con quello attuale, Teche teche te. Tre programmi identici in un decennio. Più che una trasmissione sul passato, un programma in bianco e neuro. Uno stalker quotidiano,e mentre è buio, che i telespettatori stremati non hanno la forza di denunciare al numero arancione dei telespettatori perseguitati. Basta. Sì, basta con la comicità di prima o poco prima, basta con le canzoni che furono. Il canone per Sordi e Villa lo hanno pagato i nostri avi, è assurdo pagarlo anche noi. Ma siamo lì in poltrona, affranti dalla fine del mondo che non arriva, il freddo e il caldo che si alternano ogni venti minuti. Siamo qui su Teche teche te perché il cane ha addentato il telecomando. Sono le venti e trentuno e la tivvù mi spappola in faccia cinquanta minuti di passato (di tivvù), con rade pause pubblicitarie. Ah quanto manca la pubblicità, quando c’è Teche teche te. Del resto, sono pochi i dentifrici e sciampo disposti a comprare uno spazio dove si vedono solo artisti defunti. Ormai i telespettatori dovrebbero sapere di questo scempio serale, ma ci ricascano ogni sera: per forza, chi se ne ricorda della sbobba. Non è che tutte le sere un poveretto può ricordarsi il palinsesto e alle venti e trenta invece di guardare la Rai si affaccia alla finestra perché se vede un gatto azzoppato è già più allegro di Teche teche te. E così ogni sera ricorre il due novembre. Dovrebbero esorcizzare gli autori. O tentare lo scongiuro pubblico e chiamare la trasmissione teche tiè. Basta con questo continuo varietà e con le canzoni di mezzo secolo fa: se Little Tony e Walter Chari sembrano stanchi morti, il motivo c’è. Bramieri appare dimagritissimo in bianco e nero, con il corpo di un’acciuga limata. Quando racconta una barzelletta, ripensi che fu costretto a lasciare il suo incarnato florido e dimagrire, non ridi. E c’è la Pavone col Geghegè: tutte le sere “abbiamo un riff che fa così”; il Tuca Tuca con la Carrà in pantaloni a campana e Sordi che ridice: spaghetti mi avete provocato e io ve magno. Raimondo Vianello fa un allampanato ballerino spagnolo. Monica Vitti ricanta “Dove vai se la banana non ce l’hai” e non la rivediamo mai nella Notte di Antonioni. Innumerevoli i Walter Chiari e gli Aldo Fabrizi, la Bertè giovanissima, il trio Marchesini, Solenghi e Lopez nei loro Promessi Sposi. Tutti così timbrati dentro di noi che non serve ritrasmetterli. Lasciateci la libertà di ricordarli quando capitano nel nostro petto. La parte allegra è la prima interruzione pubblicitaria. Sono passati tre minuti dall’inizio è il pubblico è sfinito. Quando finisce il castigo, si domandano a casa. Bisogna capirli: hanno appena visto Claudio Villa che imita i Rokes con un casco da motociclista e la gente teme l’arrivo di una razza di alieni che si nutre di segatura. A proposito di segatura, pare che il titolo Teche teche te sia nato durante un brain storming tra dirigenti Rai ubriachi di gazzosa. Ma come direbbe il dottor Freud, la scena madre di teche teche te si annida nella profondità, nel cuore delle cantine di viale Mazzini. Qui, fino dalla fondazione dell’azienda, vive un funzionario senza giorno né notte che dorme con la testa sopra un cuscino imbottito delle barzellette di Carlo Dapporto. La sua vita si accende quando gli uscieri aprono la finestrella del seminterrato e finalmente ha un sentore di tubi di scappamento. La verità dolce è che teche teche te è venuto fuori perché è uno di quei gridolini che fanno sorridere i neonati; la verità feroce è che teche teche te è il suono di chi batte i denti dalla paura; la verità tiranna è che teche teche te è un gioco di parole nato dalla parola “teche”, i magazzini dove la Rai conserva tutto quello che ha mandato in onda dal 1954: telegiornali, varietà, sceneggiati. Non vi inganni il suono gentile del titolo, quel teche teche te. Dietro non c’è un mondo mite, ma centinaia di artisti trasmessi e ritrasmessi perché sono morti e non possono protestare. Prima di quella che potremmo chiamare trasmissione se non fosse un potage di sonnambulismo, la cosa positiva. La vista di Giorgino, lo speakerino azzimato del Tg1. Quando finisce il notiziario, dopo avere detto per mezzora Merkel e presidente di regione, mormora come una ninna nanna: “E ora vi lascio al teche teche te”. Come vezzeggiasse milioni di neonati: "E ora vi saluto col mimmi mimmi".
|
|
Post n°106 pubblicato il 16 Agosto 2015 da Jiga0
Il segreto della rilettura (Huffington Post, 12 agosto 2015) di Alessandro Schwed Avevo nove anni, era estate, la scuola finita. Fino ad allora avevo letto Topolino, Cucciolo e Geppo, che era il fumetto di un diavolo bonario in mutande. Cercavo un modo di passare il tempo e giravo per casa con le mani in tasca. Mi trovai davanti le ante di vetro della libreria, sopra il vetro c'erano, non per caso, velieri e sirene. Trovai dei titoli irresistibili: "Alla conquista di un impero", "Le due tigri", "Il re del mare", "I misteri della jungla nera". Tra le pagine neanche il disegno di una fata, ma soldati inglesi in divisa coloniale e pirati che saltavano sopra un brigantino nemico: un cinema di carta. I libri rimandavano a un mondo di prima, un'etichetta portava la scritta Lire 7. I dialoghi non lasciavano dubbi: "Corpo di mille spingarde!", "Attento, un pitone!". Non erano noiosi libri da adulti: non polizieschi, non pedanti storie di amore, non chirurghi tra i minatori di cittadine sperdute, con le donne a casa ad aspettare davanti al paiolo. Ma avventure! Le pagine erano color avana. Avevano un odore dolciastro, il dorso dondolava sbilenco. Aspettavano il lettore per lanciarlo in un mare che si chiamava Giallo, tra la Malesia, il Borneo e le osterie cinesi di Macao dove mangiavano il cane arrosto e anche il babbuino. Lo scrittore era Emilio Salgari. Mi domandavo coma mai nessuno a casa me ne avesse parlato: eppure quei libri erano una presenza molteplice tra gli scaffali del salotto. Ma erano nascosti tra gli altri, dimenticati, forse come avviene con l'adolescenza. Con la scoperta del ciclo salgariano della Jungla Nera, io diventai un lettore. Di colpo fui un viaggiatore tra i luoghi di questo Yanez e di quel Sandokan: i pirati della Malesia. La jungla e i tagliatori di teste correvano da me come quando fischi a un cane e lui corre da te. Prima di leggere un'avventura però, c'era la caccia ai libri di Salgari: i suoi volumi bisognava scovarli. Non era difficile: mentre gli altri romanzi, i Normali, erano senza odore, l'odore della carta salgariana era dolce. Fiutarla, mi faceva capire che dietro una fila di libri c'era un Sandokan. Insomma, il primo romanzo della mia vita fu Il re del mare, di Emilio Salgari. La copertina era la minuziosa illustrazione di un incrociatore da guerra inglese, nave immane in mezzo al mare immane. Le torrette semoventi dei cannoni, di un arancione tenue. Non avevo mai visto disegni di navi da guerra. Iniziai a leggere. L'incrociatore cadeva nelle mani dei pirati malesi nonostante i loro piccoli vascelli leggeri, i prahos. Presi atto di cosa fosse leggere: emigrare in un altro mondo e viverci da padrone. Mi chiesi dove avessi vissuto fino allora: in casa c'era un tesoro immenso. Così, presi a fare il lettore. Tra Sandokan e Yanez, preferivo di mezza tacca Yanez che sparava scherzando con gli amici e così quando moriva un nemico, potevo ridere. E poi, la mia concentrazione era inossidabile: me ne stavo riverso, o appollaiato su una sedia, o arrotolato nel letto, o inginocchiato sul pavimento, o in piedi contro uno stipite. Veleggiava la voce di mia madre, squillava "a tavola" e non sapevo se fosse ora di pranzo o cena. Per anni, il caposaldo della vita fu il ciclo dei Pirati della Malesia. Era inesauribile, ogni volta che ne finivo uno, pensavo: oddio, è l'ultimo. Ma quando andavo a raspare meticolosamente tra gli scaffali, c'era sempre un altro Salgari. Poteva anche essere stato scritto da un figlio di Emilio, magari da un suo epigono, con Salgari succede, e la scrittura essere meno forte, ma c'erano i nomi di "famiglia": Sambigliong, la Tigre della Malesia, Marianna di Labuan, Tremal Naik e Kammamuri, la tigre Dharma. Dopo che li avevo letti, li rileggevo. Questo rileggere avvenne molte volte, un numero di volte che non saprei, innumerevole, e rileggendo, la mia gioia non aveva fine. Al vertice delle riletture c'era Addio Mompracem, che finisce con l'esplosione del mitico isolotto: il covo della Tigre. In modo non dichiarato, quella era la tomba di Sandokan e io non potevo crederci. Alla ricerca di una conferma della morte, rileggevo l'intero ciclo, e ogni volta, giunto ad Addio Mompracem e all'ultima, per quanto nota, pagina quando il pirata salta in aria sotto il fuoco inglese, io piangevo, per quanto insieme a Yanez. In seguito, tra gli scaffali di casa scoprii la serie umoristica del maggiordomo Jeeves e il suo padrone Berto Wooster, opera magistrale di P.G. Wodehouse. Poi le opere di Jules Verne, la cui Isola misteriosa lessi e rilessi senza sosta. Come, ci mancherebbe, accadde anche per Robinson Crusoe. Poi iniziai ad andare a frugare negli scaffali della città. Ero un lettore adulto.
|
|
Post n°105 pubblicato il 15 Gennaio 2015 da Jiga0
È chiaro che tutte le vittime di Parigi hanno diritto a un memoriale. Ma bisogna comprendere che i morti di Charlie Hebdo sono simbolo universale, per laici, come per cristiani, ebrei e la gran parte dell’Islam che vive con noi in Europa, in silenzio ma con aspirazioni. Il nome Charlie è il tetto della libertà che ci pone al riparo e che nessuno deve demolire. Questo fatto poteva essere ignorato, invece no, è assunto nel cuore e ha fatto marciare due milioni di persone con alla testa la classe dirigente dell’Europa e di parte del mondo non occidentale. Il fatto è che i morti a causa dei quali tutti proclamano “Io sono Charlie”, non sono vittime ignare, ma testimoni consapevoli. Combattenti in nome della libertà di non sottostare ad editti, a nessuna forza irrazionale. Si richiamavano alla data del 1789, l’anno in cui si è cessato di pensare come normale che il re fosse di origina divina e divini e insindacabili i suoi giudizi. Da quel 1789 per l’appunto parigino fabbrichiamo da soli giudizi e aspirazioni, lo facciamo nei nostri parlamenti, nelle nostre scuole, nei nostri libri e nelle nostre biblioteche. C’è dunque nello stracuore dell'Occidente la redazione di un piccolo giornale, libertario, anomalo, acuto, provocatorio, discusso e fatto per discutere. Si chiama Charlie Ebdo, ci lavorano artisti-giornalisti. È
(Jiga Melik)
|
|
Post n°104 pubblicato il 10 Gennaio 2015 da Jiga0
Scarpe bucate (8 gennaio, Il secolo xix / Huffington Post) di Alessandro Schwed (Jiga Melik) Le scarpe della Satira sono scomode, bucate e strabucate: ad andarci in giro fanno male. Bisogna avere qualcosa da dire per metterle ai piedi. I ragazzacci con la matita morti ieri erano gli ultimi con le scarpe rotte decisi a camminare lo stesso. Del resto, parafrasando il poeta Verlaine: la Satira è un brivido, il resto è intrattenimento. Ma era una giusta sfida creare vignette su un mondo ferale? Che dire: la Satira è un vizio strepitoso, un irrinunciabile condimento. Cabut, 77 anni, Charb, 47 anni, Wolinski, 80 anni, Tignous, 58 anni, loro e altri redattori lavoravano a Charlie Hebdo, se vogliamo limitarci a chiamare lavoro quella cosa meravigliosa che è irridere il potere. Wolinski, gli altri, erano monelli attempati. Ragazzi permanenti avvezzi ad architettare pernacchi, a togliere peso a qualsiasi peso, a non tollerare lacci, maschere, veli, chiese e minareti - la satira non conosce limiti. È la bellezza sfrontata di un mestiere non augurabile. E così ieri mattina, mentre in una stanza di Parigi i ragazzacci con la matita sono lì che disegnano caricature e congegnano motti di spirito come in un romanzo di Balzac, due tizi entrano col volto coperto e li ammazzano. Poi scendono di corsa le scale e giunti per strada finiscono con il kalasnikov un uomo moribondo. Ciò, intorno al Palazzo dei Monelli. Sono queste le scarpe della Satira. Un coltivato, educatissimo senso di irresponsabilità, una tagliente eleganza, l’essere sia consumati che limpidi, fuori mercato e fuori registro - non lo sapevate? Chi fa satira incontra sbarramenti, le frasi sibilline di chi comanda e di chi serve. L’arte della satira, in Italia da tempo sconosciuta, vuole grande tempra e grande leggerezza. Fare abitudine al pericolo, ai nemici sparsi, ai giochi di parole, ai difetti da raccontare, alle intimidazioni, a un presidente che non gradisce una copertina e lo fa sapere in un ufficio, dal sibilo di un funzionario. Il satirico deve essere pronto a scavalcare le diverse ere di poteri diversi e tutti implacabili, e intanto illustrare la stupidità, la menzogna, il cinismo, coglierli in tutta la fragrante debolezza e marciume. La satira non è mica quel semolino a cui ci ha abituato la Tv, le risate finte preregistrate che indicano il binario dove ridere, le parodie che finiscono a tarallucci e vino. E adesso vi prego, non vantiamo come nostra un’arte che nel nostro paese è obsoleta per quanto di origine latina: la Satira è un taglio che ridendo ti apre in due. Può benissimo non divertire, può raggelare, può commuovere, far ridere sino alle lacrime. Ho lavorato negli anni Settanta all’ultimo giornale satirico italiano, il Male. Avevamo rapporti con i fogli satirici francesi, Charlie Ebdo, il Canard, Harakiri. Alcuni degli artisti morti ieri mandavano disegni, venivano a trovarci. Abbiamo riso insieme, ci siamo guardati negli occhi, ragazzacci con ragazzacci. Vi vedo sdraiati in una pozza di sangue, e un poco piango e un poco sorrido di un vecchio scherzo. Scarpe rotte, eppur bisogna andar.
|
|
Post n°103 pubblicato il 14 Novembre 2014 da Jiga0
Un libro realmagico (Elisa Manieri, Montalcino News) Lo abbiamo letto quando ancora non viveva a Montalcino, lo abbiamo incontrato, conosciuto per le strade della città del Brunello, poi, nella primavera del 2014, lo abbiamo ascoltato, era la voce narrante del “docu-film “C’era una volta Montalcino”, il lavoro realizzato dalla Montalcinonews e da lui, che ne è stato autore della sceneggiatura (un lavoro realizzato grazie al Lions Club La Fortezza). È Alessandro Schwed, fiorentino, ma genovese da parte materna e ungherese da parte paterna, tra i protagonisti negli anni Settanta, con lo pseudonimo di Jiga Melik, all’esperienza della celebre rivista satirica “Il Male”, che, oggi, torna a scrivere di Montalcino. Stavolta lo fa con lo strumento del libro, un prodotto reso possibile col patrocinio del Comune di Montalcino e il contributo di cinque cittadini che vogliono rimanere anonimi e, allora, ne pubblichiamo solo i nomi: Andrea, Carolina, Marino, Stella e Stefano. Si intitola “Montalcino di sorpresa. Un paese, tutto il mondo”, il nuovo libro di Alessandro Schwed, un volume che non è un volume ma “una specie di mappa sentimentale, la guida reale e magica di Montalcino”, come spiega Schwed, che vive a Montalcino non da ieri, ma da venticinque anni. Facendo cosa? “Scrivo romanzi, e intanto che lavoro ai romanzi, le giornate rimangono giornate, e così faccio la spesa, passo da vicoli, salite e discese, compro il pane, risme di carta da Alessio ed Elisabetta, vado al mercato e parlo con Gilberto del Vivo d’Orcia mentre vende i pantaloni. Poi passeggio con Hicks, il mio cane, e salutiamo il cane Zorro, oppure andiamo al bosco, dopo le Fonti … io guardo, sento, e nascono racconti di fatti che ci sono e di fatti che non ci sono, realtà e magia nate da una reciproca frequentazione. Io che frequento Montalcino e Montalcino che frequenta me”. |
|
Post n°102 pubblicato il 07 Settembre 2014 da Jiga0
La Mercanzia dell'Arte per strade color vinaccia (Huffington Post, 02-09-2014) Un tardo pomeriggio della metà di luglio, la luce sbiadisce la terra. Vado a"Mercantia" (la ti è zeta latina), al festival internazionale del teatro di strada, di scena a Certaldo da venticinque anni. È la fine di una giornata afosa e ho pena per quel poveraccio del motore, accovacciato sotto al cofano. Al cartello "Certaldo", lascio la striscia opaca della statale. C'è un cavalcavia, c'è una periferia qualunque, e ho l'incertezza che quello sia veramente Certaldo. La vista del borgo in alto è orbata da strade strette, dalle case in fila, marciapiedi e automobili. Non fosse per i cartelli incontrati, Pogna, Semifonte, San Miniato, a evocare le battaglie che Firenze e Siena hanno vinto e perso al tavolo della Storia; che ho visto eserciti di ulivi, non saprei di essere a casa di Boccaccio. Sento due ciclisti scherzare e mi domando come faccia la lingua toscana a resistere a quel cavalcavia, alla matassa delle vie da cui non si riesce a vedere la Storia e neanche la natura. Ma la lingua rimane, nitida. Viene in mente un controllore senese che dopo aver parlato della Fiorentina e del suo Siena, indicandomi dal finestrino del treno un poggio con un albero, mi disse, grave: "...Noi e voi s'era costì". Intendendo con "noi" le schiere ghibelline senesi, e di conseguenza lui; con "voi" le milizie guelfe di Firenze e me, degli sconfitti; con "s'era" l'anno 1260 e con "costì" Montaperti, il luogo del loro trionfo. In sintesi, io ero un viaggiatore di una genia di sconfitti e lui un vincitore che verificava la validità del mio biglietto. Lascio l'auto nei pressi di una palazzina circondata da camper. Girano ragazzi coi capelli lunghi, i pantaloni corti pieni di tasche e le chitarre acustiche - sono gli artisti di strada in arrivo alla festa di Mercantia. Un cartello dice "Centro" e prendo una viuzza percorsa da autobus dell'azienda certaldese di trasporti. Avvisto un vigile, stivali d'ordinanza e camicia inspiegabilmente asciutta. Cammina così lento che riesce a scrivere sul suo blocchetto. Gli chiedo per la festa. Spiega che è in cima al paese, ma c'è la funicolare. La fermata è a cento metri, in una piazza piena di bancarelle. La funicolare è un negozio con la saracinesca tirata su. C'è un cubo che sale, dopo non pochissimo scende e smaltisce i viaggiatori in attesa. Nel cubo stiamo in sedici, cinque seduti. Io mi tengo a un palo. Sono le otto di sera, il caldo è un mantello colloso. Le corde tirano lente. Il paese antico è su, quello nuovo giù e in mezzo c'è una scesa con una terra scorbutica, rigata dalla cicatrice della funicolare. Uno scatto sordo. La porta della funicolare è spalancata, sono arrivato, c'è la brezza. Le vie del borgo sono di mattone rosso vinaccia e vinaccia i palazzi. Per strada, banchi di artigiani vendono maschere, monili, scialli. Il corso è ancora vuoto come quando si arriva a una festa prima che sia cominciata. Inizia il tramonto e via Boccaccio è color rubino. In alto la vita è bella. In una piazzola obliqua, un clown inglese grida "come on" ai primi bambini. Un prete induista con gli occhialini tondi ridacchia col barman che gli serve la birra. Il prete induista somiglia a Marco Mazzocchi di Rai Sport e parla un dialetto del Lazio. Non la conta giusta. La via dritta e lunga, patrizia e rossa, mi attrae come un magnete. Dai palazzi insigni, le corti spalancate illustrano pozzi, giardini, la ghiaia pettinata e file di sedie bianche in attesa dello spettacolo. In fondo alla vinaccia di via Boccaccio, dopo le gradinate monumentali, Palazzo Pretorio si alza come un tempio. Fu il simbolo dell'immenso potere di Firenze, ma anche se a ogni passo c'è la Storia, incrocio un frate con appeso al petto il cartello "Fra Cipolla". Ha il naso ritoccato di rosso come se fosse paonazzo: non è un frate ubriaco, è un figurante e si fa fotografare con due turisti anziani che ridono. Le nove, il giorno resiste, ma c'è un trillo di archi. Sul corso avanza una fila ondeggiante di violini e violoncelli, la ragazza in fondo batte su un tamburo. È una piccola orchestra, quasi solo donne. Forse musica irlandese, o scozzese, e poi spunta una malinconia il cui padre potrebbe essere Antonio Vivaldi, dalle "Stravaganze". Sono frastornato dall'assalto della bellezza, e sono incerto su cosa sia più bello: se la musica; Certaldo dalle vie e dalle mura di un rosso vinaccia mai visto sulle pietre; se la scoperta di Certaldo nel fresco di una sera d'estate; se la musica al tramonto tra muri color vinaccia; se sia bella questa vinaccia contro l'aria cilestrina che non vuole abbuiarsi, e Certaldo irretita dalla musica. E poi vorrei sapere se siano le strade ad abbracciare la musica, o la musica a cingere teneramente i giardini e i pozzi che spuntano dalle corti e a far splendere le entrate dei bar con le pile di schiacciate sui vassoi. Caro me stesso, ti scrivo: è inutile cercare la bellezza, bisogna farsi trovare da lei. Una piccola folla attornia le violiniste in marcia, e già la folla è attorniata dalle violiniste. Sono in piedi in mezzo alla muraglia delle macchine fotografiche, dietro gli obiettivi i fotografi scattano foto e aprono il sorriso al piacere di fotografare lo spirito del teatro. Vorrei sapere come farò domani nella vita normale, senza il teatro dappertutto. Ai bordi del muro umano che circonda i suonatori, c'è uno dai modi di ragazzo, però è attempato. La sua camicia bianca si gonfia per un colpo di vento, gesticola con la gioia spavalda di un ubriaco. Fa un cenno tagliente alla prima violinista, una zampata nell'aria. Lei, in spalla uno zaino tecnologico con l'antenna, guida gli archi nella direzione indicata dall'uomo con la camicia bianca piena di vento. Un passante pazzo, un fattucchiero, un demone euforico, un mitomane, un'apparizione irreale, un'icona dell'imprevisto. Dopodiché l'uomo con la camicia di vento si dilegua. Vado dietro ai violini e transitiamo accanto alla chiesa dove riposa Giovanni Boccaccio, con questo casino stasera è sveglio e le spoglie degli antichi certaldesi battono le ossa a tempo - clicchete e clacchete. La luce dei fari avvampa, è arrivata la notte e la folla esorbita oltre i tetti. Sulle gradinate architettate da secoli in fondo alla via, c'è l'uomo-orchestra napoletano che canta Carosone con sobria eleganza. Col tacco della scarpa scalcia su un tamburo. Mentre la folla si abbatte sulle case come una mareggiata, di fronte al bar Chichibio c'è una donna anziana con la carriola. Un cartello annuncia che è la Venditrice di Briciole e che vende pane e sogni. Alla curva di via Rivellino, la strada più antica di Certaldo, ci sono bancarelle cosparse di cappelli di paglia, e poi due uomini vestiti di rosso, uno alto e uno basso, che cantano con la chitarra, rochi, allegri e lombardi. Uno si presenta, è Casimiro, ma non ricordo se quello alto o quello basso. Ciao Casimiro, sono uno che passava e si è addossato al muro di fronte per guardarvi. La gente applaude, quello basso ringrazia il pubblico con il pupazzo di un omino che esce dalla cima del borsalino e fa un inchino - gli artisti hanno cuori giganteschi, fanno regali a ogni passo. In un chiostro ristagnano un'arpa e un canto di donna, ma confina col Giardino delle Suore dove la platea ride furiosa. Sul palco tre donne-clown: Le Galline. Un borioso Clown Bianco tenta inutilmente di dirigere gli Augusti uno e due, cioè il tonto e il pazzoide. Il Clown Bianco tiene un salvagente dietro la schiena e spiega agli Augusti la meccanica semplicissima della scenetta: reciterà di essere la proprietaria di un negozio di articoli marinari che deve vendere loro un salvagente, e loro dovranno fare le clienti che entrano per la prima volta in un negozio di articoli marinari. O cominciamo! Ma la scenetta non parte. I tonti uno e due sono immobili: non vedono nessun negozio. La ciambella da vendere, pronta dietro la schiena, immobile perché la scena non inizia, il clown bianco gorgoglia di spicciarsi con una estemporanea serie di voci tra Tina Pica, Vittorio De Sica e uno scoppiettante Picchiarello. Dalla platea, si alzano le risate piccole, quelle grandi e la donna che non riesce a smettere di ridere. In cielo passa una mongolfiera fiammeggiante. La platea e le attrici alzano la testa, e la risata del pubblico e le battute sulla scena implodono, passando dal riso allo stupore impietrito. Questa bellezza non la potrò ritrovare. Solo un grande teatro può inscenare il mondo in una notte per strada. Ne parlo con Alessandro Gigli, l'uomo con la camicia bianca gonfiata dal vento, è l'inventore di Mercantia, burattinaio e scrittore di fiabe. Dice che questo teatro è di strada nel senso che prevede di apparire a un tratto per via, sotto un arco, in cielo con un pallone infuocato. Non serve un direttore artistico, neanche un regista, ma un ministro del culto teatrale che faccia apparire gli avvenimenti. Ogni anno, lui veglia per un anno sulle braci di Mercantia, allora l'anno dopo nelle strade di Certaldo divampa il teatro - un'orazione da elevare, una domanda di sublime. In una recente edizione, un pubblico di sette persone scendeva in una cantina sprofondata sotto Palazzo Pretorio, nel gelo dell'umidità. Avvolta nei playd, la gente calava nel buio infame. In fondo, aspettava un cubicolo. Un tempo là sotto c'era una prigione con rinchiusa una donna, adesso un'attrice detenuta negli inferi del teatro. Il pubblico aveva piccolissime lampadine e le puntava sull'attrice che faceva la prigioniera, ma il pubblico era a sua volta prigioniero di buio e freddo. Un'altra notte la folla giocava con un grande pallone bianco, arrivato per strada in modo inspiegabile, cioè teatrale. Era una sfera leggera, ogni volta calciata in alto in una gara generale ad arrivare più in alto ancora. A un certo punto, la sfera oltrepassa i merli di un antico palazzo e scompare dall'altra parte del muro. E dall'altra parte, nella corte del palazzo, sopra un palco c'è un giocoliere che sta lanciando nell'aria tre palline bianche, le riprende e le rilancia. Poi ferma la girandola per ricevere l'applauso. Ma il pubblico non applaude, ha alzato la testa e guarda le stelle. Dal cielo scende lentamente una palla bianca, molto più grande delle tre palline di prima. La gente sospira: "Oooooooooh". La palla bianca lanciata dall'altra parte del muro che adesso arriva tra le mani del giocoliere, per il pubblico è la quarta pallina bianca, diventata grandissima. A cena incontro Jorg, del duo di clown tedeschi, gli Shabernack. Con l'altro clown, Angelika, e la figlia Sara, Jorg abita da trentanni a Monte Laterone, sull'Amiata. Vivono "col cappello" - vivere col cappello significa tendere la mano per ricevere l'antica paga stradale degli artisti. Shabernack è un'espressione yiddish, significa scherzo benevolo. Alla lettera, alzare il cappello dalla fronte e farlo scivolare fino alla nuca: a quel punto si può affrontare tutto. Jorg, volto regolare, i capelli bianchi sulle spalle, si accoccola vicino a me come un bambino e sussurra che nella loro vita da clown non c'è mai stata la paura. Ora ascoltami bene, Dio delle mura di Certaldo, degli acrobati, del Clown Bianco, degli Augusti Uno e Due e delle vecchie ossa certaldesi che clicchete clacchete ballano nella tomba di Boccaccio: ci faresti una cortesia? Benedici l'uomo dalla camicia bianca gonfia di vento, e conservagli l'ubriacatura. |

CAN EXPRESS - VOLUME SCANDALISTICO PER CANI



CERCA IN QUESTO BLOG
IL FRIGO GIA' PIENO
CHI PUÒ SCRIVERE SUL BLOG
I messaggi e i commenti sono moderati dall'autore del blog, verranno verificati e pubblicati a sua discrezione.
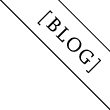



Inviato da: Jiga0
il 20/03/2012 alle 21:32
Inviato da: Jiga0
il 20/03/2012 alle 21:26
Inviato da: Jiga0
il 20/03/2012 alle 21:17
Inviato da: Jiga0
il 08/07/2011 alle 13:51
Inviato da: sergio
il 07/07/2011 alle 14:20