il segnalibro, o il sognalibro
Monsieur Flaubert, vi siete illuso
di poter compilare un elenco
esaustivo dell’idiozia umana!
Il segnalibro
Fuori, dal profondo
Come uno schiaffo inaspettato, il vento scagliò in aria le sedie e gli
ombrelloni che poco prima si trovavano disposti in file ordinate sul
prato, sputando raffiche di gocce dalle creste delle onde prima
che queste ultime, come arieti, si schiantassero sugli scogli con
fragore. Qualche bambino si mise a piagnucolare, subito
rassicurato dalla mamma, alcuni raccolsero in fretta e furia vestiti e
oggetti, altri si affannarono a chiudere gli ombrelloni rimasti in piedi.
Solo un uomo era rimasto seduto, quasi immobile. A parte i capelli,
che erano scompigliati come il mare, sembrava non essere
turbato da quella situazione, quasi non si fosse accorto di nulla. Aveva
continuato a leggere un libro dalla copertina azzurra fino a quando il
segnalibro era volato verso il mare.
Quel capriccio estivo che aveva bruscamente fatto virare, nel giro di
poco più di mezz’ora, un assolato mattino di metà luglio in un
burrascoso paesaggio autunnale, si adattava bene al libro che
aveva tra le mani: anche lì una svolta, gli eventi che prendono
direzioni impensabili fino ad un attimo prima, la vita che ti spinge alla
deriva come una tempesta. Vedi la vita come una folla che ti guarda
dalla riva mentre tu ti allontani, attonito, in balìa delle onde. E in quel
momento, all’improvviso, ti rendi conto che non arriva nemmeno una
barca a soccorrerti.
Il libro, per qualche oscuro motivo, era rimasto tra gli scaffali del
soggiorno per anni senza che nessuno si fosse mai degnato di leggerlo.
In realtà, ad essere oscura era la ragione per cui Stefano quel giorno
avesse alla fine deciso di scegliere proprio quello, e non altri libri
anch’essi rimasti lì, anno dopo anno, a ricoprirsi di polvere.
Era forse stata quella parola del titolo, ”azzurra”, e il colore stesso
della copertina ad attirarlo? Quel libro, “La camera azzurra”, aveva
improvvisamente agguantato in lui e con forza qualcosa di indistinto,
che faticava ad affiorare, quasi fosse compresso da una massa
nebbiosa che lasciava trasparire solo poche ombre. Perché quelle
parole avevano esercitato un simile fascino proprio allora? Quale
meccanismo aveva determinato all’improvviso quella scelta quasi
inevitabile, urgente?
Quel giorno si era svegliato con l’idea fissa di alzarsi e andare come
prima cosa in soggiorno, davanti alla sua libreria bianca, alta, piena di
libri ordinati per categorie – mentre era ancora a letto si immaginava a
sfiorare con l’indice il dorso di quel libro di cui aveva rimandato per
troppo tempo la lettura. Già. Perché aveva rimandato tanto? Eppure
amava Simenon.
Ora quella frustata inferta dal vento e quelle onde che lentamente si
gonfiavano tra sfumature traslucide di azzurro, blu e smeraldo, che si
infrangevano sulle rocce con rigurgiti di schiuma, gli
ricordavano i paesaggi letterari di Simenon, paesaggi immaginati,
lontani e impalpabili ma indelebili, quasi fossero fotografie attaccate
alle pareti della mente con piccoli pezzi di adesivo. Vento, sole
tagliente, nuvole. Onde, sassi. Azzurro. Grigio. Come bolle di sapone i
nomi dei luoghi – Normandia, Sables d’Olonne, Le Roche Noir,
Fecamp, Bretagna – rimanevano sospesi, librandosi a mezz’aria.
Il vento. Poco prima il sole dorava la pelle dei bagnanti distesi sui
lettini o sulle tavole da surf ancorate a pochi metri dalla riva. Poi,
improvvisamente, un sovvertimento, tutto sembrava essere cambiato,
il mare, il cielo, la stagione; ma soprattutto il vento, che adesso
aumentava sempre di più la potenza, soffiava rabbioso, quasi avesse
deciso di spazzare da quel luogo un’umanità divenutagli
insopportabile. Le pagine del libro erano state quasi strappate da
quella furia che aveva anche fatto rovesciare, qualche secondo dopo,
una piccola barca a vela tirata a secco poco distante. Il segnalibro era
ormai perso, mentre le nuvole sparse nel cielo sembravano ora
accorrere ostili come per partecipare ad una cospirazione contro il
sole e contro l’azzurro.
“Tifone” – mormorò Stefano a fior di labbra, e l’oceano in tempesta di
Conrad lo sommerse per un istante dandogli una sensazione
sgradevole, come quella da cui era assalito durante il sogno che
ultimamente ritornava e in cui un’onda gigantesca si avvicinava
inesorabilmente alla costa sommergendo poi ogni cosa.
“Tifone”. Il libro letto due settimane prima. Salsedine e acqua sulle
labbra. E onde fuori e dentro. Onde che si agitano dentro. Nel sogno
tenevo la mano a qualcuno. Non so chi. Non ne ho visto il volto. Non
me lo sono confidato, nemmeno nella libertà del sogno. Chi mi teneva
la mano mentre la furia distruttrice del mare ci investiva? Se si alzasse
ora, un’onda gigante, chi avrei accanto a tenermi la mano? Il
segnalibro è volato. Lontano, oltre la siepe, oltre l’oleandro rosa,
sembra una farfalla che batte le ali in maniera scomposta, disperata,
prima di cadere. Le parole del libro continuavano a risuonarmi nella
testa vorticosamente, non riuscivo a smettere di leggere.
Ho visto ribaltarsi il tridente: l’albero per poco non colpiva il bagnino.
La gente accanto a me ha commentato con le solite frasi, qualcosa tipo
“per miracolo non l’ha preso” e “ma le norme di sicurezza? Niente,
eh?”. Ho chiuso il libro e mi sono alzato per andarmi a riparare nella
zona ristoro, ma più che altro per evitare di dover ascoltare quelle
banalità.
La camera azzurra dell’Hotel des Voyageurs, insieme al libro, adesso
era chiusa, – la porta e le finestre sbattute, sigillate – e Tony,
giovanotto di origine italiana e figlio del vecchio Angelo Falcone che
era emigrato in Francia per cercar fortuna, Tony – sposato felicemente
con la graziosa Gisele – era rimasto immobile, fissato nel fotogramma
della pagina, nudo in piedi davanti allo specchio a radersi nell’attimo
in cui sbirciava sorridendo il riflesso di Andrée, anche lei nuda, distesa
sul letto disfatto e con le cosce spalancate.
Libro in zaino, tempesta in corso, la camera d’hotel chiusa, sospesa,
con le vite di donne e uomini dentro, in attesa che le pagine fossero
aperte di nuovo, a ritrovare quel punto preciso su una linea lì dove
avrebbe dovuto stare il segnalibro che è volato via. Come descrivere
un piacere interrotto che alimenta ancor più il desiderio? Come
definire la brama di prolungare il godimento che si prova nel vivere le
vite di altri attraverso le pagine scritte dei libri? Stefano si chiedeva
questo nel momento in cui chiudeva il libro e correva a ripararsi.
Quale foce sarebbe stata in grado di riversare all’esterno il fiume che
scorreva nelle viscere trascinando come detriti frasi e parole e
immagini e poesia dalle pagine di un libro? E come descrivere il
sapore delle parole, e ciò che vive il corpo quando leggi cose che ti
strizzano dentro, che affondano la mano in profondità, fra cuore e
stomaco? Quanti libri avrebbero potuto saziare quella fame? Mille?
Diecimila? Tutti quelli di un’intera biblioteca magari affrontati in
ordine alfabetico così come avevano creduto di dover fare Bouvard e
Pecouchet?
C’è una camera azzurra nel profondo della mia mente. È rivestita da
una carta da parati dalla superficie metallizzata, imperfetta nei suoi
riflessi sfocati, quasi spettrali, ombre senza volto. Roba anni settanta.
Mi rivedo lì, al centro della stanza, sei o sette anni, a correre in circolo
su un tappeto rotondo dominato da tinte viola. Su una delle pareti
azzurre, come affiorando da un oceano verticale, due figure dritte e
rigide. Poi una delle due agita le braccia, quasi un attacco fulmineo.
Nel silenzio che è proprio di ogni abisso, monta un’onda sempre più
alta, arriva dal profondo della parete, sommerge tutto.
Occhi
“Ho un buco nella gola. E altri, non li conto più, nelle braccia. Lividi,
cerotti. Cerco di mandare giù una pizzetta, è soffice, davvero, ma mi
uccide. Questa tosse, poi, insistente, caìna, subdola, che mi
consuma lentamente. Per quanto ancora potrò vederlo che gioca, sorride, piange?
Per quanto ancora potrò guardarlo negli occhi? Lui evita. Lo so.
Perché in fondo lo ha capito, lo vede nei miei, di occhi, nelle mie
rughe, nel mio corpo sempre più magro, pallido. Dieci anni. Lo
vedono anche loro, mi guardano come se fossi un’apparizione, un
sudario. Le mamme dei bambini mi salutano, sorridono, parlano.
“Auguri a Gianni” – è il compleanno di mio figlio – “cantate tutti!
tanti auguri a te…”, “la foto! mettetevi lì dietro la torta, tutti insieme,
anche tu, Giuseppe, accanto a tuo figlio!”, mi sorridono ma lo vedono
cos’ho dentro, dentro agli occhi, dentro al cuore, io lo vedo riflesso nei
loro sguardi il vuoto nero che mi trascina giù nel barato. Mio figlio,
dieci anni! Guarda, il mare a quest’ora è una meraviglia. Poco dopo il
tramonto l’acqua prende i riflessi bluastri del petrolio, sembra più
densa, è l’ora in cui si fanno il bagno cinesi, cingalesi, pachistani, forse
perché hanno smontato ora da lavoro e vanno con le famiglie, forse
perché a quell’ora la spiaggia si svuota e in più l’ingresso è libero,
forse perché hanno pudore a mostrarsi mentre si immergono con i loro
improbabili costumi, con le magliette e le canottiere, con i veli. Non lo
so. La pizzetta, ne ho mangiata metà. Non ho fame. E la foto, la foto
l’ho fatta, ma mi hanno dovuto reggere da dietro.”
Giuseppe ha un cancro alla gola, viaggi tra Milano e Palermo, chemio,
radio, interventi. L’ultima volta che lo avevo visto ero rimasto
impressionato dal colorito innaturale, gli avevano messo sul viso e sul
collo qualcosa tipo cerone per coprirne il pallore, col risultato che
seduto sulla panca, nel suo abito scuro azzimato, tra l’incenso e i fiori,
ho avuto la sensazione che la morte aleggiasse dentro la chiesa e che,
invece di una prima comunione, si trattasse di un funerale. Oggi suo
figlio fa dieci anni, festeggiano qui sulla spiaggia. Ha scoperto di
essere malato un anno e mezzo fa. Porco mondo. Porco mondo e
vaffanculo. I suoi occhi cerchiati, scavati, il tubo che gli penetra nella
gola, sul braccio il cerotto e i lividi. Scrive poesie, almeno ne ha scritta
una. L’ho trovata tra le pagine del libro. Dimenticata. Un foglietto di
block notes a quadretti, ingiallito. Quanti anni fa è stato, sette, otto,
che me l’ha regalato? Una sera lo ha tirato fuori da uno zainetto,
l’aveva finito la sera prima. La camera azzurra. Te lo regalo, fratello, si
legge d’un fiato. So che ti piace Simenon, pensa che l’ho anche
comprato per sbaglio!
L’ho sognata, l’onda gigante, da lontano scorgevo l’enorme massa
cristallina che avanzava, e la mia angoscia cresceva. Poi una furia di
acqua ha sommerso tutto. L’angoscia di colpo si è dissolta, potevo
respirare, anche in quell’abisso, nuotare, e i colori erano chiari, puliti.
Dopo due giorni Stefano aveva finito di leggere “La camera azzurra” e
subito dopo aveva iniziato con “Betty”, sempre di Simenon, e in altri
due giorni aveva finito pure quello. Storie di disperazione, di discesa
verso l’abisso, verso il limite, e oltre. Sorpreso dalla velocità con cui
era riuscito a leggere i due libri, aveva deciso di rileggere Questo
bacio vada al mondo intero di McCann. Il solo nominare a fior di
labbra i loro nomi gli provocava un moto interiore vasto e profondo,
fatto di immagini e suoni e odori, dalla sabbia umida della spiaggia di
Dublino ai mattoni e all’asfalto infuocato di Brooklyn del 1974.
Corrigan, il santo dei sobborghi di New York, che cercava Dio tra
prostitute e spacciatori e si era ritrovato al bivio tra l’amore divino e
quello per Adelita, e il fratello di Corrigan – Cioran – e poi Claire e
Solomon, col loro Joshua oramai fantasma, e poi Gloria e Claire e
Marcia e Janet e Jaqueline lì nel lussuoso appartamento di una di loro,
così diverse ma unite dallo stesso dolore, lì a mettere su un piatto le
loro disperazioni per i figli morti in Vietnam con l’illusione di farli
rivivere ancora solo per qualche momento, e ancora Gloria la nera, la
nipote di schiavi deportati dal Ghana fin nel Missouri, che con le sue
scarpe troppo strette se ne torna a casa a piedi e con i piedi sanguinanti
attraversa Harlem perché i taxi spengono l’insegna luminosa alla vista
di una donna di colore, e poi Tillie e Jazzlyn, mamma e figlia a battere
sullo stesso marciapiede, e tutte quelle voci che come fiumi
serpeggiano e si gonfiano e si dilatano e infine si intrecciano e
dilagano sotto un cielo di frammenti di vetro in cui – appena visibile
da quei centodieci metri di altezza – un funambolo, il funambolo,
come un angelo senza ali armato solo di una lunga asta di metallo si
libra come in un’apparizione miracolosa.
Giuseppe – Peppe – è morto ieri.
Ho tra le mani La camera azzurra, mi resta questo di lui, e un mare di
ricordi.
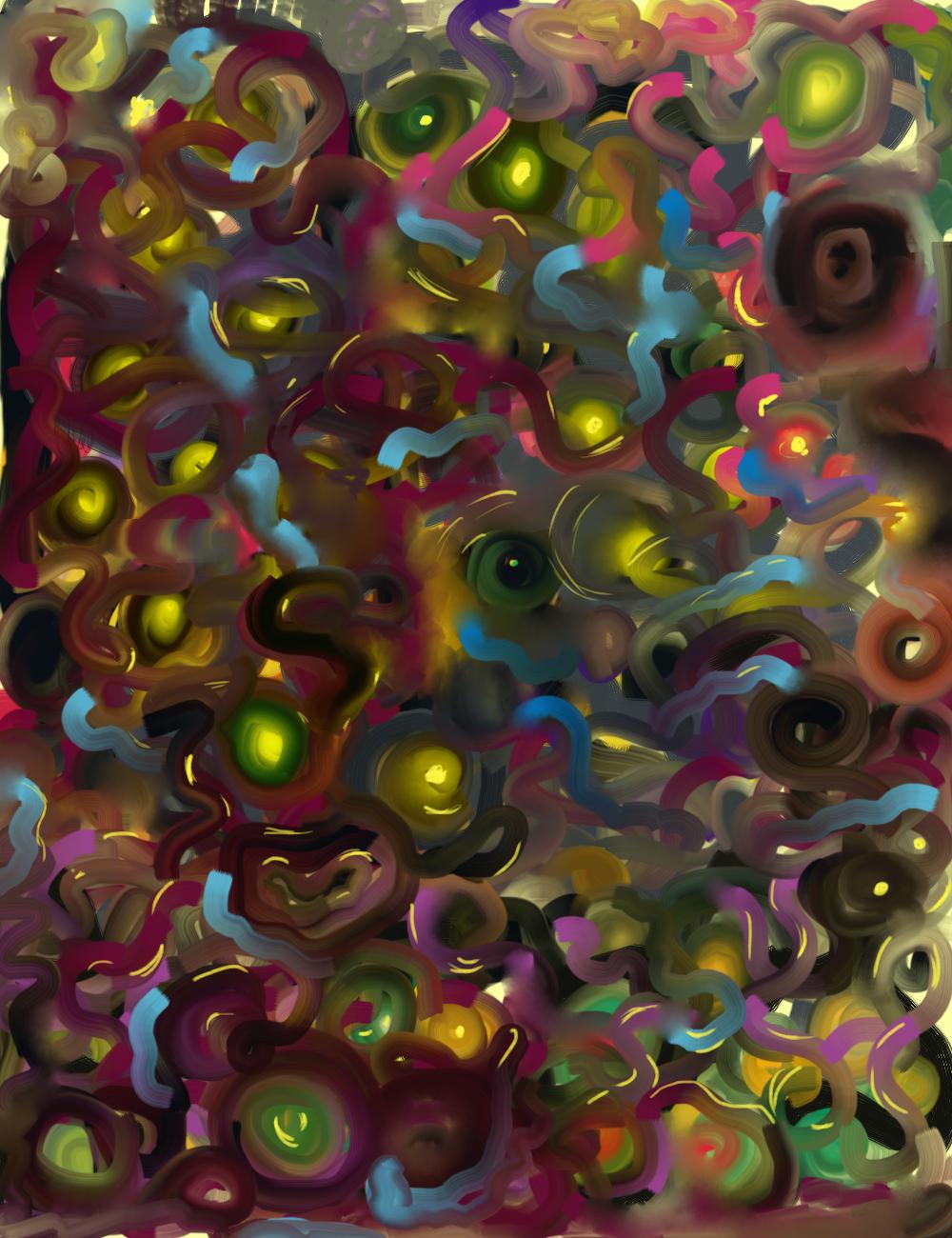



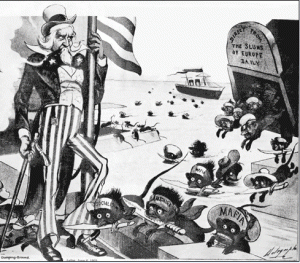 .
. 
 Chi conosce Big Sur? Per chi non sa chi sia Henry Miller, Big Sur è semplicemente una località della California, una splendida regione degli StatiUniti che si affaccia sull’Oceano Pacifico nel tratto di costa compreso tra San Francisco e Los Angeles. Per chi conosce Henry Miller, invece, Big Sur è molto di più, è luogo reale e mentale allo stesso tempo, è il “buen retiro” in cui visse per più di vent’anni lo scrittore, la meta di pellegrinaggio per i giovani della Beat generation, ed è anche quell’universo milleriano dove abitano uomini grandiosi nella loro semplicità, sogni, visioni, illuminazioni surreali e amori “millenari”, viaggi immaginati e reali. Big Sur e le arance di Hieronimus Bosh è, inoltre, il titolo fantastico ed evocativo di un libro di Miller: un libro che può essere per molti una rivelazione, l’iniziazione ad una nuova concezione della vita. Big Sur dunque può essere il punto di partenza per conoscere lo scrittore e la sua opera (che spesso coincidono).
Chi conosce Big Sur? Per chi non sa chi sia Henry Miller, Big Sur è semplicemente una località della California, una splendida regione degli StatiUniti che si affaccia sull’Oceano Pacifico nel tratto di costa compreso tra San Francisco e Los Angeles. Per chi conosce Henry Miller, invece, Big Sur è molto di più, è luogo reale e mentale allo stesso tempo, è il “buen retiro” in cui visse per più di vent’anni lo scrittore, la meta di pellegrinaggio per i giovani della Beat generation, ed è anche quell’universo milleriano dove abitano uomini grandiosi nella loro semplicità, sogni, visioni, illuminazioni surreali e amori “millenari”, viaggi immaginati e reali. Big Sur e le arance di Hieronimus Bosh è, inoltre, il titolo fantastico ed evocativo di un libro di Miller: un libro che può essere per molti una rivelazione, l’iniziazione ad una nuova concezione della vita. Big Sur dunque può essere il punto di partenza per conoscere lo scrittore e la sua opera (che spesso coincidono).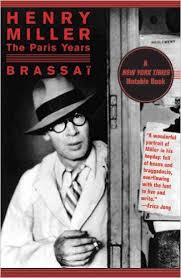

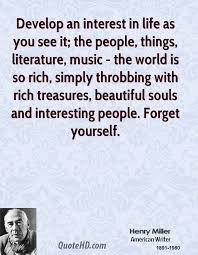


 la chiusura
la chiusura