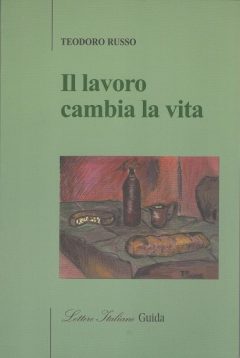IL REDDITO DI ESISTENZA
I diversi governi degli Stati, a partire dalle civiltà più antiche, hanno variamente affrontato il problema della povertà dei cittadini e della distribuzione delle ricchezze economiche.
Nessun modello organizzativo finora escogitato dalle forze politiche è riuscito a trovare un giusto rimedio per estirpare le ineguaglianze economiche e sociali dalla Comunità.
Ogni modello, infatti, sia che abbia concentrato il potere pubblico in un monarca, sia che lo abbia distribuito alla massa, cioè al cosiddetto popolo, oppure a un gruppo ristretto (spesso oligarchia), è risultato inadeguato e inefficace; così come si sono rivelati incongrui i modelli orientati verso la libera iniziativa economica e quello fondato sulla pianificazione economica degli Stati (e anche le soluzioni intermedie, di compromesso).
In verità non poteva che essere così dal momento che gli autori e gli esecutori di tali modelli, ossia gli esseri umani, sono per natura difettosi e limitati, anche quando si abbeverano alla fonte della conoscenza.
Tutti, infatti, soggiacciono all’influenza dell’istinto primordiale che spinge all’insensato accaparramento delle risorse; molte persone, però, come i malati cronici, ne hanno un bisogno maniacale per cui i beni materiali sono come delle medicine, che tuttavia non li faranno mai guarire perché la patologia ha il suo “regno” nella parte cerebrale collegata all’ego mediante un cortocircuito.
Per fortuna, però, il processo “evolutivo” dell’universo e il ciclo della terra non si arrestano ma vanno avanti, e così spingono anche le diverse specie viventi, tra cui quella degli uomini, ad acquisire nuove informazioni, a conoscere più a fondo le leggi fondamentali della natura, che sovrastano quelle degli Stati e le false ideologie politiche, economiche e religiose.
Così la “diversità” naturale, che la scienza valuta come una “ricchezza biologica”, e gli uomini interpretano come la causa e la giustificazione dell’ineguaglianza e della “selezione naturale della specie”, si rivela in realtà solo come una pura e semplice manifestazione esteriore dei corpi, i quali, tutti, sono costituiti dalla stessa materia.
È questa materia, perciò, che rende “tutti eguali”, e grazie alle scoperte scientifiche si comprende anche che le diverse forme sono soltanto delle metamorfosi relative allo spazio-tempo di riferimento.
La vera “trasformazione”, infatti, non è quella che in natura appare all’occhio umano mediante le diverse forme esistenti bensì quella che agisce sulla materia che le costituisce: non è il sole, così come appare alla vista, a mutare, bensì la sua composizione atomica che mediante il processo di fusione nucleare, iniziato con l’Idrogeno che si sta trasformando in Elio, a cui seguiranno successivi cambiamenti, terminerà il suo ciclo vitale.
Non esiste, perciò, alcuna “selezione naturale delle specie” ma soltanto una “trasformazione” della loro materia. Mentre, infatti, le forme (come, ad esempio, i dinosauri, nel passato, e nel futuro anche gli uomini) “spariscono” ciclicamente dal sistema la materia, invece, anche nella sua versione di energia, rimane sempre presente, perché nulla si crea né si distrugge ma tutto si trasforma.
Gli uomini, pertanto, scompariranno dal sistema soltanto come “forma” ma la loro materia (ed energia) resterà sempre presente (anche se questo, che equivale ad una sorta di “eternità”, non li soddisferà mai perché essi, come Narciso, amano troppo se stessi).
Agire, perciò, pensando soltanto all’accaparramento delle risorse perché queste farebbero “perpetuare” la propria specie e vincere la gara dell’adattamento e della selezione naturale, è una pura follia oltre a non essere coerente con la vera dinamica universale dove l’eguaglianza si rinviene sin dall’origine nella sostanza e non nella forma.
Occorre, perciò, un cambiamento mentale e di prospettiva da parte degli esseri umani rispetto alle creazioni dei modelli politici ed economici e dei rapporti sociali.
E con questa nuova consapevolezza si dovrà affrontare e disciplinare il “reddito di esistenza” nell’ambito degli ordinamenti giuridici degli esseri umani.
La prima e necessaria domanda alla quale occorre dare una risposta è perciò la seguente: Il “reddito di esistenza” è un “diritto naturale” oppure è un “diritto civile” ?
I) LA NATURA DEL REDDITO DI ESISTENZA.
Come vivessero i nostri progenitori nello “stato di natura” lo possiamo soltanto ipotizzare. Di sicuro i segni rupestri lasciati nelle diverse grotte a testimonianza della loro esistenza lasciano ritenere che non mancassero di estro e che anche l’arte grafica fosse parte del loro modello di vita in comune.
Un aiuto rilevante, tuttavia, lo si può avere senz’altro dalla paleontologia, dall’antropologia e dai risultati della ricerca storica.
Un altro modo per attingere notizie, in particolare sulle loro “costituzioni” (ossia sui loro modelli di organizzazione politica e di governo), è quello di interrogare “l’intellighenzia classica”, che a differenza di quella dei tempi più recenti spesso si conquistava “sul campo” gli onori e non grazie al servizio ai governanti di turno.
È stato detto da Aristotele, a proposito del modello di vita precedente alla formazione degli Stati: «I membri della famiglia avevano in comune le stesse cose, tutte».
Non credo che possano sussistere dubbi sul fatto che nell’ambito dello stesso nucleo “familiare”, ossia tra coloro che erano legati dal vincolo di sangue, vi fosse condivisione dei beni necessari per la sopravvivenza di tutti i membri (anche tra i leoni, dove a cacciare è la leonessa, e a mangiare per primo la preda è il re-leone, che ha precedenza, concorrono, poi, tutti gli altri membri del branco).
Da ciò consegue che non risulta verosimile che il passaggio dalla condizione naturale, ove soltanto le leggi della natura regolavano tutti i rapporti interni e esterni ai gruppi umani, alla società politica, abbia potuto privare anche un singolo componente della società dei beni necessari alla esistenza.
Il “consenso”, infatti, esplicito o implicito, su cui si sono costituite tutte le comunità-statali, non sarebbe mai stato concesso, se fosse stato previsto che nella nuova società civile ci sarebbe stato un peggioramento e non un miglioramento delle generali condizioni di vita rispetto alle precedenti sia da parte delle famiglie che dei singoli componenti.
E che “il minimo” per garantire l’esistenza ad ogni nucleo familiare e ad ogni singolo membro della Comunità-statale non può essere messo in dubbio si trae, altresì, sempre dal pensiero di Aristotele, il quale peraltro riteneva che fosse anche una soluzione indispensabile per impedire la disgregazione delle Costituzioni: «nessun cittadino deve mai mancare di cibo».
A quanto pare l’esperienza e i consigli forniti dai nostri illuminati predecessori non servono granché, neppure in minima parte, e la ragione, forse sta nel fatto che, così come registrava sempre Aristotele, «la perversità degli uomini non si sazia mai: e dapprima si contentano di due oboli soltanto, poi, quando questo è diventato norma consuetudinaria, vogliono sempre di più fino a superare ogni limite: senza limite, infatti, è la natura del desiderio per il cui soddisfacimento i più vivono».
Per questo accade ancora oggi che vi sono cittadini del tutto fuori dalla Comunità, e che sono privati anche del solo cibo, necessario al sostentamento e alla difesa della dignità.
È del tutto evidente, però, che quando ciò accade è perché è stato reciso il “patto originario” di fondazione della Comunità-statale e sono state ripristinate le medesime condizioni dello “stato di natura” nell’ambito della cosiddetta società civile con la differenza, però, che in questo caso le diseguaglianze sono stabilite dalla “legge” e difese dai “guardiani dello Stato”.
La “legge”, così, in questi casi, come regola politica e della ragione, tende a sostituire le “leggi universali della natura” che disciplinano la “trasformazione” naturale della specie per introdurre un regime di selezione artificiale regolato dalla legge civile che tuttavia può soltanto escludere i cittadini dal riparto delle risorse ma non potrà mai “trasformare” la sostanza né incidere sul divenire regolato dalle leggi del cosmo.
È evidente che questo regime “legale” non è coerente con la dinamica universale, nè peraltro umanamente “giusto”, e non può essere di certo la legge a renderlo tale, perché la legge lo potrà soltanto rendere formalmente “legale”, ossia conforme all’ordinamento giuridico, ma mai sostanzialmente “giusto” (giusto in sé) secondo il patto consensuale originario di fondazione della Comunità-statale.
È necessario, perciò, che l’ordinamento giuridico si adegui ai principi e ai valori fondativi del consorzio umano, che si è radicato sulle cellule familiari naturali. Sono queste, infatti, e soltanto queste, la struttura della società e delle istituzioni. Senza di esse nessuna società potrà esistere né sopravvivere.
E allora, per impedire che regni ancora incontrastata la logica del branco che opera per accaparrarsi tutte o quasi le risorse disponibili è necessario che sia “costituzionalizzato” il diritto al reddito di esistenza, sia di ogni nucleo familiare che di ogni singolo cittadino.
Il “reddito di esistenza”, così, diventa lo strumento politico per spingere l’ordinamento verso l’eguaglianza sostanziale; al tempo stesso garantisce la dignità umana e sociale di ogni cittadino.
Non vi è dubbio che tale reddito trovi la sua fonte originaria direttamente nella natura, per cui gli ordinamenti giuridici non lo devono “costituire” ma lo devono solo “riconoscere” in favore di tutti i cittadini.
Non si può escludere che alla generalità dei cittadini sia, ormai, alquanto difficile comprendere la problematica, soprattutto quando si parli di “diritti” dal momento che questi sono, per comune convenzione, soltanto quelli che sono “creati” (costituiti) dall’ordinamento giuridico, a partire dalla Carta costituzionale.
Eppure con un limitato sforzo del pensiero potrà senz’altro risultare a tutti chiaro che l’ordinamento statale non è il mondo fisico in cui si agita la vita sensibile e visibile né l’universo delle galassie ma è soltanto il prodotto, più o meno sensato, e a volte perfino insano (come le tirannie, le dittature e le oligarchie), dell’organizzazione politica degli uomini per esercitare su questi il potere, spesso nella finzione di perseguire il “bene comune” (che dovrebbe coincidere con la socratica “vita buona” garantita a tutti).
Lo Stato (o Comunità-statale) non preesiste all’uomo (né come singolo né raggruppato in nucleo familiare naturale), ma è l’essere umano che esiste in natura (e per il fine di questa e non viceversa) e le uniche vere “leggi” immutabili che regolano la sua vita sono quelle universali (basta pensare alla “legge” di gravità, che nessun Parlamento potrà mai modificare) tra cui quella della “trasformazione” della specie (il cui fine, peraltro, è al momento ignoto alla ragione, che tuttavia può cogliersi nel generale processo evolutivo e migliorativo delle diverse aggregazioni, sia in natura che in politica).
Nella “condizione di natura” (detta comunemente “stato di natura”), che è una “situazione di fatto” (assoggettata, perciò, alle regole della biofisica e della biochimica), l’uomo ha indiscutibilmente delle “libertà naturali”, delle “facoltà” (che convenzionalmente, nei tempi recenti, sono state definite “diritti” dalle società civili), che ha il potere illimitato di esercitare a difesa della sua personale esistenza e di quella della specie cui appartiene (credo che soltanto un folle, o un politico ottuso, possa immaginare che la sopravvivenza del singolo non sia in simbiosi con quella della propria specie, e viceversa, nonché con l’intero ecosistema).
La “difesa della propria vita”, pertanto, così come la propria “esistenza”, che ne costituisce la principale espressione biologica, è senz’altro preminente e preesistente rispetto all’ordinamento statale. Questo, perciò, non potrà mai “costituirla” ma solamente “riconoscerla” e disciplinarla (ad es. mediante le norme della legittima difesa e dello stato di necessità).
È vero, comunque, che nello “Stato di diritto” senza che vi sia una legge che lo preveda non esisterebbe il “diritto” di difendere la propria vita, tuttavia, pur non esistendo il “diritto” l’essere umano avrebbe comunque il potere naturale di difendere la sua vita, e lo farebbe a buon ragione, così come lo fanno tutte le altre specie viventi.
È questo “potere naturale”, perciò, che appartiene all’uomo in quanto specie vivente, che lo Stato può solo “riconoscere” e non “costituire”.
E di tanto ne è stato consapevole anche il Costituente italiano del ’46.
L’art.2 della Costituzione, infatti, sancisce che «La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali, ove si svolge la sua personalità e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale».
Trattasi, come si vede, di una “presa d’atto”.
Riconoscere, infatti, sta a significare che lo Stato-comunità è consapevole che l’uomo, in quanto uomo, è portatore, di propri “diritti” (da intendersi, questi, come “facoltà”, poteri, libertà), tra cui, in primis, quello alla vita e alla esistenza.
È certamente vero che, tuttavia, in molti Stati tali “diritti inviolabili dell’uomo” risultano tuttora negati o violati ma questo dimostra soltanto che i governi di tali Stati (sempre espressione delle maggioranze politiche in conflitto con le minoranze), abusando della propria forza collettiva hanno violato “il patto originario” in virtù del quale gli uomini decisero di unirsi in comunità.
E così anche le discussioni politiche su quali siano i “diritti inviolabili dell’uomo”, che hanno dato luogo all’approvazione di Convenzioni e Trattati internazionali (come la Dichiarazione Universale dei diritti umani), con lo scopo di limitare la discrezionalità degli Stati, hanno sinora visto prevalere il potere supremo degli Stati di stabilire quali, in concreto, debbano essere tali diritti e come e se proteggerli.
Tra i diversi diritti il «diritto alla vita» risulta essere indubbiamente quello più citato (e più violato) dagli ordinamenti statali.
La Costituzione italiana, come sopra detto, lo tutela, anche senza menzionarlo esplicitamente, con l’art.2 relativo alla tutela dei “diritti inviolabili dell’uomo” (oltre, ovviamente, in virtù della ratifica delle Convenzioni e dei Trattati internazionali).
Il “diritto di esistenza” costituisce la radice di tale “diritto alla vita”. Non si può riconoscere questo negando il primo, o disattendendolo.
Non vi è dubbio che la “esistenza” di qualsiasi essere umano non dipenda soltanto dal sostegno economico, ma di certo questo ne costituisce la base minima.
Nessuno ignora, infatti, che ogni uomo sia in balìa delle “leggi naturali universali”, prima ancora che delle leggi civili, e che mentre queste possono essere modificate, le prime, invece, non sono nella disponibilità dei governi degli Stati (non si possono “abrogare” con legge i virus, né i tumori, né impedire la fusione nucleare del sole, né la rotazione della terra). Tuttavia, non è possibile che un uomo possa perdere la propria vita perché la Comunità-statale lo ha privato delle risorse minime necessarie per la sua esistenza.
In questo modo lo Stato-comunità si sostituirebbe alla “natura” agendo sulla “selezione delle forme”, dal momento che non potrà mai agire sul mutamento della sostanza.
Questa, infatti, si trasforma per ben altre leggi, quelle universali, per le quali sono del tutto irrilevanti le dinamiche umane, anche relative al reddito e ai diritti.
Tuttavia, poiché gli uomini hanno organizzato il proprio ordinamento, non si può evitare di ragionare sullo stesso, anche al fine di coglierne eventuali anomalie.
Tra queste certamente si collocano le regole politiche ed economiche relative alla distribuzione delle risorse perché, come detto, seguono una errata convinzione, cioè quella della “selezione della specie”, che non esiste se non nella dinamica della “trasformazione” della materia.
Per queste ragioni va riconosciuto a ciascun cittadino di “esistere”, come fatto naturale, e, pertanto, reso destinatario di un “reddito di esistenza” da parte della Comunità-statale.
II) IL PRINCIPIO POLITICO.
Il riconoscimento, come innanzi detto, a ciascun cittadino di un “reddito di esistenza” si rinviene fin dall’origine nella natura, e questa deve sempre costituire il solco in cui la politica deve elaborare le migliori soluzioni per il bene dell’intera comunità-statale.
Come, però, la natura sta alla politica non vi è dubbio che questa preceda sempre le regole giuridiche.
Purtroppo non è infrequente che il legislatore dei tempi recenti operi con la convinzione che sia la regola giuridica la panacea di ogni problema sociale idonea ad esprimere da sé il principio politico, o a determinarlo ex post, e per questo eviti di attardarsi nella ricerca di tali principi.
È, ovviamente, un grave errore, che impedisce di prevedere in anticipo le gravi conseguenze che ne potranno derivare da una norma che non sia ispirata al fine generale dello Stato-Comunità.
E con lo stesso metodo, purtroppo, come già sopra evidenziato, affronta anche il tema delle “Riforme costituzionali”, senza considerare che la Costituzione è destinata a fissare i “princìpi” mentre le leggi devono disciplinare i fatti concreti ispirandosi a tali princìpi che costituiscono il quadro d’insieme dello Stato, peraltro sempre in costante cambiamento.
Sono le leggi, perciò, che si devono riferire e adattare ai princìpi della Costituzione e non viceversa, e né si può pensare che il solo “pensiero del capo” sia la soluzione politica per tutti.
Per questo in un regime democratico non si possono approvare leggi con orientamento “oligarchico” (come spesso accade con le leggi elettorali e di attribuzione di vari incarichi dirigenziali), né è corretto spostare il baricentro dall’assemblea parlamentare, organo della rappresentanza, a quello del governo, ritenendo che la “governabilità” debba prevalere sulla rappresentanza popolare.
Per quanto concerne il “reddito di esistenza” è evidente che il principio politico ben si rinvenga nei succitati contributi autorevoli di Aristotele: ««I membri della famiglia avevano in comune le stesse cose, tutte» e che «…nessun cittadino deve mancare di cibo».
Non si tratta, pertanto, di una discrezionalità giuridica del legislatore né di un atto di beneficenza del governo (in vista dei consensi elettorali) bensì di “un atto dovuto” che costituisce l’espressione del fondamento della Comunità-statale.
Nessun membro della famiglia, che aveva in comune “tutti i beni” con gli altri membri della propria famiglia, avrebbe mai accettato di entrare in società con le altre famiglie per essere escluso del tutto dal godimento dei beni, o per essere privato perfino del cibo, che non deve mai mancare a “nessun cittadino”.
I beni necessari alla sopravvivenza, tra cui il “cibo”, costituiscono un obbligo inderogabile di ogni Stato-comunità perché appartengono ad ogni cittadino come essere umano e gli derivano dal preesistente stato di natura.
La “costituzionalizzazione” del principio del riconoscimento del “reddito di esistenza” toglie la discrezionalità a tutti i governi di turno (democratici, oligarchici o monarchici che siano). Nessun governo potrà mai più farne politica elettorale, e così sarà salvaguardata anche la dignità dei cittadini.
Nel contempo si limeranno gli artigli a tutti quei cittadini che bramano accumulare risorse senza altro fine che quello del puro possesso, producendo l’effetto di rendere il sistema più giusto ed equo.
III) LE FONTI GIURIDICHE.
Come detto, il fondamento del reddito di esistenza riposa nel diritto naturale, per cui esso va soltanto “riconosciuto” come diritto inalienabile e incoercibile.
Tuttavia non mancano nell’ordinamento giuridico, soprattutto internazionale, dei riferimenti, cui sarebbe possibile ancorarlo.
Anzitutto vanno richiamate la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, che si è ispirata a tale Dichiarazione.
Trattasi di due fonti che hanno consentito di recepire negli ordinamenti giuridici dei singoli Stati l’obbligo di rispettare la dignità umana. Anche la Costituzione italiana con l’art. 2 garantisce la tutela della dignità umana.
In virtù dell’art. 1 della Carta dell’U.E. è sancito il principio che «La dignità umana è inviolabile. Essa deve essere rispettata e tutelata».
Non credo che sussistano dubbi sul fatto che la tutela debba avvenire anche mediante l’attribuzione di risorse economiche.
È senz’altro vero che soprattutto in questa fase storica un po’ tutti gli Stati stanno dimostrando scarso interesse proprio verso tale dignità umana.
Ma bisogna che tutti i cittadini si rendano conto che non rispettare oggi quella degli altri (come ad esempio la dignità dei migranti) può giustificare, un domani, il mancato rispetto della loro dignità.
Questa o è un valore “assoluto” oppure non lo è.
È difficile che possa valere soltanto in un caso e non valere per un altro, per alcuni e non per tutti, oppure solo per un periodo e non per sempre.
Per questo difendere la dignità umana vuol dire difendere un valore, che soltanto così potrà garantire tutti, nessuno escluso.
Molti cittadini, deboli di memoria (perché non ricordano più i nefasti anni del nazismo, del fascismo e del regime comunista), pensano che si possa violare impunemente la dignità umana, anche soltanto di alcuni concittadini, non immaginando che stanno gettando le premesse per la violazione futura della propria dignità.
La storia umana è fatta di continui capovolgimenti di fronti, e l’Italia più degli altri Paesi non è stata mai sempre dalla stessa parte né dalla parte giusta.
Ogni Popolo ha una sua peculiarità, nel bene e nel male, e gli italiani si caratterizzano dalla labilità delle proprie idee politiche e delle alleanze.
«È morto il re, viva il re», ma anche, e con la stessa disinvoltura, «abbasso la monarchia, viva la Repubblica».
Il “referendum istituzionale” del 2 giugno del 1946 registrò un’Italia divisa in due parti e i favorevoli alla Repubblica furono soltanto un milione in più (dato, questo, peraltro, sempre messo in dubbio, insinuando che fosse il risultato di brogli elettorali).
La vigente Costituzione è nata sulla base di un “compromesso politico” (con sessantadue voti contrari).
La Repubblica democratica è stata organizzata nel senso tendenzialmente parlamentare (così si legge negli atti dell’Assemblea Costituente), ma sin dalle sue prime esperienze le diverse classi e le categorie privilegiate presenti nel Paese hanno sempre brigato, in modo più o meno occulto, per eliminare la centralità del Parlamento e mettere al centro il governo (dei pochi).
In questa dinamica conflittuale, all’interno del Paese, le masse dei cittadini hanno sempre preso attivamente parte schierandosi a favore o contro, a seconda dei propri interessi economici e ammaliati dai demagoghi di turno che tanto rievocano i più antichi tribuni della plebe.
Non vi è mai stata una totale condivisione dell’interesse generale, anche perché questo non è stato mai instillato nelle giovani generazioni che sono state allevate con la logica della contrapposizione, del conflitto di interessi, del primato della diseguaglianza sull’eguaglianza.
E così l’industriale ha agito contro gli operai e questi contro il datore di lavoro; il pubblico contro il privato, e viceversa; lo Stato contro gli Enti territoriali e locali; questi ultimi sempre in contrasto tra di loro a difesa di campanili, che spesso vengono giù perché non costruiti nel rispetto delle leggi antisismiche.
«Chi semina vento, raccoglie tempeste», diceva un detto popolare, che così sintetizzava in modo efficace che cosa accade quando non si operi per l’armonia e la condivisione del bene comune.
È necessario che la società (la maggioranza, o quei cittadini emarginati) avvii un processo di riunificazione; che porti a completamento quell’Unità che nel 1861 fu sì proclamata ma portò Massimo D’Azeglio a dire: «Fatta l’Italia, ora bisogna fare gli italiani».
I partiti politici sono stati una conquista della democrazia, ma essi ne stanno diventando il vero problema. La loro logica conflittuale, che si esprime costantemente, anche mediante le solite leggi elettorali, mina i fondamenti della Comunità-statale.
Il sistema elettorale di tipo “maggioritario” esalta le differenze, perché spinge i cittadini a prendere parte contro un’altra parte secondo la logica degli interessi in conflitto.
Tale sistema è sempre stato espressione dei poteri dominanti, che non amano il Popolo, né come sovrano né come partecipe delle scelte politiche, neppure mediante la rappresentanza.
La distribuzione delle risorse è l’obiettivo della contrapposizione politica che si esprime mediante le aggregazioni dei partiti.
A questa logica degradata occorre necessariamente porre un argine, e il riconoscimento del reddito di esistenza potrà esserlo.
Questo reddito di esistenza, infatti, rende innocui i partiti e i poteri forti perché difenderà sempre la dignità di ogni cittadino. Questi, così, saranno definitivamente liberati dalle catene del ricatto del voto e potranno partecipare alle scelte politiche del Paese.
Cittadini con dignità, grazie al reddito di esistenza, per poter finalmente costruire un nuovo modello di Comunità-statale senza più padri-padroni.
E la “costituzionalizzazione” di tale diritto sottrarrà definitivamente ai governi il dominio sulle dignità dei cittadini.
Tratto da: https://ilmiolibro.katawb.it/libro/saggistica/279608/il-reddito-di-esistenza/