Il Libro di SabbiaLibri e dintorni... |
MENU
FRASI SPARSE.
«Per sopravvivere agli assalti degli atei come dei veri credenti mi sono tenuto nascosto nelle biblioteche, tra pile di volumi pieni di polvere, per nutrirmi di miti e cimiteriali leggende. Ho fatto festini di panico e terrore di cavalli imbizzarriti, di cani latranti, di gatti impazziti... briciole scosse da lapidi tombali. Col passare degli anni, i miei compatrioti del mondo invisibile svanirono uno a uno, mentre i castelli crollavano o i nobili affittavano i loro giardini visitati dagli spiriti a club femminili o a tenutari di tavole calde con alloggio. Privati delle nostre dimore, noi, spettrali errabondi dell'universo, siamo sprofondati nel catrame, nelle latrine, in sfere di incredulità, di dubbio, di mortificazione, o di assoluta derisione.»
Ray Bradbury, Sull'Orient, direzione nord.
FRASI SPARSE
«… nella carrozza entrò un uomo che cominciò a suonare un violino che sembrava fatto con una vecchia scatola di lucido da scarpe e, nonostante io non abbia proprio senso musicale, quei suoni mi colmarono delle più strane emozioni. Mi pareva di udire una voce di lamento provenire dall’Età dell’Oro. Mi diceva che noi siamo imperfetti, incompleti, non più simili ad una bella tela intessuta, ma piuttosto come un fascio di corde annodate insieme e gettate in un angolo. Diceva che il mondo era un tempo interamente perfetto e generoso e che quel mondo perfetto e generoso esisteva ancora, ma sepolto come un cumulo di rose sotto tante palate di terra. Gli esseri fatati e i più innocenti tra gli spiriti vi avevano dimora e si dolevano del nostro mondo caduto nel lamento delle canne mosse dal vento, nel canto degli uccelli, nel gemito delle onde e nel soave pianto del violino. Diceva che presso di noi i belli non hanno senno e gli assennati non sono belli e che i nostri momenti migliori sono offuscati da qualche volgarità, o dalla trafittura di un triste ricordo, e che il violino deve rinnovarne sempre il lamento. Diceva che soltanto se coloro che vivono nell’Età dell’Oro potessero morire per noi sarebbe possibile essere felici perché quelle voci tristi si acquieterebbero, ma loro debbono cantare e noi lacrimare finché le porte eterne non si spalancheranno.»
William Butler Yeats, Il crepuscolo celtico.
AREA PERSONALE
|
Post n°84 pubblicato il 23 Novembre 2010 da CarloBajaGuarienti
«Il cuore di cristallo» pittura e poesia nel Rinascimento «Si dice che ogni dipintore dipinge se medesimo». Nel pronunciare queste parole Girolamo Savonarola attinge a un topos ben noto nella Firenze rinascimentale: un detto caro - secondo Poliziano - a Cosimo de' Medici e che Vasari metterà in bocca a Michelangelo. Un concetto indagato sapientemente da Leonardo, che paragona la pittura a uno specchio in cui l’artista riflette inevitabilmente la propria anima: è infatti proprio l’anima, «maestra del corpo», a esprimersi attraverso il pennello e a plasmare la realtà per conferirle la propria forma. Ma quest’idea, vibrante di accordi neoplatonici, oltre che nella pittura è pienamente operante anche nell’altra metà del cielo dell’immaginazione creatrice, cioè nella parola scritta. E su un testo letterario, gli «Asolani» di Pietro Bembo, si apre il nuovo saggio di Lina Bolzoni: «Il cuore di cristallo. Ragionamenti d’amore, poesia e ritratto nel Rinascimento» (Einaudi). Da quest’opera, in cui Bembo ritrae i volti dell’esperienza amorosa scomponendo la propria anima come attraverso un prisma, si snoda un percorso fra pittura e poesia - forme espressive che nel Rinascimento si sfidano più che in ogni altra epoca - alla ricerca di un ideale: «il mito (e il bisogno) della trasparenza, di una corrispondenza tra volto e cuore, fra esteriorità e interiorità, fra linguaggio e sentimenti». Lina Bolzoni, docente di Letteratura italiana alla Scuola Normale di Pisa, affronta con la consueta finezza interpretativa un tema complesso seguendo il cammino di un’indagine la cui tappa precedente era l’affascinante «Poesia e ritratto nel Rinascimento» (Laterza 2008): il dialogo/duello fra letteratura e arti figurative. Ed è in particolare nella terza parte del saggio, dedicata al ritratto doppio, che emerge la forza di questo incontro; attraverso il ritratto doppio, in cui l’immagine del volto è legata a una seconda raffigurazione che ne fornisce una chiave di lettura, gli artisti del Rinascimento costruiscono una rete di simboli, un raffinato gioco che rivela il significato profondo dell’opera. Che rivela, a chi sia capace di vederlo, il volto dell’anima. |
|
Post n°83 pubblicato il 13 Settembre 2010 da CarloBajaGuarienti
(Massimiliano Panarari, L’egemonia sottoculturale. L’Italia da Gramsci al gossip, Einaudi 2010, 145 pp., 16,50 €) Carlo Baja Guarienti - “Sa qual è la fregatura della sinistra? Il complesso del padreterno. Puzza sotto al naso, snobismo: così il popolo non lo intercetti mai.” Christian De Sica, che sull’attenzione ai tic e alle passioni delle ultime generazioni ha costruito un genere cinematografico di innegabile impatto, riassume così le cause del fallimento d’immagine della sinistra italiana: il popolo non cerca i suoi eroi fra gli intellettuali arcigni e i rappresentanti dell’“atticismo militante” (geniale formula coniata alcuni anni orsono dalla caustica penna di Stefano Disegni), la gente si identifica più facilmente con chi “parla come mangia”. Quale strategia politica migliore può esserci, allora, che creare format sempre più digeribili, studiati per conquistare il cuore della gente, e immetterli nel circuito della comunicazione di massa? Tutto iniziò con Drive In, trasmissione cult e vero distillato degli anni Ottanta. Su quel decennio amato e odiato, così irresistibilmente kitsch, punta il dito Massimiliano Panarari, docente di Analisi del linguaggio politico all’Università di Modena e Reggio Emilia, nel suo “L’egemonia sottoculturale. L’Italia da Gramsci al gossip” (Einaudi, 145 pp., 16,50 €): nel decennio di Ronald Reagan e Margaret Thatcher, del consumismo euforico visto come unica via a una felicità quasi universale, il saggista reggiano riconosce le prime prove di quell’“egemonia sottoculturale” di cui oggi il Grande Fratello e l’Isola dei famosi, le veline e i tronisti rappresentano le forme più note. E in Antonio Ricci, sperimentatore e grande esperto della comunicazione di massa, Panarari vede la prima di una serie di figure chiave (le altre sono Alfonso Signorini, Maria De Filippi, Simona Ventura e Bruno Vespa) cui l’attuale panorama massmediatico deve la propria marcia vittoriosa. La televisione commerciale (quella cui si adatta perfettamente la formula del sociologo Marshall McLuhan “il medium è il messaggio”) come strategia volta a imporre una forma di pensiero, una visione del mondo: secondo Panarari gli alfieri del neoliberismo hanno meditato la lezione di Gramsci molto meglio dei loro rivali di sinistra e su queste basi hanno costruito la loro vittoria politica. “L’egemonia sottoculturale” è un saggio che sta facendo e farà discutere, a riprova di quanto la tematica affrontata (dov’è e dove sta andando la cultura popolare in Italia?) sia oggi tutt’altro che marginale. (Gazzetta di Parma, 11 settembre 2010) |
|
Post n°82 pubblicato il 27 Agosto 2010 da CarloBajaGuarienti
(Pier Francesco Grasselli, “Vivere da morire”, Mursia 2010, 455 p., 17 euro) Carlo Baja Guarienti - Il giovane Tony, star del Grande Fratello con un debole patologico per le donne, a bordo della sua Porsche tampona intenzionalmente una Bmw guidata da una una bionda irresistibile: la possibilità di conoscerla vale bene il sacrificio di qualche migliaio di euro. Inizia così, con un piccolo incidente e uno sguardo impietoso su un'umanità consacrata al vuoto esistenziale, il nuovo romanzo del reggiano Pier Francesco Grasselli: Vivere da morire (Mursia, 455 p., 17 euro), capitolo conclusivo di una trilogia di notevole successo iniziata con L'ultimo Cuba Libre e proseguita con All'inferno ci vado in Porsche. Al centro della scena, come nei due libri precedenti, sono donne bellissime, macchine sportive e feste nei locali più famosi di Portofino e Forte dei Marmi, ma qualcosa è cambiato. Se nella sua prima prova narrativa Grasselli osservava senza esprimere giudizi la vita sregolata dei giovani rampolli della borghesia italiana, oggi il suo sguardo è diverso: i nodi vengono al pettine e i protagonisti sono per la prima volta messi faccia a faccia con le conseguenze delle loro azioni. Come nelle visioni mistiche di Swedenborg – autore citato espressamente nel testo – c'è continuità fra il mondo in cui viviamo e gli inferni e paradisi che ci aspettano e ognuno dei personaggi – Tony l'eroe televisivo, Cesare il playboy dal torbido passato, Claudio il figlio di papà psicologicamente instabile - costruisce quotidianamente la discesa al proprio personale inferno. Così, l'inizio e la fine del romanzo si richiamano reciprocamente attraverso l'immagine di una macchina sportiva lanciata a tutta velocità, ma nel frattempo tutto – anche il taglio narrativo – muta: se l'apertura è frivola e trendy, la conclusione è un parossismo di violenza che trova nel cinema estremo degli ultimi anni (in titoli come Hostel o Martyrs) il proprio referente più immediato. Grasselli, giunto alla quinta opera, imprime una svolta alla propria produzione narrativa e, chiudendo il cerchio in cui hanno preso forma i personaggi dei suoi libri più noti, si prepara a fare i conti con una categoria – quella di “giovane scrittore” - spesso troppo angusta. (Gazzetta di Parma, 26 agosto 2010) |
|
Post n°81 pubblicato il 22 Agosto 2010 da CarloBajaGuarienti
(M. Veneziani, Amor fati, Mondadori 2010) Carlo Baja Guarienti - Il paradiso terrestre è un pomeriggio di fine maggio nella campagna del Sud, un mosaico di ricordi - la condivisione degli affetti familiari, il primo risveglio dei sensi, la corsa a tuffarsi nelle onde del mare - e di sensazioni preziose nella loro quotidiana eppure rara intensità. «Amor fati» è essere grati al destino, cogliere l’esistenza di un disegno più grande della singola avventura umana e accettare con gioia l’idea di essere una parte di quel disegno. I paesaggi dell’Italia meridionale e i ricordi di una vita semplice - ma non per questo banale - incorniciano le riflessioni di Marcello Veneziani su un tema arduo e attualissimo in questo inizio di millennio: la condizione umana tra caso e destino. «Amor fati. La vita tra caso e destino» (Mondadori, pag. 242, euro 18,00) è una dichiarazione di equidistanza fra i «progressisti del nulla» e i «conservatori del morto», ovvero fra coloro che brindano con macabro compiacimento all’esperimento fallito della società umana e coloro che pronosticano un imminente futuro senza speranza rifugiandosi nel rimpianto di un passato mitizzato. L’«amor fati» di Veneziani non è né il desiderio di contemplare la propria fine né l’«amor fati» dell’uomo di Nietzsche, che si immerge nell’eterno ciclo del mondo imprimendo con la propria volontà un impulso al ciclo stesso: è piuttosto il piacere di sentirsi compresi di un’unità in cui ogni parte trova con umiltà e insieme con gioia il proprio posto e vibra in armonia con il tutto. C'è molto neoplatonismo in questo anelito all’unione con il principio ordinatore del mondo, in questa tensione a fornire il proprio contributo alla musica dell’universo. «Amor fati - scrive Veneziani nelle pagine conclusive del saggio, - è la gratitudine al destino. Per chi vive la solitudine è la vera, essenziale compagnia. Amando il fato, non vivi e non muori da solo, ma entri in una Rete suprema, ti connetti a una Comunione di anime e a una sfera superiore che prende in custodia la tua esistenza, dalla sua radice fino alla sua destinazione. Amor fati è la persuasione - o forse la rivelazione - che non si è soli nella solitudine e non si è morti nella morte ». (Gazzetta di Parma, 10 agosto 2010) |
|
Post n°80 pubblicato il 09 Agosto 2010 da CarloBajaGuarienti
(R. Keynes, Casa Darwin, Einaudi 2007) - Il desiderio di indovinare una rotta nel naufragio delle vicende umane, la speranza di scorgere un faro nella nebbia – più per poter immaginare una meta che per comprendere il significato del viaggio – accomuna gli uomini di ogni età e nazione, di ogni cultura ed estrazione sociale. Da Agostino a Leibniz e fino alla filosofia novecentesca, che si è trovata a fronteggiare l’ineludibile interrogativo suscitato dalle Guerre mondiali, nell’Occidente cristiano la teodicea è sempre stata fonte di tormento non solo per i grandi pensatori e i teologi: quasi ogni uomo, almeno una volta nel corso della vita, è costretto a contemplare il mistero della compresenza di Dio – onnipotente e benevolo nella tradizione del monoteismo – e del male. Charles Darwin non sfuggì a questa regola. Anzi, la formazione scientifica e la rivoluzionaria teoria evolutiva lo portarono ogni giorno, a ogni passo dell’indagine, a riflettere su questo problema: il crudo e inarrestabile meccanismo della selezione naturale, che inevitabilmente schiaccia il debole per promuovere il forte, sembrava travolgere come un uragano la teodicea e le sue consolanti risposte. Ma fu solamente lo scienziato Darwin a mettere in discussione la bontà divina? Casa Darwin. Il male, il bene e l’evoluzione dell’uomo (Einaudi 2007), scritto da Randal Keynes che di Darwin (come di John Maynard Keynes) è pronipote, ricostruisce la vita privata della famiglia del grande naturalista ponendo al centro del tormentato cosmo morale darwiniano un evento drammatico: la morte – avvenuta, probabilmente per tisi, poco dopo il decimo compleanno – dell’amatissima figlia Annie. Il contrasto feroce fra il comportamento della bambina, che neppure nell’agonia smentisce la propria naturale bontà e cortesia, e l’azione devastante del morbo pone il padre della teoria evolutiva davanti a una domanda che non ammette risposte evasive: dove si trovava Dio mentre Annie si spegneva? La corrispondenza dei famigliari, le fotografie, gli oggetti personali dei Darwin ricostruiscono con grande efficacia, anche visiva, un’Inghilterra vittoriana di fabbriche fumose e salubri campagne, passione scientifica e fervore religioso: il mondo di Dickens, Tennyson e Bulwer-Lytton, insieme antico e moderno. Il mondo di Wordsworth, che come Darwin conobbe il dolore della perdita. E dal fondo scolorito dei dagherrotipi Annie, i fratelli e le sorelle osservano il lettore cancellando le distanze e ricordandoci come, fra l’uomo e Dio, si stenda ancora oggi la proteiforme e irrazionale desolazione del dolore. (Gazzetta di Parma, 11 gennaio 2008) |
|
Post n°79 pubblicato il 30 Luglio 2010 da CarloBajaGuarienti
Performance teatrale e coreografica dal romanzo omonimo di Italo Calvino |
|
Post n°78 pubblicato il 23 Luglio 2010 da CarloBajaGuarienti
Questa estate il Chiostro dei Marmi Romani dei Musei Civici di Reggio Emilia ospiterà le “Baccanti” di Euripide. Lo spettacolo, ad ingresso gratuito, debutterà Venerdì 23 Luglio 2010 con replica Sabato 24 e sarà l'occasione per avvicinare il pubblico all'affascinante mondo della tragedia greca, grazie anche ad un allestimento che fonde in tempi scenici incalzanti teatro, musica e coreografie danzate. |
|
Post n°77 pubblicato il 23 Luglio 2010 da CarloBajaGuarienti
Tag: articoli, BUR, Gazzetta di Parma, libri, mare, Medioevo, recensioni, Rinascimento, Spila, storia, viaggi Nuovi mondi. Relazioni, diari e racconti di viaggio dal XIV al XVIII secolo, a cura di Cristiano Spila, BUR 2010, 534 pp., 12 €. Carlo Baja Guarienti - “Mutano il cielo, non l’animo, coloro che corrono al di là del mare”. Da più di duemila anni i versi di Orazio esortano gli uomini a cercare in sé stessi quell’equilibrio che non troveranno nel più remoto angolo del mondo, ma quella del poeta latino è una battaglia persa in partenza: ognuno - presto o tardi - sente il richiamo di strade che si perdono all’orizzonte, dentro ciascun uomo si nasconde un Ulisse fatalmente attratto da un “folle” volo verso terre ignote. Alla fine del Medioevo i navigatori europei lasciano i porti spagnoli, portoghesi e inglesi per affrontare l’Oceano. Che si tratti della ricerca di nuove rotte commerciali o della curiosità per quelle zone che le antiche carte geografiche popolavano di leoni e mostri, il viaggio per mare è sempre un’avventura potenzialmente fatale: spesso chi parte fa testamento e molti non tornano per raccontare l’incontro con i gorghi oceanici o le popolazioni selvagge di isole lontane. Ma la paura dei naufragi non può intralciare l’inarrestabile processo di apertura dell’Europa verso il mondo. Protagonisti di questa apertura furono spesso navigatori italiani, ma quasi mai l’Italia: la frammentazione politica della penisola e la fragilità strutturale dei piccoli stati italiani costrinsero Cristoforo Colombo, Amerigo Vespucci, Giovanni Caboto e gli altri grandi esploratori degli oceani ad armare le navi e reclutare gli equipaggi con capitali stranieri. Tuttavia i resoconti delle imprese rimangono a testimoniare il ruolo dei pionieri italiani della navigazione, così come i favolosi racconti sull’Arabia, l’India, l’Africa e il Giappone rievocano l’epopea dei viaggiatori – mercanti, pellegrini, militari – che a cavallo o a piedi lasciavano l’Italia verso est. Nuovi mondi. Relazioni, diari e racconti di viaggio dal XIV al XVIII secolo (BUR 2010, 534 pp., 12 €) è il titolo di una raccolta di racconti di viaggi - per mare e per terra, di conquista o di esplorazione - curata da Cristiano Spila. Una raccolta che si apre con la spedizione di Lanzarotto Malocello alle Canarie narrata da Boccaccio - che ci tramanda il ricordo dei popoli indigeni di quelle isole, poi massacrati prima della fine del Quattrocento – e si chiude con il seicentesco viaggio in Curdistan di Pietro della Valle; in mezzo, Petrarca e Colombo, Pigafetta e Vespucci, Poggio Bracciolini e Alvise da Mosto e altri nomi entrati nella storia come esploratori o letterati. I racconti sono generalmente fedeli al vero, ma proprio quando fraintendono o scivolano nel meraviglioso si può recuperare il profondo senso di stupore provato dagli europei al contatto con i “nuovi mondi”: là dove compaiono per la prima volta parole che oggi tutti conosciamo – amaca, canoa, iguana – le pagine fanno rivivere il fascino inesauribile della scoperta. Perché il viaggio, qualsiasi sia la meta, è scoperta del mondo e di sé. “Dopo aver visto tutto ciò” – scrisse nel 1338 Francesco Petrarca a Giovannolo Guido da Mandello, che si apprestava a intraprendere un viaggio in Terrasanta – “ritornerai da noi più saggio e più santo”. (Gazzetta di Parma, 23 luglio 2010) |
|
Post n°76 pubblicato il 21 Giugno 2010 da CarloBajaGuarienti
Simon Sebag Montefiore, Il giovane Stalin, Longanesi 2010. Carlo Baja Guarienti - Nel 1893 il quindicenne Josif Vissarionovič Džugašvili, che una foto ci mostra ben pettinato nel severo abito da studente, guidava con la sua voce cristallina il coro del seminario della città georgiana di Tiflis; quattordici anni più tardi, nel 1917, il trentenne Stalin si sarebbe distinto fra i rivoluzionari comunisti mettendo le basi per uno dei poteri dittatoriali più sanguinari del Novecento. Ma chi era Josif Džugašvili prima di diventare Stalin? Gli oscuri anni della formazione del dittatore sono al centro dell’ultima fatica di Simon Sebag Montefiore, storico inglese già autore di uno studio – “Gli uomini di Stalin” – sulla carriera politica del leader sovietico e sul suo entourage. Un volume documentatissimo, questo “Il giovane Stalin” (Longanesi 2010, 554 pagine, 29 €), frutto di anni di ricerca negli archivi di tutta l’Europa e dell’ex blocco sovietico: Sebag Montefiore non ha scavato solamente fra le carte moscovite rese disponibili agli studiosi negli ultimi anni, ma ha inseguito Stalin fino in Georgia per ricostruire l’ambiente famigliare e scolastico, la quotidianità della famiglia Džugašvili. Lo storico può così raccontare l’infanzia del piccolo Soso – questo il soprannome di Stalin nell’ambiente domestico – nell’universo crudo e arretrato della provincia georgiana e tracciare ritratti efficaci dei genitori del futuro dittatore: la madre Ekaterina detta Keke - donna intelligente, religiosa e instancabile nel cercare un futuro migliore per il figlio - e il padre Vissarion soprannominato “Beso il Matto”, calzolaio psichicamente instabile. Nelle strade del paese di Gori, dove Soso frequenta una scuola ecclesiastica, e fra le mura di casa la violenza e l’alcolismo sono realtà drammaticamente evidenti: è in questo mondo che Josif impara a essere rapinatore e assassino, donnaiolo e poeta, uomo d’azione capace di rischiare in prima persona ed esperto tessitore di intrighi. L’affresco creato da Sebag Montefiore è potente nell’insieme quanto minuzioso nei dettagli, preciso anche dove lo storico concede qualcosa al romanzesco; e se qualche volta si ha l’impressione che il biografo ceda al fascino del dittatore, è bene ricordare come il piccolo Soso abbia poi tenuto in pugno con risolutezza, acume politico e – certamente – brutalità un impero costruito anche sul culto della sua tirannica personalità. (Gazzetta di Parma, 20 giugno 2010) |
|
Post n°75 pubblicato il 31 Maggio 2010 da CarloBajaGuarienti
Martedì 1 giugno 2010 alle ore 18.30 presso la libreria all'Arco di Reggio Emilia avrò il piacere di discutere con Pier Francesco Grasselli del suo quinto romanzo appena pubblicato da Mursia, "Vivere da morire". Seguirà un aperitivo con l’autore organizzato presso il ristorante “7 Torri” in via del Guazzatoio n.5 (RE). |
|
Post n°74 pubblicato il 28 Maggio 2010 da CarloBajaGuarienti
Venerdì 28 maggio 2010 ore 19.00 Circolo del Casino di Reggio Emilia via Gabbi 16
Aperitivo pianistico/letterario testi di Agota Kristof ("La vendetta", Einaudi) improvvisazioni pianistiche di Ciro Andrea Piccinini voci di Ilaria Carmeli, Roberta Iori, Erika Patroncini e Marco Sparano.
Seguirà un aperitivo Ingresso gratuito |
|
Post n°73 pubblicato il 19 Aprile 2010 da CarloBajaGuarienti
Tag: Bombasi, Cadoppi, Circolo del Casino, conferenze, eventi, letteratura, libri, Parma, poesia, Reggio Emilia, Rinascimento, storia |
|
Post n°72 pubblicato il 02 Aprile 2010 da CarloBajaGuarienti
|
|
Post n°71 pubblicato il 15 Marzo 2010 da CarloBajaGuarienti
|
|
Post n°70 pubblicato il 05 Marzo 2010 da CarloBajaGuarienti
Visto il recente anniversario bruniano, pubblico un'intervista realizzata due anni fa per la Gazzetta di Parma. Bruno, messaggero di verità. Intervista a Michele Ciliberto. Carlo Baja Guarienti - Il 17 febbraio 1600, all’alba del nuovo secolo, s’innalza in Campo dei Fiori una pira destinata a passare alla storia come il simbolo stesso dei roghi del Sant’Uffizio: la pira che darà la morte a Giordano Bruno, la cui statua oggi scruta severa la vivace piazza romana. Bruno muore da eretico confesso: ha sostenuto l’esistenza di mondi innumerevoli e la metempsicosi, ha praticato la magia, ha negato la transustanziazione e la verginità di Maria, ha accusato di falsità Mosè, Cristo e gli apostoli, ha tentato di rovesciare le basi stesse della religione cristiana. In poco più di cinquant’anni di vita – è nato nel 1548 – ha processato e condannato nel tribunale del proprio pensiero un antico edificio di teologia, filosofia e cosmologia. L’esistenza di Bruno è uno sforzo titanico, un pervicace tagliare i ponti alle proprie spalle: pur nella tensione fra desiderio di salvezza (che lo induce talvolta a trattare) e abbandono al destino, il disegno complessivo della vicenda umana del frate conduce inevitabilmente a un finale tragico. E proprio come in una tragedia, rappresentazione teatrale che celebra la solitudine di un uomo di fronte all’intera creazione, Bruno sembra rappresentare scenicamente la propria lotta contro gli “asini” delle università. Di questo si è occupato Michele Ciliberto, docente di Storia della filosofia moderna e contemporanea alla Scuola Normale Superiore di Pisa e presidente dell’Istituto Nazionale di Studi sul Rinascimento, in due recenti saggi di cui è autore (Giordano Bruno. Il teatro della vita, Mondadori) e curatore (Favole, metafore, storie. Seminario su Giordano Bruno, Edizioni della Normale). Giordano Bruno – chiediamo – è martire consapevole o solamente vittima del proprio animo tormentato? Bruno è assolutamente consapevole del proprio destino, sa fin dall’inizio che la radicale novità del suo pensiero gli porterà la solitudine e la condanna da parte di tutti. Il martirio è un destino connaturato al ruolo stesso assunto da Bruno: quello di Mercurio, messaggero di una verità che non può essere pacificamente accettata dagli uomini. Proprio questa consapevolezza permette al nolano di divenire regista e attore della propria morte, gli consente di attuare quasi uno straniamento – per usare un linguaggio teatrale – nel dramma della propria fine. Quale importanza hanno avuto la vicenda e l’opera di Bruno per il pensiero e l’immaginario dei secoli successivi? Bruno rimane fuori dall’immagine di una modernità – quella di di Galileo, Cartesio, Spinoza – che interpreta il mondo attraverso le strutture della scienza; ma questa stessa modernità è molto più complessa e l’opera di Bruno, all’inizio diffusa in Inghilterra e soprattutto in Germania, ha viaggiato – anche clandestinamente, sotto le tonache degli stessi preti – più di quanto un tempo si pensasse. Nell’Ottocento, poi, il nolano è diventato in Italia un simbolo delle battaglie risorgimentali: in questo senso sono tornati utili sia il Bruno sostenitore della libertà di pensiero, sia il Bruno che polemizza contro l’“idra romana” e il Vaticano. Ma il dramma di Bruno, come ha scritto Gramsci, è europeo, non italiano: Bruno è una figura estranea all’Italia della Controriforma, che ha visto consumarsi la frattura fra scienza e vita. La complessa vicenda del suo scontro con la Chiesa (scontro inevitabile, inestricabilmente legato alla natura della ricerca bruniana, ma non cercato a priori) ne ha fatto un eroe della laicità, ma fa in realtà parte del suo essere un ossimoro vivente: la convivenza di passione e ragione, senso di grandezza e umiltà, malinconia e furore è il mistero della personalità di Giordano Bruno. (Gazzetta di Parma, 9 febbraio 2008) |
|
Post n°69 pubblicato il 17 Febbraio 2010 da CarloBajaGuarienti
|
|
Post n°68 pubblicato il 09 Gennaio 2010 da CarloBajaGuarienti
ISTITUTO DI STUDI RINASCIMENTALI DI FERRARA
XII Settimana Alti Studi Rinascimentali
Dagli Estensi al governo pontificio. La Legazione di Pietro Aldobrandini
Sala dei Comuni Castello Estense FERRARA 14, 15, 16 gennaio 2010 -------------------------------------------------------------------------- Provincia di Ferrara - Comune di Ferrara Fondazione Cassa di Risparmio .............................................................
GIOVEDÌ 14 GENNAIO
15,00 Saluto delle Autorità
PRESENTAZIONE CONVEGNO Gianni Venturi 15,30 Maria Antonietta Visceglia Il pontificato Aldobrandini. Linee di lettura della politica internazionale. 16,15 Maria Teresa Fattori Procedura e cerimoniale romano della Devoluzione. 17,00 Gigliola Fragnito Clemente VIII e l’inquisizione. Linee di ricerca.
VENERDÌ 15 GENNAIO 9,00 Giampiero Brunelli L’insediamento delle istituzioni pontificie. Nuove fonti. 9,45 Giovanni Ricci Devoluzione rituale. Nuovi sguardi sul 1598. 10,30 Federica Gargano Le carte della Legazione ferrarese del cardinale Pietro Aldobrandini. 11,15 Franco Cazzola Ferrara da Ducato a Legazione: problemi amministrativi, economici, territoriali (1598- 1606).
15,30 Francesca Cappelletti Pietro Aldobrandini collezionista fra Roma e Ferrara. 16,15 Ranieri Varese L'immagine di Ferrara nel XVIII secolo. 17,00 relazioni dei borsisti
SABATO 16 GENNAIO 9,30 Lorenzo Paliotto La Devoluzione e il vescovo Giovanni Fontana. 10,15 Carla Molinari Gli Aldobrandini e Torquato Tasso. 11,00 Roberta Ziosi “Spectacular, Spectacular! No words in the vernacula, Can describe this
Segreteria organizzativa Claudia Spisani ISTITUTO DI STUDI RINASCIMENTALI Via Boccaleone, 19 – 44121 Ferrara tel/fax 0532 760002-768208 isr@comune.fe.it // www.comune.fe.it/isr
|
|
Post n°67 pubblicato il 08 Novembre 2009 da CarloBajaGuarienti
Tag: arte, articoli, Aztechi, British Museum, eventi, Gazzetta di Parma, Londra, Messico, Moctezuma, mostre, Rinascimento, storia Al British Museum di Londra è visitabile fino al 24 gennaio 2010 la mostra «Moctezuma Aztec ruler». Carlo Baja Guarienti - Quando il popolo Mexica fuggì da Atzlan e giunse sulle rive del lago Tetzcoco, meta indicata dalle profezie, trovò una terra ostile e popoli pronti a dare battaglia. Allora Huitzilipochtli, dio della guerra e dei sacrifici, mandò un’aquila a segnare il punto in cui il re Tenoch avrebbe dovuto costruire la nuova capitale; in quel luogo – un’isola nel lago – sorse Tenochtitlan, la città sacra dalla quale i Mexica sarebbero partiti per creare un impero. L’arrivo degli Aztechi – o meglio Mexica, nome del popolo in lingua nahuatl – inaugurò l’ultimo splendido periodo della civiltà precolombiana in America centrale: nel XIII secolo essi iniziarono una conquista che li avrebbe portati a regnare su un’area vastissima fra le sponde dei due oceani. Oggi le rovine dei templi nascosti fra la vegetazione ci lasciano solo immaginare quale potesse essere l’aspetto di questo impero, ma i codici illustrati realizzati da artigiani spagnoli e indigeni per i primi conquistadores restituiscono l’immagine della capitale in tutto il suo splendore: strade dritte e spaziose, templi giganteschi e giardini rigogliosi, lunghi ponti per collegare l’isola alle rive del lago. Questi codici figurano ora fra i tesori della mostra «Moctezuma Aztec ruler», al British Museum di Londra fino al 24 gennaio 2010, il cui percorso espositivo rievoca la storia degli Aztechi - dalle origini leggendarie alla distruzione - attraverso la tragica vicenda dell’ultimo imperatore, Moctezuma II (1467-1520). I ritratti dipinti dopo la morte del sovrano ci mostrano un uomo fiero, coperto di gioielli e di armi: non è difficile immaginarlo alla testa dei due corpi scelti, i guerrieri-aquila e i guerrieri-giaguaro, sottomettere le popolazioni del Golfo del Messico. Più difficile raffigurarselo, dopo l’arrivo degli spagnoli, prigioniero e destinato a una morte i cui contorni ancora attendono di essere disegnati con precisione. Quando Hernan Cortés sbarcò a Veracruz, nel 1519, Moctezuma inviò ambasciatori e doni, forse credendo di riconoscere nell’uomo dalla pelle bianca il dio Quetzalcoatl ritornato al suo popolo; ma dopo sole due settimane Cortés fece imprigionare l’imperatore – atto che certamente suscitò stupore e orrore in un sovrano abituato per il suo status semidivino a non essere toccato da mani mortali – e gli spagnoli presero il potere. Lo spettacolo dell’arrivo dei conquistadores terrorizzò i nativi: i cavalli – sconosciuti all’America precolombiana – indossavano armature lucenti e gli uomini portavano spade di ferro e fucili ben più letali delle lame di ossidiana azteche. La fine del mondo, tanto temuta dai sacerdoti di Tenochtitlan ed esorcizzata attraverso il fiume di sangue dei sacrifici umani, non arrivò con la morte del sole pronosticata dalle profezie, ma con l’arrivo degli europei. Oggi le rovine di Tenochtitlan sono sepolte sotto le strade di Città del Messico, gigantesca metropoli sorta nel bacino prosciugato del lago Tetzcoco, e i discendenti di Moctezuma, integrati nella nobiltà spagnola attraverso matrimoni prestigiosi, vivono in Spagna come gli eredi di Cortés. Il destino della civiltà azteca, splendida e sanguinosa con le sue maschere di oro e turchese e gli altari sacrificali, si riassume in un eloquente oggetto visibile nella mostra del British Museum: una statua di Quetzalcoatl, il dio-serpente piumato, le cui spire minacciose di pietra sono state scavate per contenere l’acqua di un fonte battesimale. (Gazzetta di Parma, 7 novembre 2009) |
|
Post n°66 pubblicato il 04 Settembre 2009 da CarloBajaGuarienti
(J. Goodwin, I signori degli orizzonti, Einaudi 2009) Carlo Baja Guarienti - «Tutta la monarchia del Turco è governata da uno signore: gli altri sono sua servi». A questa caratteristica Niccolò Machiavelli, nel quarto capitolo del «Principe», riconduceva la capacità dell’impero ottomano di resistere agli attacchi esterni e, allo stesso tempo, la sua stabilità interna: al contrario degli Stati europei, la cui complessa articolazione sociale ha portato impresso per secoli il sigillo dei rapporti feudali, quello turco era fondato sulla distanza incolmabile fra il sultano – unica incarnazione del potere e fonte di legittimità – e la massa dei sudditi. La solidità dell’impero ottomano, monolite all’apparenza inattaccabile e macchina da guerra fra le più efficaci, è uno dei fattori costitutivi del sentimento ambiguo – quella miscela di terrore e fascino che Giovanni Ricci ha chiamato «ossessione turca» – nutrito dalle popolazioni dell’Europa mediterranea nei confronti del Turco. Nei resoconti dei viaggiatori e degli ambasciatori l’ammirazione per il meccanismo amministrativo e militare della Sublime Porta è tutt’uno con l’orrore per alcune sue usanze (come quella di uccidere tutti i fratelli del sultano in concomitanza con la successione) e con la paura ispirata dalle leggende sulla forza fisica e la devozione dei giannizzeri, corpi scelti di schiavi allevati per diventare l’anima di un esercito d’élite: terra di piaceri e orrori raccontati e spesso immaginati, l’impero del Turco ha a lungo soggiogato la fantasia dell’Europa moderna. Certamente affascinato dalla Turchia è Jason Goodwin, narratore e saggista formatosi a Cambridge, che dopo aver creato il detective eunuco Yashim – protagonista dei romanzi «Il serpente di pietra», «L’albero dei giannizzeri» e «Il ritratto Bellini» – ha scelto di raccontare nel libro «I signori degli orizzonti» (Einaudi, 355 pp., 32 €) la storia dell’impero ottomano dalle origini alla dissoluzione. Un libro che fonde abilmente narrativa e saggistica ricostruendo con dovizia di particolari scenari ed eventi: gli accampamenti militari come i mercati di Istanbul o i palazzi dei sultani, in cui si intrecciano amori e intrighi politici, sono vividamente ritratti dalla penna di Goodwin e formano un affresco appassionante. L’amore per la Turchia spinge però l’autore, in particolare nei capitoli dedicati ai secoli XV e XVI, a ritrarre per contrasto l’Europa – certamente disunita e pervasa da lotte religiose fratricide – come un continente in preda al caos: persino l’Italia di Machiavelli e Guicciardini, Leonardo e Michelangelo, Ludovico Ariosto e Veronica Gambara pare qui ridotta a una terra di confine risparmiata solo per caso dalla conquista turca. Il Dio dei cristiani, scrive Goodwin, «forse se l’era svignata con il favore della spessa nebbia fuori stagione» durante la caduta di Costantinopoli; ma – si può ribattere a questa visione – la storia ha dimostrato come l’Europa avesse mezzi culturali e militari sufficienti per non scomparire sotto l’onda ottomana. (Gazzetta di Parma, 17 luglio 2009) |
|
Post n°65 pubblicato il 20 Giugno 2009 da CarloBajaGuarienti
Tag: Aristotele, articoli, Cremonini, Gazzetta di Parma, Laterza, libri, Muir, musica, Rinascimento, storia (Edward Muir, Guerre culturali. Libertinismo e religione alla fine del Rinascimento, Laterza 2009) Carlo Baja Guarienti - Padova, 1591. Con una serie di assalti da parte di giovani studenti – in gran parte rampolli di nobili famiglie veneziane – cominciava la protesta contro il collegio gesuitico, colpevole principalmente di aver aperto i propri corsi ai laici facendo concorrenza al prestigioso ateneo patavino: erano le prime prove di uno scontro che, nel giro di pochi anni, avrebbe portato all’espulsione dei gesuiti dalla Repubblica di Venezia e alla fioritura – tanto difficile da immaginare a pochi decenni di distanza dal Concilio di Trento – del libertinismo. Il libertinismo padovano affondava le proprie radici nell’insegnamento di Cesare Cremonini, filosofo aristotelico che condivise con l’allora meno noto Galileo Galilei la docenza, l’affiliazione all’Accademia dei Ricoverati e l’ostilità del Sant’Uffizio: fra le righe degli appunti del maestro, accusato di negare attraverso Aristotele l’immortalità dell’anima, gli allievi di Cremonini lessero la possibilità di mettere in discussione i costumi, la religione, l’autorità paterna e il ruolo della donna nella società. In questo scenario, una sorta di laboratorio aperto per lo spazio di due generazioni alle sperimentazioni culturali più avanzate, si mossero figure straordinarie come Ferrante Pallavicino, prete ribelle dalla vita breve e avventurosa, e suor Arcangela Tarabotti, antenata delle rivendicazioni femministe. Edward Muir, docente alla Northwestern University e già autore di diversi saggi sul Rinascimento italiano, ricostruisce in Guerre culturali. Libertinismo e religione alla fine del Rinascimento (Laterza 2008, 16 €) l’ambiente delle accademie che diede origine, grazie ai mecenati libertini provenienti dalla nobiltà veneziana, alla stagione operistica culminata con «L’Incoronazione di Poppea» di Monteverdi. La protezione accordata dal Senato veneziano ai libertini e l’anonimato – simboleggiato dalle maschere del carnevale che conquistarono i palchi dei teatri – di una società abituata alla dissimulazione concorsero a rendere possibili quelle che Muir chiama «guerre culturali»: sussulti dai risvolti talora tragici, prodotti (scrive l’autore) «dalle tensioni fra il desiderio di liberazione e il bisogno di ordine, tra coloro che esploravano i limiti della tolleranza culturale sotto la tutela di Venezia e coloro che, soprattutto al di fuori di Venezia, aborrivano l’anarchia emozionale, intellettuale e spirituale che da tale tolleranza derivava». (Gazzetta di Parma, 18 giugno 2009) |
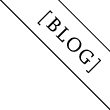
Inviato da: puzzle bubble
il 09/05/2012 alle 22:23
Inviato da: Davide
il 01/06/2010 alle 06:44
Inviato da: mondi
il 21/06/2009 alle 15:49
Inviato da: CarloBajaGuarienti
il 20/04/2009 alle 10:33
Inviato da: giane
il 09/04/2009 alle 00:26