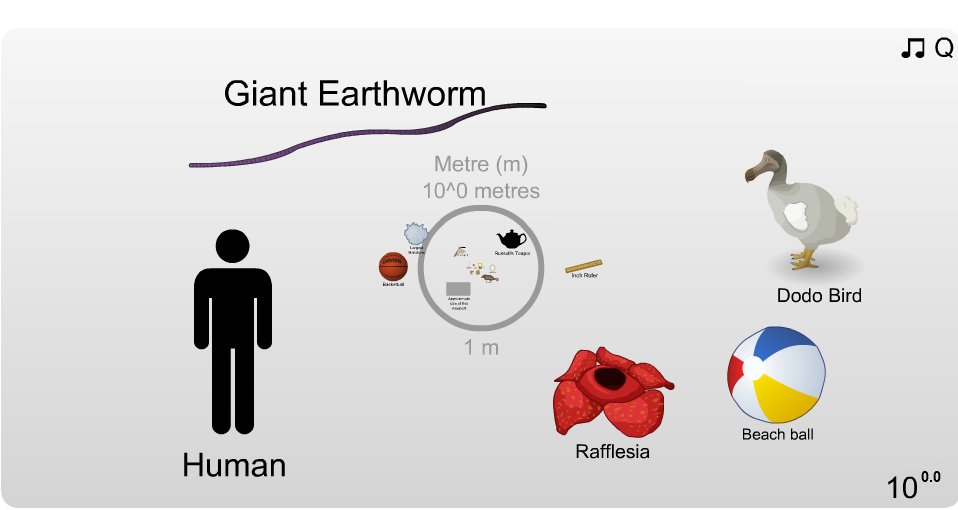|
Creato da m_de_pasquale il 05/10/2009
"il sapere ha potenza sul dolore" (Eschilo) ______________ "Perchè ci hai dato sguardi profondi?" (Goethe)
|
|
"La filosofia guarda da un altro livello cose, problemi, sofferenze, desideri, piaceri. E qui cade la solitudine del filosofo che non gode come gli altri, non soffre come gli altri, perchè non guarda le cose al livello dove le vedono gli altri. Per questo il filosofo è solo e incompreso. Della solitudine ringrazia ogni giorno gli dèi che gli tolgono di torno gli abitatori del tempo; dell'incomprensione si rammarica, non per sé ma per gli altri che non sanno quello che dicono e fanno." (Galimberti)
|
Post n°96 pubblicato il 01 Novembre 2012 da m_de_pasquale
|
|
percorso: cutino Tagliata (41°45'43.68" N, 16°03'52.04" E) – piscina la Signora – Iazzo S. Michele – abbazia della Trinità – cutino Tagliata [13 km] Anche questa montagna - l’antico monte Dodoneo consacrato al culto di Giove, poi cristianizzato con l’erezione di una chiesa dedicata alla Trinità -, come in genere ogni altura, ha una forza ierofanica (=rivelatrice del sacro) perché, come dice Eliade, “è più vicina al cielo, e qu |
|
Post n°94 pubblicato il 11 Maggio 2012 da m_de_pasquale
percorso: Baracconi (41°49'07.85" N, 15°59'55.74" E) - laghetto Umbra - coppa dei Prigionieri - caserma Murgia - laghetto d'Otri - caserma torre Palermo [AR 16 km] Difficilmente ci si addentra in un bosco o una foresta senza avere punti di riferimento. Ci muniamo di carta, bussola, gps per ricordare da dove partiamo, aver sempre chiaro dove |
|
percorso: baia Manacore (41°56'46.37" N, 16°02'46.20" E) - torre Calalunga - torre Usmai - torre Sfinale [AR 13 km] Nel XVI secolo uno dei più gravi pericoli per chi abitava in prossimità delle nostre coste era costituito dai turchi che potevano irrompere all’improvviso nei centri abitati seminando |
|
percorso: valle dell'Inferno (41°39'35.60" N, 15°47'56.30" E) - [5 km] Il nome è azzeccato: Valle dell’inferno, per il luogo impervio e difficile da abitare. Fa un certo effetto pensare che le caverne, di cui sono costellate le pareti scoscese, siano state abitate |
|
percorso: san Matteo (41°42'44.50" N, 15°39'37.07" E) - canale Fajarama - caserma Cutinelli - base scout - san Matteo [6 km] Nella misura in cui il nostro camminare nei boschi è rispettoso del luogo, abbiamo la possibilità d’incontrare per brevi attimi degli animali: può essere una esperienza piacevole |
|
percorso: Mergoli (41°45'08.69" N, 16°09'00.97" E) - Vignanotica [AR 4 km] La facoltà che entra in gioco quando si cammina in un paesaggio naturale non è prioritariamente quella dell’intelletto interessato alla spiegazione meccanica delle cose - tipica della conoscenza delle scienze che formula un giudizio determinante, secondo la definizione kantiana -, ma quella del sentimento che tende ad oltrepassare la riduzione oggettivante della conoscenza scientifica senza abbandonare l’orizzonte fenomenico in cui essa si svolge. Questo rapporto sentimentale col mondo è ciò che Kant definisce giudizio riflettente perché riflette sulla natura per comprenderla attraverso le nostre esigenze di finalità ed armonia. Una “riflessione” c |
|
percorso: ponte 13 archi (41°32'14.76" N, 14°56'47.87" E) - riva orientale lago di Occhito - diga [A 18 km] Il filosofo americano Thoreau, ad un certo punto della sua vita, decide di andare a vivere da |
|
Post n°87 pubblicato il 08 Febbraio 2012 da m_de_pasquale
percorso: Cassano (41°43'22.14" N, 15°52'34.79" E) – monte Titolone – cima di Summo – bosco Manfredonia – piscina s. Maria – coppa del Giglio – bosco Quarto – Cassano [12 km] Capita quando si cammina che, una volta che le gambe hanno preso il loro autonomo ritmo |
|
Post n°86 pubblicato il 01 Febbraio 2012 da m_de_pasquale
Come cambia la vita se viene vissuta nella dimensione dell’essere? Se viene vissuta come una e-sistenza nella costante polarità con l’essere e quindi in quella dimensione che abbiamo definito della trascendenza immanente? Una vita che lasci spazio alla fede filosofica, la possibilità che ci consente di coniugare l’immanenza con la trascendenza? Di sicuro sarebbe una vita coerente con la sua natura più propria (che è quella dell’oltrepassamento = ek-sistenza) e proprio per questo felice se è vero come ci ricorda Aristotele che la felicità coincide con la realizzazione dell’autentica natura dell’uomo. Cosa sarebbe la nostra vita interiore se non mantenesse costantemente la polarità con la trascendenza? Si appiattirebbe sulla maschera imposta dalla cultura, dalla società rimuovendo componenti della nostra interiorità verso le quali ci è impedito l’accesso. Accesso che coincide col processo d’individuazione, secondo la definizione junghiana, vale a dire la possibilità della trascendenza: solo andando oltre la mia parte conosciuta diventa possibile instaurare una relazione con la parte nascosta del mio io che contribuisce a vivificare la mia anima. Una delle esperienze – o, forse, l’esperienza - qualificanti la nostra vita è l’amore che quando è vissuto nella chiusura dell’immanenza si riduce a possesso, gelosia, godimento, sessualità ridotta a commercio di carne e quando si alimenta della pura trascendenza vive dell’idealizzazione astratta, impedendosi la possibilità dell’apertura dell’immanenza sulla trascendenza come avviene nella seduzione che col gioco vedere/non vedere apre uno spiraglio su un’ulteriorità di senso. Assecondando la natura dell’amore che è desiderio non sperimentiamo la mancanza che spinge all’azione e quindi alla trascendenza? E la passione, non gioca anch’essa con la trascendenza se la consideriamo come il turbamento per la messa in pericolo della mia identità nella disponibilità a trascendersi? Insomma è nella vera natura dell’amore non risolversi in un polo (immanenza = protezione, stabilità, misura, possesso, sicurezza) o nell’altro (trascendenza = rischio, oltrepassa mento della misura, eccesso, libertà), ma mantenere una costante polarità tra immanenza e trascendenza, appunto la trascendenza immanente. Un rapporto con la natura esercitato nell’ottica della sola immanenza, considerandola un fondo a disposizione, materiale da sfruttare per alimentare la logica del profitto, consente di cogliere in essa un rinvio all’Essere? E’ ancora possibile quello sguardo ingenuo capace di vedere nella montagna la possibilità di accedere al cielo cioè a quella parte che ci sovrasta e che è a noi ignota? Vedere nel sole e la luna il mistero della nostra vita che è un continuo morire/risorgere? Pensare alle acque come la fonte della vita e la possibilità di una rigenerazione? Meravigliarsi della stabilità delle rocce, della maestosità degli alberi, dell’infinita altezza del cielo? Un’etica che si muove nell’orizzonte della trascendenza immanente non possiede la sicurezza delle etiche che hanno solidificato la polarità tra trascendenza ed immanenza, che per assecondare il bisogno di controllo e dominio, esigenze della volontà di potenza, hanno redatto tavole di regole e prescrizioni da applicarsi universalmente e valide per ogni situazione. L’etica della trascendenza immanente è un’etica del rischio, della problematicità. Un’etica che non ha fondamenti ontologici a suo sostegno, non vive di certezze indubitabili, non prescrive comandamenti sicuri validi universalmente. E’ un’etica del viandante che vivendo passo per passo il solo paesaggio che attraversa, non ha punti di riferimenti certi come il viaggiatore che conosce la sua meta, ma decide di volta in volta ciò che è giusto fare avendo la consapevolezza che quanto deciso non può avere una valenza universale. Che ne è della politica se smarrisce la tensione con la trascendenza? Diventa esercizio del potere finalizzato all’interesse privato di singoli e gruppi: prevalenza dell’interesse privato sul bene comune. Diventa luogo del privilegio, dell’ingiustizia, dell’esclusione, della violenza. Chissà se Platone col suo comunismo che anteponeva l’interesse della polis a quello degli individui, Rousseau che prospettava la possibilità di una volontà generale capace di guadagnare una posizione che superasse le volontà individuali, Marx che anteponeva l’interesse collettivo della democrazia piena alla priorità dei diritti individuali predicati dal liberalismo borghese, non esprimano il progetto di radicare la tensione trascendente nella politica, la possibilità, cioè, di innescare un rinvio che faccia superare l’appiattimento sull’interesse particolare di gruppi ristretti e restituisca alla politica la tensione verso il bene comune. La perdita della dimensione dell’essere in economia si traduce nell’assolutizzazione della logica del profitto. Un oggetto nato come strumento per stabilire equivalenze negli scambi diviene il centro attorno a cui ruota il sistema economico: il denaro. Tutto viene sottoposto alla logica mercantile di scambio, tutto viene monetizzato (tradotto in denaro), ogni cosa ha un prezzo. Non solo le cose materiali ma anche quelle immateriali. Come insinuare la trascendenza nell’economia? Togliendo potere al denaro ed assegnandolo alle relazioni. Non è il denaro che ci fa vivere ma la possibilità di stabilire rapporti (andare oltre noi stessi = trascendenza) con gli altri. Passare da un’economia di mercato ad una economia delle relazioni che soddisfi i veri e necessari bisogni che gli individui hanno per essere felici. Una economia non più asservita al mito della crescita e dell’efficienza, ma rivolta al servizio e alla manutenzione, dove alla logica dello scambio va preferita la logica della reciprocità che rafforza la solidarietà tra gli individui. (sacro - 10 precedente) |
|
Se la musica non è abitata “dal linguaggio, dalla ponderatezza del pensiero, dal travagliato acquisire della riflessione”, ma – come dice Kirkegaard – “in questo regno risuona soltanto la voce elementare della passione, il gioco dei desideri, il chiasso selvaggio dell’ebbrezza, si gode soltanto in eterno tumulto”, essa potrebbe favorire la possibilità di accesso a quella parte più profonda e meno nota della nostra anima che ha a che fare col sacro. Sembrerebbe che l’udito più degli altri organi sensoriali abbia una potente capacità trascendente in grado di farci superare il confine e il limite: se la parola della nostra bocca è chiusa in significati ben definiti perché soggetta alle leggi della logica, se la vista del nostro occhio circoscrive e delimita l’orizzonte visibile, il suono percepito dal nostro udito è in grado di inoltrarci in sensi che stanno al di là di tutti i significati codificati. In questo senso Valentina afferma: “Se è vero che nel momento folle, dove l' Es prende il sopravvento, non ci sono più dimensioni come quella del tempo, dello spazio, del limite, della mortalità e dal punto di vista cognitivo tutto si esprime con immagini e simboli, direi che ascoltare la musica per me vuol dire essere in questo 'stato', entro certi limiti”. La musica è come un viaggio – dice Martina – che permette di raggiungere i luoghi più profondi della propria interiorità: “La musica, unitamente al contesto (la notte, il buio, il fatto di essere soli), genera sensazioni che personalmente ritengo talmente intense da poter essere paragonate a quelle di alcune droghe, visto che è un vero e proprio viaggio della mente per me: ascoltare e seguire le note è come finire in un vortice, è come se venissi ipnotizzata, la mia mente genera un flusso ininterrotto di immagini e pensieri non ben definiti, che finisce solo quando finisce la musica”. Un viaggio capace di suscitare emozioni intensissime come dice Francesca: “Non riesco a descrivere bene quello che ho provato, ma ho sentito un brivido dall’addome che è salito fino alla gola passando per il cuore, e li si è bloccato … come quando ti viene da piangere e non ci riesci”. Una irruzione sconvolgente nella propria esistenza come racconta Tonia: “Ci sono canzoni che mi fanno salire i brividi, che mi fanno scendere le lacrime … di solito quando mi commuovo, quando ho brividi, quando sto quasi per levitare in aria come uno che medita, allora quella canzone è riuscita a smuovere qualcosa di recondito in me! Non sempre il testo è chiaro ed esplicito e, tuttavia, mi emoziona. Magari alcune le ascolti e chi le canta ti sembra un usurpatore perchè ti ha invaso … senza che tu te l'aspettassi si è appropriato di te e, quando la canzone finisce, tu rimani sola a raccogliere gli stracci che ha lasciato di te…”. Un viaggio che sembra un ritorno a quel dedalo di emozioni che ci costituisce nel profondo, di stati d’animo che la musica ha il potere di evocare facendoci sperimentare una profonda nostalgia, fornendoci, però, anche la possibilità di riconoscere queste emozioni per averne intelligenza. Una possibilità che è data solo alla musica come pensa Giusy: “Non so spiegare benissimo quale sia il nesso tra la musica e la mia anima, potrei dire però che essa arriva lì dove non arriva l'italiano, o le urla o la paura o uno schiaffo o un bacio”. La funzione evocatrice della musica può non solo essere subita come quando è lo stato d’animo ad influenzare il tipo di musica che si intende ascoltare, ma può essere anche provocata affinchè favorisca l’emergere di determinate emozioni affermandosi, così, un ruolo più attivo della nostra intelligenza. L’individuo aspira ad una condizione dove, finalmente, può sperimentare lo stato di quiete originaria che rappacifica la sua incessante esperienza dei contrari, dove non conosce più lo scarto tra la possibilità e le sue realizzazioni, quella condizione d’identificazione col tutto che le religioni identificano con l’esperienza di Dio. Questa condizione diventa accessibile con la musica a sentire le sensazioni raccontate da Antonella a proposito dell’ascolto di una melodia di Einaudi: “Le note che ascoltavo mi hanno letteralmente catturata e ne sono rimasta incantata. In quel momento è come se il tempo si fosse fermato, tutto attorno fosse sparito ed io ero totalmente rapita da questa melodia … non avevo nessun pensiero per la mente, sentivo solo queste note che mi attraversavano e mi tenevano ferma e immobile per farsi ascoltare. Poi l’ho risentita ancora e ancora e ancora … e ogni volta era una sensazione diversa. A volte mi trasmettevano una pace assoluta, per la loro armonia e il loro ordine. Forse è proprio questo il potere di questa canzone: ogni nota è al posto giusto e non potrebbe essere altrove, e allora ne sono catturata perché forse trovo lì quella perfezione che fuori non c’è, ci trovo quell’ordine e quella serenità che forse dentro me a volte non ho. È come se anche la mia anima cominciasse a danzare in equilibrio con lo scorrere di queste note, e allora trovo un senso di pace e serenità, e sto lì, ferma, senza pensare a niente”. Se l’armonia della musica riproduce la situazione della quiete originaria a cui aspiriamo, è anche vero che esiste un altro tipo di musica che rinvia alle nostre origini, quella musica che riproduce la ritmicità del linguaggio originario: la musicalità del corpo (il battito del cuore, la ritmicità del respiro), della natura (il ritmo giorno/notte). Una musica che esprime l’urto della contraddizione, quella dei seguaci di Dioniso che seduce, inebria, si impossessa degli animi. Una musica che diventa tutt’uno col corpo inserendolo nel flusso dell’energia vitale come ci raccontano Valentina, Silvia ed Antonella. “ La musica ritmica, ripetitiva ha fascino sui giovani perchè a mio parere sono molto legate al ballo, al caos della discoteca, luci, gente e anche un pò di alcool ... Sento questo tipo di musica col movimento del corpo, … il corpo segue la musica; in quel momento non penso a molto e come se staccassi davvero la mente da ogni moralità, preoccupazione per i problemi piccoli o grandi; si scatena l'energia vitale che si ha dentro, non si può fare a meno di muoversi”. “A noi giovani piacciono musiche dal ritmo cadenzato e primitivo perchè risvegliano quella parte più nascosta di noi, quella istintiva e primitiva per l'appunto, che le convenzioni ci invitano a mettere sempre da parte … ed ecco quindi che balliamo, in cerchio, come dei pazzi, agitando le braccia e la testa con un fare quasi scimmiesco. E' come ritornare nell'era primitiva, in quei locali con le luci psichedeliche e una musica assordante: sono catapultata in un mondo totalmente diverso, che mi altera nel vero senso della parola”. “Fin da subito mi vien da muovere i piedi e la testa a ritmo di musica, un ritmo forte e ripetitivo. Questo tipo di musica trasmette forza, energia, ti entra dentro e ti da carica. Questi ritmi semplici così primitivi forse risvegliano in te un essere quasi primordiale, che ti fa sentire indomito, libero, quasi fuori dalle convenzioni e dalla civilizzazione. È come annullare la cognizione e l’evoluzione e tornare un tutt’uno con la natura, fatta di ritmi e cicli. Quindi forse i giovani amano questa musica proprio perché permette di uscire dai limiti delle convenzioni e tornare al puro istinto. Il ballo è energia. Non contano i movimenti o la perfezione di un passo, l’importante è farsi travolgere dalla musica. È essenziale annullare una parte di noi: la ragione. E lasciare che tutto il resto prenda il sopravvento: l’anima, il cuore, l’istinto, l’inconscio, la forza fisica, l’irrazionale …. non è più la mente a guidarci, ma tutto quello che è fuori controllo. Non ci sono regole, ed è proprio questo che permette di farci accedere alla parte più nascosta di noi. Che sia un semplice muovere i piedi, oscillare, o saltare … l’importante è sentirsi liberi. In quel momento è l’anima che ti guida. A volte quando sento la musica c’è qualcosa dentro che mi spinge a danzare energicamente, e vorrei farlo fino allo sfinimento. Ma c’è qualcosa che mi frena, e questa è la ragione, con le sue convenzioni e la sua timidezza”. In che rapporto sono la musica armonica con quella disarmonica? Sono due modi autonomi di fare musica oppure la dissonanza della disarmonia può essere godimento solo se ha in vista la consonanza dell’armonia? La dissonanza che riproduce l’inquietudine dell’individuo, il tormento derivante dai limiti della sua condizione, ha in sè naturalmente il desiderio della consonanza, della composizione dei contrari? Probabilmente la verità è nel mantenimento della polarità e pertanto la musica custodisce la sua natura utopica (e quindi è un organo della trascendenza) quando esprime costantemente lo scarto che esiste tra ciò che siamo e la sua possibilità. Le citazioni sono relative agli interventi di alcuni miei ex studenti che si sono prestati a rispondere alle mie domande sul ruolo della musica nella loro esperienza. (sacro - 7 precedente seguente) |
|
Sarà l’essenzialità di questa montagna (non c’è vegetazione, un monte calvo come dice il suo nome) che attenua ogni movimento, sarà il suono monotono del silenzio dell’altezza che riecheggia nelle orecchie, ma l’impressione prevalente che si avverte è quella della sospensione dello scorrere del tempo che fa pensare alla definizione platonica del tempo: immagine mobile dell’eternità. |
|
Si ritiene che la forma più certa di conoscenza che possiamo mettere in atto sia quella oggettiva che risolve la realtà nella relazione soggetto/oggetto (conoscenza scientifica), dove il soggetto non è il singolo ma una sorta d’intersoggettività intellettuale (e pertanto la conoscenza è valida universalmente) e l’oggetto è la realtà risolta nella sua datità (un oggetto definibile, controllabile). Ma quanto questo sapere razionale è in grado di comprendere l’e-sistenza? Quanto i suoi strumenti sono adatti a trattare la singolarità e la soggettività di una Esistenza, il nascondimento dell’Essere, l’inoggettivabilità della Trascendenza? Jaspers sostiene che occorrerebbe una sorta di “alogica razionale”, una fede: “Nel filosofare l’uomo trapassa la sua condizione naturale in forza della propria essenza. Ciò che nella rottura gli si rivela come essere e come se stesso è la sua fede”. Insomma se la filosofia intende oltrepassare i significati costruiti dal sapere scientifico, ha bisogno di una fede grazie alla quale il dato non è semplicemente assunto come un oggetto da analizzare, definire, controllare, ma come qualcosa che rinvia ad un’ulteriorità. E’ ciò che Jaspers definisce fede filosofica [filo-sofica perché ama (phìlei), si protende verso la sapienza (sophìa), ma non la possiede] che realizza l’autentica essenza dell’uomo: essa è ricerca che non trova compimento perché non solidifica l’oggetto isolandolo nell’immanenza o separandolo nella trascendenza, ma mantiene quella polarità per cui il suo spazio è quello della trascendenza immanente. Se questo è il suo orizzonte, la fede filosofica è l’unica in grado di dischiudere il senso delle cifre, ovvero quelle tracce lasciate dalla trascendenza nella nostra esperienza, l’annuncio dell’ulteriorità presente nelle situazioni-limite di cui si parlava precedentemente. Cifre che risulterebbero incomprensibili per il sapere della scienza che ha necessità di oggettivare e quindi isolare nello spazio dell’immanenza. Proprio perché sfugge ad ogni definizione che pretende di chiarire ed esaurire tutti i sensi della realtà, la fede filosofica è problematica. Ma è anche rischiosa perché non cedendo alla sicurezza della solidificazione delle cifre, rimane aperta ad ogni prospettiva e quindi anche all’insuccesso. La consapevolezza della problematicità della cifra e del rischio sono gli elementi che consentono di distinguere la fede filosofica da quella religiosa. Ambedue credono che la verità non è compiutamente svelata nell’immanenza; ma, mentre la fede filosofica – che opera nella polarità della trascendenza immanente - è consapevole della debolezza della sua verità perché non ha il carattere di universalità che potrebbe avere solo una verità scientifica, la fede religiosa – che separa immanenza dalla trascendenza - pretende di trattare con le logiche del sapere scientifico, finalizzate alla definizione di verità universali, contenuti ricadenti nel lontano orizzonte della trascendenza. Come è possibile riconoscere un carattere di necessarietà - e quindi di validità universale – a contenuti che esulano dalla nostra esperienza perché ritenuti espressione di una trascendenza assoluta (= sciolta da ogni immanenza)? L’unica possibilità è quella di una fede che si opponga alla ragione qual è appunto la fede religiosa le cui verità pretendono di avere un carattere di certezza assoluta da escludere ogni altra posizione. Si potrebbe dire che la fede religiosa, conferendo alla trascendenza un’autorità assoluta nel mondo, sostituisce alla volontà di verità la volontà di potenza? La stessa volontà di potenza che troviamo all’origine del sapere scientifico e che trova le sue manifestazioni nel “dominio” della scienza e nel “potere” della tecnica. Insomma scienza e fede religiosa che avevamo pensate come contrapposte, in realtà hanno una medesima origine: la volontà di potenza! I segni di questa prepotenza sono individuabili anche in quelle che Jaspers chiama “deviazioni” subite dai caratteri fondamentali della religione biblica: il Dio uno che uccide il molteplice; il Dio trascendente che è separato dal mondo; il Dio persona che favorisce l’egocentrismo dell’anima che lo prega; i comandamenti di Dio che da semplici fondamenti etici acquisiscono rilevanza giuridica tali da regolare ogni aspetto della vita umana; la concezione masochista o sadica del dolore pensandolo come sacrificio a Dio. La volontà di potenza assolutizza il creduto e fa del credente un militante disposto a qualsiasi forma di lotta per difendere quella fede che impropriamente ha scambiato per verità. Confessa Jaspers: “E’ una sofferenza della mia vita, che si affatica nella ricerca della verità, il constatare che la discussione con i teologi si arresta sempre nei punti più decisivi, perché essi tacciono, enunciano qualche proposizione incomprensibile, parlano d’altro, affermano qualcosa d’incondizionato, discorrono amichevolmente senza avere realmente presente ciò che prima s’era detto, e alla fine non mostrano alcun autentico interesse per la discussione. Da una parte, infatti, si sentono sicuri, terribilmente sicuri nella loro verità, dall’altra parte pare loro che non valga la pena prendersi cura di noi, uomini duri di cuore. Ma un vero dialogo richiede che si ascolti e si risponda realmente, non tollera che si taccia o si eviti la questione, e soprattutto esige che ogni proposizione fideistica, in quanto enunciata nel linguaggio umano, in quanto rivolta a oggetti appartenenti al mondo, possa essere messa di nuovo in questione, non solo esteriormente e a parole, ma dal profondo di noi stessi. Chi si trova nel possesso definitivo della verità non può più parlare veramente con un altro, perché interrompe la comunicazione autentica a favore del proprio contenuto di fede”. La fede filosofica, invece, consapevole che le sue verità sono singolari e non universali, e pertanto includenti e non escludenti, preferisce il dialogo e non la lotta perché all’assolutizzazione della propria posizione preferisce la comunicazione: “La fede filosofica è inseparabile dalla disponibilità incondizionata alla comunicazione, perché la verità autentica nasce dall’incontro delle fedi nella presenza dell’Umgreifende. Di qui l’affermazione: solo i credenti possono realizzare la comunicazione. Di contro, la non-verità nasce dalla fissazione dei contenuti della fede che si respingono l’un l’altro, donde l’affermazione: non si può parlare coi militanti di una fede determinata. Per la fede filosofica tutto ciò che costringe a interrompere la comunicazione o tenta di farlo è diabolico”. (sacro - 9 precedente seguente) |
|
Post n°82 pubblicato il 21 Dicembre 2011 da m_de_pasquale
Heidegger individua nella trascendenza il modo di esser proprio dell’uomo, “è qualcosa di appartenente all’Esserci dell’uomo non come suo comportamento possibile fra altri, ma come la costituzione fondamentale di questo ente, precedente ogni altro comportamento possibile”. La trascendenza è la tensione aperta tra l’Esserci (=l’ente-uomo la cui esistenza è individuata spazio-temporalmente) e l’Essere, badando bene ad intendere quest’ultimo non come un “oggetto” alla stregua degli altri enti, altrimenti la tensione scadrebbe nel possesso, nell’oggettivazione, nel controllo. E’ vero che il nostro desiderio di conoscenza si placa solo se ha di fronte un oggetto (= sapere oggettivabile) che è possibile guardare, analizzare, definire, controllare: ma è ancora l’Essere ciò che definiamo e controlliamo? Heidegger denuncia l’incomprensione e quindi l’oblio dell’Essere da parte della metafisica occidentale proprio perché l’Essere è stato trattato come un ente con la possibilità di oggettivarlo e controllarlo. Probabilmente serve un sapere inoggettivabile (una fede?) per potersi aprire a “ciò che fa essere gli enti” ovvero alla condizione del loro esserci. Una riduzione dell’intervento umano per lasciare spazio allo svelamento (aletheia) dell’Essere, per poter cogliere questa presenza che in ogni ente si annuncia sottraendosi. Jaspers, affascinato dal Tutto avvolgente di Anassimandro, lo definisce Umgreifende che significa “ciò che, afferrando, circoscrive gli enti”. La trascendenza, pertanto, in quanto apertura all’Essere rappresenta il carattere costitutivo dell’Esistenza (= il modo d’essere dell’Esserci): l’uomo non è un ente tra gli enti, ma è colui che può sollevarsi dalla datità per emergere dall’orizzonte dell’oggettività empirica ed aprirsi alla comprensione dell’Essere. Un’apertura sperimentabile in quelle che Jaspers definisce situazioni-limite, “situazioni come quella di dover essere sempre in una situazione, di non poter vivere senza lotta e dolore, di dover assumere inevitabilmente la propria colpa, di dover morire … sono situazioni che sfuggono alla nostra comprensione, così come sfugge al nostro esserci ciò che sta al di là di esse; sono come un muro contro cui urtiamo e naufraghiamo”. Nell’esperienza del limite le cose del mondo divengono scrittura cifrata, equivoco perché pur essendo nell’immanenza rimandano alla trascendenza. Oltre che dalla comprensione dell’Essere, l’Esistenza è qualificata dalla possibilità nel senso che l’essenza del nostro esserci non è data una volta per sempre, non è una realtà fissa e predeterminata, ma si costruisce nel riferimento a qualcosa che è al di fuori e al di sopra dell’esserci empirico; essa coincide con l’Esistenza (= ek-sistenza: star fuori) e si annuncia: “a) nell’insufficienza che l’uomo sperimenta in se stesso, quando avverte che c’è sempre in lui qualcosa di incommensurabile per il suo esserci, il suo sapere e il suo mondo spirituale; b) nell’incondizionatezza del suo autentico esser-se-stesso a cui l’uomo sottomette il suo esserci, e da cui sente derivare ciò che per lui è significativo e valido; c) nello slancio verso l’unità di cui l’uomo non può fare a meno perché non si accontenta di un solo modo dell’Umgreifende, e nemmeno di tutti i modi riuniti, ma tende all’unità del fondamento, unità che si identifica con l’essere e l’eternità; d) nella coscienza di una incomprensibile reminiscenza, simile a una coscienza partecipata con la creazione o al ricordo di una visione anteriore alla sua presenza nel mondo; e) nella coscienza dell’immortalità, che non è una continuazione della vita in un’altra forma, ma un rifugio nell’eternità che sopprime il tempo, e che all’uomo appare come il cammino inevitabile dell’azione efficace nel mondo” (Jaspers). E’ chiaro, quindi, che se noi sentiamo di essere più di quello che riusciamo a realizzare, abbiamo la necessità di andare oltre, di progettare, di trascendere: la trascendenza ci è connaturata. Perciò Jaspers alle domande: “c’è qualche motivo che giustifichi questo trascendere? Non siamo soddisfatti nel mondo degli oggetti? Tutto ciò di cui noi abbiamo bisogno, tutto ciò a cui noi riconosciamo un essere, non è lì davanti a noi oggettivamente, e questo mondo non è tutto?”, può rispondere: “il trascendere nasce nell’inquietudine che si prova davanti alla fugacità di tutto l’esserci, e che senza il trascendere sarebbe ineliminabile”. (sacro - 8 precedente seguente) |
|
Post n°81 pubblicato il 13 Dicembre 2011 da m_de_pasquale
percorso: c. Pezzente (41°46'24.92" N, 15°50'6.54" E) - coppa del Monaco - bosco Spigno - caserma delle guardie - c. Pezzente [12 km] Tradizionalmente il bosco, per la sua natura caotica e selvaggia, è sempre stato associato ad una esperienza inquietante e minacciosa. Se fatta nella stagione fredda, in una mattinata nebbiosa che a fatica fa penetrare i raggi del sole, nel sonno silenzioso della natura invernale dove si amplifica anche il più piccolo rumore, la camminata solitaria nel bosco può riservare sensazioni uniche capaci di farci accedere alla parte più antica e remota della nostra psiche. Quella parte in |
|
Post n°80 pubblicato il 02 Dicembre 2011 da m_de_pasquale
Abbiamo individuato nella tensione – intesa come apertura alla dimensione simbolica che consente all’uomo di vivere la natura come una ierofania - l’essenza della capacità di trascendenza. Se la tensione è anche l’essenza dell’amore, l’amore è trascendenza ovvero possibilità dell’esperienza del sacro. Platone ci spiega queste cose nel Simposio quando racconta il mito della nascita di Eros. Nel giorno della nascita di Afrodite, gli dèi celebrano l’evento con un banchetto a cui partecipa anche Poros (= astuzia, espediente). Penìa (= povertà), venuta a mendicare qualcosa, avendo visto Poros ubriaco ed addormentato nel giardino di Zeus, si sdraia al suo fianco con l’intento di avere un figlio. Rimane incinta e partorisce un figlio, Eros, che eredita dalla madre il carattere di costante bisogno perché la povertà alimenta il desiderio, e dal padre l’astuzia e cioè la capacità di riuscire ad ottenere ciò che desidera. Platone coglie bene la natura di costante tensione ma anche di lacerazione che caratterizza l’esperienza d’amore: quando l’oggetto del desiderio non è ancora posseduto si soffre per la sua mancanza, ma quando lo si è raggiunto la tensione non si placa completamente, come se esistesse un’eccedenza tra desiderio e realizzazione. Insomma sembra che l’amore sia caratterizzato da una contraddizione: se da una parte desidera l’oggetto d’amore e soffre finchè non lo raggiunge, e poi, una volta raggiunto, ricorda con nostalgia la condizione precedente in cui desiderava, vuol dire che l’essenziale nell’amore non è tanto il raggiungimento dell’oggetto, quanto quello di vivere costantemente uno stato di tensione. Tensione finalizzata a che cosa? Quale potrebbe essere il vero oggetto del suo desiderio? Verso cosa rinvia la sua capacità di trascendenza? Anche Freud coglie la contraddizione dell’amore quando afferma che “dove amiamo non proviamo desiderio, e dove lo proviamo non possiamo amare”. Sembra quasi che la tensione non debba mai concludersi con un possesso perché la forza dell’amore è nel desiderio costante. Dice Stendhal che il desiderio deve rimanere sempre desto grazie al dubbio e all’incertezza così da alimentare la scintilla della passione che la certezza, invece, uccide. Nella passione perdiamo il controllo, subiamo l’attrazione – che è una tensione - verso l’amato (forse sarebbe meglio dire verso la nostra idealizzazione dell’amato), un’attrazione che dura finché si nutre del “non ancora” divenendo, come direbbe Levinas, “godimento del trascendente … perché l’amore è una relazione con ciò che si sottrae per sempre e che è impossibile tradurre in termini di potere”. Quando l’amore si risolve nel possesso, come accade nell’esperienza del piacere sessuale, la passione svanisce perché il possesso interrompe la tensione e non rinvia più alla trascendenza. Insomma siamo attratti da ciò che non vediamo; direbbe Baudrillard che “l’assenza seduce la presenza”. Non ci attrae ciò che è chiaro, ma ciò che intravediamo perché solo così si mantiene quella tensione che altrimenti verrebbe dissolta. Sempre Platone nel Simposio, probabilmente, potrebbe fornirci delle indicazioni interessanti per rispondere alla domanda riguardante il vero oggetto della tensione che caratterizza l’amore. Dopo aver raccontato della decisione di Zeus di dividere a metà i primi uomini, parlando dell’attrazione provata da questi esseri nel momento in cui incontrano l’altra metà di se stessi, scrive: “E queste persone che passano la loro vita gli uni accanto agli altri non saprebbero nemmeno dirti cosa si aspettano l’uno dall’altro. Non è possibile pensare che si tratti solo delle gioie dell’amore: non possiamo immaginare che l’attrazione sessuale sia la sola ragione della loro felicità … c’è qualcos’altro: evidentemente la loro anima cerca nell’altro qualcosa che non sa esprimere e perciò la esprime con vaghi presagi, come divinando da un fondo enigmatico e buio”. Non il desiderio dell’unione dei corpi, ma qualcos’altro costituisce il vero oggetto di desiderio dell’amore: la tensione verso quella parte di sé sconosciuta che egli definisce “fondo enigmatico e buio”. Potremmo pensare che ciò che noi siamo abituati a far coincidere con l’amore, vale a dire il rapporto simbiotico tra due amanti, costituisca non il fine ma il tramite, la via per giungere ad incontrare il fondo enigmatico e buio? La sessualità quando coincide con l’esperienza del cedimento dell’Io – l’Io che perde il suo potere di controllo e pertanto muore (Bataille ci ricorda che in francese orgasmo si dice petite morte) – non apre forse sul vuoto facendo sì che questa assenza attragga più della presenza dell’amante? E se il vuoto attrae più del pieno, si può ben dire che l’amore è trascendenza. L’attrazione del vuoto è il richiamo esercitato dalla parte ignota di noi. Affacciarsi sulla parte ignota di noi significa immergersi nella follia che abita il fondo enigmatico e buio. Follia intesa come quella condizione che precede ogni distinzione, dove convivono tutti i sensi possibili, regno del caos, del disordine, della confusione. E’ un rivivere la dinamica di morte e resurrezione che abbiamo visto operante nei cicli della natura: l’Io muore / si immerge nella follia da cui proviene / rinasce in nuove configurazioni. Una periodica immersione nella follia - nel sacro – che si rivela importante per la nostra salute se Platone può affermare che “i beni più grandi ci vengono dalla follia naturalmente data per dono divino. La follia del dio proveniente è assai più bella della saggezza di origine umana”. (sacro - 6 precedente seguente) |
|
Otto individua una serie di fenomeni che rubrica nella fase ingenua dell’evoluzione umana e che considera come “l’atrio della religione”: “Essi sono la credenza nei morti e il loro culto, la credenza e il culto degli spiriti, la magia, le saghe e i miti, la venerazione dei fenomeni naturali, terribili o mirabili, nocivi o vantaggiosi, la strana idea del potere, il feticismo e il totemismo, il culto delle piante e degli animali, il demonismo”. Tralasciando il suo giudizio di valore su dette manifestazioni, per noi è interessante approfondire l’esperienza religiosa della natura nelle società premoderne perché, trattandosi di uno sguardo originario libero da ogni sovrastruttura successiva, ci permette di cogliere nella sua essenzialità quella che abbiamo definito funzione trascendente dell’uomo che si manifesta nella possibilità di andare oltre ed al di là dei significati imposti dalla ragione, cogliendo la dimensione simbolica capace di vivere la natura come una ierofania (= manifestazione del sacro). Grazie ai simboli – sostiene Eliade – l’uomo esce dalla sua situazione particolare per aprirsi al generale ed universale: “Di fronte a un albero qualunque, simbolo dell’Albero del Mondo e immagine della Vita cosmica, un uomo delle società premoderne è capace di raggiungere la più alta spiritualità: comprende il simbolo, è in grado di vivere l’universale”. Gli elementi fisici osservati dall’uomo religioso - per il quale non è ancora prevalente lo sguardo scientifico - acquisiscono una dimensione simbolica, rinviano, cioè, ad un “significato” che non coincide con quello ordinario assegnato all’elemento. Questo significato potremmo interpretarlo come la risposta che l’uomo costruisce per soddisfare la domanda generata dalla sua capacità di trascendenza. Se si passano in rassegna i più ricorrenti significati che l’uomo religioso ha attribuito agli elementi della natura, potremmo sperare di capirci qualcosa di più sulla domanda, ovvero su quei bisogni originati dal fondo oscuro che ci abita e che abbiamo identificato col sacro: il tutto che appaghi il desiderio di superamento della sua condizione di precarietà; i significati in cui possano riflettersi le esperienze e le dinamiche fondamentali della vita. L’infinita altezza del cielo rinvia alla sacralità dello stesso: “La contemplazione della volta celeste, da sola, suscita nella coscienza primitiva un’esperienza religiosa ... questa contemplazione equivale, per lui, a una rivelazione. Il Cielo si rivela quel che è in realtà: infinito, trascendente. La volta celeste è per eccellenza cosa del tutto diversa dalla pochezza dell’uomo e del suo spazio vitale … L’alto è una categoria inaccessibile all’uomo in quanto tale; appartiene di diritto alle forze e agli esseri sovrumani” (Eliade). Nell’infinita distanza del cielo, nei suoi spazi immensi non si rispecchia forse e riesce a trovar pace l’ignota profondità del mio essere? Nel simbolismo dell’altezza, dell’ascensione, del centro, si colloca la forza ierofanica della montagna che “è più vicina al cielo, e questo le conferisce una doppia sacralità: da un lato partecipa al simbolismo spaziale della trascendenza (alto, verticale, supremo, ecc.), e d’altra parte il monte è per eccellenza il dominio delle ierofanie atmosferiche … il monte, in quanto punto d’incontro fra cielo e terra, si trova al centro del mondo ed è sicuramente il punto più alto della terra” (Eliade). Se il centro è l’origine – ombelico della terra, punto d’irradiazione dell’energia della vita – da cui sono nate le differenze che per loro natura sono parziali e quindi hanno bisogno di completamento, potremmo interpretare il fascino del suo richiamo come una nostalgia delle origini? Se l’altitudine ha una virtù consacrante, il simbolismo dell’ascensione non è forse espressivo della capacità trascendente dell’uomo come possibilità di sporgersi su quel fondo ignoto e misterioso della sua interiorità? “Ogni ascensione è una rottura di livello, un passaggio nell’oltretomba, un superamento dello spazio profano … Trascendere la condizione umana, in quanto si penetra in una zona sacra” (Eliade). Il Sole incarna il simbolismo del viaggio nell’oscurità che si conclude sempre con un ritorno; il tramonto è percepito non come la sua morte, ma come discesa dell’astro nelle regioni inferiori. Diversamente dalla Luna, il Sole ha il privilegio di attraversare l’inferno senza subire la modalità della morte: “Scendendo ogni notte nel regno dei morti, il Sole può condurre gli uomini con sé e, tramontando, farli morire; d’altra parte, può contemporaneamente guidare le anime attraverso le regioni infernali e ricondurle alla luce l’indomani, col giorno” (Eliade). Insomma è come se il Sole - per la sua forza e immutabilità attestata dal fatto che non viene scalfito dalla morte - rappresentasse quella sicurezza, a cui aspiriamo, di ritornare indenni dal nostro viaggio nell’ignoto. La Luna invece cresce, cala e sparisce “la sua vita è soggetta alla legge universale del divenire, della nascita e della morte. Precisamente come l’uomo, la luna ha una storia patetica, perché la sua decrepitezza, come quella dell’uomo, termina con la morte. Ma questa morte è seguita da una rinascita: la luna nuova … La Luna rivela all’uomo la propria condizione umana: l’uomo guarda sé stesso e si ritrova nella vita della Luna” (Eliade). Diventando uno dei simboli più potenti della legge del divenire, la forza ierofanica della Luna si incarica di rispondere agli interrogativi che la ciclicità, la polarità, il conflitto e la conciliazione dei contrari pongono all’uomo. Infatti in buona parte dei temi collegati alla Luna quali la fecondità (ad es. il collegamento tra le fasi lunari e il ciclo mestruale), la rigenerazione periodica (vedi il simbolismo del serpente, animale lunare, perchè si rigenera cambiando pelle), il tempo e il destino (la luna che tesse i destini), il cambiamento segnato dall’opposizione luce-oscurità (luna nuova/luna piena), l’idea dominante è quella del ritmo ottenuto mediante la successione dei contrari. Le acque simboleggiano la sostanza primordiale, fonte di vita, da cui nascono tutte le forme e alle quali tornano, esse precedono ogni forma e sostengono ogni creazione: l’immersione nell’acqua simboleggia la regressione nel preformale, la dissoluzione delle forme; l’uscita dalle acque ripete il gesto cosmogonico della manifestazione formale. Il contatto con l’acqua, quindi, implica sempre una rigenerazione, una nuova nascita. La capacità purificatrice dell’acqua che abolendo ogni storia fa morire il passato restaurando l’integrità aurorale non soddisfa forse l’antico desiderio di tornare bambini “senza peccati e senza storia”? Per l’uomo premoderno la durezza, la ruvidità, la persistenza della roccia costituiva una ierofania: “Non vi è nulla di più immediato e di più autonomo nella pienezza della sua forza, e non vi è nulla di più nobile e di più terrificante della roccia maestosa, del blocco di granito audacemente eretto. Il sasso anzitutto è. Rimane sempre se stesso e perdura; cosa più importante di tutte, colpisce … La roccia gli rivela qualche cosa che trascende la precarietà della sua condizione umana: un modo di essere assoluto” (Eliade). La vegetazione ed in particolare gli alberi che ricoprono la terra sono carichi di forze sacre “perché sono verticali, crescono, perdono le foglie e le recuperano, e di conseguenza si rigenerano (muore e risuscita) innumerevoli volte”. Esprimendo la ciclicità morte/resurrezione – la legge fondamentale della Natura - l’albero è simbolo dell’Universo, il Cosmo di cui l’uomo vuole sentirsi parte integrante per partecipare alla continuità della sua vita. Una profonda unità con la Terra contenuta nelle parole di Smohalla, un capo Sioux, che alla fine dell’800 per giustificare il suo rifiuto di lavorare la terra diceva: “Mi chiedete di lavorare il terreno? Potrei forse prendere un coltello per conficcarlo nel seno di mia madre? Se lo facessi, quando sarò morto ella non mi accoglierebbe più nel suo seno. Volete che vanghi e scavi le pietre? Potrei forse scavare nelle sue carni fino alle sue ossa? Non potrei più, allora, rientrare nel suo corpo per rinascere a nuova vita. Volete che tagli l’erba e il fieno per venderlo, al fine di arricchirmi come fanno i bianchi? Ma potrei forse tagliare i capelli di mia madre?”. Questo breve viaggio nel modo in cui l’uomo premoderno percepiva la Natura ci ha dato l’opportunità di conoscere con maggiore chiarezza quella “dimensione in più” di cui è dotato il cosiddetto primitivo, dimensione che abbiamo definito trascendenza: “Si potrebbe chiamarla un’esistenza aperta, non essendo particolarmente limitata al modo d’essere dell’uomo … l’esistenza dell’homo religiosus, soprattutto del primitivo, è aperta al Mondo; l’uomo religioso, vivendo, non è mai solo, poiché una parte del Mondo vive in lui … L’apertura verso il Mondo mette in grado l’uomo religioso di conoscersi conoscendo il Mondo, conoscenza preziosa in quanto religiosa, in quanto riferita all’Essere” (Eliade). (sacro - 5 precedente seguente) |
|
percorso: C.Papaglione (41° 44' 15.84" N, 15°40'45.30"E) – coppa Arena - grotta Montenero – c.Papaglione [8 km]
Il passaggio dell’homo consumans e quindi produttore di rifiuti è possibile osservarlo in questo percorso che si snoda tra boschi bellissimi di cerro, dove, anche in posti difficilmente raggiungibili, si possono vedere copertoni d’auto, batterie esauste, elettrodomestici arrugginiti, ferraglie varie. |
|
Post n°77 pubblicato il 12 Novembre 2011 da m_de_pasquale
Se il sacro è l’esperienza in cui coscienza ed inconscio sono totalmente uniti, luogo dell’indifferenziato, mistero terrificante (tremendum) ed affascinante (fascinans), la ragione deve effettivamente fare un passo indietro perché esso è “inconcepibile, inafferrabile, incomprensibile razionalmente … non può esser portato entro i confini dell’intelligenza nozionale … può esser colto solo dal sentimento” (Otto). Se non abbiamo a che fare con il Dio addomesticato dalla ragione/religione, ma con quello absconditus di Pascal, con quello della coincidentia oppositorum di Cusano, la ragione è incapace di comprendere. Dobbiamo appellarci necessariamente al cuore: “E’ il cuore che sente Dio, non la ragione” (Pascal). Con questa predisposizione è possibile seguire la riflessione di Otto sulle reazioni emotive dell’individuo quando incontra il sacro la cui essenza è il numinoso in cui si esprime il rapporto ambivalente di timore e venerazione che caratterizza l’incontro con tutto ciò che è “ineffabile in quanto è assolutamente inaccessibile alla comprensione concettuale”. Esso si esprime nell’oscurità, nel silenzio, nel vuoto perché essendo queste delle negazioni rendono possibile l’apparire del totalmente diverso. Nel numinoso il divino si manifesta come mysterium tremendum e fascinans, come il nascosto, l’assolutamente altro che terrorizza e allo stesso tempo affascina; un mistero che successivamente la religione si preoccuperà di controllare dando vita all’immagine della divinità come provvidenza, come misericordia, come amore. Quali sono le reazioni emotive dell’uomo di fronte alla percezione del sacro? Quali sono i sentimenti che maturano nell’incontro col divino? Seguendo la riflessione di Otto è possibile delineare una interessante fenomenologia dell’esperienza religiosa. Al di là della questione se il sacro sia rivelativo di una presenza divina - tesi cara al teologo Otto-, la sua analisi fenomenologica ci è utile per riconoscere gli stati d’animo prodotti dall’incontro col numinoso le cui peculiarità sono spiegabili con la straordinarietà dell’oggetto della relazione che non necessariamente deve avere il volto del Dio personale della tradizione giudaico-cristiana. Il “sentimento di essere una creatura, della creatura che naufraga nella propria nullità, che scompare al cospetto di ciò che la sovrasta” è la prima reazione che l’uomo avverte quando incontra il numinoso. E’ l’esperienza della piccolezza di fronte a ciò che è sovrastante, della dipendenza da esso che Pascal descrive in questi termini: “Vedo quegli spaventosi spazi dell’universo che mi racchiudono, mi trovo confinato in un angolo di questa vasta distesa, senza sapere perché sono posto in questo luogo piuttosto che in un altro, né perché questo poco di tempo che mi è stato dato da vivere mi è stato fissato in questo momento piuttosto che in un altro di tutta l’eternità che mi ha preceduto e di tutta quella che mi seguirà. Vedo da ogni parte solo infinità che mi racchiudono come un atomo e come un’ombra che dura solo un istante senza ritorno”. L’esperienza della propria piccolezza di fronte al troppo grande produce sgomento e senso della dipendenza (è quantomeno azzardato sostenere con Otto che il sentimento creaturale è la prova dell’esistenza di un soggetto fuori dell’io). E’ la reazione di fronte all’aspetto tremendum del mistero, “il nascosto, il non manifesto, ciò che non è intuito e non è compreso, lo straordinario e l’inconsueto” di cui Otto fa questa straordinaria descrizione: “Il sentimento che ne emana può penetrarci come un flusso di armonioso, riposante, vago raccoglimento. Oppure può trapassarci l’anima con una risonanza continuamente fluente che vibra e perdura lungamente finchè svanisce per riabbandonarla al suo tono profano. Esso può anche erompere dall’anima subitamente con spasimi e convulsioni. Può trascinare alle più strane eccitazioni, alla frenesia, all’orgasmo, all’estasi. Può rivestire forme selvagge e demoniache. Può farci precipitare in un orrore spettrale e pieno di raccapriccio. Ha manifestazioni ed antecedenti primordiali crudi e barbarici, e ha la capacità di trasformarsi nel bello, nel puro, nel glorioso. Può divenire la silenziosa e tremante umiltà della creatura, al cospetto di quello che è il mistero ineffabile”. Quando il mistero è sprovvisto del momento del tremendum, esso produce reazioni emotive quali meraviglia, stupore, ammirazione, conseguenze della percezione dell’aspetto di estraneità del numinoso: “il totalmente altro, l’estraneo, ciò che riempie di stupore, quello che è al di là della sfera dell’usuale, del comprensibile, del familiare, e per questo nascosto, assolutamente fuori dell’ordinario e in contrasto con l’ordinario, e colmante quindi lo spirito di sbigottito stupore”. E’ la condizione che accompagna un elemento tipico delle religioni, il miracolo: “Quanto di sconcertante penetrava nella sfera d’azione dell’umanità, quanto nell’ordine dei fenomeni naturali e degli eventi suscitava negli uomini, negli animali e nelle piante, sorpresa, stupore o terrore paralizzante, ha sempre risvegliato e attirato prima il terrore demonico, poi il timore sacro, ed è ciò che è assurto alla qualità di portentum, di prodigium, di miraculum. Così e solo così nacque il miracolo”. Il momento raccapricciante del tremendum si intreccia in una sorta di armonia contrastante con qualcosa di attraente, di catturante, di affascinante: “A fianco all’elemento che confonde, sorge quello che ammalia, che rapisce misteriosamente, spesso crescendo in intensità fino all’ebbrezza e allo smarrimento: è l’elemento dionisiaco nell’efficacia del numen. E’ il momento fascinans del numen”. I concetti razionali che si sviluppano parallelamente a questo momento irrazionale dell’affascinante e lo traducono in schemi, sono l’amore e la misericordia, la pietà, il conforto, pensati nel loro grado massimo. In questo contesto va collocata l’esperienza della beatitudine dell’unione con Dio che fanno i mistici, i convertiti, coloro che sono stati toccati dalla grazia, l’esperienza del nirvana buddhista, tutti attestano l’esperienza di un bene trasbordante inesprimibile: “Oh, potessi io dirvi quel che sente il cuore, come esso internamente brucia e si consuma, ma io non trovo parole per dirlo. Posso semplicemente dire: se sola mente una stilla di quel che sento cadesse nell’Inferno, l’Inferno ne sarebbe d’incanto trasformato in un Paradiso”. (sacro - 4 precedente seguente) |
|
Post n°76 pubblicato il 05 Novembre 2011 da m_de_pasquale
Per Jung quando l’Io (= la ragione) è abbastanza forte per reggere il confronto con la sua parte oscura avvia il processo d’individuazione, avvia cioè il confronto col Sé che costituisce l’esperienza indifferenziata di tutte le possibilità, coscienza ed inconscio allo stesso tempo. Il Sé è il corrispondente psicologico del sacro le cui figure interiorizzate sono gli archetipi: le situazioni paradigmatiche in cui viene a trovarsi l’umanità e la reazione di fronte ad esse. Poiché gli archetipi “decidono il destino dell’uomo”, è importante accedere a questo mondo per orientare il nostro futuro. Questi potenti contenuti dell’inconscio collettivo “devono essere proiettati – dice Jung – altrimenti inonderebbero la coscienza. Si tratta semplicemente di convogliarli in una forma che possa adeguatamente contenerli. In effetti esiste un’antichissima istituzione che aiuta le persone a proiettare immagini impersonali”. Questa istituzione è la religione che, con la sua capacità di tradurre le immagini archetipiche, tradizionalmente ha regolato il rapporto tra l’uomo e l’inconscio collettivo dando, perciò, la possibilità all’uomo di entrare in contatto con esso. Ma oggi “per la moderna mente illuminata questa ipostatizzazione [la proiezione operata dalla religione in figure sacre] non è più possibile. Di conseguenza l’uomo si trova di fronte alla necessità di trovare un metodo individuale attraverso il quale le immagini impersonali possano prendere forma. Poiché devono prendere forma, devono vivere la loro vita caratteristica, altrimenti viene reciso l’indispensabile vincolo fra l’individuo e le funzioni fondamentali della psiche, e l’individuo diventa disorientato, in conflitto con sé stesso”. Pertanto quel compito di cui si è fatta carico la religione “fin dall’alba della coscienza”, oggi tocca direttamente all’uomo, appunto, attraverso il processo d’individuazione. Questo processo teso al riconoscimento e alla accettazione della parte più profonda di sé rappacifica l’individuo perché gli consente di raggiungere quell’armonia dialettica capace di rinnovare la sua esistenza, di fornirle una nuova ricerca di senso. La pace raggiunta è lo stato personale che spesso gli individui indicano per esprimere la loro esperienza di Dio, e ritengono che questa condizione possa effettivamente costituire una prova della sua esistenza. Una pace che si prospetta come quiete per la riconquistata unità: non più la lacerazione della divisione, ma l’armonia della riunione. Sembra il percorso raccontato da Hegel nella Fenomenologia dello Spirito quando la coscienza risolve la sua infelicità nel rendersi conto di essere lei stessa Dio. Per Jung l’annessione alla coscienza degli strati più profondi dell’inconscio determina una dilatazione della personalità che porta alla condizione della “somiglianza con Dio”: il “piccolo Dio di questo mondo [la persona] va ricondotto alla sua origine nel Dio universale, personificazione della psiche collettiva … la dissoluzione della persona nella psiche collettiva invita direttamente l’individuo a tuffarsi in quell’oceano di divinità”. L’uomo, quindi, ha bisogno del sacro, la coscienza dell’inconscio, l’Io del Sé. Afferma Jung che Eraclito ha scoperto la più portentosa di tutte le leggi psicologiche, quella della funzione regolatrice dei contrari: i contrari si richiamano a vicenda e sono destinati a ricostituire l’unità originaria. Questo processo compensatorio che giunge alla scoperta della parte complementare è la funzione trascendente: “L’unione dei contrari è la condizione primordiale delle cose e allo stesso tempo la meta ideale, poiché rappresenta l’unione di elementi eternamente contrapposti … Troviamo la stessa idea nell’antica filosofia cinese. La condizione ideale è chiamata il Tao, la completa armonia fra il cielo e la terra … La condizione originaria di cui l’essere umano ha struggente nostalgia è quello stato in cui coscienza ed inconscio sono totalmente uniti”. (sacro - 3 precedente seguente) |
- sitografia generale
- video storici
- video dal 1900 ad oggi
- storia antica
- storia medievale
- storia moderna
- storia del novecento
- tutti i documenti cattolici
- dizionario di storia antica e medievale
- dizionario di storia moderna e contemporanea
- dizionario di storiografia
- dizionario di economia
- dizionario del cittadino
- storia di san severo
Tag
Area personale
Menu
CAMPI FILOSOFICI
2012: il sacro, tremendum e fascinans
2011: l'altra faccia del potere
2010: inseguendo la felicità
2009: l'equivoco dell'amore
mail: m_de_pasquale@libero.it
un'altra informazione?
- report
- presa diretta
- servizio pubblico
- anno zero
- w l'italia
- current tv online
- c'era una volta
- iene
- doc 3
- il fatto quotidiano
- lettera43
- cadoinpiedi
- il post
- linkiesta
- agoravox
- giornalettismo
- articolo 21
- liberainformazione
- la voce
- carta
- peace reporter
- nigrizia
- narcomafie
- altreconomia
- arcoiris tv
- wikileaks
- paolo barnard
- tzetze
- YouReporter
- i segreti della casta