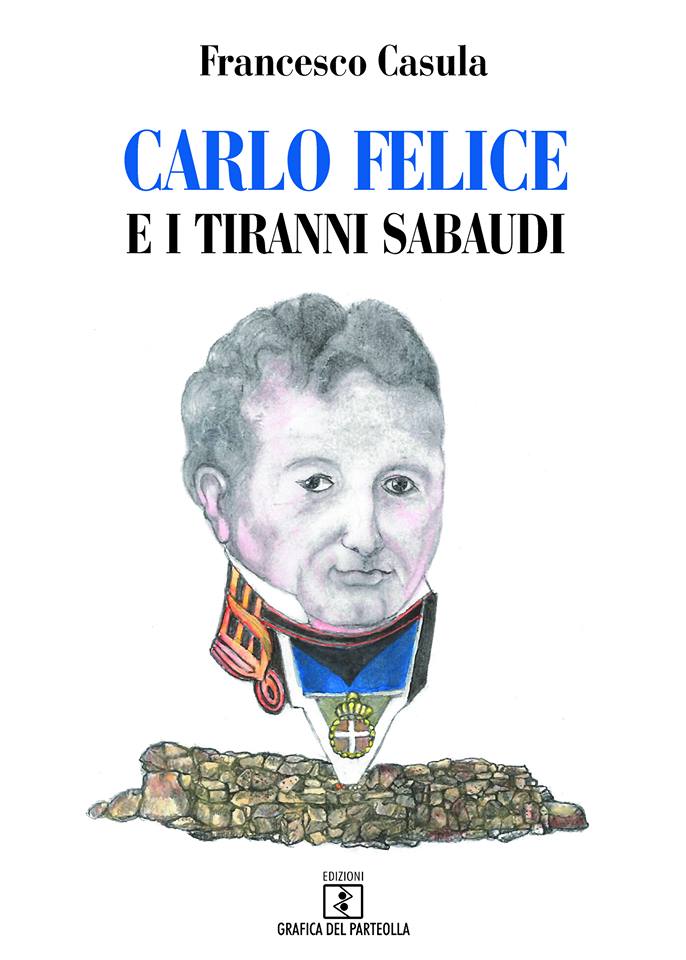Carlo Emanuele III (1730-1773)
Nel 1730, dopo l’abdicazione del padre Vittorio Amedeo II, succede al trono Carlo Emanuele III, principe di Piemonte.
Ormai, considerata la Sardegna quasi definitivamente acquisita alla sua corona, il problema del nuovo sovrano era l’assimilazione dell’Isola al sistema dei cosiddetti “Stati di terraferma”. Di qui l’ulteriore tentativo di accentrare e centralizzare il potere, svuotando viepiù l’Autonomia stamentaria. Sotto il suo dominio, il Parlamento continua a non essere convocato. Di qui l’imposizione della lingua italiana (1776) per la dessardizzazione e snazionalizzazione delle popolazioni, per poterle dominare meglio e di più, una volta che hai loro “tagliato” la lingua. Anche loro, i Piemontesi, nuovi “glottofagi”, non dimentichi dei primi glottofagi, che furono i Romani.
Uno dei problemi che lo assillava maggiormente era quello del banditismo. A tal fine si servì soprattutto di un militare (il Rivarolo), deciso e brutale, ma incapace, come vedremo, di individuare le cause di fondo del fenomeno – economiche, sociali, culturali – per limitarsi alla sola repressione.
Il 2 ottobre 1735 sbarca a Cagliari Carlo Amedeo marchese di Rivarolo, militare dalle maniere forti. Sembra che proprio per questa sua caratteristica il re Vittorio Amedeo II l’abbia scelto come viceré per eliminare il banditismo che in quei decenni imperversava in Sardegna come non mai.
Scrive lo storico Carlino Sole: ”Il Rivarolo era convinto che solo con la forza inesorabile delle armi e col terrore della forca si potesse aver ragione dei banditi. Per questo era solito far eseguire le sentenze capitali con apparato impressionante, innalzando il patibolo nei luoghi stessi dove erano stati commessi i delitti più gravi e costringendo le popolazioni ad assistervi. La testa mozza del giustiziato veniva mandata come truce ammonimento al villaggio d’origine per esservi esposta dentro una grata di ferro. In tre anni di dura e feroce repressione fece condannare alle galere più di tremila inquisiti, molti dei quali arrestati per semplici sospetti o per interessate delazioni e mandò al patibolo, spesso con un procedimento sommario o, «economico», come allora si diceva, cioè senza una preventiva istruttoria e di un regolare processo, ben 432 persone…Ordinò che nessuno si lasciasse crescere la barba, sotto pena di gravi sanzioni «ad arbitrio del giudice», credendo che una barba lunga e folta servisse non solo a mascherare le sembianze dei malviventi, ma che fosse indice di una prossima «vendetta»,: evidentemente qualcuno gli aveva fatto credere che in Sardegna vigesse l’usanza di lasciarsi crescere la barba come «voto»,:per tutto il tempo che passava prima che si potesse vendicare l’offesa e per avvalorare la sua convinzione affermava, con approssimativa etimologia, che gli abitanti della Barbagia, una delle zone più segnate dal banditismo. Si chiamavano barbaraccini, (sic!) appunto perché erano soliti portate la barba!”12
Nonostante la nomea di uomo colto, il Rivarolo non solo ha poca dimestichezza con l’etimologia ma anche con la storia sarda né vi fu chi potesse informarlo che Filippo II circa due secoli prima aveva consigliato ai Sardi di farsi crescere la barba.
Il banditismo non fu sconfitto: nonostante la repressione più dura e brutale. Gli è che veniva considerato come semplice fenomeno delinquenziale da estirpare con le forche: non come fenomeno economico-sociale e culturale, oltretutto politicamente spesso alimentato, foraggiato e protetto dai baroni e dalla Chiesa. Che però il viceré e la politica sabauda si guardano bene dal colpire!
La complessiva politica del re fu dunque improntata a un sostanziale immobilismo (a nulla mutare, nulla innovare nello stato di cose ereditato dalla Spagna) e le stesse novità introdotte con il conte Giambattista Bogino, ministro piemontese per le cose sarde – al di là degli altisonanti riconoscimenti ed elogi da parte dello storico conservatore e cortigiano Giuseppe Manno – si risolse in un “Riformismo che non rinnova”: la definizione è del giù citato storico sardo Carlino Sole. Che così scrive: ”La sua azione riformatrice fu episodica e frammentaria…mancò di una visione globale dei problemi rivolta com’era più a salvaguardare gli interessi dello «stato patrimoniale», che a promuovere il progressivo benessere delle popolazioni”2.
Benessere che sarebbe potuto essere costruito esclusivamente aggredendo i nodi di fondo dell’arretratezza e del malessere dei sardi: ad iniziare dall’anacronistico e famelico regime feudale con tutti i gravami, i privilegi e gli abusi che esso comportava.
L’intervento piemontese evidentemente non aveva lo scopo di liberare i sardi dal giogo feudale bensì di accentrare e rafforzare il potere nelle mani dei nuovi dominatori. Ricorrendo a qualunque mezzo. Tanto che – scrive Carta Raspi – “neppure il Bogino si discostò dall’indirizzo politico nei riguardi della Sardegna, che fu essenzialmente burocratico e superficiale, senza mai affrontare i gravi problemi dell’isola, ch’erano soprattutto nella sua povera e arretrata economia, lasciandoli anzi insoluti di proposito, per fini politici”3 .
Qualche storico ha avanzato l’idea che una Sardegna prospera e sviluppata potesse essere ambita e contesa da altre potenze per cui il Bogino stesso avrebbe consigliato al re di “non abbellire soverchiamente la sposa perché altri non se ne invaghisse”.
Secondo il già citato Carta Raspi la motivazione sarebbe stata invece un’altra, ovvero “la recondita politica dei sovrani sabaudi di considerare sempre la Sardegna un dominio da permutare in qualunque occasione e ciò, da Vittorio Amedeo II fino a Vittorio Emanuele III, fino agli anni in cui il Cavour si sarebbe volentieri disfatto della Sardegna se non ne fosse stato tempestivamente ostacolato”4.
Ci pare un’ipotesi credibile: la Sardegna pro sos canes de isterju dei Savoia e dei suoi commensali, sempre proni e usi a obbedir tacendo, è un semplice territorio da barattare al migliore offerente: perché dunque migliorare le sue condizioni?
Questa ipotesi, fra l’altro, serve per liquidare “la credenza – scrive Carlino Sole – avvalorata dalla storiografia filo-sabauda dell’Ottocento e del primo Novecento che il «buon governo» piemontese avesse fin da allora conciliato alla casa regnante il favore e la devozione del popolo sardo”5.
Tale credenza – scrive ancora Sole – è da relegare fra i miti. E prosegue: ”I sardi si sentivano legati alla corona nella stessa misura in cui Vittorio Amedeo II e Carlo Emanuele III si sentivano disposti a sbarazzarsi dell’Isola come di un ingombrante fardello per barattarlo con compensi territoriali più vicini, più redditizi e perciò più graditi”6.
Mazzini7, con qualche ragione avanza l’ipotesi che ad opporsi alla proposta di Giuseppe Cossu, sardo ed economista di vaglia, di introdurre in Sardegna la coltivazione del gelso, avviando la manifattura della seta, – ma è solo un esempio – siano stati proprio gli stessi governanti subalpini, per ragioni di concorrenza economica con il Piemonte. Insomma: una motivazione di puro colonialismo!
Note bibliografiche
- Carlino Sole, La Sardegna sabauda nel Settecento, Editore Chiarella, Sassari, 1984, pagine 74-76.
- Ibidem, pagina104.
- Raimondo Carta Raspi, Storia della Sardegna, Ed. Mursia, Milano, 1971, pagina 778.
- Ibidem, pagine 779-780.
- Carlino Sole, opera citata, pagina 99.
- Ibidem, pagina 99
- Giuseppe Mazzini, La Sardegna, Casa editrice Il Nuraghe, Cagliari.