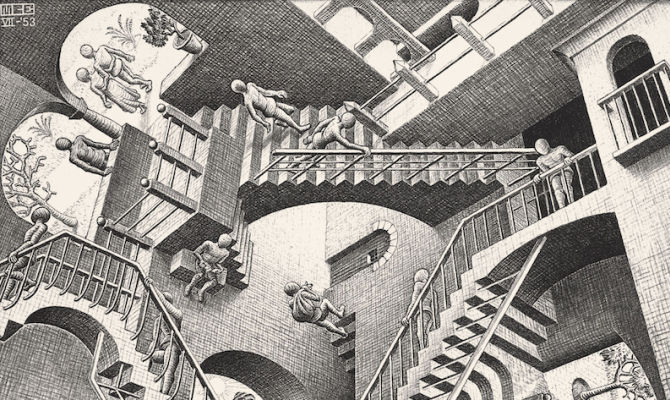Oggi il sole ha ceduto il passo alle nuvole finalmente, la brezza rinfresca lievemente l’aria e i colori cupi avvolgono dolcemente questo piccolo angolo di mondo. Quale commistione migliore di eventi per dedicarsi ad un po’ di sana riflessione?
Riflettevo riguardo quel famoso film, “Into the Wild”, tratto dal romanzo intitolato “Nelle terre estreme” di Jon Krakauer, che ahimè però non ho letto, anche se mi dicono che in pochi casi il film supera di gran lunga il libro e questo è uno di quei pochi casi.
La storia di Christopher McCandless o di Alexander Supertramp, come lo si voglia chiamare, è ben nota a molti oramai; un giovane ragazzo che decide di abbandonare tutte le ricchezze e gli agi famigliari, alla stregua di un novello San Francesco, per inseguire il sogno dell’Alaska e della vita selvaggia, sulle orme di autori quali Jack London e Henry David Thoreau. Liberarsi di tutte le convenzioni sociali e dell’Uomo stesso, “love not Man the less, but Nature more” come diceva Lord Byron, uscire al di fuori dello schema preimpostato dimostrando che un’altra vita è possibile e forse può essere anche migliore perchè persegue quell’alto principio che è la libertà. La carriera? il matrimonio? convenzioni, il denaro? qualcosa di inutile che non fa altro che rendere schiavo l’uomo, agganciato sempre di più ai bisogni che la società crea ad hoc per lui, una società che sempre più punta alla iper-produzione e alla competitività, premiando non colui che ha merito ma colui che produce più bisogni virtuali, ponendo nei fatti l’uomo dinanzi ad un bivio:
- soddisfare quei bisogni che man mano vengono “creati”
- non riuscire soddisfare quei bisogni che la società mette in vetrina e agita come un biscotto dinanzi ad un cane affamato.
In entrambi i casi il risultato è uguale e fallimentare: l’insoddisfazione. Il soddisfacimento di alcuni bisogni comporta il loro superamento e la necessità di soddisfarne sempre degli altri, il che non porta mai un reale soddisfacimento. Allo stesso tempo il non riuscire a soddisfare un bisogno, (un’auto di lusso o un viaggio costoso o uno status symbol a caso) comporta insoddisfazione e frustrazione. Il punto è che è tutto fittizio. Esistono realmente questi bisogni? sono realmente bisogni? NO! e questo probabilmente McCandless lo aveva capito bene.
Era una sorta di asceta misantropo che odiava la società? Mah, probabilmente odiava la società in quanto istituzione e portatrice di certi valori distorti, forse odiava la modernità che aveva condotto dall’uomo libero all’uomo schiavo del consumo e delle merci, ma non credo fosse uno scontroso misantropo, non odiava l’Uomo, forse lo cercava come lo cercava Diogene (ma senza lanterna), cercava il concetto di Uomo e dove cercarlo se non all’interno della natura più selvaggia? nel seno che lo ha partorito? Probabilmente nel suo piccolo era un “filantropo” per quanto ci è dato sapere.
Molto spesso il commento che più facilmente si sente a riguardo della figura di Christopher McCandless è uno in particolare: “E’ stato stupido perchè non era adeguatamente preparato ed è morto come un fesso.”
Sì, a prima vista è ciò che sembrerebbe la conclusione più ovvia, ma allo stesso tempo la più superficiale o semplicistica che non prende in considerazione quanto c’è dietro. Christopher decide di affrontare un territorio impervio come l’Alaska, vivendo in un bus abbandonato (il famoso “Magic Bus”) e cavandosela con delle nozioni base di caccia o consultando libri sulle piante edibili, morendo poi probabilmente avvelenato da semi di una qualche pianta. Eppure no, a ben pensarci, malgrado tutto non è stato un idiota. L’idea personalissima che mi sono fatto è che è stato uno dei pochi uomini a morire per qualcosa in cui credeva, sebbene fosse folle l’idea di fuggire dalle regole della società vivendo basandosi solo sulle proprie forze di uomo “addomesticato” oramai dalla società e sempre più incapace di cavarsela nel suo ambiente naturale di appartenenza. Ma d’altra parte quanti pionieri sono morti per un principio o per una idea che altri consideravano folle?
Che forse la vita acquisti davvero significato solo se si è disposti ad accettare anche l’estrema conseguenza per un proprio ideale? Essere Uomo di “fede” (non intendo strettamente religiosa, ma anche nell’accezione “laica” del termine) è per pochi, essere disposti a morire per la propria “fede” è qualcosa di raro. Allora in questo caso sì, una vita così è l’unica vita possibile.