
Forse quello fu il giorno più bello della mia vita. Non esagero.
Quello stesso giorno invece molti piansero.
Pianse mio padre, pianse la musica e pianse il jazz. Un lamento
rimase sospeso ad ondeggiare con i suoi ritmi sfiniti e i contrabbassi
di piombo e le trombe strozzate ad accompagnare una voce che
graffiava l’anima.
Quello fu il giorno più bello della mia vita. È vero. Ma alla sera –
quando tornai a casa – seppi dallo sguardo di mio padre che
qualcosa di doloroso si era manifestato, qualcosa che aveva
incrinato la quotidianità che la radio ci propinava con le
sue canzonette e i coretti e gli ottimismi da lucido
per scarpe: una voce compìta, impassibile, aveva annunciato

che Billie Holiday da quel giorno non avrebbe più cantato. Che Billie
non avrebbe più sedotto e strizzato i cuori e sfregiato la
spensieratezza con la sua voce. Era morta nel letto di un ospedale
della scintillante New York con le manette ai polsi, l’epatite, lo
spettro dell’eroina e la polizia al suo capezzale.
Quel giorno il sole sorse come ogni altro giorno, ma non sembrò
splendere come sempre.
Io e Peppe Gelfo eravamo amici per la pelle. Stavamo quasi tutto il
giorno insieme: d’inverno ci vedevamo dopo la scuola e andavamo a
giocare magari dentro qualche palazzina diroccata o in fondo a
qualche vicolo, dove qualcuno di noi assaporava il gusto delle
sigarette fumate nella clandestinità. D’estate il tempo si dilatava
infinitamente e le giornate ci apparivano come sterminate praterie
assolate di cui non riuscivamo a scorgere l’orizzonte.
A quel tempo io avevo dodici anni, lui uno in più.
Era l’epoca del rock’n roll e dei primi jeans, degli stivaletti e della
brillantina; i ragazzi si pettinavano alla James Dean, indossavano
stivaletti lucidi come specchi e si divertivano ad organizzare innocue
scorribande per le vie di Palermo fantasticando di gioventù bruciate.
Durante le sere più calde e noiose, insieme a Peppe e ad altri ragazzi
del quartiere più grandi e smaliziati, ci addentravamo furtivamente
nel cuore della città, dentro al quartiere Monte di Pietà, al
Castellammare o magari alla Kalsa, la zona del porto, alla Vucciria o
al Borgo, scivolando dentro vicoli umidi e malfamati, lungo la
via Sedie Volanti o la via dei Candelai, la via Gagini, la via Lungarini,
vicolo Marotta, rischiando forse anche la vita – sì – lì dove fino
all’anno prima lavoravano a pieno regime le “pensioni”, eufemismo
usato per indicare il bordello: la pensione Taibi, l’Igiea, la
Settequarti; il sangue ci correva caldo e veloce nelle vene mentre
penetravamo in quei luoghi impregnati del peccato, quel “peccato
sudicio” da cui Don Gino ci metteva in guardia durante i pomeriggi
passati in oratorio e che invece ci attirava a sé con forza. Le
incursioni in quelle trincee del vizio qualche volta si
esaurivano dopo avere bersagliato di insulti e frutta marcia qualche
ragazza che – dopo  la chiusura
la chiusura
delle “case” – se ne stava ore
appoggiata ad uno spigolo o ad un
portone o seduta su una seggiola
sgangherata a fumare o a leggere
un giornale o a ravvivarsi il rossetto un po’ sulle labbra e un po’
sugli zigomi. “Minchia, e che siete, pupe ri zuccaro?” qualcuno dei
ragazzi spavaldamente domandava. E in effetti quelle ragazze erano
tanto truccate da sembrare le bambole di zucchero che
mangiavamo per la festa dei Morti.
Don Gino lo sapeva che bazzicavamo quei luoghi, forse ci aveva
visto, e forse magari ci aveva visto proprio mentre ben coperto si
intrufolava in una di quelle pensioni – così come qualche malalingua
insinuava. La domenica in confessionale ci chiedeva se non eravamo
passati proprio da “quelle parti”, e se non le avevamo guardate con
“concupiscenza” – usava proprio quel termine che io non capivo ma
immaginavo avesse a che fare con qualcosa di oscuro e caldo e
seducente al tempo stesso. «Perché quelle là, quelle donnacce, eh…
peccano contro Dio e la Vergine! E voi non vi ci dovete avvicinare se
non volete cadere nelle mani del demonio! Capito?» – tuonava con
voce rauca. E a volte insisteva per sapere tutto – per redimerci, si
intende – e ci chiedeva quanto avevamo guardato e come, e poiché
«il pentimento è più sincero quante più sconcezze si

confessano», allora ci interrogava sui particolari: se
avevamo guardato le ”minne”, o «proprio lì sotto… eeeh mi sono
spiegato, ah?». «Che Dio mi perdoni, ah!», diceva asciugandosi il
sudore col fazzoletto ricamato, «se per ripulire l’anima di ‘sto
ragazzino la mia bocca si deve sporcare con simili sudicerie!».
A quel tempo c’era qualcosa di musicale nell’aria, un ritmo che
faceva quasi danzare i robusti fianchi delle ragazze che
distrattamente si voltavano verso le vetrine dei negozi sistemandosi
i capelli, un ritmo che muoveva le poche automobili scintillanti che
guizzavano per le strade.
Noi non avevamo ancora l’automobile ma spesso mio padre, la sera,
seduto sul divanetto del piccolo soggiorno,

ci portava – me e mio fratellino Giacomo – con sé in viaggi fantastici
a bordo di una superba Giulietta Alfa Romeo che si
materializzava così per incanto, ma che qualche minuto dopo
poteva diventare anche una Spider Lancia
dal colore rosso fiammante. «Che macchina volete, oggi, ragazzi?».
Accendeva il motore con un ruggito gutturale e metallico e
partivamo: sfrecciavamo lungo strade che si perdevano nel deserto
del Texas sollevando nuvole di polvere, come nei film americani che

ogni tanto andavamo a vedere al cinema Olimpia; oppure
immaginavamo delle puntate al centro, attraversando i viali alberati
della città tra palazzine liberty e teatri e ville e balconi da cui si
affacciavano delle belle ragazze che noi puntualmente salutavamo
schiacciando un occhio, mentre mio padre, cappello in testa sulle
ventitré alla Frank Sinatra, stonando cantava qualche motivo jazz
tipo “blu mun” o stormi uèder”, dicendoci in tono solenne che
quelle le aveva cantate anche la grande “Billi Olidei”. «Bella.
Bellissima, porca miseria! E che voce!».
Quella sera, alla radio, avevano dato la notizia della sua morte. A
mio padre luccicavano gli occhi e non capivo se era per il vento che
immaginavo superare il parabrezza e scompigliarci i capelli, o perché
sapeva che mai avrebbe avuto una simile automobile, lui, con quel
suo stipendio da impiegato; ma è più probabile che pensasse alla
sua triste “venere nera”, come la chiamava lui. La quale avrebbe
continuato a cantare malinconicamente meravigliosa, ma non più in
questo mondo.
Quella mattina io e Peppe avevamo preso il bus per raggiungere la
spiaggia allo Stabilimento balneare di Mondello. Salivamo sempre
alla fermata del porto, che raggiungevamo a piedi attraverso strade
incorniciate dai tetri scheletri di edifici bombardati durante la guerra
e dai cumuli di macerie che ancora sembravano fumare. Tutto quello
richiamava alla memoria, con silenziose parole di pietra, l’orrore che
ci raccontavano i nostri genitori ma che a noi sembrava
infinitamente lontano: noi, invece dell’orrore della guerra, avevamo
davanti tutta la nostra giovinezza e un mondo da ricostruire come se
si trattasse di pezzi di legno colorato di un gioco per bambini.
Quel piccolo viaggio, per noi che non eravamo mai stati fuori città e
che le vacanze estive le trascorrevamo andando ogni mattina allo
stabilimento balneare a poca distanza da casa, era sempre come una
spedizione in terre inesplorate. E poi ogni volta accadeva qualcosa
che, per quanto potesse sembrare banale, ai nostri occhi era ora
divertente, ora preoccupante, o addirittura meravigliosa. Soprattutto
mi piaceva guardare i volti di quelle persone che si facevano
trasportare sovrappensiero o rassegnate, sorridenti o incupite,
uomini e donne e bambini che per una mezz’ora al giorno della loro
vita condividevano un pezzo di strada. Riconoscevamo al volo il
borseggiatore alla ricerca di tasche gonfie, o il maniaco che si
adagiava sbadatamente a signore più o meno distratte e che ad ogni
scossone o frenata si scusava rispettosamente. C’era anche un
giovane tarchiato e lurido che, frangetta sugli occhi e folta barba
corvina, viaggiava sempre seduto sulla spalliera del sedile. Aveva lo
sguardo pacato di chi è assente dal mondo ma ogni tanto torna per
porgere un sorriso distratto. I suoi occhi erano come assonnati,
mezzi chiusi, e le labbra disegnavano un sorriso accennato e
bonario. La camicia bianca aperta fino allo sterno mostrava il petto
abbronzato e villoso, ma quello che colpiva ancora di più era il fatto
che i pantaloni, che lasciavano nudi i robusti polpacci ricoperti da
screpolature e piaghe, erano tenuti da una cintura così stretta al giro
vita che il busto ne risultava quasi tagliato in due. Quel ragazzo
teneva sempre in mano dei fogli di quaderno su cui si stagliava una
scrittura fatta di segni inventati, quasi un’onda che si increspava e
poi tornava placida qualche rigo sotto, per poi riprendere ancora più
burrascosa. Faceva lunghi discorsi incomprensibili, in una lingua di
cui era l’unico interprete; poi ti sorrideva, e ringraziava. Lo
chiamavamo “u marinaio pazzo”.
La linea nostra era quella che prendeva dal litorale, per un primo
tratto avanzando lentamente tra il riverbero accecante delle onde
nel porto, poi inoltrandosi tra palazzi antichi e fieri di essere ancora
in piedi; infine si addentrava nel parco in un’esplosione di verde e di
frescura.
Quando arrivammo al capolinea, il sole era già alto, il chiosco delle
bibite era circondato da ragazzini in mutande o in costumi troppo
larghi, che si rincorrevano lanciandosi arancine di sabbia o che
giocavano a palla. Con loro c’era anche Michela, ai miei occhi la
ragazzina più dolce e incantevole di tutta la spiaggia: era sempre lì a
giocare insieme ad altre bambine con bambole e servizi da cucina in
miniatura. Minuta, i capelli che le sfioravano le spalle, tenuti di lato
grazie a una forcina, aveva occhi neri e due grandi incisivi che le
illuminavano il volto. Avevo sognato infinite volte di avvicinarmi a lei
e dirle semplicemente “ti amo”, ma la mia timidezza mi si era
sempre conficcata nel fianco come una spina, paralizzandomi. E dire
che con Peppe facevo pure lo sbruffone, allargandomi sulle mie
esperienze con le ragazzine.
Nel pomeriggio, al bar, lei era seduta in un angolo ed io, vedendola e
desiderando immensamente di parlarle, ero già rassegnato a sentire
impazzire il mio cuore, a provare quella specie di tremore
incontrollabile e ad arrendermi impotente al torpore che dalle gambe
saliva sempre più su. Invece quando ci trovammo vicini, proprio in
quel momento sentii un suono indefinito ma a me familiare che
giungeva da lontano e lentamente si faceva sempre più intenso e
chiaro, “I’m a fool”, una tenue e struggente melodia si fece largo
“to want you” fino alle mie orecchie, “I’m a fool to want you, to
want a love that can’t be true”. L’ultimo saluto, la radio o forse un
juke box, alla Lady Day: la voce di Billie Holiday, quasi avvolta in se
stessa, mi fece pensare ad un animale impaurito e tremante, ne
vedevo gli occhi lucidi ed uno sguardo che dal basso implorava una
dose di tenerezza, una dose di amore. I colpi del mio cuore erano
adesso il ritmo di quella canzone e il tremore si scioglieva in un
tiepido formicolio. Non so come, in quel momento trovai il coraggio
di sussurrarle “sei bellissima”. Rimanemmo a parlare e a giocare e a
ridere per un tempo che non so dire, con Peppe che ogni tanto per
scherzo veniva a dirmi che delle sue amiche bellissime volevano
parlarmi, e cercava di trascinarmi via.
Il tramonto alle nostre spalle cominciava ad indorare la sabbia e il
legno delle cabine mentre io e lei, mano nella mano, camminavamo
scalzi sulla sabbia. Peppe stava più indietro, e sorrideva divertito. Sì,
me lo ricordo ancora: era il 17 luglio del ’59.
Billie holiday, Case chiuse, leggere, Lettura, mondello, palermo, racconto, rock'n roll, scrittura, spiaggia, storia
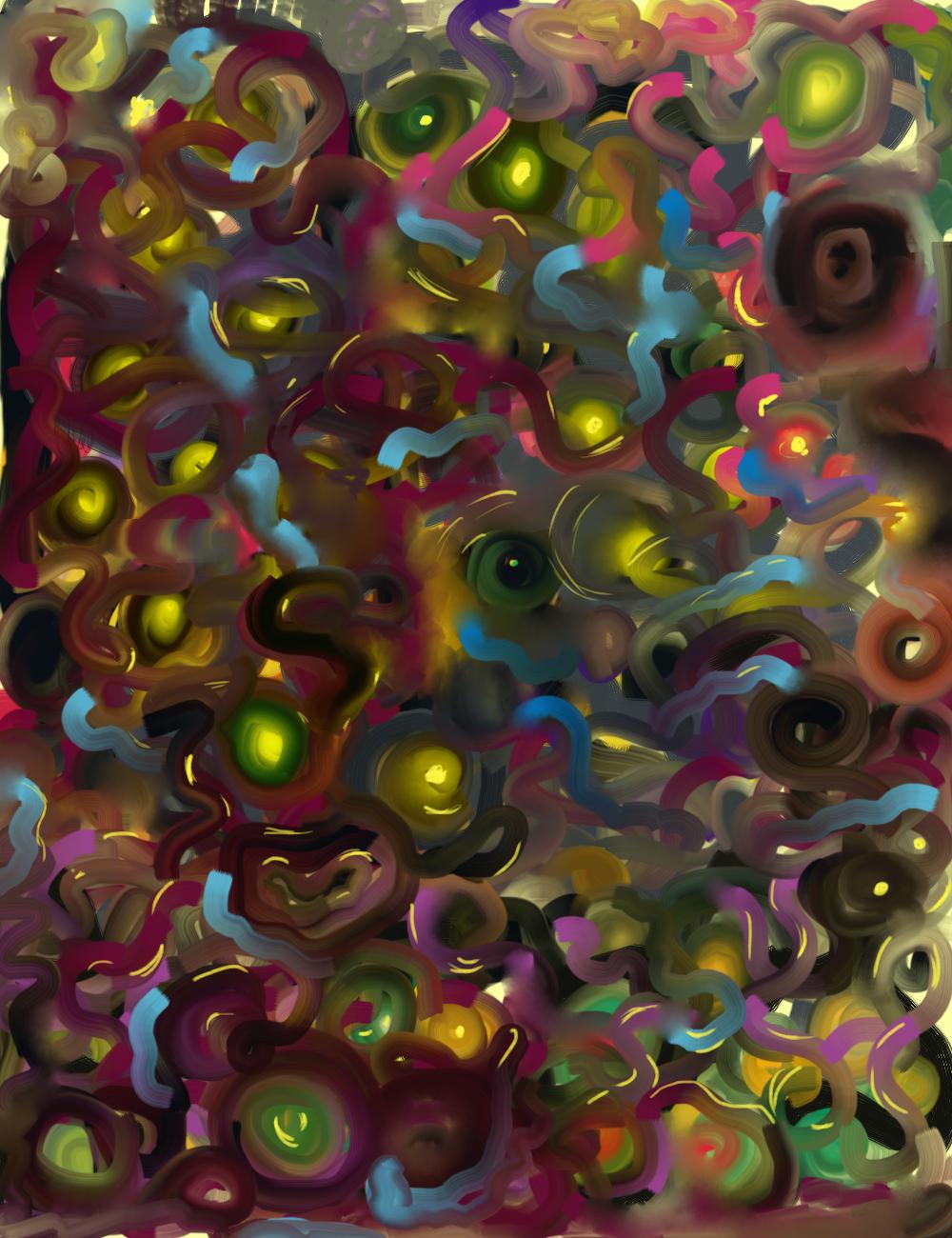
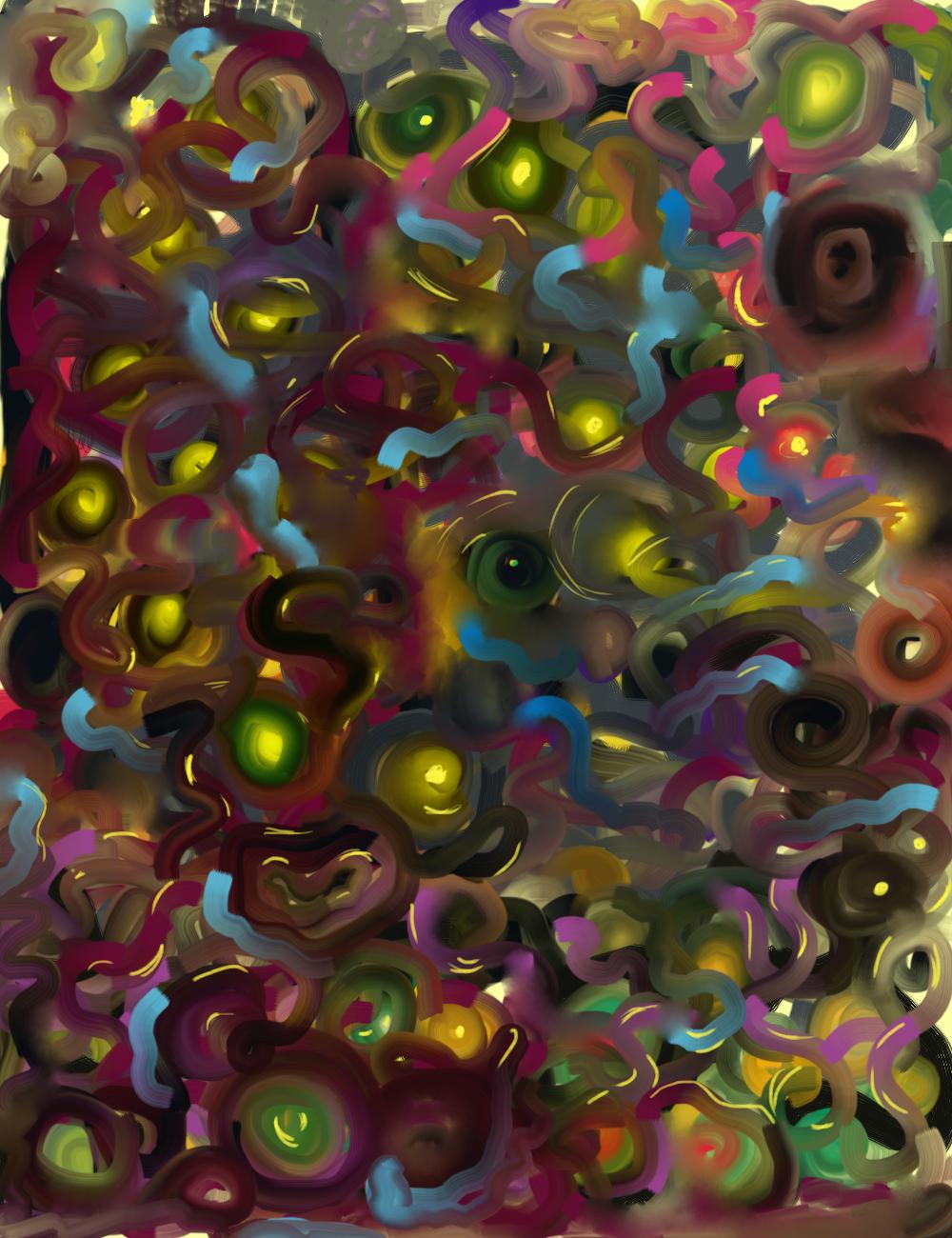


 la chiusura
la chiusura