Sangue ed animaUn capitolo al giorno del mio primo libro |
AREA PERSONALE
TAG
MENU
|
Aveva sbadatamente lasciato le grosse scarpe ai lati del fiumiciattolo che aveva appena sbollito le sue calure e, intimorito dall’essere braccato da una polizia che neanche sognava la presenza di Grant in quel bosco, aveva rinunciato all’idea di tornare a prenderle. Camminava coi piedi martoriati sempre più da piccoli calli e vesciche, come gli antichi, e con la bocca piena di un sapore salmastro di sangue e polvere. La lingua batteva la bocca alla ricerca di piccole ferite e spesso trovava schegge di vetro che ne tagliavano la superficie, procurando al fuggitivo Colbain piccoli e duraturi dolori che gli impedivano di mangiare. Era fuggito da molto dalla sua macchina incidentata, ma nonostante ciò le sirene della polizia o della guardia forestale non si facevano ancora sentire. Si aspettava da un momento all’altro il suono di un elicottero, lo stridere delle ruote delle volanti sulla mulattiera, ma le sue aspettative venivano disattese di minuto in minuto. La speranza che fosse riuscito a sfuggire definitivamente alla polizia si faceva più forte mentre un grosso interrogativo irrompeva nella sua mente. Quel pensiero, quel quesito che fin dall’inizio della fuga lo aveva tormentato, facendolo barcollare tra un ponte di certezze e un abisso di incertezze. Era giusto fuggire per qualcosa che forse non si aveva commesso? Era forse sicuro della strage che aveva compiuto quella sera d’estate con quel grosso macete d’acciaio? Era stato lui? Di sua volontà? Era forse stato costretto? Perché avrebbe dovuto massacrare quelle persone, pur minacciato da qualcuno? La sua vita era più importante di quelle che aveva estirpato? Non aveva forse cercato nella morte, nell’oscura e orrenda morte, nel suo nulla e nel suo sollievo, una fuga da questa vita? Era stato veramente lui? Non poteva essere. Perché scappava dunque? Non era innocente? Avrebbe dovuto dichiararlo alla polizia! A quella stessa polizia che ora lo cercava, lo braccava, gli dava la caccia come ad un grosso animale feroce. Chi gli avrebbe però creduto con quella faccia? Chi, alla stazione di polizia o tra gli stessi giornalisti che lo avevano messo sulla pubblica gogna, lo avrebbe preso sul serio? Con quel viso sfregiato? Con quel viso goffo, mostruoso, con quella maschera di bruttezza e orrore? No, non era possibile: i giornalisti lo conoscevano e lo avevano riconosciuto ormai come unico colpevole. Chi? Chi altri avrebbe potuto commettere quei delitti se non quel mostro dalla faccia di cuoio, sfigurata e corrugata come una patata, arroccata sugli zigomi e sulle sopracciglia come un ammasso di grossi vermi sudici e umidi, come un complesso lebbroso di pustole e cicatrici? Chi, se non quell’essere dalla faccia tondeggiante e ripugnante? Toccando i grossi rigonfiamenti e le bolle sulla sua faccia si accorse che stava pensando correttamente, che questo era ciò che tutti pensavano. I suoi sentimenti si inasprivano. L’odio verso sé stesso e verso quel suo atteggiamento, quel comportamento che, in qualsivoglia modo, aveva portato alla morte persone innocenti e forse amate, cresceva indisturbato e enorme nel suo cuore di bestia. Si grattava con forza quel viso cercando di estirparlo, di buttarlo via, per scordarsi chi era e iniziare una nuova vita, per distruggere ciò che era stato e cambiarlo in qualcosa di nuovo, di diverso. Il sangue fluiva piano dalle ferite, eliminando dal corrucciato volto alcune delle schegge che ancora vi erano ben conficcate, tagliando le sue dita con frammenti di vetro e bagnando il terreno di uno scarlatto liquido. L’erba, come un fiore rinsecchito che attende la pioggia e viene poi investito dalla tempesta, accoglieva le grosse gocce rossastre tra i suoi fili inebriandosi di quell’inatteso sollievo. Le mani di Grant, sporche di un vivido rosso sanguigno, venivano continuamente percorse da veri e propri flussi di fluido scatenati dalla sua rabbiosa voglia di cambiare. Le unghie, corrose dal viola dei capillari che avevano ormai tinto l’intero volto di un tizianesco colore, percuotevano il viso con un’insospettata durezza, spaccandosi talvolta nel tentativo di liberarsi da schegge di vetro. Le labbra, continuamente morsicate, avevano assunto ormai un colore violaceo, facendo da diga a quel vivido lago putrido. Grant stava distruggendo rabbiosamente il suo viso, trasformandolo in un perfetto nido per mosche e lombrichi. Cominciò inavvertitamente a piangere, quasi come se il suo stesso corpo volesse avvisarlo del dolore e fermare la sua pazzia. Il suo fisico lo avvertiva, lo percuoteva, colpendo il suo cervello con impulsi di ragione e sollievo. Non poteva fermarsi ora. Non doveva più pensarci. Quello che era stato era stato. Dio non esisteva e non avrebbe certo punito quel suo gesto tanto efferato, se proprio lo aveva commesso. Non era questo che pensava? Perché si preoccupava, dunque? Perché si torturava? Si sciolse in un pianto e appoggiò la nuca a terra, inchinandosi in una sorta di preghiera al nulla. Poggiò le ginocchia pucciandole nel suo stesso sangue; le mani intorno al cranio, nella posizione che assumono le persone in via di arresto da parte della polizia,tenevano una testa imbizzarrita; la fronte, appoggiata a terra, sul terreno che poco prima i suoi piedi scalzi avevano percorso, era bagnata dalla fresca rugiada. Il sangue era lavato dall’acqua della natura, che alleviando il dolore bruciava il suo odio. Doveva fuggire. Nessuno gli avrebbe mai creduto. Doveva fuggire. Non pensando al miracolo che forse la provvidenza divina, in cui lui non credeva, o forse il caso gli avevano donato rendendo la sua macchina irriconoscibile agli agenti locali, Grant alzò il capo e sollevò il massiccio corpo cominciando a correre verso nord, dove il Canada lo aspettava ancora.
|
|
Scrivere un nuovo capitolo è come scrivere un’altra storia: diversa per caratteristiche, tempo, struttura, incipit e fine. Un racconto che ha personaggi diversi, solo in apparenza simili a quelli passati. Perché, come nella realtà, in un libro la gente cambia. Cambia ad ogni risveglio, ad ogni respiro, ad ogni pensiero. E può così accadere che colui che all’inizio era carnefice diventi in realtà vittima, chi era colpevole diventi innocente, chi Era diventi Essere. La vita, l’esperienza e il dolore cambiano le persone, le mutano in nuove esperienze e nuove vite. Accadde così che Grant Colbain, vittima della strage di Norwich, diventasse, forse, il carnefice di un altrettanto efferato delitto. La nostra vecchia storia era finita nella sua gioventù, nel racconto di un dolore che ne aveva mutato profondamente la psiche. Il nuovo racconto inizierà con Colbain, smarrito nuovamente nell’oscurità e nel nulla, intento a cercare un’origine, una base. Procederemo dunque con lui in questa ricerca.
Traumatizzato dall’aver perso la madre nel mare della pazzia, da tutti quei cadaveri osceni, pustolenti, congelati e viscerali e dal tradimento del suo tutore passato in poco più di una sera da angelo vendicatore a demone mascherato, Grant vagava ora nella più profonda determinazione all’estinzione. Solo una cosa lo tratteneva al mondo, solo un dubbio. Quel dubbio, quella ricerca, quella domanda a cui non sapeva dare alcuna risposta. Perché? Perché viveva? Perché era stato salvato da morte certa? Il fato era stato crudele, lo aveva beffato, deriso, schernito. Il destino si era preso gioco di lui, lo aveva usato come un burattino in un buffo teatrino. Ed ora era lì, solo, a tormentare il suo spirito ferito. Passarono mesi prima che si accorgesse che non aveva nessuno. Nessuno lo voleva, nessuno lo cercava. In tanti avevano saputo di quel delitto. In tanti, leggendo i giornali, avevano provato pietà per quell’esserino innocente. In tanti si professavano pronti a coccolarlo, ad accoglierlo, a confortarlo. In tanti avevano detto di averlo cercato a lungo per prenderne la potestà. In tanti, ma nessuno che fosse arrivato a parlargli, a fargli una carezza, a vederlo, a pensarlo. Tutti si professano buoni quando non hanno nulla da perdere, ma quando la posta in gioco è più alta nessuno attua le proprie promesse. Nessuno. Abbandonato da tutti, perfino da quell’angelo nero che tanto aveva ammirato, Grant trovò subito conforto nelle larghe braccia granitiche di un collegio minorile a Nord. La vita in questo luogo era tutt’altro che facile, ma, come si sa, le asperità induriscono cuore e carattere. Fu così che dopo anni di pestaggi, soprusi, angherie e sfottò Colbain trovò la forza di reggersi in piedi da solo, di combattere contro un mondo che non lo cercava e tantomeno lo voleva. Il suo fisico cominciò a seguire l’irrobustimento caratteriale e in poco più di un anno crebbe di ben trenta centimetri. Questa spaventosa crescita lo portò ad accrescere ulteriormente la propria autostima, facendone un buon amico e un cattivo avversario. I giovani che tanto duramente lo avevano schernito e picchiato ora non pensavano neanche lontanamente di farlo nuovamente. Le sue mani, piccole come le chele di un granchio, erano state sostituite da arti grandi come guanti da baseball che incutevano timore in chiunque gli si avvicinasse. Qualche volta, tentato dall’usarle per volgere a proprio favore un dibattito, aveva provato il suo animo nobile, in cui ormai non riponeva fede alcuna, che era sempre riuscito a fermarlo in tempo. Il suo grande fisico era anche riuscito ad attrarre qualche donna; poche per la verità, principalmente per due motivi: in primo luogo il collegio era principalmente maschile, inoltre le femmine avevano paura della sua massa e delle reazioni che potesse avere. Alla veneranda età di diciotto anni non era giunto quasi a nulla in campo sentimentale, escludendo qualche bacio rubato e qualche palpatina. Giunse così alla maggior età senza aver avuto alcuna esperienza sessuale, candido e puro nella sua anormale oscurità. A dir la verità conosceva quasi tutto sull’argomento, ma solo per sentito dire, in modo teorico e presupposto. Dopo avergli donato un’istruzione sufficiente ad iscriversi a qualsiasi indirizzo universitario di medio livello, una piccola borsa di studio e uno scarso indirizzamento alla vita sociale e civile, il collegio lo rilasciò nel mondo libero, abbandonato alle sue scelte e al suo destino. In realtà la sua istruzione era stata tutt’altro che entusiasmante e spesso era giunto alla conoscenza di determinati argomenti solo grazie alle proprie forze e alla curiosità che ancora fortemente lo caratterizzava. Pur non tralasciando l’attività fisica, la sua vita collegiale era principalmente costituita dalla ricerca e dalla lettura. Era giunto, per noia, a divorare interi scaffali di libri in poche settimane e a lasciare nel panico qualunque professore lo interrogasse su un testo già letto. Uscì così dall’istituto pieno di curiosità per quel mondo che lo aveva precedentemente deluso, ma che ora lo attirava come una terra inesplorata attira la fame di gloria di un esploratore. Quel cosmo, conosciuto solo in parte durante l’infanzia, gli sembrava un vasto quaderno bianco completamente da riscrivere. Lo attirava respingendolo al medesimo tempo, urtandolo verso una maggiore ricerca. La ricerca di quel qualcosa che tanti anni prima, a Norwich, aveva perso, e che nei libri del collegio non c’era: un’origine. Un’origine diversa da quelle panzane su Dio a cui aveva sempre creduto, un’origine scientifica, provabile, documentabile. Un volume, in particolare, nella sua vita di lettore, lo aveva stimolato: ‘Il culto di Slaat’ del famoso storico Brian Lodge. Quel libro, imbottito di confutazioni, tesi, sofismi e ipotesi, lo aveva entusiasmato più di qualunque altro. Uscito da quell’antro che lo aveva imprigionato per anni, rilegando la sua libertà solo al viaggio mentale della lettura, il suo primo pensiero, invece di ricadere sulla madre e la sua pazzia o sul lavoro che lo avrebbe sostentato durante i prossimi studi, piombò su quel libro e su quell’autore che tanto avrebbe voluto conoscere durante la prigionia. Prese il portafoglio dalla tasca e,dopo averne estratto alcune monete per pagare il biglietto del mezzo pubblico che attendeva, lo rimise rapidamente in saccoccia. Guardando il marciapiede e cercando di non essere turbato da tutta quella improvvisa libertà, si sedette in una cabina d’attesa per autobus. Fissò l’ampio cartellone bianco con le indicazioni del tragitto fissato sul giallo ferro del cabinato e pensò a quale delle linee avrebbe dovuto seguire per arrivare a casa del suo nuovo idolo, del suo nuovo eroe, del suo nuovo faro, della sua nuova base e colonna, dell’essere che poteva ora rispondere ad ogni suo quesito. Inebriato da tante possibilità, fu per un momento annebbiato da un’indecisione cronica che lo fece cadere nel panico più totale. Quale strada avrebbe dovuto prendere? Le macchine passavano veloci davanti ai suoi piedi, alzando piccoli granelli di polvere e foglie accartocciate ai lati della via e confondendo ancor di più le sue già poco calme idee. I finestrini, illuminati dalla calda luce del sole che scaldava il volto di Colbain, lasciavano trasparire qualche sfocata immagine dei passeggeri. Qualche bici e qualche vecchia in sella, due o tre motorini e qualche moto, qualche giovane e qualche anziano a passeggio; fu questa tutta la compagnia consentita a Grant, che immaginava nei loro visi indaffarati e noncuranti una vita, esperienze, un motivo, un carattere, parole , un conforto. Provò a rasserenarsi cercando un po’ di sicurezza guardandosi nel vetro della struttura d’attesa,dove non vedeva altro che un ragazzetto felice, un po’ spaesato e ingenuo,ma entusiasta e esaltato dal suo prossimo incontro. Il volto bianco, quasi incipriato, dalla mascella ampia e spelacchiata, dal naso piccolo e abbozzato, quasi a patata, tra i piccoli occhi, parecchio distante dalle grandi labbra rossastre, lo calmò un poco. Lui era lì, fermo, con quei capelli castani, ondulati, un po’ mossi, mediamente lunghi e dai riflessi dorati; il taglio semplice e dalla riga in mezzo non molto marcata, la rosetta folta e piena a ricordare quanto lontana sarebbe stata la vecchiaia. Le spalle, grosse, coperte da una camicia nera ad ampi quadrettoni di un verde brillante ma non troppo sormontata da una giacchetta marrone in morbida pelle. La cintura di pelle scura marrone a sostenere quei calzoni blu un po’ larghi donatigli da un compagno di stanza un po’ più anziano, stufo del solito look da collegiale. I mocassini neri a coprire calze lunghe tinte di un blu scuro e grossi piedi da calciatore. La schiena, leggermente inarcuata per lo sforzo di rimanere sotto il padiglione, sosteneva una testa proporzionata al corpo e un petto ampio e forte. La pancia, non troppo allenata, brontolava vistosamente, ma ciò non importava. Era nervoso, solo, squattrinato, senza domicilio e aveva fame, tanta fame da trasformare il suo ventre in una pentola a pressione, ma neanche ciò importava. L’unica cosa che ora importava era salire sull’autobus che portava da Brian Lodge, al numero 210 di Alabama street. Un ampio soffio, colpendo l’atmosfera e i timpani del giovane, preannunciò la frenata del bus, pronto a fermarsi dinnanzi a lui. Quel mezzo gli ricordava l’ultimo pullman preso prima dell’imprigionamento nel collegio, quello scuolabus assalito dai suoi compagni di classe di un tempo e tanto odiato per quanto gli faceva ricordare. Quel ricordo, quell’oscuro ricordo che gli riportava alla mente il suo angelo, fermo sul ciglio a controllare che salisse, statico e calmo nel suo ampio sorriso, salutandolo con una foga falsa e ipocrita. Pensava a quanto era stato falsamente buono con lui e a quanto lo aveva fatto soffrire quando, quella notte, aveva scoperto Il Segreto. Pensava a Dio, e questo era impossibile e inutile per lui, reputando che nessuna divinità esistesse. Pensava troppo. Pensava a cose che troppo lo avevano tormentato durante la sua prigionia e che troppo lo avevano cambiato. Pensava che l’unica risposta era lui, lo studioso, lo storico, lo scrittore, Brian Lodge. Pensava, mentre quasi inciampava salendo sull’autobus e cercando di trattenere l’emozione, il nervosismo e la paura. La paura che quell’incontro non gli sarebbe servito a nulla. La paura che un altro incontro lo avrebbe cambiato ancora, tramutandolo in qualcosa di nuovo, qualcosa che non voleva essere. Pensava, mentre la sua ricerca aveva inizio.
|
|
Tornato a casa da quella visita infernale che lo aveva condotto su una via oscura e solitaria, si tolse le pesanti scarpe e si accorse subito che il suo profumo non era certo il migliore del mondo. Appoggiò i calzari sul tappeto e salì piano, con moto scanzonato e svogliato, le lunghe scale ripide. Guardò l’ampia finestra di fronte a lui e si diresse alla sua camera, dove si rinchiuse immediatamente a pensare. Il freddo della casa gelida lo avvolgeva in un manto di brividi e singhiozzi, tipici di qualsiasi ragazzo che perda ogni punto di riferimento. Il materasso duro e umido su cui si era seduto stava inzuppando ogni fibra dei suoi jeans, regalo di una madre ormai persa. Pensava a quando era piccolo e suo padre, prendendolo per le mani, lo faceva volare in alto, come gli aeroplani. Pensava a quando suo padre lo sgridava per le marachelle. Lui era piccolo e si infilava sempre nello sgabuzzino a nascondersi, facendo cadere dalle mensole un po’ di tutto. Il papà lo prendeva da parte togliendolo dallo stanzino, lo fissava con sguardo severo e gli faceva una lunga ramanzina. Pur essendo momenti brutti, si ricordava che anche in quegli istanti lo sguardo del padre era pieno di amore e tenerezza, colmo di fragile insicurezza paterna e di grande dolcezza. Sua madre era sempre stata un po’ in disparte. Pur avendo modi molto teneri e ragguardevoli, ovviamente materni, aveva sempre dimostrato una certa freddezza nella comprensione e nell’allevamento del figlio, che a tutti gli effetti gli preferiva il padre. Ricordando tutto questo Grant si ritrovò a piangere come un bambino,- quale in effetti era -disteso sul letto bagnato. Cole, noncurante del suo stato emotivo, era rimasto al pianoterra a preparare la cena della sera. Colbain si sfogò completamente, tirando fuori tutta la rabbia per quel Dio che gli aveva dato una bellissima famiglia per poi togliergliela crudelmente. Poteva esistere una divinità così cattiva? In cosa aveva creduto in tutti questi anni? Si sentiva stupido, stupido e incompreso. E piangeva, come le nuvole nere di un temporale, come una fontana zampillante. Come un bambino. La cena fu squisita. Come l’ultima cena dei condannati, era rifornita di tutte le leccornie immaginabili. Forse, in fin dei conti, Cole si era accorto di quanto il ragazzo avesse sofferto e gli voleva dare una seppur minima soddisfazione rifornendolo di tutto il ben di Dio immaginabile. Il piccolo non faceva neanche caso al viso compiaciuto e curioso di Cole, intento a fissare il suo sguardo opaco e depresso. Appena finito di cenare, Grant si diresse di corsa verso il letto, preparato da poco nei minimi particolari dal suo tutore. Prima di dirigersi alla stanza pensò bene di farsi una doccia veloce e, tutto indaffarato, entrò nel bagno senza nemmeno accendere la luce e portandosi dietro solo un paio di slip. Fu allora che Cole commise l’Errore. Uscì in fretta di casa, sbattendo piano la porta. Credeva che il piccolo fosse già andato a dormire e fosse avvolto fino alle orecchie, per colpa del freddo, dalle coperte. Si diresse verso l’auto, parcheggiata nell’ampio garage; ne aprì con forza la serranda e, fugacemente, spalancò il portabagagli della macchina. Il piccolo era uscito dal bagno, in mutande, per accendere la luce e aveva inavvertitamente sentito quegli strani rumori provenire dal retro. Si mise allora alla grossa finestra e fu in quel momento che li vide: i grossi vermi neri, impilati l’uno sull’altro, erano adagiati di fianco al box macchina. E c’era anche il suo angelo nero. Il suo salvatore stava trascinando quegli esseri di plastica fuori dal garage con una smorfia compiaciuta dipinta sulla faccia. La luce del bagno era attutita dalla porta socchiusa e grazie a questo e ai lampioni il piccolo Grant riuscì a vedere la scena nei minimi particolari. Quelli non erano vermi. Erano sacchi. Sacchi grandi, neri, di quelli che si vedono all’obitorio o nelle fosse comuni. E lui, quell’omuncolo, come lo chiamava sua madre, li stava impilando l’uno sull’altro. Grant fu pervaso dal dubbio e ,lentamente , scese le scale. E vide che la cantina era aperta. Uno sciamare di mosche e moscerini ne circondava l’entrata ed un alone di gelo ne usciva potentemente, come quando si apre un congelatore e si sente il gelo penetrare fin dentro le ossa. Poteva finalmente scoprire il mistero di quella cantina. Risalì le scale e controllò alla finestra che Cole non lo avesse scoperto, quindi si voltò con le spalle verso la vetrata e raccolse tutto il suo coraggio per tentare l’impresa. Williams, intento ad accatastare i sacchi, gettò uno sguardo in direzione della finestra. Lo vide. Vide l’ombra di un fanciullo voltato di spalle che probabilmente lo aveva fissato fino a pochi momenti prima. Fu preso dal panico. Che fare? Che fare ora? Lo aveva visto, lo aveva visto sicuramente! Perché era sveglio? Non era a letto? Perché non aveva controllato prima di uscire? E ora? Mollò il sacco che stava trasportando nel bel mezzo del giardino e corse verso casa. Intanto Grant, diretto verso la cantina, aveva gettato uno sguardo nell’oscurità che la colmava. Afferrò con una mano il corrimano delle ripide scale che portavano allo scantinato e con l’altra tentò di farsi strada tra i vari insetti volanti che infestavano la stanza. Un odore di marcio e morto assalì le sue narici insieme al freddo rumore di un grande congelatore. Prese coraggio e scese il primo scalino verso l’oscurità del seminterrato. La porta dell’ingresso sbatté con forza e Cole, appena entrato, lanciò un urlo che invase tutta la casa – GRAAANT! Colbain risalì il gradino e richiuse con forza la porta della cantina, serrandola con un giro di chiave. Riprese in mano il corrimano e scese rapidamente le scale mentre la porta sobbalzava sotto i pugni del suo angelo nero. Quasi cadde cercando di scenderle il più velocemente possibile, ma riuscì ad appendersi al corrimano, forse lussandosi una spalla. Saltò giù dall’ultimo gradino e voltandosi verso la scalinata che aveva appena percorso, vide la porta in legno gemere sotto le spallate di Williams. – GRAAANT! FAMMI ENTRARE! Il buio che lo circondava, le grida, i gemiti della porta, l’odore di marcio e putrefatto, il ronzio delle mosche che gli pungevano la pelle, il freddo che riempiva la stanza e quell’intenso rumore tipico di un climatizzatore facevano fremere il suo corpo di bimbo come una foglia. La porta sbottava insistentemente. Williams era arrivato a colpirla con un estintore – GRAAANT! DANNATO RAGAZZINO! Grant non vedeva nulla in quell’oscurità profonda. Sentiva sulla sua carne le mosche, le loro piccole zampette viscide, il loro corpo pungente. Sentiva le loro ali vibrare nel vuoto della stanza, invasa da quell’odore di morte profonda. Sentiva il freddo che gli gelava la cute, gli faceva battere i denti, gli faceva lacrimare gli occhi. Le mosche erano nervose e sbattevano con forza contro il suo corpicino. ZZZZ- le mosche, il climatizzatore, il freddo, avevano lo stesso rumore- ZZZZ. CLUNG- il rumore di un dondolante oggetto metallico pendeva sulla sua testa –CLUNG. – APRIIII! FIGLIO DI PUTTANA, APRI QUESTA FOTTUTISSIMA PORTA! Il grido lo spaventò profondamente, tanto da farlo arretrare di qualche metro. Cadde. Era inciampato su qualcosa di freddo e grosso. Era col culo a terra, la gamba poggiata sull’ostacolo e lo sguardo fisso alla porta. Poi lo sentì. Ciò che l’aveva intralciato aveva una mano. Una mano fredda, gelata e salda. Tolse la gambe immediatamente e fissò il punto dove la sua cute ne aveva incontrata un’altra, ma immensamente più ferma e secca. Lo guardò, e lo vide. Un viso. Bianco come la neve, glabro. Gli occhi a fissare il vuoto, la bocca leggermente aperta in una smorfia. I segni di un casco che gli aveva deformato il cranio. Scese con lo sguardo verso il torace. Lo vide. Nudo, niveo, gonfio, rigido come il cranio. Le braccia a stringerlo, quasi a contenere la sua espansione e a riscaldarlo dal gelo. Un conato gli salì per la gola, ma la curiosità era troppo forte. Scese ancora, cercando la vita e le gambe. Buio. Non c’erano. Una macchia scura sul pavimento all’altezza del busto, un insieme di frattaglie grigiastre, appallottolate come nei supermercati. Erano ferme, rigide, indurite dal gelo. Il vomito gli uscì potentemente dalla bocca, raggiungendo la macchia rossastra che circondava il cadavere. Si mise una mano sullo sterno e fece uscire ogni frammento di ripugnanza allungando la lingua verso il labbro inferiore. La sua bocca, spalancata dal disgusto, era rivolta verso il basso. Le mosche continuavano a tormentarlo mentre infestavano la salma. – APRIII!!! APRI, O DOVRO’ SFONDARLA! A sentire il suo angelo nero, per lui un idolo fino a poco tempo prima, la sensazione di rigurgito si fece più forte. Come aveva potuto affidarsi ad un tipo del genere? Quello davanti a lui era un cadavere! Perché aveva un cadavere in casa? Colpi. Colpi fortissimi alla porta, che reggeva agli urti in modo eroico. Le lacrime cominciarono a cadere sul pavimento insieme al vomito e a quella macchia scura. – Perché?- gemette Grant Passi. Pesanti, forti. Colbain si abbandonò sul pavimento sporco sulle mutande messe la mattina. Piangeva, come poche ore prima. Piangeva di terrore. Uno sparo. La serratura si sbriciolò in mille pezzi. La porta, gemendo un ultima volta, si aprì. La luce del piano di sopra, lontana, illuminò la figura dello scassinatore. Williams scese piano le scale, fissando i lineamenti del bimbo seduto. Accese la luce. Il bambino era adagiato sul pavimento, vicino al putrido cadavere. La luce bianca e vitrea illuminò la salma, mostrando le interiora riverse sul suolo e il volto bloccato in una espressione dolorosa e verdognola. Il viso del bimbo era sconvolto e fremente di terrore. Cole si avvicinava a passi lenti. - Tu.. devi capire- disse Williams, approssimandosi a Grant. Il gelo Bloccava i muscoli e le mosche annebbiavano la vista, illuminate da quella luce candida e forte. Lo sguardo del suo tutore era fermo e sicuro, tanto da sembrare sclerotico - Se.. se capissi.. se solo capissi- Colbain lo vedeva sempre più vicino, sempre più folle. Fissandolo, percepì il gancio alle sue spalle. E la salma che vi era appesa. Un altro corpo umano esanime. L’angelo nero gli allungò la mano aperta, come quella volta vicino alla stazione dell’autobus. Una mosca vi si posò sopra, sporcata da un recente sangue. Il palmo vibrava al freddo della stanza. - Noi.. noi non abbiamo libertà..- disse l’uomo- Come.. come può l’uomo essere libero se è costretto a rispettare la legge di Dio?- il suo sguardo diveniva sempre più forte ed esasperato- Quale libertà è più grande del trasgredire le leggi di Dio? Quale libertà è più forte dell’esser liberi da qualsiasi vincolo, persino da quello col nostro creatore? Le parole dell’invasato colpivano l’animo del piccolo come potenti battiti di campana. Era questa la risposta che cercava? Era forse questa? - Uccidere.. uccidere non è nulla… perfino un agnello può uccidere..- sussurrò il pazzo- ma nutrirsi.. nutrirsi del corpo e dell’animo dei propri simili, del popolo eletto! Chi può questo? Neppure il diavolo! Quale libertà è più grande? Quale p-POTERE? Il giovane fissò quello che a lungo era stato il suo supereroe. Lo guardò come fosse un pazzo, pieno di sdegno. Cole afferrò le sue spalle e lo scosse con forza. - Capisci? L’uomo! L’uomo che diviene più grande di Dio! Del Diavolo! Chi può fermarmi? Guarda!- girando le spalle del giovane, gli mostrò l’intera stanza. L’antro, bianchissimo, era pieno di corpi vitrei e ripuliti dal sangue, appesi al soffitto da grossi ganci infilati nella schiena- Questa.. gente.. queste nullità.. hanno peccato alle leggi di Dio.. in cerca dell’ebrezza di una libertà che hanno provato solo per un istante, bloccati dalla legge…ma io.. io.. sono libero! - Tu.. tu..- sussurrò Grant, fissando sconvolto i cadaveri che cigolando dondolavano nella stanza bianca come animali da macello. - Chi? Chi in questa vita può fermarmi? Forse il Diavolo, che schernisco ogni giorno? Forse Dio? Perché non interviene, perché non appare? Perché non appari, DIO ONNIPOTENTE?- gridò il pazzo Un suono. Uno sparo. Il volto di Williams paralizzato in una smorfia di disgusto. Il torace di Grant ricoperto di sangue. - Mi cercavi?- una voce. Un poliziotto, in divisa completa, era fermo sulle scale, le braccia dritte davanti al volto ad impugnare una pistola fumante. Cole toccò tremante il buco da cui il sangue fuoriusciva zampillando copiosamente. Lo sguardo fisso nel vuoto, vitreo come i suoi cadaveri. Le dita, scostate dalla ferita, piene di sangue. Di un sangue che stavolta apparteneva a lui e non alle sue vittime. - Come?- sussurrò, svenendo a terra di fianco al suo ultimo pasto. Grant fissò la scena, poi si riprese e corse verso il poliziotto, che lo accolse con un forte abbraccio. - Va tutto bene- disse l’agente – va tutto bene. Lo sbirro lo avvolse in una coperta e lo portò al piano superiore, mentre il suo angelo nero pronunciava, stringendosi la mano al petto e alla ferita, le sue ultime parole: - E’ dunque.. la mia.. libertà.. già.. cough cough.. è.. dunque.. la mia libertà.. già.. finita? Il suo corpo morto, disteso a terra, per ironia della sorte, in quella stanza, faceva compagnia a tutte le sue vittime. Grant, avvolto in una calda coltre di lana, attendeva, lo sguardo fisso nel vuoto, un prossimo evento. La sua fede, le sue speranze, il voler ricambiare quell’uomo che tanto gli sembrava buono, svanirono nel nulla. L’inferno a cui era condannato l’aveva appena vissuto. Tutto ciò in cui credeva, tutto ciò che lo sosteneva, tutto quanto svanì nel nulla. Dio? Dio non esisteva più. Come poteva permettere ad un uomo in apparenza tanto buono di fare tanto scempio della vita? Come poteva essere una tale divinità un’entità buona? Non poteva esistere. Dio non c’era. Dio non c’era più. Era morto in quella stanza, in quella cantina, nell’antro dell’angelo nero, nella caverna dell’angelo di Norwich.
Da un estratto dei verbali della polizia di Norwich city: Il beneamato Cole Williams, direttore del carcere penitenziario, è stato rinvenuto insieme al suo figlio adottivo nella cantina di casa sua in compagnia di molteplici salme trafugate dallo stesso carcere penitenziario tra i condannati a morte per sedia elettrica. Il sergente Winston, sentendo uno sparo provenire dalla casa del suddetto, vi si è subito precipitato per controllare l’accaduto, trovando il suddetto in atteggiamenti poco ragionevoli. E’ stato costretto a sparare per liberare il piccolo adottato dalla morsa del tutore, che lo avrebbe probabilmente reso la sua prossima vittima. Maggio, 13 1996, Norwich City
|
|
Si svegliò di soprassalto. Il suo volto dolorante era trafitto da miriadi di pezzi di vetro fini come la pioggia. Uscendo di strada, il parabrezza si era frantumato ed aveva penetrato in piccole schegge il viso putrefatto di Grant Colbain, intento a scappare verso il Canada. Probabilmente il sonno e i viaggi mentali, ispirati dalla strada lunga, larga e buia, avevano distratto completamente l’autista dalla guida. Sollevò una mano e tocco il suo viso lanciato dal dolore, togliendo pezzo per pezzo, lentamente, i piccoli frammenti di vetro. Ad ogni scheggia tolta uno zampillo di sangue usciva dalla carne putrida, sporcando i vestiti e lo sterzo di un rosso scarlatto. La carne grossolana e rigonfia che costituiva quello che si poteva difficilmente definire il suo viso attutiva il dolore dell’estrazione. Gli occhi, incastonati nelle guance gonfie e negli zigomi dilatati, vedevano a malapena in ciò che restava dello specchietto retrovisore il volto del conducente. Colbain prese il cappello, caduto insieme alla valigia sotto il sedile anteriore destro, se lo ficcò bene in testa e, dando una potente botta alla portiera, uscì dalla macchina arrugginita. Il cofano era totalmente accartocciato sul lampione davanti a quella che un tempo era un auto e i fanali anteriori erano praticamente l’uno di fronte all’altro. Maledicendo la sua vecchia auto e tirandole dei calci ben assestati, Colbain si scordò del suo dolore. Prese la valigetta sotto braccio e lasciò il luogo dell’incidente incamminandosi nella foresta vicina alla strada. Benedisse sé stesso per aver impattato vicino ad una boscaglia e non in piena cittadina, cosicché il suo incidente passasse inosservato. L’accaduto poteva anche essere a suo favore: lasciando l’auto in quel luogo Grant avrebbe fatto perdere completamente le tracce di sé. Penetrò nel fogliame velocemente lasciandosi l’auto alle spalle e cercando un posto isolato in cui riposare. Un piccolo albero rinsecchito, nascosto tra grossi alberi, gli si presentò dinnanzi come il giaciglio perfetto per la sua schiena martoriata. Appoggiò la schiena al fusto e socchiuse gli occhi, cercando un temporaneo riposo in quella fuga senza sosta. La mattina seguente un carro attrezzi era intervenuto per rimuovere l’auto dal percorso stradale e per facilitare la circolazione. Per fortuna nessuno riconobbe che quella era l’auto del famigerato omicida Grant Colbain, appena scappato dal luogo del delitto. Neppure lo sceriffo, giunto a sincerarsi che nessuno fosse coinvolto nell’incidente, pensò all’eventualità che il ferito potesse essersi riparato nella foresta. Ipotizzando che fosse andato all’ospedale sulle proprie gambe, salì sulla sua tipica auto blu e marrone e fuggì all’orizzonte. Intanto Grant si era risvegliato, dolorante più della notte precedente. Qualche scheggia era penetrata in profondità e se non si fosse fatto curare avrebbe rischiato la cancrena. Si alzò dal suo giaciglio e si diresse, attraverso la conoscenza degli indizi che svelano i punti cardinali, a nord, verso il Canada. Trascinando il suo corpo dolente, raggiunse un sentiero, probabilmente usato dai contrabbandieri della zona, e calpestando con i grossi piedi il suolo battuto, continuò la sua marcia verso la salvezza. Dopo aver percorso qualche chilometro, si rese conto che i piedi e le gambe, abituate a lunghe fughe sedentarie su quel catorcio che chiamava macchina, non gli reggevano più. Si sedette sulle sponde di un fiumiciattolo a bagnare i piedi doloranti nell’acqua fresca, fissando il suo volto nello specchio vitreo del liquido. Come aveva potuto essere così sfortunato? Che la dannazione e la maledizione del Dio in cui da tempo non credeva più fossero ripiombate su di lui? Non poteva. Non poteva essere. Sapeva che ciò che tutti chiamavano Dio nella sua mente non esisteva più. Lo aveva arginato ad un ruolo marginale per poi farlo sparire nel nulla, insieme alla sua infanzia tormentata. Quell’infanzia che lo aveva portato a conoscere la sua futura moglie. Quell’infanzia che lo aveva tormentato a lungo e che era finita con la nascita di sua figlia, svanita per sempre in un mare di felicità. Quell’infanzia che ora era tornata a tormentarlo, quasi fosse tornato bambino. Quasi fosse tornato all’inferno dell’angelo nero.
|
|
Effettivamente quel mattino fu molto duro: i compagni lo presero in giro dietro le spalle mentre lui, concentratosi solo su come ripagare l’aiuto del suo angelo, faceva poco caso al chiacchiericcio. Si sa che spesso la gente parla per niente e trova nelle persone difetti che non esistono, ma in questo caso i commenti dei compagni furono più che giustificati dall’olezzo del ragazzo. Uscito da scuola, il ragazzo si decise a far visita alla madre in clinica. Fu il suo stesso tutore a portarlo quasi presso la madre, per poi abbandonarlo a pochi metri da questa. In realtà Williams covava ancora qualche rancore nei confronti di quest’ultima, anche se l’assicurazione che intervenne dopo l’incendio non solo coprì i costi di riparazione, ma consentì anche al povero diavolo di costruirsi la casa che sognava da tanto tempo. Il giovane aprì la porta della sala di ricreazione della clinica dove sua madre passava la maggior parte del tempo tra un pasto e l’altro. La trovò lì, seduta su una sedia a rotelle, lo sguardo perso nel vuoto, le mani appese al duro metallo del sedile. Le si avvicinò lentamente, senza sorprenderla, ma abituandola a poco a poco a un incontro visivo, quasi per non farle paura. - Mamma..- disse Grant, colpito dallo stato della donna. La sua anima non era però così dispiaciuta, poiché credeva che senza la follia della madre lui non avrebbe mai trovato l’accoglienza del suo giovane angelo. Si chinò e le strinse la mano, fissandola, inginocchiato, dal basso in alto. La madre non spiccicava parola. Era muta, come un pesce. Continuava a fissare nel vuoto, a non guardare il figlio prostrato davanti a lei che gli accarezzava la mano. A sua volta Grant si sentiva in colpa per non provare dispiacere per la situazione materna e cercava di comportarsi il più possibile come un figlio amorevole, ma la donna non lo osservava affatto. - Mamma. Mi manchi- sapeva che era una menzogna, ma non sapeva che altro dire per togliersi di dosso quel maledetto senso di colpa- Io comunque sto bene. Il signor Williams mi ha accolto in casa sua. - Spregevole figlio di un cane- sussurrò la madre nel vuoto, lontano dalle orecchie del figlio, continuando a fissare la vastità aerea della stanza- Se tuo padre fosse qui…se tuo padre fosse qui… Colbain fu colpito duramente dalla risposta della madre e si alzò di scatto, spaventato dalla reazione inusitata alle sue parole. Che sapesse che non gli mancava? Che era solo una menzogna? - Quel farabutto.. farabutto figlio del diavolo- tuonò la donna, con voce crescente- Si è portato via mio figlio! Quell’OMUNCOLO!- gridò, tutt’a un tratto. - Mamma- disse Grant, allontanandosi via via dalla madre e dalla sua sedia a rotelle - E tu.. tu .. Perché? Perché vai a cena col demonio?- gemette la donna, singhiozzando vistosamente. Le lacrime cominciarono a scendere e la donna si alzò dalla sedia per precipitarsi sul petto del giovane, che avvinghiò con forza. Grant, intimorito dalla situazione, vedeva il volto degli altri ricoverati seguire sghignazzante il colloquio. - Non sederti alla sua mensa, o verrai corrotto! L’Omuncolo ti vuole soggiogare! Il suo impero di carne e tuono è grande e forte, non prestargli attenzione! Scappa! – gridò la donna, appendendosi alle spalle del ragazzo e scivolando lentamente- Se tuo padre fosse qui- gemette, per poi sedersi sul pavimento di fronte al piccolo. La stanza, bianca ed eterea, era invasa dalle risa dei pazzi che, lontano da loro due, continuavano le loro attività. Grant guardò la madre e pensò a quanta fortuna aveva avuto a perderla. Fu colpito da quel pensiero che lordò ancor più la sua anima, unica cosa sporca in quell’ambiente bianco e pulito. Come poteva disprezzare così la donna che gli aveva donato la luce? Forse perché disprezzava la sua stessa vita, allora doveva necessariamente odiare anche lei? La fissò per l’ultima volta, lasciando cadere la sua mano implorante nel vuoto. Uscì dalla stanza lasciando la donna china sul pavimento, chiudendo la porta senza guardarsi dietro e dirigendosi verso la reception, dove Cole era comodamente seduto. Fece un segno a Williams sollevando leggermente il capo e se ne uscì dalla clinica. Restò seduto sui gradini dell’uscita mentre il suo tutore sbrigava alcune pratiche burocratiche. Pensò a cosa doveva aspettarsi dalla vita, lui che era già stato condannato dall’infanzia. Suo padre, morto in un incidente stradale, era stato a lungo il suo unico punto di riferimento e il suo decesso portò il giovane in una crisi profonda, acuitasi con gli sfottò dei compagni e il duro rapporto con la madre. Il suicidio, tentato da bambino, non aveva fatto altro che aggravare la situazione, portandolo alla disperazione più totale. Ora era dannato non solo per la vita, ma anche per l’eternità. Era nato dannato e sarebbe vissuto dannato per sempre. Quel mondo, la cui apparenza naturale esteriore era così bella e fragile, non era altro che un camion per il trasporto di detenuti all’ergastolo, una via ricoperta di spine per un campo minato. Come poteva solo pensare di esistere in un mondo basato su queste regole? Nemmeno la morte l’avrebbe potuto fare stare meglio, poiché lo avrebbe portato alla sofferenza eterna, una punizione da cui non sarebbe più potuto scappare. Non poteva neppure godersi la vita lasciando perdere quella dannazione e godendosi gli ultimi momenti di libertà, perché nutriva troppo rispetto per quell’uomo pio e impeccabile che rispondeva al nome di Cole Williams. Fu allora che la sua fede in Dio cominciò a vacillare. Perché Dio lo aveva fatto nascere dannato? Perché il suo destino doveva essere così brutale e meschino? Quale male aveva apportato all’umanità? Era più malvagio dei bulletti della scuola e della gente del paese? Perché? Fu allora che cominciò a concentrarsi sull’uomo e a credere in Dio in modo blando, pacato, indifferente. Credeva nella punizione che si aspettava quanto si crede nell’aspro castigo che i nostri genitori non ci danno mai. Williams uscì dalla porta e trovò il giovane pensieroso sulle gradinate. - Allora, andiamo?- disse Cole, mostrando le chiavi della macchina al giovane. Grant annuì e s’incamminò di fianco al suo tutore verso la macchina. Quei pensieri lo tediavano continuamente. Le parole della madre gli tornarono alla mente, come i gridi dei marinai in una tempesta. Colbain fissò Williams e gli guardò attentamente la mano, in cerca di un simbolo che il demonio avrebbe potuto lasciargli. Non trovandolo, ripensò che la madre era solo pazza e che questo era ormai chiaro a tutti i medici della clinica. - A che pensi?- chiese Cole, sorridendo. - ….- esitò il ragazzo- niente. E’ solo.. fa freddo, vero?- rispose - Sì. Freddo. I due salirono in macchina dalle opposte portiere. Il giovane si sedette e fissò la clinica. Pensò a sua madre, che ormai aveva perso. Insieme a suo padre. E insieme a Dio.
|
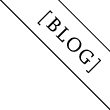



Inviato da: Volo_di_porpora
il 27/01/2015 alle 22:42
Inviato da: sangueedanima
il 07/08/2008 alle 13:43
Inviato da: writerwoman
il 05/08/2008 alle 19:24