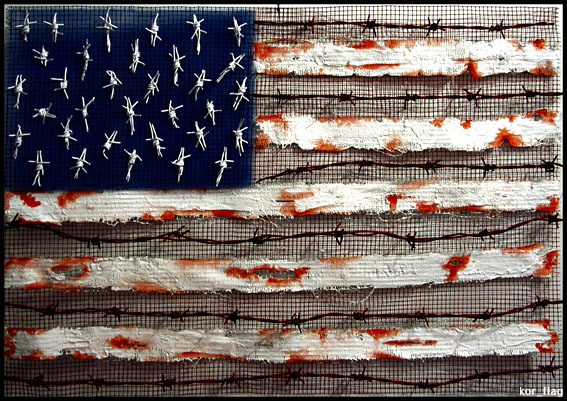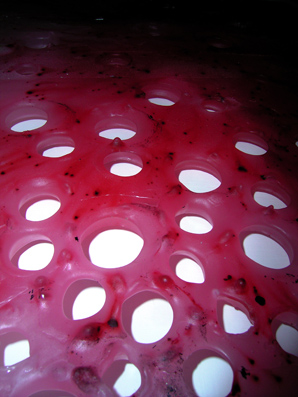- Intervista: Mario Vegetti
- 29/4/1998
Professor Vegetti, è possibile identificare nella Grecia antica il momento o il luogo della genesi della riflessione sul problema della morale?
Ritengo che il luogo dove si presenta per la prima volta il problema della riflessione sulla morale sia l'Iliade, il testo inaugurale della cultura greca. L'Iliade, infatti, comincia presentando il conflitto fra Agamennone e Achille, conflitto non risolvibile nell'ambito dei valori propri di quel mondo arcaico, dove la virtù del guerriero consisteva essenzialmente nella eccellenza della sua prestazione in battaglia, e veniva ricompensata dal bottino e dalla fama che si diffondeva presso gli altri uomini, fama che poi, a sua volta, era il fondamento del prestigio del guerriero. Nell'Iliade Agamennone viene privato di una parte del suo bottino, quindi della sua gloria e della sua dignità, da un guerriero più potente di lui, il dio Apollo, e si rifà di questa lesione inferta al suo prestigio, a danno di Achille.
Questo gesto comporta la rottura dell'unità di quella comunità che l'esercito greco formava sotto le mura di Troia, e apre anche un conflitto di valori che si rivela in qualche modo irrisolvibile. Infatti, sia Agamennone che Achille hanno ragione, non esistendo altra norma di valore oltre le virtù guerriere individuali. Ciò dimostra come, nell'antica Grecia, occorresse pensare a norme che potevano valere in modo superindividuale, cioè al di là della rivendicazione immediatamente personale dell'eroe, e quindi a norme morali, politiche, giuridiche o di altro genere.
La riflessione morale ed etico-politica greca si mosse in una pluralità di direzioni molto differenziate. Da un lato nella direzione della legge, verso l'identificazione di un livello sopraindividuale di valori e di norme - questa fu la direzione presa, ad esempio, da Solone, il primo legislatore della polis ateniese; dall'altro verso l'identificazione di un soggetto morale non immediatamente vincolato alle circostanze dei conflitti interpersonali e sociali. Di qui nacque il concetto di anima, intesa come il vero soggetto della responsabilità morale e del valore morale, indipendentemente dalle vicende, dalle avventure o dalle sventure dell'interazione sociale. Questa fu la direzione che prese una tradizione religiosa prima e filosofica poi, ovvero la tradizione orfico-pitagorica. Questa tradizione non ebbe probabilmente origini culturali greche, ma ebbe certamente una straordinaria diffusione proprio nella Grecia postomerica, nella Grecia del VI secolo, imponendo a tale cultura la nuova figura dell'anima immortale. L'anima, infatti, era concepita come svincolata dalla vicenda corporea, e attesa da un destino divino o da una punizione atroce a seconda delle colpe o dei meriti acquisiti durante la vita terrena.
2. Alla base della visione greca del mondo c'è, fin dalle origini, il concetto di «kosmos», di ordine del reale. Esiste una qualche relazione tra questo concetto e la visione morale dell'uomo greco?
Alla base della visione greca c'era la consapevolezza antica che il mondo degli astri e il mondo degli dèi fosse ordinato. Dal momento che tale ordine era immediatamente in contrasto con il disordine che invece regnava nella società degli uomini, occorreva rendere la società umana altrettanto ordinata quanto lo spettacolo del cosmo che gli dèi offrivano attraverso, per esempio, il moto regolare degli astri.
C'era un ordine degli astri, un ordine delle stagioni, un ordine della natura, mentre nella vita degli uomini regnava un grande disordine, di cui era certamente un esempio il conflitto omerico fra Achille e Agamennone. E' proprio riflettendo su questo conflitto che una tradizione di tipo religioso, come quella contratta sul santuario di Delfi e riflessioni più propriamente morali, filosofiche e politiche, si incontrarono. La sapienza che il sacerdozio delfico tendeva a diffondere era appunto una sapienza dell'ordine; i famosi motti "nulla di troppo", "conosci te stesso" invitavano gli uomini a rispettare quell'ordine che gli dèi avevano voluto. Tale sapienza costituiva anche il centro del pensiero morale e politico di Solone. Infatti quando questi parlava di «eunomia», della buona legge che bisognava istituire nella città, o quando si sforzava di istituire nella polis un ordine politico-morale, pensava proprio a trasferire nel mondo umano quell'ordine che il cosmo presentava. Si tratta dell'ordine per il quale ognuno riceveva la parte che gli spettava in base ai meriti e naturalmente alla condizione sociale, per il quale ognuno rispettava la parte che gli altri aveva ricevuto, e in virtù del quale ognuno stava al suo posto non perché costretto, ma perché capace di interiorizzare le ragioni di tale ordine.
Bisogna poi considerare un altro aspetto di questa idea di kosmos che perdurò nella coscienza greca. Il termine kosmos ha infatti anche un significato estetico, in quanto rimanda direttamente al concetto di bellezza. Di qui nacque l'idea che nell'ordine consiste la bellezza e che, nella vita sociale e morale, il bello coincide con il comportamento misurato, ordinato e regolare. Fu un tratto costante dell'etica greca quello di puntare a una stilizzazione della vita, a un'arte della vita che non fosse solo buona moralmente, ma che fosse anche esteticamente bella.
3. Potrebbe delineare brevemente i tratti fondamentali dell'antropologia di Aristotele?
Secondo Aristotele l'uomo è innanzitutto un complesso psicofisico, una integrazione funzionale di anima e corpo; non c'è, in altri termini, per Aristotele quella opposizione di valore fra anima e corpo sulla quale aveva tanto insistito la tradizione orfico-pitagorica e per certi aspetti anche Platone. Secondo Aristotele, infatti, l'anima è la forma del corpo organico, cioè l'insieme delle funzioni vitali a diversi livelli, da quello riproduttivo a quello percettivo, e, per quanto riguarda l'uomo, fino al livello specificatamente conoscitivo.
Questo significa che non esiste per Aristotele alcuna forma di immortalità dell'anima individuale: per lui la vita umana è segnata dai limiti dell'esistenza corporea. Ciò è molto importante anche per la morale di Aristotele, perché la felicità o la infelicità sono qualche cosa che l'uomo si gioca interamente in rapporto alla sua esistenza morale in questa vita e che con questa vita si conclude; non c'è dunque un rinvio a premi e punizioni in una vita dell'aldilà, in una vita ultraterrena dell'anima.
La struttura fondamentale dell'animale uomo è quella politica; l'uomo è cioè l'animale che vive in società e in forme di interazione politica con gli altri uomini. Aristotele, infatti sostiene che al di fuori della polis, della città, non si può essere propriamente uomini; chi vive fuori dalla città, o è un dio o è una bestia, dal momento che l'uomo in quanto tale non può vivere se non nella polis, non può dunque far proprie se non quelle norme che reggono l'interazione armonica e non conflittuale degli uomini.
Naturalmente bisogna tener conto del fatto che, per Aristotele, non tutti gli individui umani sono propriamente uomini, ma che esistono forme inferiori all'umanità, forme incapaci di giungere al livello di questa vita politica che è la condizione propriamente umana. Si tratta in primo luogo degli schiavi, che, secondo Aristotele, sono per natura incapaci di acquisire le virtù necessarie alla vita politica, in quanto non possiedono la razionalità. Si tratta poi dei barbari, cioè dei non-greci, che sono naturalmente predisposti a diventare schiavi dei greci in quanto non possiedono a loro volta quella capacità razionale di vivere le forme della vita etica e morale della polis. Inoltre, per Aristotele, esiste anche un'inferiorità femminile, che tuttavia non è del tipo che affligge barbari e schiavi; la donna infatti possiede la razionalità ma non possiede in pieno quelle capacità deliberative che sono essenziali del cittadino nella sua esistenza politica. La donna quindi non può accedere alle forme e ai meccanismi di decisione politica, e anche nella vita familiare deve essere sottoposta a un tutore, sia esso il padre o il marito, che suppliscano alla sua costituzionale incapacità psicologica di decidere. Dunque propriamente uomo, nel senso di essere pienamente adatto a una vita morale nella città, è il cittadino greco, libero, maschio e naturalmente adulto, in quanto i bambini non hanno le doti necessarie per questa forma di esistenza.
La forma di vita specificamente umana si delimita quindi verso il basso, rispetto ad altre forme di vita che sono soltanto parzialmente umane. Ma Aristotele dice poi che esiste anche una forma di vita più che umana che eccede i limiti normali della dimensione politica e sociale vissuta dal cittadino. Questa forma di vita che tende ad avvicinarsi maggiormente alla divinità, è quella del filosofo, dove per filosofo si intende un uomo dedito alla pura conoscenza cosmologica, della struttura del mondo, o meglio di quell'ordine del mondo di cui anche i pitagorici avevano cominciato a parlare e che rimase un tema fondamentale della filosofia greca. Tale conoscenza, poi, va a coincidere con la conoscenza della divinità che regola l'ordine, e che è il principio stesso di questo ordine.
Aristotele afferma che il filosofo conduce dunque nella città una vita da straniero perché non è come i normali umani, rappresentando qualcosa di più. I filosofi sono pochi, e la loro felicità e il loro valore è maggiore rispetto a quello concesso alla maggior parte degli uomini. Non c'è tuttavia contrasto fra la condizione del filosofo e quella degli altri uomini, perché questi ultimi conducono la loro giusta, armoniosa vita nel contesto politico-sociale, mentre il filosofo rappresenta quel grado massimo di razionalità cui non tutti possono accedere, ma che qualcuno tuttavia deve esercitare affinché la specie umana si possa dire compiuta in tutte le sue potenzialità.
Nell'antropologia aristotelica la forma di vita tipicamente umana, rappresentata dal libero cittadino greco, maschio e adulto, ha dunque una delimitazione verso il basso, rappresentata dalla moltitudine degli schiavi e dei barbari, e una verso l'alto, costituita dai filosofi.
4. Quali sono le differenze sostanziali tra l'approccio di Aristotele all'uomo, al suo mondo etico, e quello di Platone?
Platone pensava che il mondo esistente, le forme di vita esistenti, l'ordine politico esistente fossero erronei, conflittuali, incapaci di realizzare la giustizia, tanto nella città quanto nell'anima individuale. Egli pensava quindi che occorresse trasformare profondamente la vita individuale e collettiva degli uomini, che occorresse richiamarsi a un piano di valori esterni all'esistente, per rifondare, a partire da essi, l'esistenza stessa. Il bene platonico, infatti, non era un bene che si attuava compiutamente nel mondo, ma era sempre un limite, un orizzonte verso il quale orientarsi per trasformare progressivamente il mondo in cui si viveva e la propria natura.
All'opposto Aristotele pensava che la forma di vita sedimentata dalla tradizione culturale e morale che aveva dato luogo alla polis, era in se stessa perfettamente legittima. Ciò, ovviamente, non voleva dire che, per Aristotele, tutto andava bene, ma che, nella sostanza, la polis e la sua forma di vita rappresentavano il compimento delle potenzialità attuali della specie umana. Non si trattava dunque di cambiare, di modificare, di trasformare, ma di conformarsi a ciò che la tradizione e l'esistente offrivano. La tradizione e l'esistente erano considerati positivi proprio perché condivisi dalla maggior parte degli uomini e soprattutto perché rappresentavano la realizzazione di ciò che la natura propria degli uomini chiedeva; non si trattava pertanto di fantasticare, di vaneggiare nuovi mondi, nuove forme di vita, ma di adeguarsi compiutamente, razionalmente, ragionevolmente a ciò che già esisteva.
Aristotele pensa che il compito della filosofia non sia quello che le aveva assegnato Platone. Questi pensava che la filosofia dovesse servire alla ricostruzione della città, assolvendo una funzione non solo conoscitiva ma anche etico-politica; Aristotele, invece, afferma letteralmente che la filosofia è "inutile", nel senso che è l'attività più alta dell'uomo ed è pura conoscenza. La conoscenza viene perseguita solo in virtù di se stessa: conosciamo per conoscere. La filosofia, nella sua forma più alta, è pura teoria, e, da questo punto di vista, dice Aristotele con un'espressione molto efficace, è "servizio reso a Dio", non più naturalmente nel senso religioso, ma nel senso della conoscenza del mondo.
5. Platone, soprattutto dalla tradizione di carattere liberale, è stato considerato colui che ha inventato una società chiusa, una società autoritaria e tirannica. Pensiamo a Popper, che lo ha definito come colui che avrebbe dato luogo a tutte le forme di tirannia e di dispotismo. Lei è d'accordo con questa interpretazione ?
In Platone c'è sicuramente un aspetto fondamentale che si situa all'esatto opposto della tradizione liberale e democratica occidentale moderna. Per lui il punto di vista della comunità veniva sempre prima rispetto al punto di vista dell'individuo. Se infatti solo una comunità giusta poteva produrre individui giusti, l'individuo era considerato come strumentale rispetto alla comunità, che aveva il ruolo decisivo.
Da questo punto di vista il pensiero di Platone si pone certamente agli antipodi rispetto a quel pensiero liberale che lo ha accusato di arcaismo, di spirito tribale, di immaginare la città molto più come un clan o una tribù che non come un aggregato di individui autonomi e liberi. Sembra dunque lecito ritenere che il pensiero platonico fosse totalitario. Per Platone solo un gruppo ristretto di uomini, i filosofi, conoscitori del bene, avevano il diritto e il dovere di trasformare la città e di governarla, mentre agli altri spettava solo il dovere di seguire le indicazioni dei filosofi.
D'altra parte è vero anche che Platone, proprio in virtù del fatto che pose l'orizzonte dei valori, ovvero il bene, sempre al di là di ogni esistente dato, creò una possibilità di critica, liberatrice e libertaria, rispetto all'esistente. Infatti, se il bene non coincide mai con una data situazione, neppure con quella che i filosofi potrebbero realizzare, perché il bene non si attua mai compiutamente nella realtà, allora ogni situazione è provvisoria, è precaria, è criticabile, è trasformabile. Da questo punto di vista, dunque, non credo che Platone possa considerarsi un pensatore totalitario, in quanto aprì una radicale possibilità di critica dell'esistente in ogni suo aspetto o momento, in base alla quale anche il governo dei filosofi poteva essere criticato. A tal proposito vale la pena ricordare che Platone non è stato soltanto criticato dal pensiero liberale, ma è stato anche visto con simpatia da forme di pensiero rivoluzionario.
6. Tornando ad Aristotele. Quale è il ruolo e lo statuto epistemologico della filosofia pratica nel pensiero aristotelico?
La filosofia pratica, cioè la filosofia che verte sul mondo dei rapporti etico-politici e dei valori che regolano tali rapporti, non è per Aristotele teoria in senso forte. Infatti la teoria forte riguarda solo oggetti immutabili e necessari, dovendo produrre enunciati universalmente veri; il campo a cui spetta la teoria forte è dunque il campo teologico cosmologico e fisico matematico. Il mondo dei rapporti umani è troppo indefinitivamente variabile perché sia suscettibile di una teorizzazione forte.
La filosofia pratica, del resto, non è inutile come la filosofia teorica in senso forte. Aristotele, infatti, dice che la filosofia pratica non serve a conoscere le virtù, ma serve a diventare virtuosi. Essa ha quindi immediatamente un fine pratico, ovvero deve fornire delle norme di comportamento in modo mutevole e variabile, come la razionalità propria del medico, che deve trovare la sua diagnosi in situazioni che appunto mutano continuamente o del marinaio che deve seguire una rotta in circostanze mutevoli e difficili. Aristotele dice che, a differenza della razionalità rigorosa del geometra o del teologo, nel campo della filosofia pratica serve un regolo flessibile che sia capace di adeguarsi alle singole situazioni, e non una norma rigida come quella che Platone pensava di derivare dalla teoria filosofica del bene. Quindi la filosofia pratica costituisce un pensiero meno rigoroso rispetto alla filosofia teoretica, ma più capace di aiutare nei frangenti della esistenza, di indicare la rotta, la via da seguire nella complessità dei rapporti sociali.
7. Qual è la differenza tra virtù etiche e virtù dianoetiche per Aristotele? E quali sono le virtù specifiche del cittadino?
Le virtù dianoetiche sono le virtù del filosofo, sono quelle che hanno a che fare con la razionalità pura, cioè con la contemplazione che porta fuori dall'orizzonte dei rapporti fra uomini e verso la conoscenza della struttura del mondo, dell'ordine del mondo nei suoi dati più profondi e immutabili.
Le virtù etiche sono invece quelle che governano il mondo delle passioni umane, dei desideri, dei comportamenti nel rapporto con gli altri, all'interno della famiglia e della città. Si tratta dunque di quelle virtù di giustizia, di moderazione, di coraggio, di temperanza, che permettono di vivere come uomini giusti e adeguati al contesto sociale in cui si è inseriti.
Per Aristotele le virtù specifiche del cittadino sono, infatti, la giustizia, che significa equità nei rapporti fra uomini; la moderazione che significa il non eccedere nei desideri, il non voler più della propria parte secondo il dettame delphico, il comportarsi con equità nei riguardi dei propri simili e infine il coraggio in guerra.
In generale la regola di queste virtù è definita da Aristotele come la «mesotes», la medietà, che non è mediocrità come molto spesso si pensa, ma è la capacità di evitare sia gli eccessi che i difetti delle risposte dell'uomo alle situazioni in cui si trova. Per esempio, in battaglia, quando ci si trova a combattere fianco a fianco con altri compagni, non bisogna eccedere per viltà, fuggendo dal pericolo, abbandonando la linea e quindi i compagni, ma neppure eccedere per temerarietà, gettandosi da soli a inseguire nemici, poiché ciò, per lo schieramento dei combattenti, sarebbe altrettanto pericoloso quanto la fuga. Questa è la medietà aristotelica: il mantenere un equilibrio di fronte alle situazioni della vita, attento al comportamento e alle necessità degli altri.
Aristotele non crede, come credevano Platone e gli stoici, che le passioni vadano del tutto sdradicate. Egli invece pensa che le passioni abbiano una loro utilità morale e sociale: per esempio l'ira è una passione che, se governata in modo equilibrato e mediano, è utile e necessaria; infatti non sarebbe accettabile un cittadino che non fosse capace di rispondere a provocazioni, o a lesioni del suo prestigio. Naturalmente bisogna evitare l'eccesso di iracondia, l'eccesso collerico, ma anche la troppa rassegnazione; infatti, la mancanza totale di capacità di risposta sarebbe, secondo Aristotele, un errore. La virtù starebbe dunque in questa medietà equilibrata e ragionevole di comportamento.
Napoli, Istituto Italiano Studi filosofici, Palazzo Serra di Cassano, 29 aprile 1988