blogtecaolivelli
blog informazione e cultura della biblioteca Olivelli
TAG
TAG
Messaggi del 28/04/2018
|
Post n°1636 pubblicato il 28 Aprile 2018 da blogtecaolivelli
fonte: Internet Home > Classifiche > CLASSIFICA: dal 16 al 22 aprile 2018 - segnaliamo "L'università del crimine" di Petros Markaris (La nave di Teseo) aprile 27, 2018letteratitudinenews
* * * 1° posto per il nuovo romanzo di Maurizio de Giovanni: "Sara al tramonto" (Rizzoli) Entra in top ten in 2^ posizione "Macbeth" di Jo Nesbø (Rizzoli) Al 3° posto: "Sulla tua parola. Messalino maggio-giugno 2018. Letture della messa commentate per vivere la parola di Dio" (Editrice Shalom) Al 4° posto (la settimana scorsa era in 5^ posizione) "Una ragazza affidabile" di Silena Santoni (Giunti) Al 5° posto (la settimana scorsa era in 3^ posizione) "Mio caro serial killer" di Alicia Giménez Bartlett (Sellerio) In 6^ posizione (la settimana scorsa era al 4° posto), "Storie della buonanotte per bambine ribelli 2. Ediz. a colori " di Francesca Cavallo e Elena Favilli (Mondadori) Al 7° posto (la settimana scorsa era 1° in classifica) "Gaudete et exsultate. Esortazione apostolica sulla chiamata alla santità nel mondo contemporaneo " di Francesco (Jorge Mario Bergoglio) (Libreria Editrice Vaticana ) Entra in top ten in 8^ posizione "La vita e i giorni. Sulla vecchiaia" di Enzo Bianchi (Il Mulino) Rientra in top ten al 9° posto, "Una di voi" di Iris Ferrari (Mondadori Electa) In 10^ posizione (la settimana scorsa era all'8° posto) "Storie della buonanotte per bambine ribelli. 100 vite di donne straordinarie. Ediz. a colori" di Francesca Cavallo e Elena Favilli (Mondadori) * * *
Un'inchiesta mozzafiato per il ritorno del Maigret greco in forma smagliante: divertente, ironico, implacabile con i colpevoli. Una notizia improvvisa scuote il commissariato di Kostas Charitos: il direttore Ghikas va in pensione e lascia proprio a Charitos il comando temporaneo della Centrale di polizia di Atene. Ma il commissario più famoso di Grecia non ha tempo di festeggiare la promozione. Viene infatti ucciso il ministro per le Riforme: nella rivendicazione si legge che il politico, già stimato professore universitario, è stato ucciso perché ha tradito la sua missione di docente per fare carriera politica, venendo così meno ai suoi doveri verso gli studenti. L'aria in città è tesa, ma Charitos e l'amata moglie Adriana assaporano una nuova felicità perché la figlia Caterina li renderà presto nonni, così si rilassano frequentando tre nuove amiche dalla simpatia irresistibile, conosciute durante una vacanza in Epiro. Qualche giorno dopo viene ucciso con un'iniezione letale un altro ministro, ex docente anch'egli. Quando spunta il cadavere di un terzo professore, la situazione sembra andare fuori controllo: il governo chiede un'immediata svolta alle indagini che, tuttavia, continuano a brancolare nel buio. Kostas Charitos deve abituarsi in fretta alle responsabilità del suo nuovo ruolo per venire a capo di un intrigo tra politica e università che lo vede coinvolto in prima persona, un gioco pericoloso in cui nulla è come appare. Un'inchiesta mozzafiato per il ritorno del Maigret greco in forma smagliante: divertente, ironico, implacabile con i colpevoli. * * * Posizioni dal n. 1 al n. 10
Posizioni dal n. 11 al n. 40
|
|
Post n°1635 pubblicato il 28 Aprile 2018 da blogtecaolivelli
FONTE:iNTERNET Narrativa italiana, i 10 libri più venduti della settimanaEcco la top ten dei libri di narrativa italiana più venduti della settimana (nella settimana dal 16 al 22 aprile), secondo dati iBuk. 10) Dawla. La storia dello Stato islamico raccontata dai suoi disertori di Gabriele Del Grande"Dawla" in arabo significa Stato ed è uno dei modi in cui gli affiliati dello Stato islamico chiamano la propria organizzazione. Gabriele Del Grande è andato a incontrarli in un avventuroso viaggio partito nel Kurdistan iracheno e terminato con il suo arresto in Turchia. Il libro Dawla. La storia dello Stato islamico raccontata dai suoi disertori è il racconto delle loro storie intrecciate alla storia più grande dell'ascesa e della caduta dello Stato islamico. Un racconto che parte nel 2005 nei sotterranei del carcere di massima sicurezza di Saydnaya, in Siria, e che passa per la rivoluzione fallita del 2011, la guerra per procura contro al-Asad, il ritorno del Califfato e gli attentati che hanno sconvolto l'Europa. Gabriele Del Grande The cage. Uno di noi mente è il primo romanzo di Lorenzo Ostuni, il giovane youtuber di successo conosciuto al grande pubblico come Favij. Lorenzo Ostuni Resto qui è il nuovo romanzo di Marco Balzano, vincitore del Premio Campiello 2015. Marco Balzano Il magistrato scrittore Giancarlo De Cataldo autore di Romanzo criminale torna con L'agente del caos. Giancarlo De Cataldo Superficie non è un romanzo, ma una raccolta di frasi e luoghi comuni del nostro linguaggio. Diego De Silva con questo libro gioca con la nostra stupidità e la nostra intelligenza. Accosta frasi fulminee producendo cortocircuiti spiazzanti. Molti discorsi umani sono irresistibilmente comici e vanno semplicemente riportati sulla pagina in un montaggio sapiente. Sembrano costruiti solo per iniziare e non andare mai a fondo: sono grandiosi tentativi di semplificazione impastati in un chiacchiericcio che supera ogni pretesa di profondità per diventare, rigorosamente, superficie: "Ormai l'unica voce di sinistra è quella di Papa Francesco. Il videocitofono è stato un fallimento. Bello, l'ultimo di Gramellini. Ma quanto si sono rincoglioniti i ragazzi di oggi, che devono vendergli i preservativi con l'apertura facilitata? Ma cosa ve ne frega se Macron si è sposato la professoressa?". Diego De Silva La clinica Riposo e pace. Commedia nera n. 2 è un altro tassello della serie Commedia nera con cui Francesco Recami prende a bersaglio della sua comicità i paradossi sociali più evidenti e più fastidiosi dell'epoca. Ora ordisce una parodia fantastica e feroce, che mette alla berlina la medicalizzazione del disagio quotidiano. Francesco Recami Il nuovo romanzo Storia della mia ansia di Daria Bignardi ha per protagonista Lea, una donna che odia l'ansia perché sua madre ne era devastata. Crescendo però si rende conto di non poter sfuggire allo stesso destino: è preda di pensieri ossessivi su tutto quello che non va nella sua vita, che, a dire il vero, funzionerebbe abbastanza. Ha tre figli, un lavoro stimolante e Shlomo, il marito israeliano di cui è innamorata. Ma la loro relazione è conflittuale, infelice. Nella vita di Lea improvvisamente irrompono una malattia e nuovi incontri, che lei accoglie con curiosità, quasi con allegria: nessuno è più di buon umore di un ansioso, di un depresso o di uno scrittore, quando gli succede qualcosa di grosso. Daria Bignardi La parola magica è il romanzo del trainer di PNL e life coach Paolo Borzacchiello che ha un preciso intento: intrattenere il lettore e, pagina dopo pagina, trasformarlo, aiutandolo a liberare il suo potenziale. Paolo Borzacchiello Sempre d'amore di Susanna Casciani racconta la storia di Livia, dall'infanzia all'età adulta. Livia è una bambina timidissima, parla poco, però sorride a tutti. E poi ama scrivere, perché farlo la fa sentire diversa, nel senso di speciale. È un cuore puro il suo, e fragile. A un certo punto nella sua vita accade qualcosa che le inceppa il cuore. Coll'aggravarsi della depressione della madre, tutto per lei diventa faticoso, difficile. Ragazzina sognatrice e poi giovane donna, Livia cerca comunque di spiccare il volo ma, quasi fosse una farfalla con un'ala di seta e una di piombo, non fa che sbattere da tutte le parti rovinando puntualmente al suolo. Così, caduta dopo caduta, sfinita da un amore - quello per la mamma malata - che si ciba della parte migliore di lei, inizia a non fare più caso alle piccole magie che accadono ogni giorno. Ma l'amore è più potente di qualsiasi delusione e sa farsi largo anche tra le macerie di una vita che sa di terra bruciata come la sua. Susanna Casciani Una ragazza affidabile è il romanzo d'esordio di Silena Santoni che sembra aprirsi come un romanzo famigliare per rivelarsi un thriller con protagoniste due sorelle dal legame conflittuale. Un'eredità inattesa costringe Agnese a tornare a Firenze, la città in cui è nata e cresciuta e da cui è fuggita anni prima. Qui l'attende la sorella Micaela, che non vede da tempo. La vita di Micaela ha seguito un percorso assai diverso, lontano dalle scelte che Agnese ha fatto per sé: una vita tranquilla e sicura nella provinciale Ancona, un bravo marito benestante, due figlie allevate nell'agio, tutti valori che Micaela, sola, senza un'occupazione fissa, precaria per vocazione e per convinzione, irride. Mentre il viaggio nella memoria, sollecitato dal confronto con la sorella, riconduce Agnese al momento più doloroso e rimosso, un'altra preoccupazione interviene: le sue due figlie, in vacanza da sole e non raggiungibili telefonicamente, non danno notizie da giorni... Silena Santoni Maurizio De Giovanni, il giallista napoletano autore della serie sui bastardi di Pizzofalcone, torna con il noir Sara al tramonto e il nuovo personaggio Sara Morozzi. Maurizio De Giovanni
|
|
Post n°1634 pubblicato il 28 Aprile 2018 da blogtecaolivelli
I libri più venduti in Italia, settimana per settimana In testa "Sara al tramonto" di Maurizio De Giovanni seguito da "Macbeth" di Jo Nesbø Simona Santoni - 27 aprile 2018 Ecco la classifica dei libri più venduti della settimana in Italia (nella settimana dal 16 al 22 aprile, secondo dati iBuk). Classifica generale: i 10 libri più venduti della settimana10) Storie della buonanotte per bambine ribelli di Francesca Cavallo ed Elena Favilli C'era una volta... una principessa? Macché! C'era una volta una bambina che voleva andare su Marte. Ce n'era un'altra che diventò la più forte tennista al mondo e un'altra ancora che scoprì la metamorfosi delle farfalle. Da Serena Williams a Malala Yousafzai, da Rita Levi Montalcini a Frida Kahlo, da Margherita Hack a Michelle Obama, sono 100 le donne raccontate nel libro Storie della buonanotte per bambine ribelli di Elena Favilli e Francesca Cavallo e ritratte da 60 illustratrici provenienti da tutto il mondo. Scienziate, pittrici, astronaute, sollevatrici di pesi, musiciste, giudici, chef... esempi di coraggio, determinazione e generosità per chiunque voglia realizzare i propri sogni. Francesca Cavallo ed Elena Favilli 9) Una di voi di Iris Ferrari Iris Ferrari è una giovane youtuber che ha iniziato il suo percorso sul web a soli 12 anni nel 2015. Il suo canale YouTube ha oltre 250 mila iscritti. Una di voi è il suo primo libro. "Quella che troverete qui sono proprio io, nella mia semplicità, nei miei momenti sì e in quelli no, una ragazza come voi, con tanti sogni e tanta passione che mette in tutto ciò che fa... una di voi!". Iris Ferrari 8) La vita e i giorni. Sulla vecchiaia di Enzo Bianchi Terra sconosciuta in cui ci inoltriamo lentamente, paese aspro da attraversare e da conquistare, la vecchiaia ha le sue grandi ombre, le sue insidie e le sue fragilità, ma non va separata dalla vita: fa parte del cammino dell'esistenza e ha le sue chances. Nell'inesorabile faccia a faccia con il corpo che progressivamente ci tradisce, Enzo Bianchi, fondatore della Comunità Monastica di Bose, conLa vita e i giorni. Sulla vecchiaia invita tutti noi ad accogliere questo tempo della vita pieno, senza nulla concedere a una malinconica nostalgia del futuro, ma anzi trovando qui l'occasione preziosa di un generoso atto di fiducia verso le nuove generazioni. Enzo Bianchi
10 libri di successo in uscita a maggio 2018
Libri novità: i gialli italiani da leggere
"Storie della buonanotte per bambine ribelli" di Francesca Cavallo ed Elena Favilli Credits: Mondadori "Una di voi" di Iris Ferrari Cre "La vita e i giorni. Sulla vecchiaia" di Enzo Bianchi Cred "Gaudete et exsultate" di Papa Francesco Credits: Libreria Editrice Vaticana "Storie della buonanotte per bambine ribelli 2" di Elena Favilli e Francesca Cavallo Credits: Mondadori Mio caro serial killer di Alicia Giménez-Bartlett Credits: Sellerio editore "Una ragazza affidabile" di Silena Santoni Credits: Giunti Editore Sulla tua parola. Messalino maggio-giugno 2018 Credits: Editrice Shalom "Macbeth" di Jo Nesbø Credits: Rizzoli "Sara al tramonto" di Maurizio De Giovanni Credits: Rizzoli1/10 "Storie della buonanotte per bambine ribelli" di Francesca Cavallo ed Elena Favilli Credits: Mondadori 7) Gaudete et exsultate. Esortazione apostolica sulla chiamata alla santità nel mondo contemporaneo di Papa Francesco Gaudete et exsultate (Rallegratevi ed esultate) è la terza esortazione apostolica di papa Francesco, che affronta il tema della chiamata alla santità nel mondo contemporaneo. Non ci si deve aspettare qui un trattato sulla santità, con tante definizioni e distinzioni che potrebbero arricchire questo importante tema, o con analisi che si potrebbero fare circa i mezzi di santificazione", spiega Jorge Mario Bergoglio. "Il mio umile obiettivo è far risuonare ancora una volta la chiamata alla santità, cercando di incarnarla nel contesto attuale, con i suoi rischi, le sue sfide e le sue opportunità". Papa Francesco 6) Storie della buonanotte per bambine ribelli 2 di Elena Favilli e Francesca Cavallo Storie della buonanotte per bambine ribelli è stata la sorpresa del 2017, il libro più venduto dell'anno in Italia. Oltre un milione di copie vendute in tutto il mondo. Da Rita Levi Montalcini a Frida Kahlo, Elena Favilli e Francesca Cavallo hanno raccontato la storia di 100 donne straordinarie, ritratte da 60 illustratrici internazionali. E ora ritornano con Storie della buonanotte per bambine ribelli 2 e altre ragazze capaci di cambiare il mondo: Beyoncé, Mary Shelley, J.K. Rowling, Beatrix Potter e Steffi Graf sono solo alcune delle 100 storie raccolte. 100 eroine, 100 favole, 100 esempi di coraggio per continuare a sognare in grande. Età di lettura: da 8 anni. Elena Favilli e Francesca Cavallo 5) Mio caro serial killer di Alicia Giménez-Bartlett Una nuova avventura per l'ispettrice creata dalla giallista spagnola Alicia Giménez-Bartlett. Un nuovo caso scuote Petra Delicado, un delitto "mostruoso e miserabile" che la rimescola dentro in quanto donna. In Mio caro serial killer l'ispettrice Petra Delicado di Barcellona è un po' giù, sente che gli anni le sono piombati addosso tutti insieme. La nuova indagine la turba. Una signora sola, mai sposata, con un piccolo lavoro e una piccola vita, è stata trovata accoltellata. L'assassino si è accanito su di lei e ha poggiato sul corpo martoriato un messaggio di passione. Tutto parla di femminicidio. Alicia Giménez-Bartlett 4) Una ragazza affidabile di Silena Santoni Una ragazza affidabile è il romanzo d'esordio di Silena Santoni che sembra aprirsi come un romanzo famigliare per rivelarsi un thriller con protagoniste due sorelle dal legame conflittuale. Un'eredità inattesa costringe Agnese a tornare a Firenze, la città in cui è nata e cresciuta e da cui è fuggita anni prima. Qui l'attende la sorella Micaela, che non vede da tempo. La vita di Micaela ha seguito un percorso assai diverso, lontano dalle scelte che Agnese ha fatto per sé: una vita tranquilla e sicura nella provinciale Ancona, un bravo marito benestante, due figlie allevate nell'agio, tutti valori che Micaela, sola, senza un'occupazione fissa, precaria per vocazione e per convinzione, irride. Mentre il viaggio nella memoria, sollecitato dal confronto con la sorella, riconduce Agnese al momento più doloroso e rimosso, un'altra preoccupazione interviene: le sue due figlie, in vacanza da sole e non raggiungibili telefonicamente, non danno notizie da giorni... Silena Santoni 3) Sulla tua parola. Messalino maggio-giugno 2018 Il messalino è uno strumento che offre le letture della messa commentate per vivere la parola di Dio. Pensato affinché la celebrazione eucaristica divenga sempre più il fulcro delle giornate e delle settimane dei fedeli e non si tralasci nulla nel prepararla o nel rinfrescare e rinvigorire l'incontro con Gesù. Un compagno di viaggio semplice ed edificante durante tutte le ore del giorno. |
|
Post n°1633 pubblicato il 28 Aprile 2018 da blogtecaolivelli
fonte; Internet Letteratitudine è...Lascia un commentoGo to comments Letteratitudine è uno dei più noti blog letterari italiani. Fondato da Massimo Maugeri nel settembre 2006, è tra i blog d'autore di Kataweb/Gruppo L'Espresso. Su Letteratitudine si organizzano dibattiti su argomenti di natura letteraria e culturale e si pubblicano articoli dedicati a vari spazi tematici. LetteratitudineNews è il quotidiano online dedicato alla pubblicazione di notizie relative a libri, fatti ed eventi segnalati speciali (con recensioni, segnalazioni, autoracconti, interviste, avvisi e annunci) in connessione con http://www.letteratitudine.blog.kataweb.it Dal 2009 Letteratitudine è anche un seguito programma radiofonico di libri e letteratura curato e condotto da Massimo Maugeri su Radio Hinterland (le puntate sono ascoltabili online da qui). |
|
Post n°1632 pubblicato il 28 Aprile 2018 da blogtecaolivelli
fonte: Internet DONNE CHE CORRONO COI LUPI, di Clarissa Pinkola Estés (recensione) ottobre 28, 2014letteratitudinenews
Riscoprendo l'essenza selvaggia, istintiva e ferina della donna di Katya Maugeri «In tempi duri dobbiamo avere sogni duri, sogni reali, quelli che, se ci daremo da fare, si avvereranno». Un connubio apparentemente strano, lontano dalla nostra visione quotidiana: la donna e il lupo. «Andate e lasciate che le storie, ovvero la vita, vi accadano, e lavorate queste storie dalla vostra vita, riversateci sopra il vostro sangue e le vostre lacrime e il vostro riso finché non fioriranno, finché non fiorirete». |
|
Post n°1631 pubblicato il 28 Aprile 2018 da blogtecaolivelli
fonte: Internet Le ragioni del delitto, forse di natura politica o forse dovute a contrasti di lavoro, non furono mai chiarite e i responsabili rimasero ignoti, nonostante tre processi celebrati e nonostante la famiglia avesse forti sospetti sull'identità dell'assassino, come traspare evidentemente nella poesia La cavalla storna: il probabile mandante fu infatti un delinquente, Pietro Cacciaguerra (al quale Pascoli fa riferimento, senza nominarlo, nella lirica Tra San Mauro e Savignano), possidente ed esperto fattore da bestiame, che divenne successivamente agente per conto del principe, coadiuvando l'amministratore Achille Petri, subentrato a Ruggero Pascoli dopo il delitto. I due sicari, i cui nomi correvano di bocca in bocca in paese, furono Luigi Pagliarani detto Bigéca (fervente repubblicano), e Michele Dellarocca, probabilmente fomentati dal presunto mandante. Sempre da Pascoli venne scritta una poesia in ricordo della notte dell'assassinio del padre, X agosto, la notte di San Lorenzo, la stessa notte in cui morì il padre.
Nel 1871, all'età di quindici anni e dopo la morte del fratello Luigi avvenuta per meningite il 19 ottobre dello stesso anno, Giovanni Pascoli dovette lasciare il collegio Raffaello dei padri Scolopi di Urbino; si trasferì a Rimini, per frequentare il liceo classico Giulio Cesare. Giovanni giunse a Rimini assieme ai suoi cinque fratelli: Giacomo (19 anni), Raffaele (14), Alessandro Giuseppe, (12), Ida (8), Maria (6, chiamata affettuosamente Mariù). «L'appartamento, già scelto da Giacomo ed arredato con lettini di ferro e di legno, e con mobili di casa nostra, era in uno stabile interno di via San Simone, e si componeva del pianterreno e del primo piano», scrive Mariù: «La vita che si conduceva a Rimini... era di una economia che appena consentiva il puro necessario». Pascoli terminò infine gli studi liceali a Cesena dopo aver frequentato il ginnasio ed il liceo al prestigioso Liceo Dante di Firenze, ed aver fallito l'esame di licenza a causa delle materie scientifiche. L'università e l'impegno politico
|
|
Post n°1630 pubblicato il 28 Aprile 2018 da blogtecaolivelli
fonte: Internet Dopo poco più di cento giorni, esclusa la maggiore gravità del reato, con sentenza del 18 novembre 1879, la Corte d'Appello rinviò gli imputati - Pascoli e Ugo Corradini - davanti al Tribunale: il processo, in cui Pascoli era difeso dall'avvocato Barbanti, ebbe luogo il 22 dicembre, chiamato a testimone anche il maestro Giosue Carducci che inviò una sua dichiarazione: "Il Pascoli non ha capacità a delinquere in relazione ai fatti denunciati". Viene assolto ma attraversa un periodo difficile, medita il suicidio ma il pensiero della madre defunta lo fa desistere, come dirà nella poesia La voce. Alla fine riprende gli studi con impegno.Nonostante le simpatie verso il movimento anarco-socialista in età giovanile, nel 1900, quando Umberto I venne ucciso da un altro anarchico, Gaetano Bresci, Pascoli rimase amareggiato dall'accaduto e compose la poesia Al Re Umberto. Abbandona la militanza politica, mantenendo un socialismo umanitario che incoraggiasse l'impegno verso i deboli e la concordia universale tra gli uomini, argomento di alcune liriche:« Pace, fratelli! e fate che le braccia / ch'ora o poi tenderete ai più vicini, / non sappiano la lotta e la minaccia. »(I due fanciulli) La docenza Dopo la laurea, conseguita nel 1882 con una tesi su Alceo, Pascoli intraprese la carriera di insegnante di latino e greco nei licei di Matera e di Massa. Dopo le vicissitudini e i lutti, il poeta aveva finalmente ritrovato la gioia di vivere e di credere nel futuro. Ecco cosa scrive all'indomani della laurea da Argenta:"Il prossimo ottobre andrò professore, ma non so ancora dove: forse lontano; ma che importa? Tutto il mondo è paese ed io ho risoluto di trovar bella la vita e piacevole il mio destino".Su richiesta delle sorelle Ida e Maria, fino al 1882 nel convento di Sogliano, Pascoli riformulò il proprio progetto di vita, sentendosi in colpa per avere abbandonato le sorelle negli anni universitari. Ecco a tale proposito una lettera di Giovanni scritta da Argenta il 3 luglio 1882, il quale, ripreso dalle sorelle per averle abbandonate, così risponde:"Povere bambine! Sotto ogni parola di quella vostra lettera così tenera, io leggevo un rimprovero per me, io intravedevo una lagrima!."E ancora da Matera il poeta scrive nell'ottobre del 1882:"Amate voi me, che ero lontano e parevo indifferente, mentre voi vivevate nell'ombra del chiostro [...] Amate voi me, che sono accorso a voi soltanto quando escivate dal convento raggianti di mite contentezza, m'amate almeno come le gentili compagne delle vostre gioie e consolatrici dei vostri dolori?".Il 22 settembre 1882 era stato iniziato alla massoneria, presso la loggia "Rizzoli" di Bologna. Il testamento massonico autografo del Pascoli, a forma di triangolo (il triangolo è un simbolo massonico), è stato rinvenuto nel 2002. Dal 1887 al 1895 insegnò a Livorno al Ginnasio-Liceo "Guerrazzi e Niccolini", nel cui archivio si trovano ancora lettere e appunti scritti di suo pugno. Intanto iniziò la collaborazione con la rivista Vita nuova, su cui uscirono le prime poesie di Myricae, raccolta che continuò a rinnovarsi in cinque edizioni fino al 1900. . Molti particolari della vita personale, emersi dalle lettere private, furono taciuti dalla celebre biografia scritta da Maria Pascoli, poiché giudicati da lei sconvenienti o non conosciuti. Il fidanzamento con la cugina Imelde Morri di Rimini, all'indomani delle nozze di Ida, organizzato all'insaputa di Mariù, dimostra infatti il reale intento del poeta. Di fronte alla disperazione di Mariù, che non avrebbe mai accettato di sposarsi, né l'ingerenza di un'altra donna in casa sua, Pascoli ancora una volta rinuncerà al proposito di vita coniugale.Si può affermare che la vita moderna della città non entrò mai, neppure come antitesi, come contrapposizione polemica, nella poesia pascoliana: egli, in un certo senso, non uscì mai dal suo mondo, che costituì, in tutta la sua produzione letteraria, l'unico grande tema, una specie di microcosmo chiuso su sé stesso, come se il poeta avesse bisogno di difenderlo da un minaccioso disordine esterno, peraltro sempre innominato e oscuro, privo di riferimenti e di identità, come lo era stato l'assassino di suo padre. Sul tormentato rapporto con le sorelle - il "nido" familiare che ben presto divenne "tutto il mondo" della poesia di Pascoli - ha scritto parole di estrema chiarezza il poeta Mario Luzi:« Di fatto si determina nei tre che la disgrazia ha diviso e ricongiunto una sorta di infatuazione e mistificazione infantili, alle quali Ida è connivente solo in parte. Per il Pascoli si tratta in ogni caso di una vera e propria regressione al mondo degli affetti e dei sensi, anteriore alla responsabilità; al mondo da cui era stato sbalzato violentemente e troppo presto. Possiamo notare due movimenti concorrenti: uno, quasi paterno, che gli suggerisce di ricostruire con fatica e pietà il nido edificato dai genitori; di investirsi della parte del padre, di imitarlo. Un altro, di ben diversa natura, gli suggerisce invece di chiudersi là dentro con le piccole sorelle che meglio gli garantiscono il regresso all'infanzia, escludendo di fatto, talvolta con durezza, gli altri fratelli. In pratica il Pascoli difende il nido con sacrificio, ma anche lo oppone con voluttà a tutto il resto: non è solo il suo ricovero ma anche la sua misura del mondo. Tutto ciò che tende a strapparlo di lì in qualche misura lo ferisce; altre dimensioni della realtà non gli riescono, positivamente, accettabili. Per renderlo più sicuro e profondo lo sposta dalla città, lo colloca tra i monti della Media Valle del Serchio dove può, oltre tutto, mimetizzarsi con la natura. »([M. Luzi, Giovanni Pascoli]) In particolare si fecero difficili i rapporti con Giuseppe, che mise più volte in imbarazzo Giovanni a Bologna, ubriacandosi continuamente in pubblico nelle osterie,e con il marito di Ida, il quale nel 1910, dopo aver ricevuto in prestito dei soldi da Giovanni, partì per l'America lasciando in Italia la moglie e le tre figlie. Gli ultimi anni Le trasformazioni politiche e sociali che agitavano gli anni di fine secolo e preludevano alla catastrofe bellica europea, gettarono progressivamente Pascoli, già emotivamente provato dall'ulteriore fallimento del suo tentativo di ricostruzione familiare, in una condizione di insicurezza e pessimismo ancora più marcati, che lo condussero in una fase di depressione e nel baratro dell'alcolismo: il poeta abusava di vino e cognac, come riferisce anche nelle lettere. Le uniche consolazioni sono la poesia, e il suo "nido di Castelvecchio", dopo la perdita della fede trascendente, cercata e avvertita comunque nel senso del mistero universale, in una sorta di agnosticismo mistico, come testimonia una missiva al cappellano militare padre Giovanni Semeria: «Io penso molto all'oscuro problema che resta... oscuro. La fiaccola che lo rischiara è in mano della nostra sorella grande Morte! Oh! sarebbe pur dolce cosa il credere che di là fosse abitato! Ma io sento che le religioni, compresa la più pura di tutte, la cristiana, sono per così dire, Tolemaiche. Copernico, Galileo le hanno scosse».Mentre insegnava latino e greco nelle varie università dove aveva accettato l'incarico, pubblicò anche i volumi di analisi dantesca Minerva oscura (1898), Sotto il velame (1900) e La Mirabile Visione (1902). Nel 1906 assunse la cattedra di letteratura italiana all'Università di Bologna succedendo a Carducci. Qui ebbe allievi che sarebbero stati poi celebri, tra cui Aldo Garzanti. Nel novembre 1911, presenta al concorso indetto dal Comune di Roma per celebrare il cinquantesimo dell'Unità d'Italia, il poema latino Inno a Roma in cui riprendendo un tema già anticipato nell'ode Al corbezzolo esalta Pallante come il primo morto per la causa nazionale e poi deposto su rami di corbezzolo che con i fiori bianchi, le bacche rosse e le foglie verdi, vengono visti come un'anticipazione della bandiera tricolore.Scoppiata la guerra italo-turca, presso il teatro di Barga pronuncia il celebre discorso a favore dell'imperialismo La grande Proletaria si è mossa: egli sostiene infatti che la Libia sia parte dell'Italia irredenta, e l'impresa sia anche a favore delle popolazioni sottomesse alla Turchia, oltre che positiva per i contadini italiani, che avranno nuove terre. Si tratta, in sostanza, non di nazionalismo vero e proprio, ma di un'evoluzione delle sue utopie socialiste e patriottiche. Il 31 dicembre 1911 compie 56 anni; sarà il suo ultimo compleanno: poco tempo dopo le sue condizioni di salute peggiorano. Il medico gli consiglia di lasciare Castelvecchio e trasferirsi a Bologna, dove gli viene diagnosticata la cirrosi epatica per l'abuso di alcool; nelle memorie della sorella viene invece affermato che fosse malato di epatite e tumore al fegato. Il certificato di morte riporta come causa un tumore allo stomaco, ma è probabile fosse stato redatto dal medico su richiesta di Mariù, che intendeva eliminare tutti gli aspetti che lei giudicava sconvenienti dall'immagine del fratello, come la dipendenza da alcool, la simpatia giovanile per Passannante e la sua affiliazione alla Massoneria. La malattia lo porta infatti alla morte il 6 aprile 1912, un Sabato Santo vigilia di Pasqua,nella sua casa di Bologna, in via dell'Osservanza n. 2; la vera causa del decesso fu probabilmente la cirrosi epatica. Pascoli venne sepolto nella cappella annessa alla sua dimora di Castelvecchio di Barga, dove sarà tumulata anche l'amata sorella Maria, sua biografa, nominata erede universale nel testamento, nonché curatrice delle opere postume. |
|
Post n°1629 pubblicato il 28 Aprile 2018 da blogtecaolivelli
fonte:Internet L'ultima dimora di Giovanni Pascoli, dove morì, a Bologna in via dell'Osservanza n. 2: sul cancello si può notare ancora la "P" di PascoliIl profilo letterario: la sua rivoluzione poetica. L'esperienza poetica pascoliana si inserisce, con tratti originalissimi, nel panorama del decadentismo europeo e segna in maniera indelebile la poesia italiana: essa affonda le radici in una visione pessimistica della vita in cui si riflette la scomparsa della fiducia, propria del Positivismo, e in una conoscenza in grado di spiegare compiutamente la realtà. Il mondo appare all'autore come un insieme misterioso e indecifrabile tanto che il poeta tende a rappresentare la realtà con una pennellata impressionistica che colga solo un determinato particolare del reale, non essendo possibile per l'autore avere una concreta visione d'insieme. Coerentemente con la visione decadente, il poeta si configura come un "veggente", mediatore di una conoscenza aurorale, in grado di spingere lo sguardo oltre il mondo sensibile: nel Fanciullino, Pascoli afferma quanto il poeta fanciullino sappia dare il nome alle cose, scoprendole nella loro freschezza originaria, in maniera immaginosa e alogica.La formazione letteraria La fase cruciale della formazione letteraria di Pascoli va fatta risalire ai nove anni trascorsi a Bologna come studente alla Facoltà di Lettere (1873-1882). Allievo di Carducci, che si accorse subito delle qualità del giovane Pascoli, nella cerchia ristretta dell'ambiente creatosi attorno al poeta, Pascoli visse gli anni più movimentati della sua vita. Qui, protetto comunque dalla naturale dipendenza tra maestro e allievo, Pascoli non ebbe bisogno di alzare barriere nei confronti della realtà, dovendo limitarsi a seguire gli indirizzi e i modelli del suo corso di studi: i classici, la filologia, la letteratura italiana. Nel 1875 perse la borsa di studio e con essa l'unico mezzo di sostentamento su cui poteva contare. La frustrazione e i disagi materiali lo spinsero verso il movimento socialista in quella che fu una delle poche, brevi parentesi politiche della sua vita. Nel 1879 venne arrestato e assolto dopo tre mesi di carcere; l'ulteriore senso di ingiustizia e la delusione lo riportarono nell'alveo d'ordine del maestro Carducci e al compimento degli studi con una tesi sul poeta greco Alceo.A margine degli studi veri e propri, egli, comunque, condusse una vasta esplorazione del mondo letterario e anche scientifico straniero, attraverso le riviste francesi specializzate come la Revue des deux Mondes, che lo misero in contatto con l'avanguardia simbolista, e la lettura dei testi scientifico-naturalistici di Jules Michelet, Jean-Henri Fabre e Maurice Maeterlinck. Tali testi utilizzavano la descrizione naturalistica - la vita degli insetti soprattutto, per quell'attrazione per il microcosmo così caratteristica del Romanticismo decadente di fine Ottocento - in chiave poetica; l'osservazione era aggiornata sulle più recenti acquisizioni scientifiche dovute al perfezionamento del microscopio e della sperimentazione di laboratorio, ma poi veniva filtrata letterariamente attraverso uno stile lirico in cui dominava il senso della meraviglia e della fantasia. Era un atteggiamento positivista "romanticheggiante" che tendeva a vedere nella natura l'aspetto pre-cosciente del mondo umano.Coerentemente con questi interessi, vi fu anche quello per la cosiddetta "filosofia dell'inconscio" del tedesco Karl Robert Eduard von Hartmann, l'opera che aprì quella linea di interpretazione della psicologia in senso anti-meccanicistico che sfociò nella psicanalisi freudiana. È evidente in queste letture - come in quella successiva dell'opera dell'inglese James Sully sulla "psicologia dei bambini" - un'attrazione di Pascoli verso il "mondo piccolo" dei fenomeni naturali e psicologicamente elementari che tanto fortemente caratterizzò tutta la sua poesia. E non solo la sua. Per tutto l'Ottocento la cultura europea aveva coltivato un particolare culto per il mondo dell'infanzia, dapprima, in un senso pedagogico e culturale più generico, poi, verso la fine del secolo, con un più accentuato intendimento psicologico. I Romantici, sulla scia di Giambattista Vico e di Rousseau, avevano paragonato l'infanzia allo stato primordiale "di natura" dell'umanità, inteso come una sorta di età dell'oro.Verso gli anni Ottanta si cominciò, invece, ad analizzare in modo più realistico e scientifico la psicologia dell'infanzia, portando l'attenzione sul bambino come individuo in sé, caratterizzato da una propria realtà di riferimento. La letteratura per l'infanzia aveva prodotto in meno di un secolo una quantità considerevole di libri che costituirono la vera letteratura di massa fino alla fine dell'Ottocento. Parliamo dei libri per i bambini, come le innumerevoli raccolte di fiabe dei fratelli Grimm (1822), di H.C. Andersen (1872), di Ruskin (1851), Wilde (1888), Maurice Maeterlinck (1909); o come il capolavoro di Carroll, Alice nel Paese delle Meraviglie (1865). Oppure i libri di avventura adatti anche all'infanzia, come i romanzi di Jules Verne, Kipling, Twain, Salgari, London. O libri sull'infanzia, dall'intento moralistico ed educativo, come Senza famiglia di Malot (1878), Il piccolo Lord di F.H. Burnett (1886), Piccole donne di Alcott (1869) e i celeberrimi Cuore di De Amicis (1886) e Pinocchio di Collodi (1887).Tutto questo ci serve a ricondurre, naturalmente, la teoria pascoliana della poesia come intuizione pura e ingenua, espressa nella poetica del Fanciullino, ai riflessi di un vasto ambiente culturale europeo che era assolutamente maturo per accogliere la sua proposta. In questo senso non si può parlare di una vera novità, quanto piuttosto della sensibilità con cui egli seppe cogliere un gusto diffuso e un interesse già educato, traducendoli in quella grande poesia che all'Italia mancava dall'epoca di Leopardi. Per quanto riguarda il linguaggio, Pascoli ricerca una sorta di musicalità evocativa, accentuando l'elemento sonoro del verso, secondo il modello dei poeti maledetti Paul Verlaine e Stéphane Mallarmé.La poesia come "nido" che protegge dal mondo. Per Pascoli la poesia ha natura irrazionale e con essa si può giungere alla verità di ogni cosa; il poeta deve essere un poeta-fanciullo che arriva a questa verità mediante l'irrazionalità e l'intuizione. Rifiuta quindi la ragione e, di conseguenza, rifiuta il Positivismo, che era l'esaltazione della ragione stessa e del progresso, approdando così al decadentismo. La poesia diventa così analogica, cioè senza apparente connessione tra due o più realtà che vengono rappresentate; ma in realtà una connessione, a volte anche un po' forzata, è presente tra i concetti, e il poeta spesso e volentieri è costretto a voli vertiginosi per mettere in comunicazione questi concetti. La poesia irrazionale o analogica è una poesia di svelamento o di scoperta e non di invenzione. I motivi principali di questa poesia devono essere "umili cose": cose della vita quotidiana, cose modeste o familiari. A questo si unisce il ricordo ossessivo dei suoi morti, le cui presenze aleggiano continuamente nel "nido", riproponendo il passato di lutti e di dolori e inibendo al poeta ogni rapporto con la realtà esterna, ogni vita di relazione, che viene sentita come un tradimento nei confronti dei legami oscuri, viscerali del "nido".Il duomo, al cui suono della campana si fa riferimento ne L'ora di BargaNella vita dei letterati italiani degli ultimi due secoli ricorre pressoché costantemente la contrapposizione problematica tra mondo cittadino e mondo agreste, intesi come portatori di valori opposti: mentre la campagna appare sempre più come il "paradiso perduto" dei valori morali e culturali, la città diviene simbolo di una condizione umana maledetta e snaturata, vittima della degradazione morale causata da un ideale di progresso puramente materiale. Questa contrapposizione può essere interpretata sia alla luce dell'arretratezza economica e culturale di gran parte dell'Italia rispetto all'evoluzione industriale delle grandi nazioni europee, sia come conseguenza della divisione politica e della mancanza di una grande metropoli unificante come erano Parigi per la Francia e Londra per l'Inghilterra. I "luoghi" poetici della "terra", del "borgo", dell'"umile popolo" che ricorrono fino agli anni del primo dopoguerra non fanno che ripetere il sogno di una piccola patria lontana, che l'ideale unitario vagheggiato o realizzato non spegne mai del tutto.Decisivo nella continuazione di questa tradizione fu proprio Pascoli, anche se i suoi motivi non furono quelli tipicamente ideologici degli altri scrittori, ma nacquero da radici più intimistiche e soggettive. Nel 1899 scrisse al pittore De Witt: «C'è del gran dolore e del gran mistero nel mondo; ma nella vita semplice e familiare e nella contemplazione della natura, specialmente in campagna, c'è gran consolazione, la quale pure non basta a liberarci dall'immutabile destino». In questa contrapposizione tra l'esteriorità della vita sociale (e cittadina) e l'interiorità dell'esistenza familiare (e agreste) si racchiude l'idea dominante - accanto a quella della morte - della poesia pascoliana. Dalla casa di Castelvecchio, dolcemente protetta dai boschi della Media Valle del Serchio, Pascoli non "uscì" più (psicologicamente parlando) fino alla morte. Pur continuando in un intenso lavoro di pubblicazioni poetiche e saggistiche, e accettando nel 1905 di succedere a Carducci sulla cattedra dell'Università di Bologna, egli ci ha lasciato del mondo una visione univocamente ristretta attorno ad un "centro", rappresentato dal mistero della natura e dal rapporto tra amore e morte.Fu come se, sopraffatto da un'angoscia impossibile a dominarsi, il poeta avesse trovato nello strumento intellettuale del componimento poetico l'unico mezzo per costringere le paure e i fantasmi dell'esistenza in un recinto ben delimitato, al di fuori del quale egli potesse continuare una vita di normali relazioni umane. A questo "recinto" poetico egli lavorò con straordinario impegno creativo, costruendo una raccolta di versi e di forme che la letteratura italiana non vedeva, per complessità e varietà, dai tempi di Chiabrera. La ricercatezza quasi sofisticata, e artificiosa nella sua eleganza, delle strutture metriche scelte da Pascoli - mescolanza di novenari, quinari e quaternari nello stesso componimento, e così via - è stata interpretata come un paziente e attento lavoro di organizzazione razionale della forma poetica attorno a contenuti psicologici informi e incontrollabili che premevano dall'inconscio. Insomma, esattamente il contrario di quanto i simbolisti francesi e le altre avanguardie artistiche del primo Novecento proclamavano nei confronti della spontaneità espressiva.Frontespizio di un'edizione del discorso socialista e nazionalista di Pascoli La Grande Proletaria si è mossa, in favore della guerra di Libia.Anche se l'ultima fase della produzione pascoliana è ricca di tematiche socio-politiche (Odi e inni del 1906, comprendenti gli inni Ad Antonio Fratti, Al re Umberto, Al Duca degli Abruzzi e ai suoi compagni, Andrée, nonché l'ode, aggiunta nella terza edizione, Chavez; Poemi italici del 1911; Poemi del Risorgimento, postumi; nonché il celebre discorso La grande Proletaria si è mossa, tenuto nel 1911 in occasione di una manifestazione a favore dei feriti della guerra di Libia), non c'è dubbio che la sua opera più significativa è rappresentata dai volumi poetici che comprendono le raccolte di Myricae e dei Canti di Castelvecchio (1903), nei quali il poeta trae spunto dall'ambiente a lui familiare come la Ferrovia Lucca-Aulla ("In viaggio"), nonché parte dei Poemetti. Il "mondo" di Pascoli è tutto lì: la natura come luogo dell'anima dal quale contemplare la morte come ricordo dei lutti privati.« Troppa questa morte? Ma la vita, senza il pensiero della morte, senza, cioè, religione, senza quello che ci distingue dalle bestie, è un delirio, o intermittente o continuo, o stolido o tragico. D'altra parte queste poesie sono nate quasi tutte in campagna; e non c'è visione che più campeggi o sul bianco della gran nave o sul verde delle selve o sul biondo del grano, che quella dei trasporti o delle comunioni che passano: e non c'è suono che più si distingua sul fragor dei fiumi e dei ruscelli, su lo stormir delle piante, sul canto delle cicale e degli uccelli, che quello delle Avemarie. Crescano e fioriscano intorno all'antica tomba della mia giovane madre queste myricae (diciamo cesti o stipe) autunnali. »(Dalla Prefazione di Pascoli ai Canti di Castelvecchio)Il poeta e il fanciullino]« Il poeta è poeta, non oratore o predicatore, non filosofo, non istorico, non maestro, non tribuno o demagogo, non uomo di stato o di corte. E nemmeno è, sia con pace del maestro Giosuè Carducci, un artiere che foggi spada e scudi e vomeri; e nemmeno, con pace di tanti altri, un artista che nielli e ceselli l'oro che altri gli porga. A costituire il poeta vale infinitamente più il suo sentimento e la sua visione, che il modo col quale agli altri trasmette l'uno e l'altra [...] »(Da Il fanciullino)Uno dei tratti salienti per i quali Pascoli è passato alla storia della letteratura è la cosiddetta poetica del fanciullino, da lui stesso esplicitata nello scritto omonimo apparso sulla rivista Il Marzocco nel 1897. In tale scritto Pascoli, influenzato dal manuale di psicologia infantile di James Sully e da La filosofia dell'inconscio di Eduard von Hartmann, dà una definizione assolutamente compiuta - almeno secondo il suo punto di vista - della poesia (dichiarazione poetica). Si tratta di un testo di 20 capitoli, in cui si svolge il dialogo fra il poeta e la sua anima di fanciullino, simbolo:dei margini di purezza e candore, che sopravvivono nell'uomo adulto;della poesia e delle potenzialità latenti di scrittura poetica nel fondo dell'animo umano.Caratteristiche del fanciullino:"Rimane piccolo anche quando noi ingrossiamo e arrugginiamo la voce ed egli fa sentire il suo tinnulo squillo come di campanella"."Piange e ride senza un perché di cose, che sfuggono ai nostri sensi ed alla nostra ragione"."Guarda tutte le cose con stupore e con meraviglia, non coglie i rapporti logici di causa - effetto, ma intuisce"."Scopre nelle cose le relazioni più ingegnose"."Riempie ogni oggetto della propria immaginazione e dei propri ricordi (soggettivazione), trasformandolo in simbolo".Una rondine. Gli uccelli e la natura, con precisione del lessico zoologico e botanico ma anche con semplicità, sono stati spesso cantati da Giovanni PascoliIl poeta allora mantiene una razionalità di fondo, organizzatrice della metrica poetica, ma:Possiede una sensibilità speciale, che gli consente di caricare di significati ulteriori e misteriosi anche gli oggetti più comuni;Comunica verità latenti agli uomini: è "Adamo", che mette nome a tutto ciò che vede e sente (secondo il proprio personale modo di sentire, che tuttavia ha portata universale).Deve saper combinare il talento della fanciullezza (saper vedere), con quello della vecchiaia (saper dire);Percepisce l'essenza delle cose e non la loro apparenza fenomenica.La poesia, quindi, è tale solo quando riesce a parlare con la voce del fanciullo ed è vista come la perenne capacità di stupirsi tipica del mondo infantile, in una disposizione irrazionale che permane nell'uomo anche quando questi si è ormai allontanato, almeno cronologicamente, dall'infanzia propriamente intesa. È una realtà ontologica. Ha scarso rilievo per Pascoli la dimensione storica (egli trova suoi interlocutori in Omero, Virgilio, come se non vi fossero secoli e secoli di mezzo): la poesia vive fuori dal tempo ed esiste in quanto tale. Nel fare poesia una realtà ontologica (il poeta-microcosmo) si interroga su un'altra realtà ontologica (il mondo-macrocosmo); ma per essere poeta è necessario confondersi con la realtà circostante senza che il proprio punto di vista personale e preciso interferisca: il poeta si impone la rinuncia a parlare di se stesso, tranne in poche poesie, in cui esplicitamente parla della sua vicenda personale. È vero che la vicenda autobiografica dell'autore caratterizza la sua poesia, ma con connotazioni di portata universale: ad esempio la morte del padre viene percepita come l'esempio principe della descrizione dell'universo, di conseguenza gli elementi autenticamente autobiografici sono scarsi, in quanto raffigura il male del mondo in generale. Tuttavia, nel passo XI de "Il fanciullino", Pascoli dichiara che un vero poeta è, più che altro, il suo sentimento e la sua visione che cerca di trasmettere agli altri. Per cui il poeta Pascoli rifiuta:il Classicismo, che si qualifica per la centralità ed unicità del punto di vista del poeta, che narra la sua opera ed esprime le proprie sensazioni.il Romanticismo, dove il poeta fa di sé stesso, dei suoi sentimenti e della sua vita, poesia.La poesia, così definita, è naturalmente buona ed è occasione di consolazione per l'uomo e il poeta. Pascoli fu anche commentatore e critico dell'opera di Dante e diresse inoltre la collana editoriale "Biblioteca dei Popoli". Il limite della poesia del Pascoli è costituito dall'ostentata pateticità e dall'eccessiva ricerca dell'effetto commovente. D'altro canto, il merito maggiore attribuibile al Pascoli fu quello di essere riuscito nell'impresa di far uscire la poesia italiana dall'eccessiva aulicità e retoricità non solo del Carducci e del Leopardi, ma anche del suo contemporaneo D'Annunzio. In altre parole, fu in grado di creare finalmente un legame diretto con la poesia d'Oltralpe e di respiro europeo. La lingua pascoliana è profondamente innovativa: essa perde il proprio tradizionale supporto logico, procede per simboli e immagini, con brevi frasi, musicali e suggestive.La poesia cosmica L'ammasso aperto delle Pleiadi (M45), nella costellazione del Toro. Pascoli lo cita col nome dialettale di "Chioccetta" ne Il gelsomino notturno. La visione dello spazio buio e stellato è uno dei temi ricorrenti nella sua poesiaFanno parte di questa produzione pascoliana liriche come Il bolide (Canti di Castelvecchio) e La vertigine (Nuovi Poemetti). Il poeta scrive nei versi conclusivi de Il bolide: "E la terra sentii nell'Universo. / Sentii, fremendo, ch'è del cielo anch'ella. / E mi vidi quaggiù piccolo e sperso / errare, tra le stelle, in una stella". Si tratta di componimenti permeati di spiritualismo e di panteismo ( La Vertigine). |
|
Post n°1628 pubblicato il 28 Aprile 2018 da blogtecaolivelli
La Terra è errante nel vuoto, non più qualcosa di certo; lo spazio aperto è la vera dimora dell'uomo rapito come da un vento cosmico. Scrive il critico Giovanni Getto: " È questo il modo nuovo, autenticamente pascoliano, di avvertire la realtà cosmica: al geocentrismo praticamente ancora operante nell'emozione fantastica, nonostante la chiara nozione copernicana sul piano intellettuale, del Leopardi, il Pascoli sostituisce una visione eliocentrica o addirittura galassiocentrica: o meglio ancora, una visione in cui non si dà più un centro di sorta, ma soltanto sussistono voragini misteriose di spazio, di buio e di fuoco. Di qui quel sentimento di smarrita solitudine che nessuno ancora prima del Pascoli aveva saputo consegnare alla poesia".[30][31]La lingua pascoliana[modifica | modifica wikitesto]Pascoli disintegra la forma tradizionale del linguaggio poetico: con lui la poesia italiana perde il suo tradizionale supporto logico, procede per simboli ed immagini, con frasi brevi, musicali e suggestive. Il linguaggio è fonosimbolico con un frequente uso di onomatopee, metafore, sinestesie, allitterazioni, anafore, vocaboli delle lingue speciali (gerghi). La disintegrazione della forma tradizionale comporta "il concepire per immagini isolate (il frammentismo), il periodo di frasi brevi e a sobbalzi (senza indicazione di passaggi intermedi, di modi di sutura), pacatamente musicali e suggestive; la parola circondata di silenzio. "[32] Pascoli ha rotto la frontiera tra grammaticalità e evocatività della lingua. E non solo ha infranto la frontiera tra pregrammaticalità e semanticità, ma ha anche annullato "il confine tra melodicità ed icasticità, cioè tra fluido corrente, continuità del discorso, e immagini isolate autosufficienti. In una parola egli ha rotto la frontiera fra determinato e indeterminato".[33]Pascoli e il mondo degli animali[modifica | modifica wikitesto]In un'epoca storica in cui il mondo degli animali rappresenta un'entità assai ridotta nella vita degli uomini e dei loro sentimenti, quasi esclusivamente relegato agli aspetti di utilizzo pratico e di supporto al lavoro, soprattutto agricolo, Pascoli riconosce la loro dignità e squarcia un'originale apertura sull'esistenza delle specie animali e sul loro originale mondo di relazioni. Come scrive Maria Cristina Solfanelli, «Giovanni Pascoli si avvede assai presto che il suo amore per la natura gli permette di vivere le esperienze più appaganti, se non fondamentali, della sua vita. Lui vede negli animali delle creature perfette da rispettare, da amare e da accudire al pari degli esseri umani; infatti, si relaziona con essi, ci parla di loro e, spesso, prega affinché possano avere un'anima per poterli rivedere un giorno».[34]Opere[modifica | modifica wikitesto]1891Myricae, Livorno, Giusti, 1891; 1892; 1894; 1897; 1900; 1903.1895Lyra romana. Ad uso delle scuole classiche, Livorno, Giusti, 1895; 1899; 1903; 1911. (antologia di scritti latini per la scuola superiore)1897Pensieri sull'arte poetica, in Il Marzocco, 17 gennaio, 7 marzo, 21 marzo, 11 aprile 1897. (meglio noto come Il fanciullino)Iugurtha. Carmen Johannis Pascoli ex castro Sancti Mauri civis liburnensis et Bargaei in certamine poetico Hoeufftiano magna laude ornatum, Amstelodami, Apud Io. Mullerum, 1897. (poemetto latino)Epos, Livorno, Giusti, 1897. (antologia di autori latini)Poemetti, Firenze, Paggi, 1897.1898Minerva oscura. Prolegomeni: la costruzione morale del poema di Dante, Livorno, Giusti, 1898. (studi danteschi)1899Intorno alla Minerva oscura, Napoli, Pierro & Veraldi, 1899.1900Sul limitare. Poesie e prose per la scuola italiana, Milano-Palermo, Sandron, 1900. (antologia di poesie e prose per la scuola)Sotto il velame. Saggio di un'interpretazione generale del poema sacro, Messina, Vincenzo Muglia, 1900.1901Fior da fiore. Prose e poesie scelte per le scuole secondarie inferiori, Milano-Palermo, Sandron, 1901. (antologia di prose e poesie italiane per le scuole medie)1902La mirabile visione. Abbozzo d'una storia della Divina Comedia, Messina, Vincenzo Muglia, 19021903Canti di Castelvecchio, Bologna, Zanichelli, 1903; 1905; 1907. (dedicati alla madre)1904Primi poemetti, Bologna, Zanichelli, 1904.Poemi conviviali, Bologna, Zanichelli, 1904.1906Odi e Inni. 1896-1905, Bologna, Zanichelli, 1906.1907Pensieri e discorsi. 1895-1906, Bologna, Zanichelli, 1907.1909Nuovi poemetti, Bologna, Zanichelli, 1909.Canzoni di re EnzioLa canzone del Carroccio, Bologna, Zanichelli, 1908.La canzone del Paradiso, Bologna, Zanichelli, 1909.La canzone dell'Olifante, Bologna, Zanichelli, 1908.1911Poemi italici, Bologna, Zanichelli, 1911.La grande proletaria si è mossa. Discorso tenuto a Barga per i nostri morti e feriti, Bologna, Zanichelli, 1911. (Già pubbl. in La tribuna, 27 novembre 1911)1912Poesie varie, Bologna, Zanichelli, 1912; 1914. (a cura della sorella Maria)1913Poemi del Risorgimento, Bologna, Zanichelli, 1913.1914Patria e umanità. Raccolta di scritti e discorsi, Bologna, Zanichelli, 1914.Carmina, Bononiae, Zanichelli, 1914. (poesie latine)1922Nell'anno Mille. Dramma, Bologna, Zanichelli, 1922. (dramma incompiuto)1923Nell'anno Mille. Sue notizie e schemi di altri drammi, Bologna, Zanichelli, 1923.1925Antico sempre nuovo. Scritti vari di argomento latino, Bologna, Zanichelli, 1925.Approfondimenti[modifica | modifica wikitesto]Myricae[modifica | modifica wikitesto]Magnifying glass icon mgx2.svgLo stesso argomento in dettaglio: Myricae.Il libro Myricae è la prima vera e propria raccolta di poesie del Pascoli, nonché una delle più amate. Il titolo riprende una citazione di Virgilio all'inizio della IV Bucolica in cui il poeta latino proclama di innalzare il tono poetico poiché "non a tutti piacciono gli arbusti e le umili tamerici" (non omnes arbusta iuvant humilesque myricae). Pascoli invece propone "quadretti" di vita campestre in cui vengono evidenziati particolari, colori, luci, suoni i quali hanno natura ignota e misteriosa. Il libro crebbe per il numero delle poesie in esso raccolte. Nel 1891, data della sua prima edizione, il libro raccoglieva soltanto 22 poesie dedicate alle nozze di amici. Nel 1903, la raccolta definitiva comprendeva 156 liriche del poeta. I componimenti sono dedicati al ciclo delle stagioni, al lavoro dei campi e alla vita contadina. Le myricae, le umili tamerici, diventano un simbolo delle tematiche del Pascoli ed evocano riflessioni profonde.La descrizione realistica cela un significato più ampio così che, dal mondo contadino si arriva poi ad un significato universale. La rappresentazione della vita nei campi e della condizione contadina è solo all'apparenza il messaggio che il poeta vuole trasmettere con le sue opere. In realtà questa frettolosa interpretazione della poetica pascoliana fa da scenario a stati d'animo come inquietudini ed emozioni. Il significato delle Myricae va quindi oltre l'apparenza. Nell'edizione del 1897 compare la poesia Novembre, mentre nelle successive compariranno anche altri componimenti come L'Assiuolo. Pascoli ha dedicato questa raccolta alla memoria di suo padre ("A Ruggero Pascoli, mio padre").La produzione latina[modifica | modifica wikitesto]Giovanni Pascoli fu anche autore di poesie in lingua latina e con esse vinse per ben tredici volte il Certamen Hoeufftianum, un prestigioso concorso di poesia latina che annualmente si teneva ad Amsterdam. La produzione latina accompagnò il poeta per tutta la sua vita: dai primi componimenti scritti sui banchi del collegio degli Scolopi di Urbino, fino al poemetto Thallusa, la cui vittoria il poeta apprese solo sul letto di morte nel 1912. In particolare, l'anno 1892 fu insieme l'anno della sua prima premiazione con il poemetto Veianus e l'anno della stesura definitiva delle Myricae. Tra la sua produzione latina, vi è anche il carme alcaico Corda Fratres, composto nel 1898, pubblicato nel 1902, inno ufficiale della Fédération internationale des étudiants, una confraternita studentesca meglio nota come Corda Fratres[35]. Pascoli amava molto il latino, che può essere considerato la sua lingua del cuore: il poeta scriveva in latino, prendeva appunti in latino, spesso pensava in latino, trasponendo poi espressioni latine in italiano; la sorella Maria ricorda che dal suo letto di morte Pascoli parlò in latino, anche se la notizia è considerata dai più poco attendibile, dal momento che la sorella non conosceva questa lingua. Per lungo tempo la produzione latina pascoliana non ha ricevuto l'attenzione che merita, essendo stata erroneamente considerata quale un semplice esercizio del poeta. Il Pascoli in quegli anni non era infatti l'unico a cimentarsi nella poesia latina (Giuseppe Giacoletti, un insegnante nel collegio degli Scolopi di Urbino frequentato dal Pascoli, vinse l'edizione del Certamen del 1863 con un poemetto sulle locomotive a vapore[36]); ma Pascoli lo fece in maniera nuova e con risultati, poetici e linguistici, sorprendenti. L'attenzione verso questi componimenti si accese con la raccolta in due volumi curata da Ermenegildo Pistelli nel 1914[37], col saggio di Adolfo Gandiglio nell'edizione del 1930[38]. Esistono delle traduzioni in lingua italiana delle poesie latine di Pascoli quali quella curata da Manara Valgimigli[39] o le traduzioni di Enzo Mandruzzato[40].Tuttavia la produzione latina ha un significato fondamentale, essendo coerente con la poetica del Fanciullino, la cifra del pensiero pascoliano. In realtà, la poetica del Fanciullino è la confluenza di due differenti poetiche: la poetica della memoria e la poetica delle cose. Gran parte della poesia pascoliana nasce dalle memorie, dolci e tristi, della sua infanzia: "Ditelo voi [...], se la poesia non è solo in ciò che fu e in ciò che sarà, in ciò che è morto e in ciò che è sogno! E dite voi, se il sogno più bello non è sempre quello in cui rivive ciò che è morto". Pascoli dunque intende fare rivivere ciò che è morto, attingendo non solo al proprio ricordo personale, bensì travalica la propria esperienza, descrivendo personaggi facenti parte anche dell'evo antico: infanzia e mondo antico sono le età nelle quali l'uomo vive o è vissuto più vicino ad una sorta di stato di natura. "Io sento nel cuore dolori antichissimi, pure ancor pungenti. Dove e quando ho provato tanti martori? Sofferto tante ingiustizie? Da quanti secoli vive al dolore l'anima mia? Ero io forse uno di quegli schiavi che giravano la macina al buio, affamati, con la museruola?". Contro la morte - delle lingue, degli uomini e delle epoche - il poeta si appella alla poesia: essa è la sola, la vera vittoria umana contro la morte. "L'uomo alla morte deve disputare, contrastare, ritogliere quanto può". Ma da ciò non consegue di necessità l'uso del latino.Qui interviene l'altra e complementare poetica pascoliana: la poetica delle cose. "Vedere e udire: altro non deve il poeta. Il poeta è l'arpa che un soffio anima, è la lastra che un raggio dipinge. La poesia è nelle cose". Ma questa aderenza alle cose ha una conseguenza linguistica di estrema importanza, ogni cosa deve parlare quanto più è possibile con la propria voce: gli esseri della natura con l'onomatopea, i contadini col vernacolo, gli emigranti con l'italo-americano, Re Enzio col bolognese del Duecento; i Romani, naturalmente, parleranno in latino. Dunque il bilinguismo di Pascoli in realtà è solo una faccia del suo plurilinguismo. Bisogna tenere conto anche di un altro elemento: il latino del Pascoli non è la lingua che abbiamo appreso a scuola. Questo è forse il secondo motivo per il quale la produzione latina pascoliana è stata per anni oggetto di scarso interesse: per poter leggere i suoi poemetti latini è necessario essere esperti non solo del latino in generale, ma anche del latino di Pascoli. Si è già fatto menzione del fatto che nello stesso periodo, e anche prima di lui, altri autori avevano scritto in latino; scrivere in latino per un moderno comporta due differenti e contrapposti rischi. L'autore che si cimenti in questa impresa potrebbe, da una parte, incappare nell'errore di esprimere una sensibilità moderna in una lingua classica, cadendo in un latino maccheronico; oppure potrebbe semplicemente imitare gli autori classici, senza apportare alcuna novità alla letteratura latina.Pascoli invece reinventa il latino, lo plasma, piega la lingua perché possa esprimere una sensibilità moderna, perché possa essere una lingua contemporanea. Se oggi noi parlassimo ancora latino, forse parleremmo il latino di Pascoli. (cfr. Alfonso Traina, Saggio sul latino del Pascoli, Pàtron). Numerosi sono i componimenti, in genere raggruppati in diverse raccolte secondo l'edizione del Gandiglio, tra le quali: Poemata Christiana, Liber de Poetis, Res Romanae, Odi et Hymni. Due sembrano essere i temi favoriti del poeta: Orazio, poeta della aurea mediocritas, che Pascoli sentiva come suo alter ego, e le madri orbate, cioè private del loro figlio (cfr. Thallusa, Pomponia Graecina, Rufius Crispinus). In quest'ultimo caso il poeta sembra come ribaltare la sua esperienza personale di orfano, privando invece le madri del loro ocellus ("occhietto", come Thallusa chiama il bambino). I Poemata Christiana sono da considerarsi il suo capolavoro in lingua latina. In essi Pascoli traccia, attraverso i vari poemetti, tutti in esametri, la storia del Cristianesimo in Occidente: dal ritorno a Roma del centurione che assistette alla morte di Cristo sul Golgota (Centurio), alla penetrazione del Cristianesimo nella società romana, dapprima attraverso gli strati sociali di condizione servile (Thallusa), poi attraverso la nobiltà romana (Pomponia Graecina), fino al tramonto del paganesimo (Fanum Apollinis).Biblioteca e archivio personali[modifica | modifica wikitesto]La sua biblioteca e il suo archivio sono depositati sia nella Casa Pascoli a Castelvecchio Pascoli frazione di Barga, sia alla Biblioteca statale di Lucca[41].Onori[modifica | modifica wikitesto]Nel 2009 Alitalia gli dedica uno dei suoi Airbus A320-216 (EI-DTJ).Nel 2012, in occasione del centenario della morte del poeta, varie città gli dedicano importanti manifestazioni. Oltre a San Mauro Pascoli[42] e Barga[43], si possono ricordare Forlì[44], Lecce[45], Messina[46] e Urbino[47].Nel 2012 viene anche coniata una moneta celebrativa da due euro[48]. |
|
Post n°1627 pubblicato il 28 Aprile 2018 da blogtecaolivelli
|
|
Post n°1626 pubblicato il 28 Aprile 2018 da blogtecaolivelli
fonte: Internet Salvatore Quasimodo (Modica, 20 agosto 1901 - Napoli, 14 giugno 1968) è stato un poeta italiano, esponente di rilievo dell'ermetismo. Ha contribuito alla traduzione di vari componimenti dell'età classica, soprattutto liriche greche, ma anche di opere teatrali di Molière e William Shakespeare. È stato vincitore del premio Nobel per la letteratura. Salvatore Quasimodo nacque il 20 agosto 1901 da Gaetano Quasimodo e Clotilde Ragusa a Modica, dove il padre era stato assegnato come capostazione. A pochi giorni dalla sua nascita, la madre Clotilde insieme al piccolo Salvatore e il primogenito Vincenzo (1899) si trasferì dai nonni paterni, nella più sicura casa di Roccalumera. Il padre Gaetano non poté abbandonare il luogo di lavoro per seguirla. Salvatore fu battezzato a Roccalumera, nella Chiesa della Madonna Bambina, l'11 settembre 1901. A Roccalumera il poeta trascorrerà tutta la sua infanzia e giovinezza. A Roccalumera Quasimodo tornava da grande per trovare i genitori e la famiglia. Dopo circa due mesi dalla sua nascita, il padre Gaetano fu trasferito. Nel 1908 a Gela iniziò a frequentare le scuole elementari. Nel 1916 si iscrisse all'Istituto Tecnico Matematico-Fisico di Palermo per poi trasferirsi a Messina. nel 1917 e continuare gli studi presso l'Istituto "A. M. Jaci", dove conseguì il diploma nel 1919. Durante la permanenza in questa città conobbe il giurista Salvatore Pugliatti e il futuro sindaco di Firenze Giorgio La Pira, con i quali strinse un'amicizia destinata a durare negli anni. Insieme ad essi fondò nel 1917 il «Nuovo Giornale Letterario», mensile sul quale pubblicò le sue prime poesie. La tabaccheria di uno zio di La Pira, unico rivenditore della rivista, divenne luogo di ritrovo per giovani letterati. Nel 1919 si trasferì a Roma dove pensava di terminare gli studi di ingegneria ma, subentrate precarie condizioni economiche, dovette abbandonarli per impiegarsi in più umili attività: disegnatore tecnico presso un'impresa edile, e in seguito impiegato presso un grande magazzino. Nel frattempo collaborò ad alcuni periodici e iniziò lo studio del greco e del latino con la guida di monsignor Mariano Rampolla del Tindaro, pronipote omonimo del più famoso cardinale Rampolla del Tindaro, Segretario di Stato di Papa Leone XIII. Collaborò ad alcuni periodici e studiò il greco e il latino dedicandosi ai classici, che divennero per lui una grande fonte di ispirazione. Nello stesso anno sposò Bice Donetti, una donna di otto anni più grande, con la quale aveva precedentemente convissuto e a cui dedicherà una poesia dopo la sua morte, avvenuta nel 1946: Nel 1948, due anni dopo la morte della prima moglie, si risposerà con la ballerina Maria Cumani, da cui avrà il figlio Alessandro Quasimodo. Nel periodo di Reggio Calabria nacque la nota lirica Vento a Tindari, dedicata alla storica località presso Patti: Il padre andò in pensione nel 1927 e dopo una breve permanenza a Firenze si ritirò definitivamente nella sua casa di Roccalumera, dove visse con due sorelle che non si erano sposate. Molti anni dopo il poeta emigrato si raffigurerà con questi versi: Risolti i problemi economici poté dedicarsi più assiduamente all'opera letteraria. Fu invitato a Firenze dallo scrittore Elio Vittorini, che nel 1927 aveva sposato la sorella Rosa, che lo introdusse nei locali ambienti letterari permettendogli di conoscere Eugenio Montale, Arturo Loria, Gianna Manzini e Alessandro Bonsanti. Il Bonsanti che in quel tempo dirigeva la rivista Solaria pubblicò nel 1930 tre poesie (Albero, Prima volta, Angeli). Maturò e affinò così il gusto per lo stile ermetico, cominciando a dare consistenza alla sua prima raccolta Acque e terre, che lo stesso anno pubblicò per le edizioni Solaria. Nel 1938 lasciò il Genio Civile per dedicarsi alla letteratura, iniziò a lavorare per Cesare Zavattini in un'impresa di editoria e soprattutto si dedicò alla collaborazione con Letteratura, una rivista vicina all'ermetismo. Nel 1938 pubblicò a Milano una raccolta antologica intitolata Poesie, e nel 1939 iniziò la traduzione dei lirici greci. Nel 1941 venne nominato professore di Letteratura italiana presso il Conservatorio di musica "Giuseppe Verdi" di Milano, incarico che mantenne fino alla fine del 1968. Seconda guerra mondiale Nel 1942 entrerà nella collezione Lo specchio della Arnoldo Mondadori Editore l'opera Ed è subito sera, che inglobava anche le Nuove poesie scritte tra il 1936 e il 1942. Nel 1940, a guerra iniziata e a Patto d'Acciaio consolidato, collaborò con la rivista Primato. Lettere e arti d'Italia dove il ministro Giuseppe Bottai raccolse intellettuali di varia estrazione e orientamento, anche lontani dal regime. Gli sarà rimproverato, in anni recenti, di aver sostenuto l'uso del voi con un intervento su un numero monografico del 1939 della rivista Antieuropa, e di aver inoltrato supplica a Mussolini che gli venisse assegnato un contributo per potere proseguire l'attività di scrittore. Pur professando chiare idee antifasciste, non partecipò attivamente alla Resistenza; in quegli anni si diede alla traduzione del Vangelo secondo Giovanni, di alcuni Canti di Catullo e di episodi dell'Odissea che verranno pubblicati solamente dopo la Liberazione. Periodo della poesia impegnata (1945 - 1966) Salvatore Quasimodo nel 1958Nel 1945 si iscrisse al PCI e l'anno seguente pubblicò la nuova raccolta dal titolo Con il piede straniero sopra il cuore - ristampata nel 1947 con il nuovo titolo Giorno dopo giorno, testimonianza dell'impegno morale e sociale dell'autore che continuerà, in modo sempre più profondo, nelle successive raccolte, composte fra il 1949 e il 1958, come La vita non è sogno, Il falso e il vero verde e La terra impareggiabile, che si pongono, con il loro tono epico, come esempio di limpida poesia civile. Durante questi anni il poeta continuò a dedicarsi con passione all'opera di traduttore sia di autori classici che moderni, e svolse una continua attività giornalistica per periodici e quotidiani, dando il suo contributo soprattutto con articoli di critica teatrale. Nel 1950 il poeta ottenne il Premio San Babila, nel 1953 condivise il Premio Etna-Taormina con il poeta gallese Dylan Thomas, nel 1958 il premio Viareggio e nel 1959 gli fu assegnato il premio Nobel per la letteratura «per la sua poetica lirica, che con ardente classicità esprime le tragiche esperienze della vita dei nostri tempi» che gli fece raggiungere una definitiva fama. Ad esso seguirono le lauree honoris causa dalla Università di Messina nel 1960 e da quella di Oxford nel 1967. Il poeta trascorse gli ultimi anni di vita compiendo numerosi viaggi in Europa e in America per tenere conferenze e letture pubbliche delle sue liriche che nel frattempo erano state tradotte in diverse lingue. Nel 1965 cura la pubblicazione di Calignarmata, opera di poesia dell'autore Luigi Berti, uscita un anno dopo la morte di quest'ultimo (1964). Il 14 giugno del 1968, mentre il poeta si trovava ad Amalfi, dove doveva presiedere un premio di poesia, venne colpito da un ictus (aveva avuto già un infarto mentre visitava l'Unione Sovietica), che lo condusse alla morte poche ore dopo, il cuore del poeta smise di battere sull'auto che lo stava trasportando all'ospedale di Napoli. Il suo corpo fu trasportato a Milano e tumulato nel Famedio del Cimitero Monumentale, luogo che già ospitava le spoglie di Alessandro Manzoni.
Sei ancora quello della pietra e della fionda, uomo del mio tempo. »(Salvatore Quasimodo, da Uomo del mio tempo)
Il ricordo della Sicilia è ancora vivissimo ma si avverte nel poeta un'inquietudine nuova, la voglia di uscire dalla sua solitudine e confrontarsi con i luoghi e le persone della sua vita attuale. Il poeta sente l'esigenza di confrontarsi con i propri affetti, con la madre che ha lasciato quand'era ancora un ragazzo (e che continua a vivere la sua vita semplice e ignara dell'angoscia del figlio ormai adulto), o col ricordo della prima moglie Bice Donetti. Nella raccolta Il falso e vero verde (1956) dove lo stesso titolo è indicativo di un'estrema incertezza esistenziale, un'intera sezione è dedicata alla Sicilia, ma nel volume trova posto anche una sofferta meditazione sui campi di concentramento che esprime «un no alla morte, morta ad Auschwitz» (Auschwitz). La terra impareggiabile (1958) mostra un linguaggio più vicino alla cronaca, legato alla rappresentazione della Milano simbolo di quella «civiltà dell'atomo» che porta ad una condizione di devastante solitudine e conferma nel poeta la voglia di dialogare con gli altri uomini, fratelli di dolore. L'isola natìa è luogo mitizzato, «terra impareggiabile» appunto, ma è anche memoria di eventi tragici come il terremoto di Messina del 1908 (Al padre). L'ultima raccolta di Quasimodo, Dare e avere, risale al 1966 e costituisce una sorta di bilancio della propria esperienza poetica e umana: accanto ad impressioni di viaggio e riflessioni esistenziali molti testi affrontano, in modo più o meno esplicito, il tema della morte, con accenti di notevole intensità lirica. Opere: Raccolte di poesie Acque e terre, Firenze, sulla rivista Solaria, 1930. Oboe sommerso, Genova, sulla rivista Circoli, 1932. Odore di eucalyptus ed altri versi, Firenze, Antico Fattore, 1933. Erato e Apòllìon, Milano, Scheiwiller, 1936. Nuove Poesie, Milano, Primi Piani, 1938. Ed è subito sera, Milano-Verona, A. Mondadori, 1942 Giorno dopo giorno, Milano, A. Mondadori, 1947. La vita non è sogno, Milano, A. Mondadori, 1949. Il falso e vero verde (1949-1955), Milano, Schwarz, 1956. La terra impareggiabile, Milano, A. Mondadori, 1958. Dare e avere. 1959-1965, Milano, A. Mondadori, 1966. Lirici greci, Milano, Edizioni di Corrente, 1940; maggio 1944, Mondadori.Virgilio, Il Fiore delle Georgiche, Milano, Edizioni della Conchiglia, 1942. - Milano, Gentile, 1944; Milano, Mondadori, 1957. Catulli Veronensis, Carmina, Milano, Edizioni di Uomo, 1945. - Milano, Mondadori, 1955. Omero, Dall'Odissea, Milano, Rosa e Ballo, 1945.Sofocle, Edipo re, Milano, Bompiani, 1946. Il Vangelo secondo Giovanni, Milano, Gentile, 1946. John Ruskin, La Bibbia di Amiens, Milano, Bompiani, 1946. William Shakespeare, Romeo e Giulietta, Milano, Mondadori, 1948 .Eschilo, Le Coefore, Milano, Bompiani, 1949. William Shakespeare, Riccardo III, Milano, Edizioni del Piccolo Teatro, 1950. - Milano, Mondadori, 1952. Pablo Neruda, Poesie, Torino, Einaudi, 1952. William Shakespeare, Macbeth, Torino, Einaudi, 1952.Sofocle, Elettra, Milano, William Shakespeare, La Tempesta, Torino, Einaudi, 1956. Molière, Il Tartufo, Milano, Bompiani, 1958. Fiore dell'Antologia Palatina, Parma, Guanda, 1958. Edward Estlin Cummings, Poesie scelte, Milano, Scheiwiller, 1958. Ovidio, Dalle Metamorfosi, Milano, Scheiwiller, 1959. William Shakespeare, Otello, Collana Lo Specchio, Milano, Mondadori, 1959. Euripide, Ecuba, Urbino, Armando Argalìa Editore, 1962. Conrad Aiken, Mutevoli pensieri, Milano, Scheiwiller, 1963. Euripide, Eracle, Urbino, Armando Argalìa Editore, 1964. William Shakespeare, Antonio e Cleopatra, Milano, Mondadori, 1966 Tudor Arghezi, Poesie, Milano, Mondadori, 1966. Yves Lecomte, Il gioco degli astragali, Edizioni Moneta, 1968. CurateleLirici minori del XIII e XIV secolo, a cura di S. Quasimodo e Luciano Anceschi, Milano, Edizioni della Conchiglia, 1941. Lirica d'amore italiana, dalle origini ai nostri giorni, 1957. Poesia italiana del dopoguerra, 1958. Altri scritti: Petrarca e il sentimento della solitudine, Milano, Garotto, 1945. Scritti sul teatro, 1961.L'amore di Galatea libretto per musica, 1964 Il poeta e il politico e altri saggi, Milano, Schwarz, 1967. Leonida di Taranto, Milano, Guido Le Noci ed., 1968; Manduria, Lacaita, 1969.Lettere d'amore di Quasimodo, post., 1969 Poesie e discorsi sulla poesia, post., 1971. Marzabotto parla. Con scritti di Salvatore Quasimodo, Giuseppe Dozza, post., 1976A colpo omicida e altri scritti, post., 1977
|
AREA PERSONALE
MENU
CHI PUņ SCRIVERE SUL BLOG
I messaggi e i commenti sono moderati dall'autore del blog, verranno verificati e pubblicati a sua discrezione.


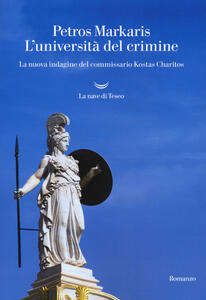 I primi 40 titoli in classifica nella settimana dal 16 al 22 aprile 2018
I primi 40 titoli in classifica nella settimana dal 16 al 22 aprile 2018
 Ciao ciao petrolio: la sostenibilità raccontata da Harriet Russell
Ciao ciao petrolio: la sostenibilità raccontata da Harriet Russell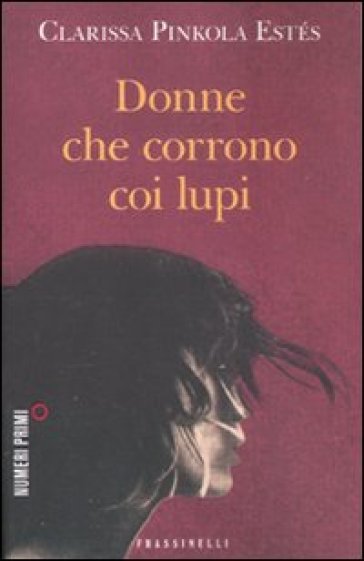
 Pagina dopo pagina, favola dopo favola si percepisce nitidamente quanto entrambe riescano a intersecarsi con armonia e sinuosità. Sensibilità, spirito allegro, una spiccata curiosità, sete di conoscenza, un'intuizione innata, spirito di adattamento, voglia di scoprire nuove frontiere, nuovi territori, il desiderio di oltrepassare i limiti del proprio territorio: caratteristiche che rendono le donne e i lupi un'unica energia. Le storie che la Estés racconta sono le copie di quelle utilizzate nelle sue lezioni con i propri pazienti, fiabe che vanno dai miti e leggende dei nativi americani, alle fiabe europee e russe, alle fiabe asiatiche: Barbablù, La piccola fiammiferaia, Vassilissa, Il brutto anatroccolo. Fiabe ascoltate durante l'infanzia che adesso diventano un canale per una crescita interiore. La Donna Selvaggia, descritta da Clarissa Pinkola Estés, è intesa come forza psichica potente, creatrice, libera ma limitata dalle proprie paure, dalle insicurezze e da tutte le convenzioni cucite addosso. In ogni storia, riletta da una prospettiva psicanalitica, ritroviamo situazioni nelle quali la donna si trova ad affrontare sentimenti, emozioni, crisi. In ogni donna coesiste una parte naturale e una selvaggia, caratterizzata da istinti, da una forte creatività, ed è solo ritrovando il proprio istinto, prendendo coscienza del proprio intuito e accettando i cicli vita-morte-vita, che si potrà nuovamente correre con il proprio sé. Quello autentico, privo di contaminazioni.
Pagina dopo pagina, favola dopo favola si percepisce nitidamente quanto entrambe riescano a intersecarsi con armonia e sinuosità. Sensibilità, spirito allegro, una spiccata curiosità, sete di conoscenza, un'intuizione innata, spirito di adattamento, voglia di scoprire nuove frontiere, nuovi territori, il desiderio di oltrepassare i limiti del proprio territorio: caratteristiche che rendono le donne e i lupi un'unica energia. Le storie che la Estés racconta sono le copie di quelle utilizzate nelle sue lezioni con i propri pazienti, fiabe che vanno dai miti e leggende dei nativi americani, alle fiabe europee e russe, alle fiabe asiatiche: Barbablù, La piccola fiammiferaia, Vassilissa, Il brutto anatroccolo. Fiabe ascoltate durante l'infanzia che adesso diventano un canale per una crescita interiore. La Donna Selvaggia, descritta da Clarissa Pinkola Estés, è intesa come forza psichica potente, creatrice, libera ma limitata dalle proprie paure, dalle insicurezze e da tutte le convenzioni cucite addosso. In ogni storia, riletta da una prospettiva psicanalitica, ritroviamo situazioni nelle quali la donna si trova ad affrontare sentimenti, emozioni, crisi. In ogni donna coesiste una parte naturale e una selvaggia, caratterizzata da istinti, da una forte creatività, ed è solo ritrovando il proprio istinto, prendendo coscienza del proprio intuito e accettando i cicli vita-morte-vita, che si potrà nuovamente correre con il proprio sé. Quello autentico, privo di contaminazioni.