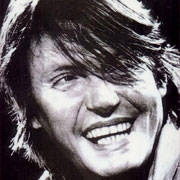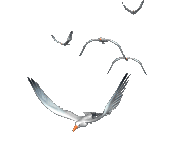Genova Nei Ricordi
Ma se ghe pensu...Uno straordinario viaggio alla scoperta della vecchia Genova, quella più sconosciuta.Ricca di leggende,aneddoti,curiosità,segreti,tradizioni e personaggi.Il fascino di luoghi dimenticati per ritrovare la magia delle atmosfere perdute.
|
Post n°11 pubblicato il 04 Agosto 2009 da Bibi1742
|
La bella di Torriglia che tutti la vogliono ma nessuno la prende |
|
Post n°9 pubblicato il 03 Agosto 2009 da Bibi1742
Da wikipedia |
|
Post n°8 pubblicato il 03 Agosto 2009 da Bibi1742
La Bella di Torriglia è una figura leggendaria e popolare legata alla cittadina di Torriglia, in provincia di Genova. Secondo un'antica filastrocca, è colei che tutti vogliono, ma nessuno piglia (in dialetto genovese: A Bella de Torriggia: tutti a vêuan, nisciûn a piggia). La locuzione è divenuta un modo comune per indicare qualcosa di molto ambito solo in apparenza. La maggiore pretendente a questo titolo è forse Rosa Garaventa (nata a Torriglia in data sconosciuta e morta nel 1868), un cui ritratto venne pubblicato sul periodico umoristico-letterario Farfalla. La veridicità della leggenda che vuole Rosa Garaventa essere stata la Bella di Torriglia, viene messa in discussione da altre di segno opposto, di cui una risalente al XVI secolo, secondo la quale la vera Bella di Torriglia sarebbe stata tale Clementina, amante di Sinibaldo Fieschi, Signore di Torriglia, oggi comune in provincia di Genova. Per il Fieschi, Principe di Borgo Val di Taro dal 1520 al 1532, venne coniato appositamente un Testone d'argento di sette grammi. Clementina - si dice - gli rimase fedele tutta la vita pur se la relazione venne interrotta dall'esilio genovese della famiglia Fieschi. Ma a Rosa Garaventa e alla misteriosa Clementina, altre fonti, oppongono una terza pretendente al ruolo di Bella di Torriglia: sulla facciata di una casa del comune ligure vi è un bel ritratto di fantasia, a piena figura, opera del pittore locale Pietro Lumachi, che raffigura tale Maria Traverso, morta nel 1886, altra possibile Bella torrigliese. A Torriglia viene anche preparata, dall'unica pasticceria del paese, una tipica torta, composta da pasta frolla e impasto di mandorle, che porta il nome di Bella di Torriglia. dA WIKIPEDIA |
|
Gli angeli hanno occhi orecchie ed unghie come gli altri?" (variante tipica del comune di Cogorno). |
|
Post n°6 pubblicato il 01 Agosto 2009 da Bibi1742
Un piatto caratteristico della cucina tradizionale genovese sono le frittelle di baccalà, in dialetto detti "bacallè friti" o "friscieu de bacallè". Il baccalà è entrato nella gastronomia genovese a seguito dei ricchi e intensi scambi commerciali marittimi con il nord Europa.
possiamo trovare in gastronomia come piatto"svelto". Occorrente: 200 gr circa fi farina 00 un bicchiere di vino bianco uno di acqua minerale gassata 400 gr.circa di baccalà bagnato olio extravergine sale Il baccalà va lasciato in acqua corrente per almeno 48 ore. In una terrina amalgamatee la farina con il vino bianco e l'acqua con una frusta per ottenere un impasto più denso che liquido. Togliete le pelle ai baccalà, tagliateli a filetti o a pezzetti, quindi immergeteli nella pastella dopo averla lasciata riposare circa due ore. Fate scaldare per bene abbondante olio di oliva extra vergine in padella capiente e quando sarà ben caldo immergetivi i pezzi di baccalà nella pastella servendovi di un mestolino. Quando saranno belli croccanti sistemateli su un vassoio con della carta assorbente per eliminare l'eccesso di unto. Servire caldi accompagnati da un buon vinello bianco secco. |
|
Son zeneize, riso ræo, strenzo i denti e parlo ciæo = Sono genovese, rido raramente, stringo i denti e parlo chiaramente. Al bambino che si lamenta Gh'ò famme, facilmente la mamma risponde: Gràttite e zenogge e fatte e lasagne = "grattati le ginocchia e fatti le lasagne". D'altronde è noto anche ai bambini di ogni età che Chi no cianze, no tetta, ossia "chi non piange, non viene alimentato dalla mamma". Pòscito-êse alughetòu = Possa tu essere riposto, allogato per un po': alughetâ è il frequentativo del verbo alugâ (in italiano riporre, allogare) e l'uso del frequentativo è appropriato dato che la frase si diceva ai bambini vivaci: che potessero appunto essere riposti per un po' (di qui il frequentativo del verbo). Esistono alcune varianti: pòscito moî òrbo = "possa tu morire orbo"; pòscito ëse ammassòu! = "possa tu esser ammazzato". Chi veu vive da bon crestian, da-i beghin o stagghe lontàn = Antico proverbio che mette in guardia da fanatici ed ipocriti: "Chi vuole vivere da buon cristiano, dai beghini" (i falsi devoti) "stia lontano". A sfortunn-a a l'é 'n grifon, ch'o gïa in gïo a-a testa do belinon = Saggezza popolare che riflette il carattere risoluto ed alcuni simboli e luoghi comuni propri del popolo genovese: "La sfortuna è un grifone che gira intorno alla testa dello stupido". Citazione utilizzata anche da Fabrizio De André nella canzone Sinàn Capodàn Pascià dell'album Crêuza de mâ. Sciusciâ e sciorbî no se peu = Detto quasi esclusivamente ligure, significa "Soffiare e aspirare non si può". Non si può pretendere di fare una cosa e il suo contrario; occorre fare una scelta e sapersi accontentare. L'é megio avei e braghe sguaræ 'nto cù che o cù sguaròu'nte brâghe = "è meglio avere i pantaloni rotti nel sedere, che il sedere rotto nei i pantaloni". Da wikipedia |
|
Post n°4 pubblicato il 31 Luglio 2009 da Bibi1742
Ma se ghe pensu (Ma se ci penso in italiano) è una canzone in dialetto genovese,
In tempi recenti è stato eseguito da diversi cantanti, fra cui Mina nel 1967. Nel 2007 è stata incisa anche da Antonella Ruggiero,
in occasione
senza la congiunzione iniziale "Ma",
in un secondo momento. La paternità della canzone è invece sicuramente attribuibile a Mario Cappello (tanto per i versi quanto per la musica) mentre Attilio Margutti collaborò soltanto alla stesura musicale. L'anno di nascita del brano fu il 1925. del soprano Luisa Rondolotti, che lo cantò al Teatro Orfeo, una sala genovese che oggi non esiste più. Erano gli anni in cui nasceva la canzone dialettale genovese derivazione degli antichi trallallero, e che sarebbe poi sfociata in un certo senso nella scuola dei cantautori genovesi passando prima attraverso lo swing dell'immediato dopoguerra di Natalino Otto e il gruppo degli urlatori anni sessanta di cui faceva parte il cantante con il saltino: Joe Sentieri.
a emigrare in America Latina della sua città e sopraffatto
La canzone apre e chiude con il riferimento alla povertà del protagonista,
(sensa ûn-a palanca), torna trent'anni Non gli importa che il figlio preferisca rimanere: lui partirà in un viaggio a ritroso
verso la loro città e (finalmente) sfata il mito della loro avarizia, riconoscendo loro valori più alti di quelli materiali: ad un'iniziale bramosia di benessere
pian piano la nostalgia gli attanaglia il cuore.
U l'ëa passou du tempu, forse troppu, Ma se ghe penso allua mi veddo u mâ, E sensa tante cöse u l'è partïu TRADUZIONE:
Ed era passato del tempo, forse troppo, Ma se ci penso allora io vedo il mare, E senza tante cose è partito |
|
La crêuza è un termine della lingua ligure spesso italianizzato in crosa. Viene fatto derivare, come l'aggettivo francese creux/creuse, dal new,courier,monospace">latino crŏsus, a sua volta di origine celtica, e definisce il tipico stretto viottolo o mulattiera che fende, spesso verticalmente, le colline del Genovesato e di tutta la Liguria. La crêuza', tipica struttura viaria suburbana, ha precise caratteristiche: la principale è quella di percorrere le colline se possibile sul crinale e spesso con la massima pendenza, piuttosto che negli avvallamenti, ciò è voluto a minimizzare l'impatto di compluvio della pioggia, limitando le opere relative; essendo soleggiata è inoltre evitata, o limitata, la permanenza di umidità neve e ghiaccio che negli avvallamenti possono permanere ed essere molto pericolosi, data la possibilità climatica della regione di avere repentini passaggi dal caldo al freddo in poco tempo, in caso di passaggio del vento ai quadranti settentrionali. È quindi privilegiata la conservazione della percorribilità in ogni condizione piuttosto che facilità di percorso. La pavimentazione tipicamente è data da mattoni al centro e ciottoli tondi ai lati, il profilo è decisamente convesso per il drenaggio laterale, anche del pericolosissimo ghiaccio incastrato tra i mattoni; può essere articolata in lunghi e bassi gradoni, definiti da blocchetti in pietra, nei tratti a maggior pendenza. Le crêuze, così come le coltivazioni a terrazza (le cosiddette fasce) caratterizzano il paesaggio di tutta la Liguria, sia quelle che si affaccia sul mare, più conosciuto e pubblicizzato, sia quello dell'entroterra, meno famoso ma non per questo meno caratteristico e bello, spesso cantato da famosi poeti, come Eugenio Montale, Camillo Sbarbaro e Dino Campana. In lingua genovese il termine di crêuza ha preso anche il significato figurato per “strada” o “percorso”. Così anche un fenomeno meteorologico, ben visibile dalle colline costiere, che si realizza sul mare, con mare calmo e vortici di vento sulla superficie. La superficie del mare appare brillante per il riflesso del sole, ma è percorsa da strisce scure, curve e contorte, prodotte dal diverso increspamento della superficie, quasi a segnare fantastici percorsi che si aprono per quella che è da sempre stata la via privilegiata ed a volte obbligata dei liguri, il mare aperto. Si dice quindi “u ma u fa e crêuze” cioè “ il mare fa le strade, i viottoli”, segna un percorso. |