|
|
Creato da vita_da_blog50 il 29/08/2009
in nave con Dioniso
|
Area personale
La vita puo' essere atroce, questo si sa.
Arrivare a un passo dal comprendere tutto - senza per questo diventare cinici!
Ecco, poter dire: “Ora nulla potrà più ingannarmi”.
E poi finire con una bella risata.
Walter Abish
(senza fatica! perchè rubato direttamente dal blog di Dianavera.)
bugìa
è paradossale che
una bugìa di terracotta
possa illuminare
le bugìe degli uomini.
Menu
Tag
...e comunque vacci sempre
piano con le parole...
Ultimi commenti
Cerca in questo Blog
Chi può scrivere sul blog
| « ..rose rosse per te... | Integrazione: requisiti minimi » |
.
Post n°33 pubblicato il 16 Gennaio 2010 da vita_da_blog50
«la maggior parte di quei duecento sono
Il piccolo Redjeson Hausteen Claud, due anni, estratto vivo dalle macerie da un soccorritore spagnolo. PORT AU PRINCE - In teoria dovrebbe essere una buona notizia: non è vero che a Port-au-Prince si muore e basta. Negli ultimi tre giorni, nella capitale dei centomila uccisi dalla terra, sono anche nati almeno duecento nuovi bambini. «Naturalmente è una stima per difetto— dice la dottoressa —. Perché quanti siano davvero non lo sa nessuno». E del resto anche la buona notizia è già finita, perché «la maggior parte di quei duecento sono quasi certamente già morti a loro volta». È una cosa che non emoziona neanche più tanto, da queste parti. In fondo oggi ne nasceranno altri cento, forse più: e uno su tre morirà comunque, è così da anni. «Ma la statistica era aggiornata a prima del terremoto», dice la dottoressa. Un uomo improvvisamente grida e crolla in ginocchio vicino a un mucchio di qualcosa che forse era casa sua. Indica qualcosa che si intravede là sotto, un paio di metri dentro le macerie. Sembra un ramo bianco, però con delle piccole dita. L’uomo non piange neanche. Deve cercare un altro figlio. I figli di Haiti sono adesso «la prima cosa che noti» in mezzo a quel che resta di una città in briciole, nella pur tremenda infinità — a dire il vero — di tutte le altre prime cose che noti. Già normalmente, e rispetto al disastro di adesso non è più neanche un eufemismo, faceva parte della quotidianità vedere i bambini degli slums come Warf Jeremy o Cité Soleil andarsene in giro da soli anche di notte, in questo sterminio di baracche che sino a due anni fa facevano paura anche ai caschi blu. Non bambini di sei anni: di tre. Jean Fritz Sevère e sua moglie Bonnette, visto che i drammi basta aver visto la tv per immaginarli e sono solo un po’ peggio dell’antologia straziante che si immagina, sono una storia «quasi» a lieto fine pescata nel disastro: ora sono qui seduti per terra nel cortile dell’ospedale Saint Damien e lì di fianco, con uno straccio come riparo dal sole, ci sono i loro due gemelli Sneider e Smith. Hanno sei giorni di vita, tre più del terremoto. Smith ha una microscopica flebo infilata addosso, fa impressione vederlo così immobile. Mani adulte scacciano da lui, all’infinito, mosche che un secondo dopo gli tornano sopra. Ce la farà, dicono i dottori. «La casa dove sono nati — racconta un po’ in francese un po’ in creolo il padre Jean Fritz, meccanico per autodichiarazione, disoccupato di fatto come tutti — adesso non c’è più». Crollata come tutto il resto di Petionville. «Quando è arrivato il disastro eravamo usciti da cinque minuti tutti quanti, compresi gli altri nostri tre figli, per andare con i gemellini da mio fratello. Dovevamo fare una piccola festa. In un secondo ci siamo ritrovati sotto il muro di una casa dall’altra parte della strada. Ma i piccolini sono rimasti protetti dai corpi di noi più grandi. Siamo usciti da sotto i mattoni piano piano. Poi ci siamo incamminati verso questo ospedale». Da Petionville sono pochi chilometri. «A piedi ci abbiamo messo un giorno e mezzo». E gli altri tre figli? «Tutto bene, li hanno visti, sono vivi anche loro». Jean nota lo sguardo interrogativo: «No — dice — in realtà non sappiamo dove». Haiti cioè sarebbe buon un antidoto per tutti i preoccupati circa l’invecchiamento della popolazione mondiale. Un Paese «giovane», se le tragedie non trasformassero l’ironia in rabbia: ogni bambino che nasce oggi ha un’«aspettativa di vita media» intorno ai 50 anni, il che significa un’«età media reale» di diciotto. Un risultato non facile, al ritmo di tremila nascite al mese: la morte deve impegnarsi molto. Ma qui la si combatte anche, la morte. L'ospedale pediatrico Saint Damien, costruito nel quartiere Tabarre dalla fondazione americana Nph, è uno di quelli le cui strutture hanno sostanzialmente resistito: certo per due giorni non c’è stata corrente, acqua razionata, scorte all’osso. Il suo direttore sanitario, Roberto Dall’Amico, è uno dei medici volontari partiti dall’Italia all’indomani del sisma. I duecento bambini che normalmente ospita sono diventati quattrocento in un giorno, e l’unica cosa certa è che continueranno ad aumentare, insieme con i tanti adulti che in questa emergenza finiscono qui a loro volta. Adesso sono le due del pomeriggio. Adesso, tra adulti e bambini, stanno operando i più gravi. Quelli dove «c’è da amputare». Accampati fuori, nei cortili, la folla dei genitori che sono riusciti ad arrivare. Con gli altri loro figli. L’interno dell’ospedale va usato ancora con prudenza, come tutto: ci mancherebbe solo una nuova scossa che azzerasse il lavoro fatto. Sul prato c’è una lunga fila di culle in plastica, sotto un’ombra inventata con mezzi di fortuna: pali, teli, quel che c’era. E c’è un’altra cosa, tra quelle che in principio non si notano ma che dopo, invece, ti entrano dentro peggio di un grido. Che di grida non ce n’è. Pochissime. Giusto quando una ferita è proprio molto molto dolorosa da medicare. E quasi sempre è un adulto. I bambini non piangono. O molto, molto raramente. Guardano il dottore che li disinfetta, cuce, fascia. Poi guardano il muro, o il soffitto, o quello che hanno davanti. Se gli dai un dito però te lo afferrano e stringono. Come i bambini. Da domani avranno una mano italiana in più, che non aiuterà solo loro: la Protezione Civile ha infatti scelto l’ospedale Saint Damien come base operativa per i venti medici del Medical Advanced Post che ora raggiungeranno l’avanguardia arrivata qui già il secondo giorno col primo Falcon partito da Roma sotto il coordinamento di Giovanni De Sierno, insieme col chirurgo Alessandro Rubino e gli uomini del capitano della Finanza Marco Molle. Da domani l’ospedale avrà altre sale operatorie da campo, tende, strutture, medicinali in più. Ma quello dei dottori è solo una pezzo della battaglia. Il resto, sul fronte dei piccoli, lo stanno combattendo le squadre di volontari che — per Nph come per altre associazioni venute da tutto il mondo — da quando fa giorno sinché vien buio percorrono la città nei suoi quattro sensi: proprio alla ricerca dei bambini senza più nessuno. Un compito non facile, anche perché l’indipendenza è un concetto che a Port-au-Prince matura presto: un bambino di sei anni lo puoi anche vedere in giro da solo ma di qui a farlo venire via con te, a meno che non sia proprio ferito, a volte ce ne corre. E del resto, anche quando hanno una famiglia, non è sempre così scontato trasmettere l’idea occidentale semplice di una «cura». Le quattro «cliniche di strada» che il medico missionario padre Rick ha aperto un po’ alla volta negli slums sono una sua invenzione degli ultimi due-tre anni. «E la cosa più difficile — dice — è appunto spiegare alle madri e ai padri che quando il loro bambino scotta bisogna portarlo da un dottore. E non semplicemente rassegnarsi alla possibilità che muoia. Perché è questo, la rassegnazione, il cancro peggiore insito nella miseria».
|


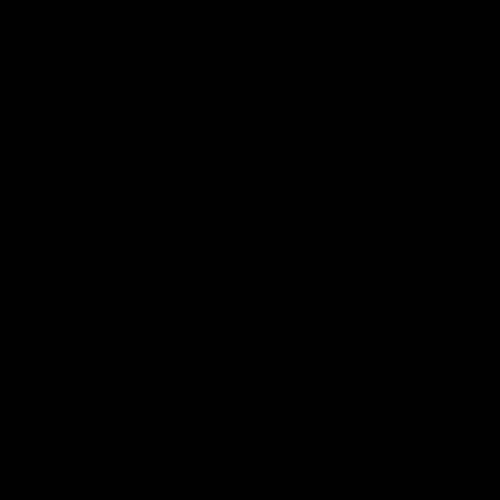
Inviato da: sono.dettagli
il 21/06/2011 alle 19:47
Inviato da: dianavera
il 20/11/2010 alle 20:09
Inviato da: dianavera
il 10/11/2010 alle 18:17
Inviato da: dianavera
il 04/11/2010 alle 20:23
Inviato da: dianavera
il 31/10/2010 alle 12:37