

È normale che esista la paura, in ogni uomo, l’importante è che sia accompagnata dal coraggio. Non bisogna lasciarsi sopraffare dalla paura, altrimenti diventa un ostacolo che impedisce di andare avanti. Paolo Borsellino



È normale che esista la paura, in ogni uomo, l’importante è che sia accompagnata dal coraggio. Non bisogna lasciarsi sopraffare dalla paura, altrimenti diventa un ostacolo che impedisce di andare avanti. Paolo Borsellino
di Alessandra Spallarossa
Forse complice la memoria che sbiadisce dopo una certa età, forse anche il processo di rimozione dei ricordi dolorosi per salvaguardare la propria salute mentale, mia nonna al telefono mi spiega che la guerra fu meno pesante per loro rispetto a questa reclusione forzata e a questo dramma epidemiologico.
La sua dichiarazione arriva in risposta al pensiero che ho condiviso con lei pochi secondi prima: “certo è dura ma per voi la guerra dev’esser stata molto peggio”. “No”, mi dice, lasciandomi sorpresa.
Mia nonna ha 87 anni, la sua giovinezza è stata segnata dal grande conflitto mondiale che ha tracimato tutta l’Europa, proprio come sta facendo ora il Covid-19, di cui il vecchio continente è diventato il nuovo epicentro.
“Intanto noi sapevamo chi era il nemico e da dove arrivava” continua mia nonna con la sua voce traballante “e poi potevamo riunirci, anzi, ci riunivano tutte le sere, trovavamo conforto nella socialità” quelle parole mi procurano una strana sensazione allo stomaco, ma la voce di mia nonna al telefono continua “certo, poteva cascarti la casa addosso sotto i colpi dei bombardieri, ma io ero una bambina, mi sedevo sulle ginocchia di mio padre e mi sembrava che nulla di male potesse accadermi finché lui mi stringeva”.
Non credo mia nonna intenda davvero sostenere la tesi che la guerra sia meglio di questa situazione, come non credo sia interessante cercare di assegnare premi agli eventi più traumatici della storia umana, eppure un pensiero emerge prepotentemente: la necessità umana del rapporto sociale e del contatto coi suoi simili.
Sono trascorse ormai più di due settimane da quando il Presidente Conte ha messo tutto il paese in quarantena, e pochi giorni in meno da quando l’OMS ha dichiarato il Covid-19 pandemia mondiale. Siamo ogni giorno testimoni di una tragedia che segnerà la storia, che sta mettendo in ginocchio i nostri sistemi; il mondo pare essersi fermato, e mentre noi ci affacciamo alle finestre come carcerati, la natura là fuori si riappropria dei suoi spazi usurpati, dandoci un’amara lezione su cosa possa essere la vita sul pianeta senza l’uomo.
Siamo tutti preoccupati, smarriti, provati, e chi non lo è non ha forse ben afferrato la situazione.
I contagi in tutto il mondo continuano a salire e i morti ad aumentare, la cantilena del telegiornale impregna i nostri salotti senza sosta, ricordandoci continuamente che bisogna restare a casa e che solo così finirà presto. “Presto”, questa parola sembra ormai aver abbandonato il suo significato reale, sembra piuttosto voglia rivestirsi di speranza, perché la verità è che non sappiamo quanto ancora andrà avanti questa reclusione coatta e necessaria. I dubbi sono tanti, ma risposte non ce ne sono.
Mentre aumenta il numero delle anime che si spengono, mentre il nostro paese barcolla sotto i colpi di tosse del coronavirus, qualcosa si aggrappa al nostro cuore ridandoci speranza: la prospettiva di poterci riabbracciare tutti “presto”.
Quando mia nonna mi spiega perché la guerra era diversa si sofferma sul contatto umano, sulla speranza e la forza che scaturiscono da un semplice abbraccio, dall’ancestrale conforto che ci da e che oggi ci è negato. Per la nostra e altrui sicurezza siamo chiamati a reprimere alcune delle più forti connotazioni umane: la socialità, l’aggregazione, l’affetto, il senso di comunità. Allora usciamo sui balconi, tentando di accorciare un po’ quella distanza fisica, cantiamo insieme per sentirci di nuovo vicini.
Mia nonna si sofferma anche sulla forma di questo nemico infido che ci ha costretti a fermarci e nasconderci, che è invisibile e che attecchisce all’interno dei nostri corpi in silenzio, sorprendendoci completamente disarmati.
Sebbene siano giorni delicati e confusi il telegiornale e i media non fanno altro che ripetere che siamo in guerra; voglio credere che ricorrano a quest’espressione col solo scopo di farci mantenere la massima cautela, e non di spargere il panico. Eppure il paragone viene naturale, non serve il giornalista con la sua dialettica a farci sentire come se ci stessero bombardando. Non cascano i palazzi, il nemico si insinua nelle nostre cellule, non ci sono frontiere da difendere, la trincea è nelle corsie d’ospedale, non ci sparano addosso, il virus aleggia tra le strade cittadine, non perdiamo valorosi soldati che combattono per la patria, vediamo i nostri cari spegnersi ineluttabilmente, e a volte neanche possiamo vederli. Il Covid-19 ci ha privati anche del più sacro avamposto umano: l’ultimo saluto ai nostri cari perduti.
Ebbene, nonostante tutto, non perdiamo la speranza, da questi giorni funesti si leva la tenace bellezza umana che non sembra volersi affievolire: l’inestimabile valore del vero contatto, che nessuna tecnologia può surrogare e nessuna tragedia può cancellare.
Nonostante tutto ricordiamoci che il dopoguerra è stato un periodo florido, di rinascita economica, un boom demografico con un miglioramento nello stile di vita, allora anche questa “guerra” un giorno finirà e noi faremo tesoro delle lezioni imparate, apprezzando profondamente le cose più semplici, daremo vita ad un nuovo splendido mondo. Voglio credere che sarà così.
https://www.nazioneindiana.com/2020/03/29/attendiamo-il-dopoguerra/
https://www.filastrocche.it/contenuti/girotondo-intorno-al-mondo-2/Girotondo in tutto il mondo
 Filastrocca per tutti i bambini,
Filastrocca per tutti i bambini,
per gli italiani e per gli abissini,
per i russi e per gli inglesi,
gli americani ed i francesi;
per quelli neri come il carbone,
per quelli rossi come il mattone;
per quelli gialli che stanno in Cina
dove è sera se qui è mattina.
Per quelli che stanno in mezzo ai ghiacci
e dormono dentro un sacco di stracci;
per quelli che stanno nella foresta
dove le scimmie fan sempre festa.
Per quelli che stanno di qua o di là,
in campagna od in città,
per i bambini di tutto il mondo
che fanno un grande girotondo,
con le mani nelle mani,
sui paralleli e sui meridiani…
Gianni Rodari
https://maestramary.altervista.org/poesie-e-filastrocche-di-gianni-rodari.htm
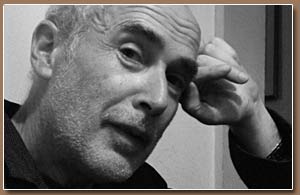
Mi sento nel giro che facevi a prendere la legna,
nel rumore del camion che va perchè si possa entrare
in trattoria durante l’ora di pausa: nei pensieri
che accompagnano la terra da togliere in cantiere.
Lo scavo è lo sguardo che lo tiene, quando si va via la sera,
e volendo ci si può chiedere com’è stata, che cosa, la giornata:
restare in una melodia o con un disegno più nervoso
e impossibile.
Così mi penso nelle parole che risalgono il cortile,
dopo averti sentita nell’aria che ti affaticava: e un po’ intorno
come una sera d’aria tra le pietre e sulla campagna.
Dove la neve è occuparsi di che cosa sono le erbe e i sassi,
rimanere sulle cose per un po’, nel bianco della neve:
con le piane che avevano il tuo sguardo grande,
tu che diventavi le giornate, lavoro e prati di un mondo.
https://www.gironi.it/poesia/benedetti.php
Nota
di Alida Airaghi
Garzanti ha da poco pubblicato Tutte le poesie di Mario Benedetti (Udine, 1955), poeta schivo e non conosciuto quanto merita, che dagli anni ’70 ha seguito un suo percorso autentico e originale di scrittura, fedele a una interpretazione umile e partecipe della realtà e del proprio vissuto.
Il volume raccoglie per la prima volta le sue opere più rappresentative, da Umana gloria (2004) a Pitture nere su carta (2008), fino a Tersa morte (2013) e all’inedito Questo inizio di noi (2015), ed è prefato da tre illustri poeti e amici (Antonio Riccardi, Stefano Dal Bianco, Gian Mario Villalta), che sottolineano con affetto e stima non solo la qualità letteraria dei versi di Benedetti, ma anche la tensione etica che li anima, radicata nei dati sofferti della sua vicenda biografica.
La madre originaria di una Slovenia impoverita, il padre invalido, il mondo contadino di Nimis con la sua lingua non esportabile, il terremoto del’76, gli studi a Padova e il trasferimento in una Milano proletaria e indifferente, la malattia autoimmune che si aggraverà nel corso di tutta l’esistenza per evolvere poi in sclerosi e infine nell’ictus che lo costringe oggi a una vita dimidiata, solitaria, impossibilitata a esprimersi: motivi sufficienti a spiegare «l’energia fredda e compressa e mista di intransigenza» di questo autore, i «sentimenti di inadeguatezza, inappartenenza e precarietà», la «durezza» e lo «smarrimento» di cui parlano i suoi commentatori.
In un’intervista radiofonica del 2012, Mario Benedetti diceva di sé «Sono nato malato… anche da bambino… avevo sempre qualcosa»: ma la sua pare al lettore una malattia più dell’anima che del corpo, l’impossibilità di adattarsi al reale, il sentirsi eternamente fuori luogo, in uno stato di perenne provvisorietà.
Se leggiamo le poesie tratte da Umana gloria (quale gloria, c’è da chiedersi, se non quella sconfortata e avvilita della pura sopravvivenza), troviamo ripetuto il simbolo del muro: scrostato, “strappato”, che più che a proteggere serve a rinchiudere, a limitare, a imprigionare. Intorno, erbe, sassi, campi da dissodare, la fatica di un lavoro pesante e senza parole. L’infanzia, regno mitico del ricordo, è malinconia e stupore, un domandarsi impauriti perché si è sulla terra, a fare cosa e come, maldestri nei gesti e nell’espressione: «non so come dire», «Dove sono? / io dove sono?», «perché sono qualcuno?», «Servirebbe guardare da lontano, pensare che si guarda. / Pieno un pomeriggio di dormiveglia voglio stare», «Mattine senza sapere di essere in un posto, dentro una vita / che sta sempre lì». Le persone si muovono con lentezza e rassegnazione; sono i nonni, i genitori, il fratello, e altre comparse di cui si citano i nomi, tanti nomi paesani oggi in disuso (Dino, Vanni, Agostino, Ernesta, Rina, Giacomino…) quasi fossero a disagio anche nel solo sentirsi chiamare.
Se il poeta si allontana dal paese per andare in altre città più grandi, o all’estero (la Bretagna e il mare del Nord tornano spesso, con i loro freddi) rimane comunque estraneo ai luoghi, confuso, in attesa di una identificazione che non arriva mai, senza alcuna volontà introspettiva o di scavo psicologico. Il lessico semplicissimo, lo stile volutamente dimesso, la sintassi sconvolta, con frequenti anacoluti e tautologie, sembrano voler sottolineare l’incapacità di adeguarsi alle aspettative di chi legge.
Questa volontà spiazzante e provocatoria della lingua è tanto più evidente in Pitture nere su carta, in cui Benedetti approda a una scrittura sincopata, scarnificata, quasi celaniana, che denuncia l’assurdità del vivere, poiché è la morte che alla fine vince, e tutto si dissolve nel turbinoso rincorrersi di anni, secoli, millenni, di cui solo i musei, i cimiteri e i reliquari manterranno testimonianza: «Ma nessuno è qualcuno, niente la notte, nessun mattino», «Infinite mattine, infinite notti. / Va dolce il nulla, // il dolcissimo nulla», «Non l’ascolto, sta la veglia, senza. / Carriole di muri, non raccontate». Il verso diventa balbettio, chiede soccorso a termini stranieri, alla pittura di Goya, di Cézanne, di Mondrian, alla storia e alla preistoria, alla teologia: «Rinnegato il canto. / Gli altari. / Perché tutti possano udire».
La riflessione sul tempo cede il passo, nell’ultima raccolta Tersa morte, al pensiero ossessivo della morte, al disfacimento dei corpi che diventano ossa, teschi, putridume, assediati in ospedali e case di riposo, tra personale impaziente, cateteri, diarree. Il poeta, o il suo sosia (poiché non è lui davvero che fa visita al padre, alla madre malati, agonizzanti: il dolore lo costringe a uscire da sé, a costruirsi una controfigura), si muove come sonnambulo, in una incomunicabilità totale con gli altri per pudore e vergogna della propria fisicità, aspettando una liberazione o una condanna: «Morire e non c’è nulla vivere e non c’è nulla, mi toglie le parole», «Il gas dei corpi, / i vestiti smangiati, i femori, / le mascelle, i denti, il loro sorriso, / il bacio dei denti, senza labbra», «Non è valsa la pena affaccendarsi».
Siamo sostituibili, irrilevanti, e nemmeno la poesia ci salva, come ammoniscono questi versi testamentari e purtroppo profetici: «Non saprai di essere morto, / non sarai, quel nulla che nella vita diciamo / non sarai, non ci sarai più, non saprai di te. / Perfetta assenza. Non distrarti, non eludere / la pura inconcepibile assenza, non distrarti», «Ma io nella mia vita non ho scritto nessuna poesia, / io nella mia vita non ho letto nessuna poesia. / E questa nessuno l’ha scritta, nessuno l’ha letta».
https://www.nazioneindiana.com/2018/01/12/poeti-appartati-mario-benedetti/

Poesia di Giovanni Pascoli
I Gattici
E vi rivedo, o gattici d’argento,
brulli in questa giornata sementina:
e pigra ancor la nebbia mattutina :
sfuma dorata intorno ogni sarmento.
Già vi schiudea le gemme questo vento
che queste foglie gialle ora mulina;
e io che al tempo allor gridai, Cammina,
ora gocciare il pianto in cuor mi sento.
Ora le nevi inerti sopra i monti,
e le squallide piogge, e le lunghe ire
del rovaio che a notte urta le porte,
e i brevi dì che paiono tramonti
infiniti, e il vanire e lo sfiorire,
e i crisantemi., il fiore della morte.
https://www.poesie.reportonline.it/poesie-di-giovanni-pascoli/poesia-di-giovanni-pascoli-i-gattici.html
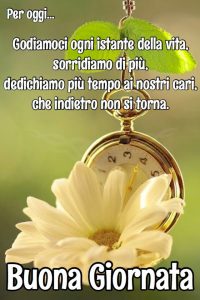
 https://it.wikiquote.org/wiki/Proverbi_friulani
https://it.wikiquote.org/wiki/Proverbi_friulani