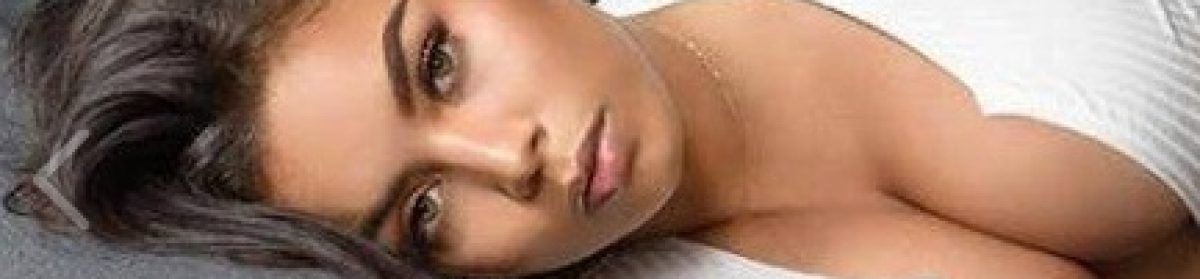Categoria: Cultura
5.7.1946, nasce il bikini a Parigi

Viva lo studio

Tra i libri


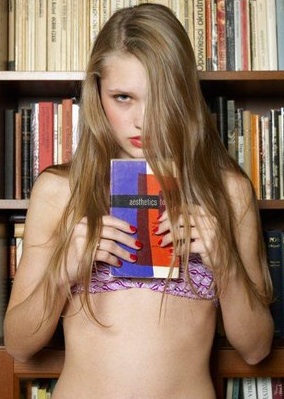
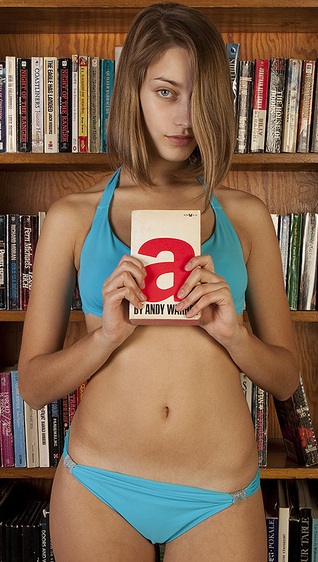
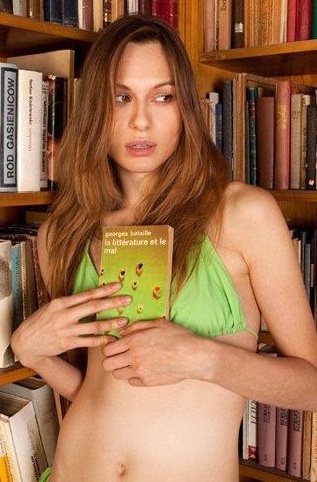
Dalla Francia
 Foto di www.over-blog.com.
Foto di www.over-blog.com.
Leggere comodi
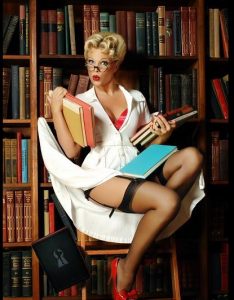
London Breed sindaca a San Francisco


London Breed, 43 anni, è stata eletta sindaca a San Francisco, è la prima sindaca “black” della città, leggiamo nel “Corriere della Sera” di stamani. Dove si racconta che è cresciuta nel ghetto.

Amore come malattia, fissazione politica

Faccio seguito alla mia lettera del 27 marzo, "Amore come malattia, la colpa è di Catullo". Era d’accordo anche Baldassar Castiglione (1478-1529): il suo "Cortegiano" dovrebbe pensare soltanto all’amor platonico perché quello sensuale provoca "continue lacrime e sospiri", come aveva già dimostrato Ovidio ("Ars Amatoria").
Al Cortegiano, Castiglione suggerisce di non aver un aspetto "molle e femminile" simile a quello delle più lascive e disoneste donne del mondo, con i capelli arricciati e le ciglia spelate.
Ovidio è il maestro da cui Castiglione riprende il tema: "Stieno lungi da noi i giovani adorni come femmine. Parcamente deve adornarsi la forma dell’uomo". Ma Ovidio distingueva fanciulle tenuta alla castità e quelle "a cui la legge e la condizione sociale permettono di poter apprendere" i suoi precetti d’amore, come si legge nella "Storia erotica d’Italia" di Cinzia Giorgio (2014).
In questo testo si ricorda che Ovidio pagò cara l’esortazione alla libertà ed all’amore: Augusto non volle graziarlo (lo aveva condannato all’esilio sul Mar Nero, nell’attuale Costanza in Romania), perché egli "aveva descritto l’élite romana come prigioniera nella gabbia dorata del principato, e tutta presa da giochi artistici ed erotici".
Se l’amore è una malattia, anche la politica lo è lungo la Storia perché nega il libero pensiero.
Lontano da Ovidio, papa Pio II da giovane aveva avuto due figli: da una donna maritata in Germania ed un altro in Scozia. Pio II fu colui che accusò il nostro Sigismondo dei Malatesti di aver ripudiato la prima moglie, avvelenata la seconda, strangolata la terza.
Jeanne C. Granese
Rimini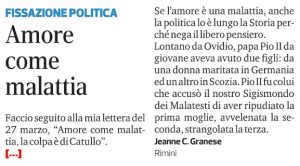
Lettera pubblicata sul “Corriere Romagna” il 4 maggio 2018
Amore come malattia
Amore come malattia,
la colpa è di Catullo

La Formula dell’Amore come malattia è vecchia come il mondo. Una delle più celebri voci della poesia antica, Catullo (87-54 a. C.), la ripropone (Carme 51, vv. 9-13), riprendendola da Saffo (Ode 31).
Nel 1895 Giovanni Pascoli, citando gli endecasillabi derivati da Saffo, riporta un giudizio di Plinio il Giovine, riassumibile in una formula breve ma efficace: “amamus, dolemus”.
Quanto pesi in questa enunciazione (che da poetica si fa filosofica) l’esperienza di vita di Catullo stesso, ce lo spiega ancora Pascoli: “La sua poesia è ‘vita’ descritta, e la vita ha vicino il sorriso alla lagrima e il sogghigno al dolore”, come appunto riassume Plinio con quel suo “amamus, dolemus”.
Catullo però cerca di superare questa condizione, come quando all’inizio del Carme 51 grida “Vivamus, mea Lesbia, atque amemus”, “dobbiamo vivere ed amare, senza tener conto delle proteste dei vecchi severi, e dammi mille baci, e poi cento, e poi ancora mille ed altri cento”, senza contarli però, perché nessun malvagio porti male sapendo quanti sono stati i nostri baci.
Oggi qualche psicanalista potrebbe suggerire che la terapia del bacio suggerita da Catullo, è il vero tema dell’amore come malattia.
(Le citazioni riportate sono riprese dai “Canti” di Catullo curati da A. Traina, Milano, edd. 1982 e 2016.)
In epoche successive il tema si sviluppa con variazioni che, ignorando tutto quanto la scienza dimostra circa la psicologia femminile, riducono la donna ad immagine negativa e persino ripugnante.
Jeanne C. Granese
Rimini
Pubblicata su “Corriere Romagna”, 27 marzo 2018

Visitate il mio sito

Visitate il mio sito, a questo indirizzo.