Universo personaPedagogia clinica & dintorni |
“Ogni persona brilla con luce propria fra tutte le altre. Non ci sono due fuochi uguali, ci sono fuochi grandi, fuochi piccoli e fuochi di ogni colore. Ci sono persone di un fuoco sereno, che non sente neanche il vento, e persone di un fuoco pazzesco, che riempie l´aria di scintille. Alcuni fuochi, fuochi sciocchi, né illuminano né bruciano, ma altri si infiammano con tanta forza che non si puó guardarli senza esserne colpiti, e chi si avvicina si accende”.
(Eduardo Galeano)

AMBITI DI INTERVENTO
L’intervento di aiuto per soggetti in età pre-scolastica e scolastica trova orientamento a seguito di un percorso diagnostico ed è rivolto alle abilità: espressivo/elocutorie, organizzativo/motorie,
comunicativo/relazionali
e apprenditive.
In accodo con la famiglia è previsto un coordinamento tra il pedagogista clinico e la scuola al fine di favorire un’utile integrazione tra l’intervento di aiuto dello specialista e l’iter educativo scolastico.
L’intervento di aiuto a favore di singoli adulti viene garantito da una diagnosi e dalla scelta di tecniche appropriate e armonizzate in modo flessibile, capaci di sostetare la scoperta, la conoscenza e l’accettazione di sé, placare le tensioni, mantenere vivo l’equilibrio delle emozioni, assumere una ritrovata fiducia, muoversi positivamente verso gli obiettivi desiderati. Interventi che predispongono ad andare oltre il disagio fino a modificare positivamente le abitudini, le regole di vita e il comportamento.
Le coppie e i gruppi trovano nelle diverse tecniche e modalità di utilizzo, occasioni importanti per uscire dal disordine e dal caos, conoscere e affrontare i rischi e le delusioni esistenziali. Ogni singolo ha l’opportunità di attingere alla propria fonte viva di significati e di risorse per acquisire un adeguato stile relazionale e comunicativo.
Altri interventi di aiuto condotti dal pedagogista clinico sono rivolti:
× all’orientamento scolastico
× alla formulazione di itinerari educativi di aggiornamento e formazione per il personale delle scuole e per gli educatori presenti in enti pubblici e privati
× al sostegno alla genitorialità.

PRESENTAZIONE DELLA PROFESSIONE.
METODI
Educromo, per il recupero della capacità di lettura; Writing Codex, per la codifica scrittoria; Eucalculia, per il potenziamento delle abilità logico- matematiche; Edumovment, per lo sviluppo delle potenzialità organizzativo-motorie; InterArt, per lo sviluppo della creatività; Body Work, Trust System, DiscoverProject, TouchBall per favorire la conoscenza e la coscienza topografico-corporea; Musicopedagogia, per il potenziamento delle capacità comunicative e interazionali; Memory Power Improvement (MPI), per lo sviluppo dell’attentività e della mnesi;
Bon Geste, per favorire abilità grafo-gestuali; Training Induttivo (TI), metodo di rilassamento per fronteggiare gli stati di disagio psi-fisico; Metodo Ritmo-Fonico, Coreografia Fonetica, Vibro Vocale, per lo sviluppo delle espressività e della comunicazione orale; Metodo Self, per il risveglio delle abilità nell’autonomia e coscienza di sé; Metodo Feeding, per migliorare la funzione masticatoria; Reflecting, per favorire lo sviluppo del sé; Semiotica Senso-percettiva, per facilitare l’interazione; PsicoFiabe, per stimolare l’immaginazione; Cyberclinica, PictureFantasmagory, ClinicalMentalPicture per favorire rinforzi ergici e nuove disponibilità al rapporto.
CONTATTA L'AUTORE
|
Nickname: pedagogista72
|
|
|
|
Età: 51 Prov: CZ |
MENU
AREA PERSONALE
I MIEI LINK PREFERITI
EFFETTI PERSONALI
| « NOVEMBRE 2011 | Educare alla creatività » |
|
E’ auspicabile considerare l’interdisciplinarità in relazione all’unità del sapere sia sotto l'aspetto oggettivo che soggettivo. Sotto l'aspetto oggettivo, essa rimanda a quello che Agazzi definisce “senso comune”, inteso non come doxa, disgiunta dalla ricerca della verità, ma come condizione originaria della visione del mondo. E’ la posizione dell’immediato che si dona, della realtà umana e scientifica quale esperienza unitaria, manifesta ai nostri occhi. Esiste una realtà totale alla quale si può fare riferimento come oggetto possibile di tutti i vari punti di vista parziali o settoriali. D’altra parte è da tener presente, ed è qui il secondo fondamento dell’interdisciplinarità, forse ancora più importante, un’unità soggettiva del sapere, essendo tutte le varie scienze niente altro che il prodotto di un’unica attività dell'intelletto umano.
A tale scopo, però, si sono verificate settorializzazioni e, con l’aumentare dei punti di vista disciplinari, in alcuni casi, separazioni degli ambiti di approfondimento. Si è cominciata a sentire, per questo motivo, l'esigenza di ricomporre la totalità delle conoscenze analitiche e di riconquistare nell’interdisciplinarità quell'unitarietà del sapere che è l'unica forma capace di soddisfare l'esigenza di comprensione della realtà nella sua totalità. Nella ricerca scientifica, accanto alla sempre più accentuata diffusione dei settori specialistici, è così emersa contemporaneamente l'esigenza di comunicare e di integrare i diversi campi del sapere, al fine di avere una visione unitaria e comprensiva dei problemi analizzati dai molteplici punti di vista disciplinari, nonché di mantenere ferma la concezione integrale della persona. Per soddisfare tale ultima prospettiva, è necessaria una paideia unitaria di riferimento, in quanto in essa è possibile configurare la condizione dell’unità dell’esperienza, nonché il senso comune, declinato dall’apprendimento in categorizzazioni, classificazioni, concetti generali, codificazioni linguistiche, concezioni metafisiche, tali da produrre una reale comprensione del mondo. L’immagine scientifica della realtà, in quanto intrinsecamente ad essa collegata, a partire dallo stesso atto costitutivo, si coniuga così con una dimensione filosofica e metafisica. Il presupposto perché si persegua realmente un apprendimento interdisciplinare consiste nel riconoscimento di una pari dignità alle discipline e alle competenze specialistiche, tutte ugualmente importanti, necessarie per affrontare un problema nelle sue diverse sfaccettature, essenziali per rintracciare possibili interazioni di assunti e di metodologie. Nella scuola, il discorso affrontato sull'interdisciplinarità e sul suo fondamento, genera l’esigenza di superare la tradizionale autosufficienza dell’insegnamento disciplinare, che, se non procede mediante una comunicazione e un’integrazione tra gli ambiti di riferimento, ostacola la formazione integrale della persona, e determina una frantumazione di quel mondo e di quella realtà, che la mente in sviluppo intende conoscere, comprendere, interpretare nella sua interezza. Sul piano dell'apprendimento, cioè, l'interdisciplinarità si pone come esigenza di ricomporre in senso comprensivo ed intersettoriale i contenuti di apprendimento e di esperienza dell'alunno. La misura dell’efficacia formativa di una scuola, ravvisa il prof. Bertagna, si traduce non nella quantità dell’offerta, ma nella qualità della stessa, perseguita attraverso l’interconnessione tra le discipline che la compongono e la costituzione di una “rete” di apporti, tale da comportare un superamento di settorialismi. L’apprendimento interdisciplinare del sapere, perseguito in forma problematica e laboratoriale, comporta la generazione di un approccio critico e costruttivo nel soggetto, una visione e una comprensione nel contempo multifattoriale e unitaria della realtà e dell’uomo, in cui le varie discipline costituiscono i tasselli di un percorso integrato. |
https://blog.libero.it/miriamcomito/trackback.php?msg=10836517
I blog che hanno inviato un Trackback a questo messaggio:
|
|
|
|
INFO
BENVENUTO/A NEL MIO BLOG!!!
Ciao a tutti, sono l'autrice di questo blog. Dal giugno 2010, oltre ad essere una maestra di Scuola Primaria, sono diventata un Pedagogista Clinico. Mi sono specializzata con un corso post-laurea promosso dall’ I. S. F. A. R. di Firenze e ho pensato di utilizzare un canale web per far conoscere e valorizzare le mie iniziative nell’ambito dell’aiuto alla persona, cui l’intervento pedagogico clinico è rivolto. Il mio primo lavoro è quello dell’insegnamento, quindi proporrò soprattutto dei progetti indirizzati a soggetti in età scolare, ma ciò non toglie che è mio intento rendere nota questa professione e la validità dei suoi metodi anche in altri ambiti d’intervento e per tutte le età. Ho usato l’espressione “pedagogia clinica & dintorni” in quanto questo contenitore multimediale accoglierà contributi di altra natura, che appartengono alle attività e interessi di chi scrive e che comunque sarà facile distinguere da quanto è strettamente attinente alla professione del pedagogista clinico.
Agli amici, conoscenti e visitatori che a vario titolo contribuiscono ad arricchire questo blog con la loro presenza:

FORMAZIONE PERSONALE
- Laurea in Pedagogia (Università di Messina)
- Specializzazione in Pedagogia Clinica (ISFAR di Firenze)
- Master di II livello in Dirigenza Scolastica (UNICAL)
- Master di II livello in "Dislessia e DSA in ambito scolastico" (UNICAL)
- Insegnante a T.I. nella Scuola dell'Infanzia dal 2002 al 2004
- Insegnante a T.I. nella Scuola Primaria dal 2004 in poi
- Competenze informatiche:ECDL e LIM
- Corsi di aggiornamento, laboratori, attività e progetti vari nelle scuole pubbliche.

LA PEDAGOGIA CLINICA
La pedagogia clinica ha come compiti lo studio, l’approfondimento e l’innovazione nel campo pedagogico, in riferimento a modalità diagnostiche e metodi educativi, volti ad aiutare non solo il singolo individuo, ma anche il gruppo con percorsi di superamento di ogni forma di disagio psicofisico e socio-relazionale. Superando ogni visione miope dell’essere, tale scienza ha fatto della Persona il suo presupposto: l’uomo è considerato nella sua interezza, nella sua complessità, in una visione che è olistica. L’ottica di un’educazione permanente, inoltre, fa considerare ogni individuo in continua evoluzione, dalla nascita alla morte, quindi passibile di rinnovamento e creativi sviluppi di sé e dei propri vissuti. Le persone coinvolte nell’aiuto pedagogico clinico, sia esso rivolto al singolo o al gruppo, sono accompagnate nel raggiungimento di nuovi equilibri e di una rinnovata disponibilità allo scambio con gli altri e con l’ambiente.
PROPOSTA

Seleziona il TAG “AGORÀ”:
troverai spazi sempre aperti
di confronto “circolare”.
ULTIMI COMMENTI
Inviato da: pedagogista72
il 26/11/2013 alle 19:08
Inviato da: luca.manu1989
il 25/11/2013 alle 15:26
Inviato da: delegoinme
il 08/07/2013 alle 12:17
Inviato da: delegoinme
il 10/05/2013 alle 21:28
Inviato da: pedagogista72
il 10/05/2013 alle 17:19
CERCA IN QUESTO BLOG
CHI PUò SCRIVERE SUL BLOG
I messaggi e i commenti sono moderati dall'autore del blog, verranno verificati e pubblicati a sua discrezione.
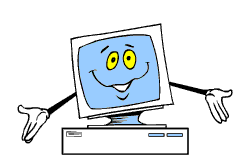

 La specializzazione delle scienze corrisponde all’esigenza di una migliore e più completa comprensione della realtà che, col progredire degli studi, si è andata rivelando sempre più complessa ed articolata.
La specializzazione delle scienze corrisponde all’esigenza di una migliore e più completa comprensione della realtà che, col progredire degli studi, si è andata rivelando sempre più complessa ed articolata. 
