Gennaio 2019: Tim Buckley – STARSAILOR (1970)
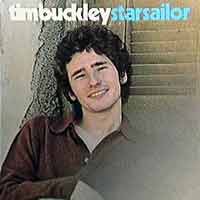
Data di pubblicazione: Novembre 1970
Registrato a: Whitney Studios (Glendale)
Produttore: Tim Buckley
Formazione: Tim Buckley (voce, chitarra 12 corde), John Balkin (basso), Lee Underwood (chitarra, piano, organo), Buzz Gardner (tromba), Maury Baker (percussioni), Bunk Gardner (flauto, sassofono)
Tracklist
Come here woman
I woke up
Monterey
Moulin Rouge
Song to the siren
Jungle fire
Starsailor
The Healing Festival
Down by the Borderline
“Sto muovendo oltre e probabilmente sarà molto, molto più in là di quello che la gente si aspetta. Ma so dove sto andando, verso la strada”
(Tim Buckley)
Storia triste quella della famiglia Buckey, baciata dal genio, ma anche dalla sciagura. Storia triste il pensare che di padre in figlio, quel talento tanto genuino, quanto squisitamente umano, tremendamente umano, di una dolcezza così delicata, fragile, si fosse tramandato quasi come una sorta di testamento biologico, potentemente impresso nella natura, nei geni. Entrambi avevano una voce che non si fatica a definirla angelica, ma nello stesso tempo tormentata dalla passione, dal dolore. Una voce talmente bella da sembrare quella di un messaggero di Dio!
Storia triste pensare che per il padre abbiamo abbiamo visto spezzare le ali della sua vita, prima ancora della sua arte, il primo il 29 giugno 1975 a causa di una sciagurata depressione e di alcune merdosissime sostanze, e dell’altro l’abbiamo viste annegare nelle torbide acque del Wolf River il 29 maggio 1997. E se Jeff ha poi subito beneficiato di una sorta di beatificazione post mortem, per suo padre invece tristemente lo avvolgerà l’oblio, tanto che per moltissimi anni i suoi bellissimi dischi saranno oggetto di culto degli appassionati. Segno che certe volte il destino è proprio bastardo!
Comunque la vedi la storia di Tim e Jeff Buckley, non si può non restare inondati da una sorta di tristezza, e pensare che in fondo avrebbero meritato di più. Ma forse alcune voci possono essere solo l’eco angelico di pochi eletti, e la cosa che ci rassicura è che la loro arte resta eterna, impressa nella storia e nell’anima.
Tim Buckley nacque Washington nel 1947. Fu indotto alla passione musicale dai suoi genitori, che avevano una verazione, la madre per Miles Davis, il padre per il country. A quasi dieci anni, la sua famiglia si trasferì in California. Qui ebbe la possibilità di iniziare a suonare il banjo, ma a causa di un incidente durante una partita di football, si fratturò le prime due dita della mano sinistra, che non tornarono mai più a posto, tant’è che da musicista lui non usava mai il barré, ma ricorreva all’uso degli accordi estesi. Durante il periodo della scuola ebbe la possibilità di mettere su un gruppo assieme a due suoi compagni, Larry Beckett (autore di alcune delle sue prime canzoni), e Jim Fiedler.
Nel 1966 Jac Holzman della Elektra Records lo mette sotto contratto, tanto da essere considerato una delle promesse più importanti della scena di Los Angeles. Qualcuno addirittura sostiene che Tim Buckley sarebbe stata una sorta di alternativa ai Doors (anch’essi sotto contatto con la Elektra), qualora questi avessero fallito nella loro impresa artistica. Purtroppo la storia ci dirà che col tempo sarà Tim ad avere uno spazio popolare molto meno vasto di quello di Jim Morrison e compagni!
Esordito con l’interlocutorio e ancora acerdo omonimo album del 1966, Tim Buckley comincerà a forgiare la sua arte visionaria, introducendo uno stile di canto decisamente nuovo, fatto di grida, gemiti, vocalizzi angelici e improvvisi sussulti nevrotici, dapprima con il più accessibile Goodbye and hello del 1967, poi entrando sempre più in un tunnel fatto di oscurità e viaggi interstellari, dove la melodia lascia spazio al dolore, la musica alla deviazione, alla fusione tra la psichedelia, il folk e il jazz, e le canzoni non sono qualcosa di realmente compiuto, ma esperimenti sempre in movimento. Scegliere uno dei suoi dischi che lo rappresenti, dal 1967 al 1970, è un’impresa davvero ardua da rasentare l’impossibile. Pertanto ci lasciamo ammaliare dall’aspra bellezza di Starsailor.
Reduce dal fallimento commerciale del complicato e bellissimo Lorca, Tim Buckley non tenta di raddrizzare il colpo e di rimettersi in carreggiata per seguire il successo, ma cerca di rimpere tutti gli orizzonti che gli si frappongono per il raggiungimento di una nuova forma del canto e della musica. Qualcosa che sia davvero oltre!
Si tende a scarnificare i brani fino all’osso, come se si volesse mettere a nudo l’anima, più che il corpo. Come se non bastasse mostrare le ferite, ma indagare nei profondi moti dell’anima, inseguire fantasmi e incubi che tormentano e non lasciano in pace. Non tenta di “piacere” il Tim Buckley di questo periodo, non è una rockstar, ma un poeta vero!
Sono le convulsioni di Come here woman che aprono Starsailor. Apre il dramma, non il romanticismo. L’istrionismo, non la quiete. Un senso di incompiutezza, ma nello stesso tempo un divenire in continua catarsi. I woke up si dipana invece elegiaco e stralunato, straziante, straziante. Mentre Monterey sembra aprire degli ingannevoli spazi di luce, quando invece è una sorta di jam elettrica, sulla quale la voce di Buckley improvvisa strilli e acuti lancinanti. Mouline Rouge è uno scherzetto che ha il compito di spezzare la densa depressione del disco, e introduce a Song to the siren, uno dei capolavori assoluti dei Tim Buckley, e uno dei pezzi più belli che mente umana potesse concepire! Una dolcissima melodia su un tappeto sonoro elettrico e sospeso. E quella voce che trapassa qualsiasi anima! Impossibile restarne estasiati!
L’arabesca Jungle fire si divide in due parti: una declamatoria e sospesa, l’altra spigolosa e movimentata. La tenebrosa title-track invece è un imponente esercizio vocale, una sorta di viaggio nel buio della mente, dove risuonano echi spaventosi e la speranza è annullata dalla disperazione. Pace non si riesce a scovare nemmeno nella caotica The Healing Festival, e si chiude con una Down by the Borderline, che viene aperto da una tromba squisitamente dolceamara.
Il disco ebbe poco successo, facendo ulteriormente naufragare il sogno di un ragazzo che avrebbe potuto essere un altro Dylan, un altro Morrison, un’altra celebrità insomma… Ma il paradosso sta tutto qui: saranno questi dischi che incendieranno la leggenda di uno dei più grandi artisti che abbiano calcato la scena del rock, tanto da rivoluzionarla in senso totale. E poco importa se il tentativo di recuperare terreno con Greeting from L.A. sarà un tiepido esercizio di stile, o se prima di lasciarci, il suo testamento discografico fu l’inglosioso Look at the fool. Poco impora davvero, perché la leggenda, la storia spesso passa anche attraverso il silenzio inglorioso, spesso non sente il bisogno di essere illuminata dai riflettori, spesso non vuole confondersi con la celebrità! E Tim Buckley, che celebrità non lo è mai stato, è un angelo che vivrà per sempre!
“Buckley fu per il canto ciò che Hendrix fu per la chitarra, Cecil Taylor per il piano e John Coltane per il sassofono”
(Lee Underwood)


