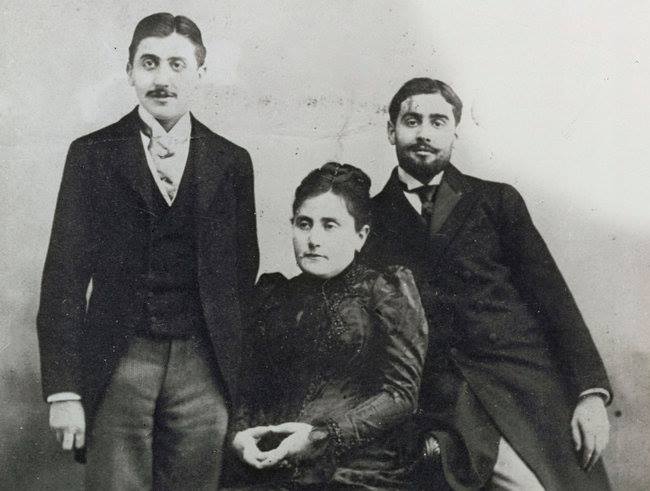Per tornare a Françoise, in vita mia non ho mai subìto un’umiliazione senza trovare sul suo volto, in anticipo, delle condoglianze bell’e pronte; e quando, nella rabbia scatenatami dalla sua compassione, mi ostinavo a pretendere d’aver invece riportato un successo, le mie menzogne andavano vanamente a frantumarsi contro un’incredulità rispettosa ma evidente e contro una ferma consapevolezza della propria infallibilità. Françoise, infatti, sapeva la verità; la taceva, e si limitava a fare un piccolo movimento con le labbra come se avesse la bocca piena e stesse finendo un buon boccone. La taceva, così, almeno, ho lungamente creduto, io che a quel tempo mi figuravo ancora che la verità si comunicasse agli altri con le parole. Anzi, le parole che mi venivano dette deponevano con tanta accuratezza il proprio inalterabile significato nella mia mente, nella mia sensibilità, da farmi escludere che qualcuno che m’avesse detto d’amarmi non m’amasse (…) Ma fu Françoise a insegnarmi, dandomene l’esempio (un esempio che avrei capito solo in seguito, quando di nuovo e più dolorosamente me l’avrebbe dato, come si vedrà negli ultimi volumi di quest’opera, una persona a me più cara), che, per manifestare la verità, non occorre esprimerla a parole, e che è forse possibile coglierla con maggiore certezza, senza aspettare le parole e senza tenerne alcun conto, in mille segni esteriori, persino in certi fenomeni invisibili, analoghi, nel mondo dei caratteri, a quel che sono, nella sfera fisica, i mutamenti atmosferici. (…) E fu lei, così, la prima a suggerirmi che, contrariamente a quanto avevo creduto, una persona non se ne sta davanti a noi limpida e immobile con le sue qualità, i suoi difetti, i suoi progetti, le intenzioni che nutre nei nostri confronti (come un giardino osservato aiola per aiola, attraverso una cancellata), ma è un’ombra in cui non ci è mai possibile penetrare, di cui non ci è data conoscenza diretta, intorno a cui ci formiamo numerose convinzioni fondate su parole e anche azioni che ci forniscono – sia le une che le altre – informazioni insufficienti e d’altronde contraddittorie, un’ombra dove possiamo di volta in volta immaginare, con lo stesso grado di verosimiglianza, il balenare dell’odio o dell’amore.
M. Proust, La parte di Guermantes I
Traduzione di G. Raboni per i Meridiani Mondadori
Versione originale:
Pour en revenir à Françoise, je n’ai jamais dans ma vie éprouvé une humiliation sans avoir trouvé d’avance sur le visage de Françoise des condoléances toutes prêtes; et lorsque dans ma colère d’être plaint par elle, je tentais de prétendre avoir au contraire remporté un succès, mes mensonges venaient inutilement se briser à son incrédulité respectueuse mais visible et à la conscience qu’elle avait de son infaillibilité. Car elle savait la vérité; elle la taisait et faisait seulement un petit mouvement des lèvres comme si elle avait encore la bouche pleine et finissait un bon morceau. Elle la taisait? Du moins je l’ai cru longtemps, car à cette époque-là je me figurais encore que c’était au moyen de paroles qu’on apprend aux autres la vérité. Même les paroles qu’on me disait déposaient si bien leur signification inaltérable dans mon esprit sensible, que je ne croyais pas plus possible que quelqu’un qui m’avait dit m’aimer ne m’aimât pas (…)
Et ainsi ce fut elle qui la première me donna l’idée qu’une personne n’est pas, comme j’avais cru, claire et immobile devant nous avec ses qualités, ses défauts, ses projets, ses intentions à notre égard (comme un jardin qu’on regarde, avec toutes ses plates-bandes, à travers une grille), mais est une ombre où nous ne pouvons jamais pénétrer, pour laquelle il n’existe pas de connaissance directe, au sujet de quoi nous nous faisons des croyances nombreuses à l’aide de paroles et même d’actions, lesquelles les unes et les autres ne nous donnent que des renseignements insuffisants et d’ailleurs contradictoires, une ombre où nous pouvons tour à tour imaginer, avec autant de vraisemblance, que brillent la haine et l’amour.
E per tornare al primo volume:
E come l’imenottero studiato da Fabre, la vespa scarificatrice, che per assicurare ai piccoli, dopo la sua morte, della carne fresca da mangiare, chiama l’anatomia in aiuto della crudeltà e, catturato qualche ragno o punteruolo, gli trafigge con una sapienza e un’abilità meravigliosa il centro nervoso da cui dipende il movimento delle zampe, ma non le altre funzioni vitali, in modo che l’insetto paralizzato, accanto al quale depone le proprie uova, fornisca alle larve, quando si schiuderanno, una preda docile, inoffensiva, incapace di fuga o di resistenza, ma non ancora frollata, Franҫoise escogitava, per assecondare la sua pervicace volontà di rendere la casa insostenibile da parte di qualsiasi domestico, degli accorgimenti così sottili e così spietati che, parecchi anni dopo scoprimmo che se quell’estate avevamo mangiato asparagi quasi quotidianamente, era stato perché il loro odore provocava alla povera sguattera incaricata di pulirli delle crisi d’asma d’una violenza tale che, alla fine fu, costretta ad andarsene.
Dalla parte di Swann