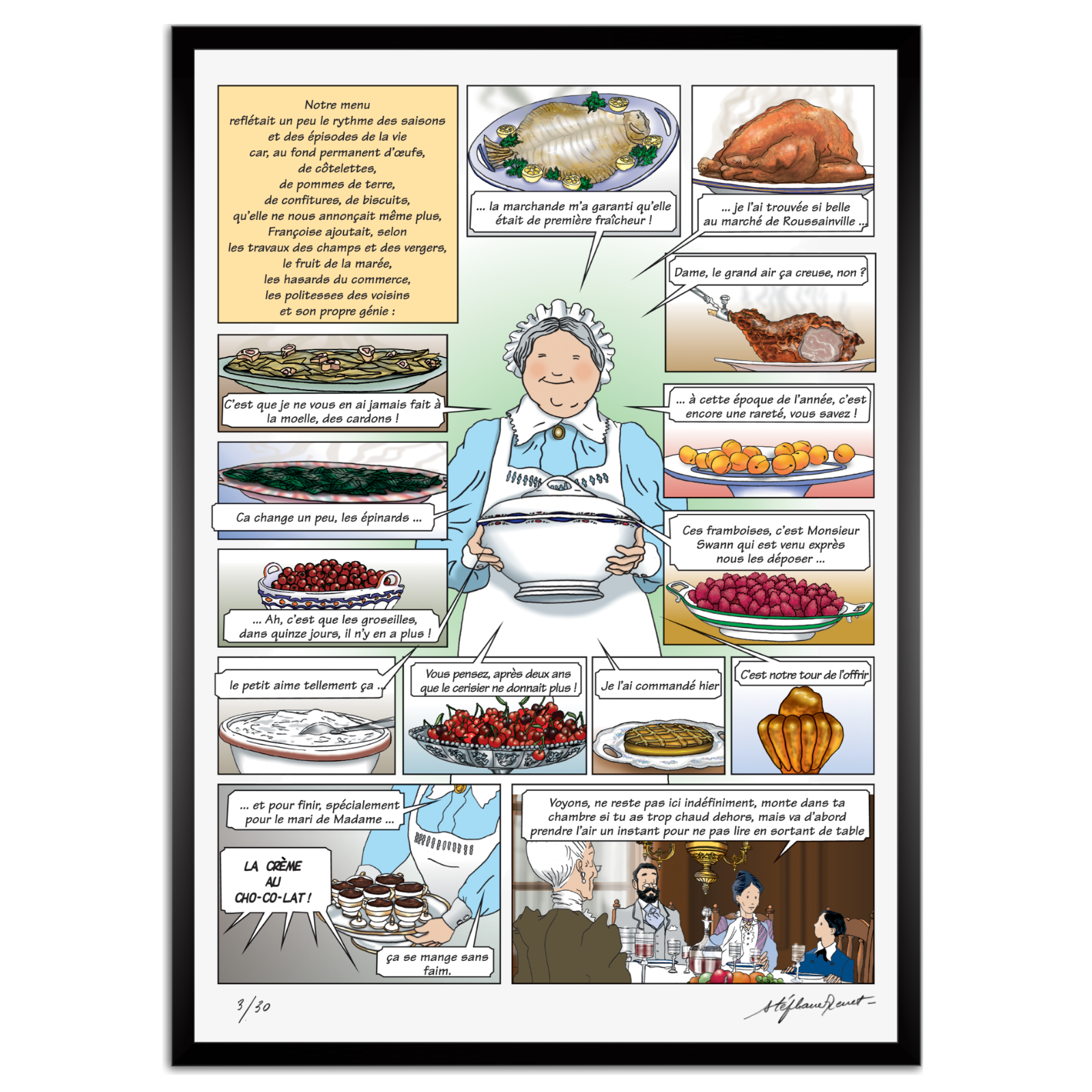Durante i quindici giorni che durò la sua ultima malattia, Françoise non la abbandonò un istante, non si spogliò mai, non permise a nessun altro di prestarle qualche cura, e non lasciò il suo corpo che quando fu sepolto. Allora ci apparve chiaro che quella sorta di timore, nel quale Françoise era vissuta, delle cattive parole, dei sospetti, delle collere di mia zia aveva sviluppato in lei un sentimento che avevamo scambiato per odio e che era invece venerazione e amore. La sua padrona vera, la padrona dalle decisioni impossibili a prevedersi, dalle astuzie difficili da eludere, dal buon cuore facile da piegare, la sua sovrana, la sua monarca misteriosa e onnipotente non c’era più. Al suo confronto, noi contavamo ben poco. Era lontano il tempo (quando avevamo cominciato a venire a Combray, per le vacanze) in cui agli occhi di Françoise, uguagliavamo in prestigio la zia. Quell’autunno, interamente assorbiti dalle formalità da sbrigare, dagli incontri con i notai e con i fattori, i miei genitori, non avendo la possibilità di fare delle gite che d’altronde il tempo non favoriva, presero l’abitudine di lasciarmi andare a passeggiare senza di loro dalla parte di Méséglise, avvolto in un grande plaid che mi proteggeva dalla pioggia e che io mi gettavo tanto più volentieri sulle spalle quanto più percepivo che il suo disegno scozzese scandalizzava Françoise, nella cui testa era impossibile inculcare l’idea che il colore dei vestiti non ha nulla a che vedere con il lutto e alla quale, per altro, il dispiacere che noi provavamo per la morte della zia era poco gradito dal momento che non avevamo offerto nessun banchetto funebre, non assumevamo un tono di voce speciale per parlare di lei e io, a volte, addirittura canterellavo. Sono sicuro che in un libro – sotto questo profilo ero anch’io come Françoise – una simile concezione del lutto, derivata dalla Chanson de Roland e dal portale di Saint-André-des-Champs, avrebbe suscitato la mia simpatia. Ma dato che Françoise mi era vicina, un demone mi spingeva a desiderare che fosse in collera, coglievo ogni pretesto per dirle che rimpiangevo mia zia perché era una buona donna, malgrado le sue fisime ridicole, ma assolutamente non perché era mia zia, che avrebbe potuto essere mia zia e risultarmi odiosa, e la sua morte non provocarmi alcuna sofferenza, tutti discorsi che in un libro mi sarebbero sembrati insulsi. Se Françoise, traboccante come un poeta d’un flusso di pensieri confusi sul dolore, sui ricordi di famiglia, si scusava allora di non saper rispondere alle mie teorie e diceva: “Non so esprimermi”, io trionfavo di quell’ammissione con un buonsenso ironico e brutale degno del dottor Percepied; e se lei aggiungeva: “Però era sempre della parentela, resta comunque il rispetto che si deve alla parentela”, io scrollavo le spalle e pensavo: “Sono troppo buono a mettermi a discutere con un’analfabeta che fa degli svarioni simili”, adottando così, per giudicare Françoise, il meschino punto di vista di quella gente di cui gli stessi che più la disprezzano nell’imparzialità della riflessione sono poi capacissimi di assumere la parte quando devono recitare in una della scene volgari della vita.
[Marcel Proust, Alla Ricerca del tempo perduto, Dalla parte di Swann, traduzione di Giovanni Raboni, I Meridiani Mondadori ] pp. 186-187-188