Cavalieri Templari
"Non nobis Domini, non nobis, sed nomini Tuo da gloriam"
“Se il fine è giusto non può essere sbagliata la lotta”

"M' interessa poco essere giudicato da quelli che chiamano bene il male e male il bene,
che fanno tenebre della luce e luce delle tenebre"
“E’ grande chi, colpito dalla sventura, non perde neanche un poco la sapienza, non meno grande è chi, baciato dalla fortuna, non se ne lascia illudere. Ma è più facile trovare chi ha saputo conservare la sapienza nella sfortuna, che chi non la perse nella buona sorte"

Amare il corpo
a causa dell’anima,
l’anima a causa di Dio,
ma Dio per sé stesso
AREA PERSONALE
MENU
I MIEI BLOG AMICI

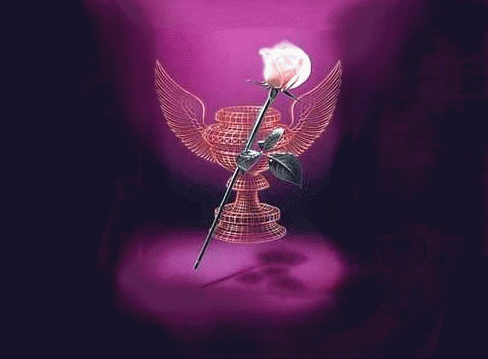

|
Post n°9 pubblicato il 16 Novembre 2009 da jacquesdemolay1118
Impossibile stabilire con precisione il numero degli uomini armati e dei pellegrini che presero la croce e seguirono l'appello del Papa; le cifre riportate dalle cronache del tempo sono sempre largamente arrotondate per eccesso e difficilmente credibili. Lo storico Steven Runcimann stima che, tra l'estate 1096 e la primavera dell'anno seguente, entrarono nell'Impero d'Oriente tra le sessanta e le centomila persone dirette alla Terra Santa, pellegrini compresi. Circa ventimila sarebbero stati i seguaci di Pietro l'Eremita, combattenti e non, e di circa diecimila unità erano composti gli eserciti di Goffredo di Lorena, di Raimondo di Tolosa e quello dei Francesi del Nord. Le armate di Goffredo e di Raimondo IV di Tolosa erano forse le più numerose, ma i Normanni di Boemondo e gli uomini del Conte di Fiandra erano di qualità superiore e meglio addestrati. Più che veri eserciti nel senso stretto, i principi della Crociata guidavano delle coalizioni d'uomini d'arme legati da rapporti di parentela e vincoli di vassallaggio, nelle quali esisteva una guida cui fare riferimento, ma non un vero e proprio comandante supremo. Al termine di un'estenuante marcia di circa due anni, nei primi di giugno del 1099 l'armata giunse a Gerusalemme; durante il cammino, il numero dei Crucisegnati si era certamente ridotto a causa delle perdite in battaglia o per gli stenti e le fatiche del viaggio, oltre che per le defezioni di quanti scoraggiati e sfiduciati avevano abbandonato l'impresa, Secondo la cronaca di Raimondo d'Aguilers, le forze dei Crociati contavano ancora dodicimila fanti e milleduecento o milletrecento cavalieri. Falliti i primi tentativi d'assalto alle mura della Città Santa, i Crociati riuscirono, grazie all'arrivo nel porto di Giaffa d'alcune navi cristiane, ad ottenere il legname ed il materiale per costruire delle torri d'assedio. Seguendo le raccomandazioni impartite in sogno ad un prete pellegrino dal Vescovo Ademaro de Monteil (ormai morto ma sempre presente nell'animo dei molti che erano rimasti toccati dal suo prestigio e dal suo carisma), i Crociati osservarono un digiuno di tre giorni e l'8 luglio si mossero in processione, scalzi, lungo le mura della Città. Nella notte tra il 13 ed il 14 luglio iniziò l'assalto alle mura e nella tarda mattinata del 15 la torre d'assedio di Goffredo riuscì ad avvicinarsi tanto da permettere agli uomini di salire sulla cinta. Entrati in città i Crociati, esaltati dalla vittoria, si abbandonarono ad un massacro che non risparmiò nessuno; vecchi, donne, bambini e persino gli stessi Ebrei, accusati di aver aiutato i Musulmani, caddero travolti dalla furia degli assalitori. La Sinagoga, nella quale avevano trovato rifugio gli Ebrei, fu data alle fiamme, e nell'area del Tempio la carneficina fu talmente furiosa che, secondo il cronista Raimondo d'Aguilers, si camminava facendosi largo tra i cadaveri ed il sangue arrivava alle ginocchia. Non è possibile stabilire quante furono le vittime della strage operata dai vincitori, ma il suo ricordo pesò sempre in maniera drammatica sulla coscienza dei Cristiani. A differenza di questi, quando ottantotto anni dopo il Saladino riconquistò all'Islam la Città Santa, si comportò con clemenza, evitando ogni atteggiamento violento nei confronti della popolazione. "Liberata" Gerusalemme e sciolti dal loro voto, Roberto di Normandia e suo cugino il Conte di Fiandra, il valore dei quali era ampiamente apprezzato, rientrarono in Europa accompagnati dal fratello di Goffredo, Eustachio de Boulogne, evanescente figura di crociato svogliato e desideroso di tornare ai suoi possedimenti. Baldovino de Boulogne, nominatosi Conte d'Edessa, non prese parte alla conquista della Città Santa, così come Boemondo che dopo aver contribuito all'assedio ed alla presa d'Antiochia, rimase come Principe in quello che considerava ormai un suo possedimento. Il Conte Raimondo di Tolosa, offeso nei confronti di Goffredo e deluso di essere stato relegato in una posizione non di primo piano nel governo e nell'amministrazione della città, si ritirò per due anni a Costantinopoli; in seguito si ritagliò una contea in Libano intorno alla città di Tripoli. L'Advocatus Sancti Sepulchri, Goffredo di Lorena (Goffredo di Buglione), cavaliere coraggioso ma amministratore incapace, governò solo per un anno sulla Gerusalemme Cristiana, spegnendosi il 18 luglio del 1100. Secondo lo storico J. R. Smith non ci sarebbero prove certe che il titolo di Advocatus Sancti Sepulchri sia mai stato adottato da Goffredo, che si sarebbe fatto chiamare principe o Duca. Con la successione di Baldovino suo fratello, primo Re di Gerusalemme, nasceva il Regno, davanti al quale stavano circa due secoli di storia; la caduta degli ultimi possedimenti costieri nel 1291, pose fine all'epopea Crociata in Terra Santa. |
|
Post n°8 pubblicato il 15 Ottobre 2009 da jacquesdemolay1118
Riferendosi alla Prima Crociata spesso si pensa ad una spedizione militare ben organizzata, ad un esercito omogeneo di grandi proporzioni partito compatto dall'Europa Cristiana al seguito di Goffredo di Buglione, che dopo aver attraversato l'Asia Minore giunse a Gerusalemme, obiettivo designato della spedizione. La realtà storica differisce notevolmente da quest'immagine molto scolastica di un evento le cui conseguenze avrebbero inciso pesantemente nei rapporti con le popolazioni medio-orientali, accentuando il contrasto non solo con le religioni Islamica ed Ebraica, ma con gli stessi Cristiani d'Oriente. Una precisazione, doverosa, sulla prima di queste spedizioni militari che identifichiamo come "Crociate", (termine che fu utilizzato solo molto tardi quando, al meno quelle rivolte verso la Terra Santa, appartenevano già al passato), riguarda l'appello del Papa Urbano II al Concilio di Clermont, considerato il "bando" della Crociata, la chiamata alle armi della Chiesa. Non si conoscono con esattezza le parole che il Papa pronunciò in quell'occasione poiché le versioni tramandateci dai cronisti sono tutte successive d'alcuni anni, e più o meno tutte, sono state in parte influenzate dagli eventi e personalizzate. Quasi sicuramente l'appello, che non era direttamente rivolto alle masse del popolo, bensì ai nobili ed in particolare ai cadetti senza feudo, invitava a porre fine alle lotte tra Cristiani, invitando semmai a soccorrere i fratelli nella fede che in Oriente erano insidiati dalle forze dell'Islam. A causa delle norme del sistema feudale, che prevedevano il passaggio diretto delle proprietà dal padre al primogenito maschio, in Europa si andava definendo una generazione di nobili "esclusi" dall'eredità, in costante fermento e alla ricerca di un'identità nella quale riconoscersi. Questa schiera di figli di nobili natali, a parte quelli che prendevano la via monastica e clericale, erano costretti a mettersi al servizio di signori feudali, a volte degli stessi fratelli, vivendo in maniera un po' irrequieta e turbolenta questa loro condizione di nobili senza terra. Richiamando l'unità dei Cristiani e le difficoltà dei fratelli nella fede Bizantini, il Papa sperava di dirottare altrove le energie di questi "cavalieri erranti" (la cui immagine era molto distante da quella che la letteratura cortese avrebbe successivamente idealizzato), che rappresentavano per l'Europa cristiana una fonte di preoccupazione. Non è neanche certo che nel suo discorso il Papa indicasse Gerusalemme e la sua liberazione, come meta ed obiettivo d'eventuali iniziative belliche, poiché l'invito ad un impegno armato dei Cristiani d'Occidente, corrispondeva a quanto richiesto dagli ambasciatori dell'imperatore bizantino, che il Papa aveva incontrato poco prima del Concilio del novembre 1095, in pratica al reclutamento di soldati mercenari da impiegare per la difesa contro i Turchi. L'Imperatore sperava di ricevere truppe di cavalieri occidentali da affiancare al suo esercito, mentre dall'Europa arrivarono per prime masse indisciplinate d'uomini male armati con la spedizione di Pietro l'Eremita, e successivamente veri e propri eserciti, non meno disordinati e violenti di quelli della prima ondata (da rilevare che al confronto del mondo bizantino, i Crociati erano poco meno che dei barbari, e che 15 anni prima gli stessi Normanni dell'Italia del sud presenti tra le fila dei "crucesignati" avevano combattuto l'Impero). Tralasciando le spedizioni popolari e la così detta "Crociata dei pezzenti" guidata da Pierre d'Amiens ("l'Eremita" che incendiò gli animi raccogliendo intorno a sé una moltitudine di pellegrini che, insieme ad esiguo numero di cavalieri, finirono col farsi massacrare dai Turchi), la spedizione passata alla storia come Prima Crociata vide la mobilitazione d'armate affatto omogenee al seguito di grandi Principi dell'Europa Cristiana, accompagnate da masse di donne ed uomini del popolo, prevalentemente inermi ed impreparati ad una campagna militare. Allora (come oggi) far la guerra era un impegno economico e richiedeva una preparazione ed un equipaggiamento estranei alle classi più umili: era una sorta di "lusso" per i nobili, nella quale il popolo era coinvolto (di solito suo malgrado), per rinfoltire i ranghi della fanteria. E' quindi assai improbabile che il Papa, parlando al Concilio del 1095, si rivolgesse alle masse: l'appello era destinato a coloro che "potevano" rispondere ed erano in grado di sostenere un impegno militare, vale a dire i nobili. Non si può escludere che nelle intenzioni del Papa vi fossero due obiettivi importanti per la Cristianità Europea: da un lato ricucire i rapporti con la Chiesa Bizantina, dall'altro allontanare nobili e cavalieri irrequieti e scarsamente controllabili, elementi che rappresentavano un rischio per la pace. Tra coloro che risposero, con motivazioni soggettive diverse e con personalità molto differenti tra loro, principi della nobiltà Francese e Normanna, ma nessun Reale (il Re di Francia era scomunicato in quel periodo). |
|
Post n°7 pubblicato il 04 Ottobre 2009 da jacquesdemolay1118
L'idea delle Crociate nasce, molto verosimilmente, a causa di gravi atti di intolleranza religiosa subita dai pellegrini cristiani in Terrasanta. Atti che, tra l'altro, seguirono un lungo periodo di relativa pacifica accettazione dei pellegrini stessi. Il passo verso la brutalità fu segnato dalla conquista delle regioni d'oltremare da parte dei Turchi Selgiucidi, un primitivo popolo di razza mongola proveniente dall'est e di recente convertitosi all'islamismo. A gravi atti sanguinari sui pellegrini, i Turchi sommarono un regime di esosi dazi che resero impossibile l'accesso ai meno facoltosi. Uno tra i tanti atti di scelleratezza da parte dei turchi fu quello del 1065 quando 7.000 cristiani partiti in pellegrinaggio per la Terra Santa furono attaccati e assediati in una rocca. L'attentato provocò 5.000 morti. L'idea che le Crociate abbiano rappresentato una fonte di cospicui guadagni per chi vi partecipò è stata in parte smentita; al contrario, si trattò di operazioni molto dispendiose, sia in termini di costi diretti (sostentamento, equipaggiamento) sia per il mancato apporto produttivo a causa dell'assenza dai luoghi di vita e di lavoro di chi vi partecipò. Eppure queste imprese tanto pericolose - le estenuanti marce, lo spettro delle malattie o della morte in battaglia - quanto costose e scarsamente remunerative ebbero un forte richiamo sulla società del tempo. Per comprendere questa apparente contraddizione, bisogna innanzitutto ricordare che, in una società di credenti qual era l'Europa medievale, la partecipazione alla guerra contro gli infedeli era vista come garanzia di salvezza individuale; si trattava inoltre di una società fortemente militarizzata e dar prova di valore in battaglia era una delle principali ambizioni per un nobile. Su queste basi Papa Urbano II, eletto nel 1088, bandisce la Crociata nel corso del Concilio di Clermont, il 25 novembre 1095. Papa Urbano II espose il piano di una spedizione volta a liberare i Luoghi Santi esortando i fedeli presenti ad arruolarsi. Le adesioni furono numerose e perciò il papa dette mandato ai vescovi conciliari di procedere a nuovi arruolamenti nelle loro sedi originarie. Secondo la strategia da lui delineata, singoli gruppi di crociati, autofinanziati e guidati ciascuno da un proprio comandante, avrebbero dovuto partire per riunirsi a Costantinopoli, capitale dell'impero bizantino, nell'agosto del 1096; di lì avrebbero mosso l'attacco ai selgiuchidi conquistatori dell'Anatolia. I passi con cui Urbano destò il fervido entusiasmo religioso furono i seguenti: i Turchi avevano moltiplicato le guerre e gli eccidi occupando le terre dei cristiani sino ai confini della Romania uccidendo e rendendo schiavi gli uomini, rovinando le chiese, devastando il regno di Dio, giungendo fino al Mediterraneo, ossia al Bosforo. Il 15 agosto 1096 inizia ufficialmente, come nei piani di Urbano, la Prima Crociata. I primi a partire furono rispettivamente il conte Ugo di Vermandois e Goffredo di Buglione (da considerarsi il capo della spedizione). Nell'ottobre dello stesso anno partono il conte Raimondo IV di Tolosa, il principe Boemondo di Taranto, Baldovino di Fiandra e il duca Roberto di Normandia. Giunti a Costantinopoli tra il novembre 1096 e il maggio 1097, i crociati si impegnarono con un giuramento a restituire all'imperatore Alessio I Comneno i territori già appartenuti all'impero bizantino, via via che fossero stati liberati, in cambio del permesso al passaggio nei loro territori dell'esercito crociato. Nel giugno del 1097 Nicea, la capitale turca dell'Anatolia, si arrese non ai crociati, bensì ai bizantini. Poco tempo dopo, i crociati ottennero una decisiva vittoria sui turchi a Dorileo, aprendosi così la via verso l'Asia Minore. L'obiettivo seguente, Antiochia, nella Siria settentrionale, cadde dopo otto mesi di assedio, grazie alla tenacia di Boemondo, il 3 giugno 1098. Nel maggio 1099 i crociati raggiunsero i confini settentrionali della Palestina e la sera del 7 giugno si accamparono sotto le mura di Gerusalemme. La città, controllata dagli egiziani, si presentava ai crociati ben difesa, fortificata e attrezzata per resistere anche ad un lungo assedio. Con il sostegno di rinforzi venuti da Genova, i crociati diedero l'assalto a Gerusalemme il 5 luglio ed entrarono da conquistatori il 14 luglio 1099. Goffredo di Buglione, duca della Bassa Lorena, fu nominato governatore della città e in questa veste condusse l'ultima fase della campagna, sconfiggendo l'armata egiziana ritiratasi ad Ascolana. La prima vera spedizione in Terrasanta (una antecedente spedizione non organizzata militarmente, capeggiata da Pietro l'Eremita e definita la Crociata del popolo, si rivelò una strage di cristiani compiuta ad opera dei Turchi presso Nicea) fu quindi un vero e proprio trionfo per l'occidente: Gerusalemme era in mano cristiana, il sogno del Papa e quindi della cristianità era realtà, un'impresa incredibile era stata compiuta. In più erano state conquistate altri centri importanti (come Antiochia ed Edessa). |
|
Post n°6 pubblicato il 14 Settembre 2009 da jacquesdemolay1118
Uno dei miti più affascinanti e longevi di tutta la cultura dal Medioevo in poi è senza dubbio quello del Santo Graal. Le origini del mito si perdono nella storia: con tutta probabilità le leggende legate a "coppe" o "vasi sacri" erano già tramandate da lungo tempo per via orale da cantori, trovatori e menestrelli di corte, prima che lo scrittore Chretien de Troyes, alla fine del XII sec., lo inserisse in uno dei suoi romanzi, dando vita al cosiddetto "ciclo del Graal". Infatti, attorno al 1190 egli scrisse "Perceval le Gallois ou le Compte du Graal", ispirandosi alla ridda di leggende ed aneddoti preesistenti su coppe ed altri recipienti di carattere magico (di cui abbondava, ad esempio, la mitologia celtica: si pensi, ad esempio, al calderone magico di Bran). Nel romanzo, il cavaliere Parsifal, ospite nel castello del "Re Pescatore" Anfortas, assiste ad una strana processione in cui appare per la prima volta un mistico oggetto definito "Graal", realizzato in oro puro e tempestato di pietre preziose. L'etimologia della parola viene fatta derivare dal latino "gradalis", a sua volta desunto da un arcaico termine celtico che significa "calice". Fu solo successivamente, intorno al 1202, con "Le Roman de l'Estoire du Graal" di Robert de Boron, che il Graal assume una connotazione cristiana, essendo identificato come il calice utilizzato da Gesù durante l'Ultima Cena, nel quale successivamente Giuseppe di Arimatea raccolse il sangue di Gesù crocefisso. Questa caratteristica conferisce al calice delle straordinarie virtù, come quella di guarire ogni male ed, addirittura, di donare l'immortalità a colui che ne beve e, soprattutto, che ne sia degno. Secondo una delle leggende più diffuse, il primo detentore del Santo Graal fu Giuseppe di Arimatea. Quest'uomo era un ricco ebreo, membro del Sinedrio, del quale non aveva condiviso la condanna di Gesù (Luca, 23, 50 e seg.); era egli stesso un discepolo di Gesù, "ma di nascosto, per timore dei Giudei" (Giovanni, 19, 38). Dopo la morte di Gesù, vinta la paura, si recò da Pilato e ne chiese ed ottenne la salma. Dopo che un altro uomo, Nicodemo, ebbe provveduto a cospargere il cadavere di aromi quali l'aloe e la mirra, Giuseppe lo avvolse in un lenzuolo (la Sacra Sindone) e lo depose nel sepolcro. Questo è quanto riportato dai Vangeli ufficiali. La leggenda aggiunge che egli raccolse anche alcune gocce del suo sangue in un calice, che poi portò con sé in Bretagna durante la sua predicazione del Vangelo. Secondo una versione inglese, Giuseppe si spinse con i suoi uomini fino all'isola di Avalon, l'antica Glastonbury, e lì depose il calice. Esso passò poi nelle mani dei Templari, che l'avrebbero custodito nel castello di Montsalvat, dove sarebbe stato accessibile solo ai puri di cuore predestinati, che ne avrebbero tratto la salvezza celeste o, secondo altre tradizioni, l'immortalità. L'ultima e più enigmatica versione del mito è il "Parzival" del tedesco Wolfram von Eschenbach (1200-1210 ca.). Parsifal irrompe nella vicenda come un giovane rozzo, perfetto rappresentante di una cavalleria dai modi brutali. Raggiunto il castello del Graal, fallisce nel tentativo di liberare il suo Guardiano, il Re Pescatore, misteriosamente ferito. Soltanto quando è allo stremo delle forze, umiliato, dopo aver abbandonato il mondo materiale e messo da parte il suo orgoglio, può chiedere pietà, liberare il Re Pescatore e trovare il suo Graal. In questo romanzo il Graal viene definito "Lapis exillis", un'espressione che a lungo si è cercato di interpretare. Le ipotesi più diffuse sono due: la prima secondo cui si tratta dell'errata trascrizione di "Lapis exiliis", cioè "Pietra dell'esilio", a sottolineare il cammino spirituale cui deve giungere l'uomo per trasformarsi completamente e diventare degno di possedere il Graal. Altri autori, invece, ipotizzano che si tratta di una contrazione di "Lapis ex coelis", ovvero "Pietra dal cielo", riferendosi alla leggenda narrata dallo stesso Eschenbach secondo cui il Graal sarebbe stato intagliato da uno smeraldo caduto in terra dalla testa di Lucifero durante la precipitazione agli Inferi dopo la rivolta verso il Creatore. Tutto il filone legato a queste interpretazioni del Graal ha dato origine ad un vero e proprio ciclo di romanzi chiamato "ciclo del Graal". Questo ciclo si inserisce e compenetra, a sua volta, un filone ancora più grande costituito da tutta la letteratura cavalleresca bretone, avente per protagonista il Re Artù, diventato sovrano dopo essere riuscito ad estrarre la famosa "Spada nella Roccia", ed i suoi Cavalieri della Tavola Rotonda: Parsifal, Lancillotto, Galahad, Tristano, ecc. |
|
Post n°5 pubblicato il 03 Settembre 2009 da jacquesdemolay1118
I Sigilli dell'Ordine
Il sigillo ufficiale, più noto e diffuso tra i Cavalieri Templari, era quello che li ritraeva in due in groppa sullo stesso cavallo. Questo emblema, che all'epoca delle accuse e delle persecuzioni mosse nei confronti dell'Ordine venne interpretato come chiara allusione alla sodomia, in realtà voleva rappresentare lo spirito di fratellanza e di povertà che aveva contraddistinto l'Ordine sin dalla sua fondazione. Esso, inoltre, aveva un altro significato, a livello più profondo: simboleggiava la duplicità insita sia nella natura dell'Ordine, monastico e guerriero, sia in quella dell'uomo, divina a umana.
Croci templari
Come per i sigilli, anche per le croci templari non c'è unicità, perché nel corso degli anni ne sono state adottate di diversi tipi e forme, e spesso neanche in maniera univoca, come si può vedere dall'immagine qui sopra. La semplice croce greca, che appare prima nella fila in alto, è stato il primo modello di croce distintiva dell'ordine. Gli altri modelli sono tutti più o meno ispirati a quello della croce patente (o croix pattèe), ovvero la croce a bracci uguali che si allargano nella parte esterna. Generalmente la presenza di una di queste croci in un sito non è sufficiente ad attribuire ad esso una presenza di Cavalieri del Tempio.
Il Beauceant
Il Beauceant (spesso scritto anche in altre grafie: baussant, bauçant o beaucant) era il vessillo dei Cavalieri Templari. Sia esso in forma di scudo o di bandiera, presentava sempre la medesima caratteristica, la suddivisione in due parti simmetriche di colori opposti, bianco e nero. Il dualismo espresso da questo emblema costituisce un concetto fondamentale nelle filosofie esoteriche. Esso rappresenta le due forze cosmiche opposte e complementari, la lotta tra il Bene e il Male, il costante dinamismo dei due principi fondamentali che muove e governa il mondo. Incerta l'etimologia del termine. Alcuni lo fanno derivare dalla locuzione francese "beau séant", «che appare bello»; altri dal provenzale bausan, a sua volta derivato dall'italiano balza, che significa bordo, fascia. Ancora oggi la "balzana" è un termine araldico che indica uno scudo o uno stemma bipartito orizzontalmente, metà bianco e metà nero. Un'altra etimologia che è stata proposta è quella derivante dal termine provenzale bausan, che si riferisce ad una particolare specie di cavallo dal manto nero e ciuffi di peli bianchi sulle zampe, ma ve ne sono diverse altre, molto fantasiose.
Il motto
Il motto dei Templari, che compariva sotto il stemma, era "Non nobis Domini, non nobis, sed nomini Tuo da gloriam", che significava: «Non per noi Signore, non per noi, ma per il Tuo nome dai la gloria". |

Miti come agnelli
nella quiete della casa
implacabbili come lupi
nella foga della battaglia
CERCA IN QUESTO BLOG
ULTIMI COMMENTI
CHI PUÒ SCRIVERE SUL BLOG
I messaggi e i commenti sono moderati dall'autore del blog, verranno verificati e pubblicati a sua discrezione.



Inviato da: rosadeicostanti
il 04/10/2009 alle 15:58
Inviato da: bisou_fatal
il 20/09/2009 alle 17:29
Inviato da: bisou_fatal
il 20/09/2009 alle 17:27
Inviato da: lia173
il 15/09/2009 alle 22:35
Inviato da: teatron78
il 03/09/2009 alle 18:07