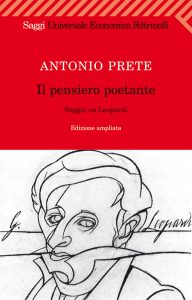blogtecaolivelli
blog informazione e cultura della biblioteca Olivelli
TAG
TAG
Messaggi del 10/05/2018
|
Post n°1663 pubblicato il 10 Maggio 2018 da blogtecaolivelli
Quando i cavalli avevano le dita La zebra è bianca a strisce nere o nera a strisce bianche Come mai non ci sono animali con le ruote? Perché le imperfezioni presenti negli organismi sono prova dell'evoluzione? Domande a volte bizzarre, aneddoti, mostri e meraviglie della natura sono altrettante occasioni di approfondite e...... Quando i cavalli avevano le dita raccoglie una parte dei saggi pubblicati in quella sede. Gli spunti e i percorsi sono molteplici e possono apparire eterogenei - stranezze biologiche che si spiegano soltanto in rapporto al passato filogenetico delle specie, concezioni continuiste e discontinuiste dell'evoluzione, la frode di Piltdown, scienza e politica, l'estinzione delle specie ecc. -; in realtà gli argomenti trattati si organizzano attorno al tema portante del libro, la costruzione di un'immagine storica della natura, contribuendo con la loro varietà a suggerire la complessità e il fascino delle problematiche connesse all' evoluzionismo." |
|
Post n°1662 pubblicato il 10 Maggio 2018 da blogtecaolivelli
Fonte: Internet Sintesi di Miseria dello storicismo di Karl R. Popper Il contesto storico in cui il libro è nato Il primo nucleo del testo ha preso forma intorno al 1919-'20 guardando alla rivoluzione bolscevica del 1917 e alle tesi marxiste (il titolo infatti si rifà polemicamente ad un testo di Marx, Miseria della filosofia) e la sua ripresa è in funzione della critica al marxismo come una delle forme dello storicismo.
- Individuazione di leggi universali storiche e di sviluppo e quindi intrinseche al corso del mondo. Queste leggi darebbero la possibilità di fare delle previsioni sul futuro e addirittura permetterebbero di conoscere il fine ultimo della storia (per es. nel marxismo, dopo la fine del capitalismo e la dittatura del proletariato, la società socialista senza classi.). Queste leggi farebbero così luce su un destino del mondo, un destino storico a cui tutti sono sottoposti e spiegherebbero in qualche modo il senso della storia (e qui entriamo nel campo delle essenze).
3.3. I pericoli di questa forma di storicismo 3.4. Due opposte forme di meccanica sociale 3.5. La storia ha un senso? 3.6. Una profezia che si autoavvera |
|
Post n°1661 pubblicato il 10 Maggio 2018 da blogtecaolivelli
Fonte: Internet Pensare globale contro le semplificazioni del fanatismo Riflessioni sul terrorismo contemporaneo, nelle sue varie forme, rileggendo "Sette lezioni sul pensiero globale" del pensatore francese Edgar Morinscritto da ANDRÉ-YVES PORTNOFF 12 marzo 2018 Sette sparatorie micidiali nelle scuole americane durante le prime sette settimane del 2018! Diciassette persone ammazzate a Parkland il 15 febbraio scorso. Da un giovane violento, appassionato di armi e simpatizzante di un gruppuscolo che esalta la superiorità della cosiddetta razza bianca. Il massacro di Parkland è doppiamente simbolico. Come molti altri attacchi estremisti in Europa, poteva essere evitato se solo i responsabili della sicurezza agissero di concerto e non in corpi ognuno separato dall'altro. Questa è una delle conseguenze di un pensiero e di una visione frammentate che impediscono di percepire le realtà complesse. Ma la violenza omicida nelle scuole è anche simbolica perché questi drammi hanno luogo proprio là dove si dovrebbe educare i futuri adulti in modo che non diventino terroristi. Edgar Morin ha moltiplicato gli allarmi da anni. Aldo Manuzio, il creatore dell'editoria moderna, sosteneva che solo la lettura di buoni libri può bloccare la barbarie. Oggi, questo è ancora più vero. È necessario leggere e rileggere "Sette lezioni sul pensiero globale" (Raffaello Cortina Editore. 2016). In questo libro, più attuale che mai, Edgar Morin spiega che tutto passa per la scuola: il passato dimostra che
Peraltro, queste misure potrebbero finire in mani "cattive" e "autorizzare la peggiore arbitrarietà". Anche quest'ammonimento diventa ancora più di attualità con l'evoluzione politica europea. Edgar Morin ribadisce la necessità di "educare alla pace per resistere allo spirito della guerra" e di insegnare che "la conoscenza è soggetta all'incertezza e all'errore"; perché il fanatismo, forma estrema dello spirito di guerra, è portato
Tre costanti di tutti i fanatismi Secondo Edgar Morin,
La scuola deve e può sradicare queste perversioni. Il riduzionismo conduce a giudicare una persona sulla base di alcuni tratti superficiali e a "ridurla alla sua parte peggiore". Il manicheismo si diffonde e si sviluppa sulla scia del riduzionismo. Esiste solo la lotta del bene assoluto contro il male assoluto. Poi interviene in un gruppo un processo mentale di reificazione:
Cosi si sono sviluppati i fanatismi e i massacri nazisti, stalinisti, maoisti e quelli commessi dai piccoli gruppi che, in piena pace,
La banda di Baader in Germania, le brigate rosse e gli stragisti neri in Italia, i separatisti baschi in Spagna, hanno agito e ammazzato cosi. Per combattere queste derive, è più che urgente integrare "nel nostro insegnamento, dal primario all'università", la "conoscenza del sapere" e il pensiero complesso. Perché la conoscenza è rilevante solo se ci si sforza di "vedere le cose nel loro contesto, osservandole nelle loro molteplici sfaccettature, superando l'atteggiamento partigiano o binario (buono/brutto, gentile/cattivo...). In altre parole, abbiamo bisogno d'un pensiero globale che scruti la complessità e non la mutili con approcci binari, dove tutto è bianco o nero; occorre un pensiero che non decomponga tutto in visioni parziali, in particolare la natura dell'essere umano. Questo non è il requisito di intellettuale sognante, ma d'un testimone realista: troppi esseri umani non riconoscono l'umanità dell'altro. Per questo il fondamentalismo islamico commette massacri quasi quotidiani; per questo, anche, molti altri atti barbarici sono perpetrati nel mondo: gli agenti di polizia americani, in maggior parte cristiani, abbattono, in uno stato democratico, quasi una persona al giorno, colpevole di essere nero.
Edgar Morin Ma "se non insegniamo agli umani quello che sono, (...) manca la conoscenza di sé", spiega Edgar Morin. Perché
a causa d'un modello mentale che cede alla facilità di scindere la realtà per descriverla. L'insegnamento è frammentato come se la giustapposizione di visioni parziali, che s'ignorano l'una l'altra, potesse dare allo studente, al ricercatore, al cittadino, una percezione dell'insieme complesso che è un essere umano. L'uomo è studiato separatamente, come individuo, come membro di una società e come essere biologico. Questo provoca "una disgiunzione drammatica nel nostro sistema educativo" e tra i ricercatori. La sociologia tende a considerare gli individui come soltanto determinati dai processi sociali, e la psicologia, con l'eccezione della psicologia sociale, fa un errore inverso, ignorando le interazione tra società e individuo. L'umano è anche il risultato di processi biologici; pero non possiamo essere ridotti ad una somma di molecole o cellule o persino al nostro patrimonio genetico. In qualsiasi sistema complesso, il tutto è il risultato di una serie d'interazioni continue, non è la somma delle parti. Pertanto, il nostro insegnamento continua a fornire visioni parziali che s'ignorano a vicenda mentre
Ritrovare la dolcezza nelle relazioni È quindi necessario riformare profondamente la scuola. Edgar Morin s'impegna a ripeterlo e spiega che il pensiero complesso è l'anticamera della solidarietà perché rende evidente le nostre interdipendenze. La scuola dovrebbe insegnare già nelle piccole classi a lavorare insieme, quindi ad accettare e sfruttare le differenze degli altri. Sempre più studi dimostrano l'importanza economica della tolleranza, perché la diversità, soprattutto nel management, favorisce la creatività, l'innovazione, rafforza l'intelligenza collettiva ed è correlata a migliori risultati economici. I bambini dovrebbero imparare ad accettare e rispettare la differenza di genere, invece di essere incoraggiati a perpetuare degli archetipi caricaturali.
Edgar Morin Il filosofo Laurent Bibard, che dirige la cattedra Edgar Morin della complessità all'Essec (una delle principale scuole di commercio francese), dimostra che questo contribuisce anche alla produzione di terroristi ("Terrorisme et féminisme - Le masculin en question", Editions de l'Aube, 2016). Secondo Laurent Bibard, il terrorismo rappresenta una forma di deviazione del modo maschile d'essere nel mondo. Siamo di fronte a ritorni arcaici della violenza di certi maschi contro le donne. La scuola potrebbe aiutare a ritrovare la dolcezza nelle relazioni insegnata da alcuni filosofi greci. Preparerebbe una società migliore insegnando a essere moderati con gli altri, a non richiedere dagli altri una perfezione irraggiungibile per noi, esseri umani. E Laurent Bibard insiste sulla necessità d'aiutare i giovani a fare la differenza tra realtà e finzione: sotto l'influenza dei videogiochi realistici, certi giovani rischiano d'ammettere nella vita reale le atrocità che hanno visto troppo spesso sui loro schermi. Il cancro del re denaro Tuttavia Edgar Morin non dimentica un altro elemento del problema, che anche papa Francesco ha coraggiosamente spiegato:
Per Edgar Morin, che denuncia anche lui il dio denaro, accanto alla barbarie del terrorismo fanatico, esiste
Si noti che in Europa, degli esperti pretendono misurare con cifre il capitale immateriale, quel che è un'assurdità, poiché questo capitale è per definizione soggettivo e contestuale. Einstein avrebbe detto che "ciò che conta di più è quello che non contiamo". L'economia mondiale è malata, secondo Edgar Morin, di "una specie di tumore: la dominazione del capitale finanziario speculativo". In nome della competitività, i dipendenti sono oberati di lavoro e licenziati senza limiti. Anche la farmacia, che dovrebbe essere l'industria della salute, "soffre di corruzioni interne". L'urbanizzazione massiccia produce città irrespirabili e aumenta la miseria, mentre continua "la devastazione ecologica della pianeta". A causa di una mentalità binaria e quantitativa, poniamo domande sbagliate: "Crescita o decrescita". Mentre si dovrebbe scegliere la "crescita di un'economia del bene pubblico, della solidarietà" e la "decrescita dell'economia della frivolezza", delle mistificazioni pubblicitarie che ci fanno accettare l'obsolescenza programmata. Questo implica "un'educazione al consumo". Edgar Morin La battaglia per uno sviluppo qualitativo e pacifico potrà essere vinta solo quando un numero sufficiente di statisti capirà che
e provocherà sempre rigetti violenti. Ma questi dirigenti dovrebbero avere una visione a lungo termine e conservare, per agire, abbastanza coraggio di fronte ai corruttori. In un altro libro ("La nostra Europa", Raffaello Cortina Editore), Mauro Ceruti e Edgar Morin hanno osservato che la maggior parte dei nostri politichi conserva una visione binaria che impedisce loro di percepire i problemi reali a cui dobbiamo fare fronte. Così i dirigenti prendono, sotto la pressione dell'urgenza e del breve termine, decisioni che chiamano "tecniche", dettate da esperti tecnocrati troppo spesso legati agli interessi di lobby o di organizzazioni mafiose. |
|
Post n°1660 pubblicato il 10 Maggio 2018 da blogtecaolivelli
Fonte: Internet
La nostra Europa: decomposizione o metamorfosi? Un saggio di Morin e Ceruti
di André-Yves Portnoff per www.ytali.com "La maggior parte degli uomini politici non sa ascoltare. Peggio ancora, mancano loro i modelli mentali necessari per capire la complessità della crisi che stiamo vivendo e quella dell'Europa". Mauro Ceruti non ha peli sulla lingua. Quello che Edgar Morin chiama il suo fratello spirituale italiano, ha partecipato alla creazione del Partito Democratico ed è stato cinque anni senatore, fino al 2013. "Un'esperienza deludente". Ora insegna filosofia della scienza alla Libera Università di lingue e comunicazione di Milano (IULM), ma il professore non ha ridotto il suo impegno civico. Perché teme un imminente crollo dell'Europa. "Questo timore ci ha decisi, Edgar e me, a scrivere La nostra Europa" e a spiegare cos'è l'Europa della quale "i politici e gli economisti non parlano più". Gli avvenimenti confermano ogni giorno di più l'analisi della situazione descritta nel libro. Scegliere la nostra Europa e il nostro umanesimo Mauro Ceruti e Edgar Morin ci ricordano che l'identità e l'unità europee si sono costruite a colpi di divisioni e di conflitti, creando la più grande diversità culturale esistente nel mondo. Ma risultano anche da interazioni positive costanti tra le regioni europee e i contributi esterni. L'Europa è sempre stata doppia e contraddittoria, civilizzata e barbara: ha portato i diritti umani, la democrazia, la misura; culturalmente policentrica, ha onorato la diversità del suo "retaggio alla volta greco, romano, ebreo e cristiano". Ma ha anche sviluppato l'arbitrio, l'oppressione, l'eccesso. Ha inventato lo stato-nazione, che ha sviluppato due malattie: "all'interno, la purificazione etnica, linguistica, religiosa, culturale; all'esterno, la sacralizzazione delle frontiere". Mauro Ceruti e Edgar Morin sottolineano che anche l'umanesimo ha due facce. Quella "che esalta la dignità di ogni essere umano, i diritti delle donne, la libertà-uguaglianza-fratellanza". Ma anche quella dell'arrogante "proprietario della natura, occidentalocentrico", giustificando lo sterminio di altre civiltà. "Dobbiamo abbandonare questo secondo umanesimo." Il peggio è possibile La crisi è "strumentalizzata da populismi, nazionalismi, autoritarismi, localismi e vari razzismi" tutti anti-europei. "L'Unione europea non esercita un controllo efficace sulle regressioni anti-democratiche". Come in Ungheria. E si cercano dei capri espiatori: islam, zingari, ebrei... "L'Europa meta-nazionale è nata dalla resistenza alle barbarie naziste e staliniste, e dalla difesa della democrazia"; oggi, "la resistenza alla barbarie costituisce il nucleo originario di una comunità di destino", ma dobbiamo andare oltre il pentimento, riconoscere pienamente la barbarie europea e mondiale; quella di tutti i genocidi del passato. Si è voluto giustificare il macello di Hiroshima col confronto distorto tra i numeri di vittime della bomba e di quelle, ipotetiche, di un proseguimento del conflitto. "Attraversiamo condizioni storiche, politiche e sociali che rendono il peggio immaginabile." Mauro Ceruti ricorda che siamo le prime generazioni capaci di provocare un suicidio mondiale: una guerra mondiale non avrebbe che vinti. I politici e i loro consiglieri economici sono prigionieri di un pensiero quantitativo, lineare, che frammenta tutto e impedisce la percezione globale di una realtà complessa. "Politiche e governi, deplora Mauro Ceruti, si sono messi nelle mani dei tecnocrati ultra specializzati, impregnati dalla scienza economica la più cieca che abbiamo conosciuto perché ignora l'umano. Si cifra tutto, si coltivano le razionalizzazioni fino alla paranoia!" Persa, la sovranità democratica! Il paradigma ultra-finanziario si è imposto. La classe dirigente conserva soltanto le cerimonie della democrazia. Lascia la sovranità del potere democratico perdersi a beneficio di tecnocrati legati a interessi particolari, che cercano i profitti a molto breve termine. Da qui, corruzione. L'economia dominante produce disuguaglianze, miseria, devastando l'ambiente antropologico ed ecologico. Al termine, anche i privilegiati saranno minacciati, "perché siamo solidali di fatto, che lo vogliamo o no." La nostra Europa abbozza un programma: colmare un deficit democratico, instaurare la sovranità popolare e l'equilibrio dei poteri nell'Unione, costruire una difesa, una politica di sicurezza unitarie, reinventare un modello economico, civile e politico, governare la transizione energetica, salvaguardare la biodiversità, "resuscitare le città là dove si espandono agglomerati anonimi e ibridi", moltiplicare gli spazi dedicati alla cultura, alla vita pubblica, rivitalizzare i vecchi borghi, regolare il trionfo della mercificazione. Liberare le intelligenze Tutto ciò richiede "un pensiero politico che non si limita esclusivamente a ciò che è economico e quantitativo [...], un pensiero coraggioso, in grado di collegare i problemi tra di loro, d'integrare la conoscenza delle parti e la conoscenza del tutto". Siamo ancora lontani da questa "riforma del pensiero e dell'educazione". Secondo Mauro Ceruti, l'università italiana, affascinata dal modello americano, vive una profonda crisi. L'importante non è di gonfiare i programmi, ma di aiutare gli studenti a crescere, a collegare le loro conoscenze a quelle degli altri e di valorizzare le diversità. Dobbiamo passare da una meritocrazia proclamata a un reale riconoscimento dei meriti personali, garanzia per "ognuno" del pieno esercizio della sua intelligenza. Dappertutto, dobbiamo sostituire delle azioni win-win ai giochi a somma zero. Queste osservazioni valgono per tutta l'Europa. Mauro Ceruti è più che mai convinto che l'Europa possa diventare per il mondo un laboratorio di costruzione dell'unità umana attraverso la valorizzazione delle diversità. "La nostra salvezza è altrettanto improbabile di quanto è stata la nascita dell'Europa. Ma rimane possibile se riusciamo a mettere da parte la faccia oscura dell'Europa e dell'umanesimo. " Questo articolo è stato pubblicato in francese dalla rivista Futuribles André-Yves Portnoff è direttore dell'Observatoire de la révolution de l'intelligence presso Futuribles international, centro di prospettiva parigino. Nel 1983 è stato uno degli autori del primo rapporto francese sulla società immateriale La révolution de l'intelligence, e su questo tema ha concentrato in seguito il suo pensiero. Lavora come consulente in strategie, innovazione e valutazione del capitale globale di imprese e organizzazioni. Insegna management e strategia presso la Haute école de gestion di Friburgo, Svizzera. 13 marzo 2017 |
|
Post n°1659 pubblicato il 10 Maggio 2018 da blogtecaolivelli
Fonte: Internet Pensiero poetante e poesia pensante in Leopardi Da Maurizio Marchese - 17 dicembre 2016 1351
"Il pensiero poetante" è il titolo di un saggio di Antonio Pretesull'opera e sul modus operandi di Giacomo Leopardi. Il saggio compie un'analisi del laboratorio labirintico del poeta di Recanat ipartendo dallo Zibaldone; analisi centrale del saggio è, come suggerisce il titolo, il rapporto che sussiste tra poesia e filosofia. Ne "Il pensiero poetante" Antonio Prete mostra come il pensiero leopardiano sia animato nelle sue forme dall'esperienza poetica, e questa esperienza abbia una forte energia conoscitiva. L'immaginazione Nel pensiero leopardiano il discorso sulla separazione tra poesia e filosofia è la constatazione di un processo in atto che non intacca l'istanza della loro unità: poesia e filosofia sono due attività che si muovono sulla stessa scena con l'immaginazione, che scandisce il loro rapporto; il privarsi di essa produrrebbe un'insanabile divaricazione deleteria per entrambe le attività. Anche nelle riflessioni e negli appunti prosastici dello Zibaldone sussiste il linguaggio poetico. Al di qua dei procedimenti linguistici, Leopardi è consapevole che il poeta e il filosofo possono scambiarsi i ruoli, e l'immagine può apparire propria della filosofia, come l'analisi può apparire propria della poesia. Parlando del poeta si parla del filosofo, e che Leopardi fosse consapevole dell'unità delle due attività, poetica e filosofica, si ricava chiaramente dello Zibaldone:
Mentre una tradizione classicista aveva lavorato a riportare la poesia nello spazio "naturale" dello stile - tecnica, retorica, modelli - relegando fuori dalla poesia la "novità" del pensiero: riduzione ed esclusione fondate sull'equivoco d'una separazione tra stile e pensiero, d'una formalizzazione assoluta del fare poetico.
Leopardi ritiene ogni fissazione in "facoltà" esclusive, che ha come primo risultato di scoprirsi insufficiente nell'interpretazione della natura: in gioco è proprio l'interpretazione della natura nel pensiero illuminista e leopardiano. È in questo orizzonte che vanno a definirsi il discorso simbolico e il problema della conoscenza. Come nella critica alla civiltà e del rapporto con il sapere degli antichi, anche nel pensiero poetante, nell'intreccio di poesia e filosofia, per Leopardi ha un ruolo fondamentale l'immaginazione.
di"penetrare nel sistema della natura" la sola ragione non basta.L'analisi è sì una categoria della ragione, ma una ragione che non muove da un soggetto di passioni e di contraddizioni è "fredda", scorporata, congelata nella sua autosufficienza; la sua analisi non può che frantumarsi sulla complessità della natura. Sulla scena della riflessione leopardiana Natura e Ragione sono in opposizione, e tuttavia la ragione non ha altro fondamento né principio, altro soggetto di meditazione, speculazione ed esercizio che la natura. Conoscere la natura vuol dire conoscere anche il suo "modo di essere", cioè il "poetico" della natura,; solo immaginazione e passione rendono possibile tale conoscenza. Opponendosi alla visione illuminista, si dichiara l'insufficienza della ragione nella conoscenza della natura, e ciò implica che l'aprirsi di tale scontro ha al centro la difesa del simbolico, dei diritti del simbolico, diritti che nella topica del sapere moderno sono contenuti nel nome della poesia, al di là della sua riduzione a "genere" di scrittura, o ad attività propria del ruolo sociale del letterato poeta. Per Leopardi la filosofia diverrebbe sterile se abbandonasse il "poetico". E il tema dell'abbandono del poetico ha nello Zibaldone una rilevanza diversa da quella giocata nella polemica col carattere raziocinante della filosofia moderna. L'abbandono del poetico intende la caduta, nella civiltà, del potere delle illusioni, lo spegnersi di passioni forti e vive, la morte delle favole antiche e addirittura la morte di Dio: il pensiero negativo di Leopardi si configura in un continuo racconto della crisi del moderno, in uno sguardo sull'assenza e sull'abisso. Con abbandono del poetico si intende uno stato di distanza dalla natura, uno stato di chiusura nell'autosufficienza della ragione filosofica, ed è contraddittorio con il compito stesso di tale ragione, cioè conoscere la natura. Tolto il "meccanismo del bello" al sistema della natura, si finisce per ragionare su un sistema dimezzato, non intero. Lo scorporamento dei rapporti, l'abbandono del poetico, la ricomposizione parziale del sistema della natura sono le connotazioni di una filosofia che si presenta come fredda proiezione della ragione. L'autonomia della ragione è anch'essa un'illusione, una cattiva illusione a cui è legata quella del "preteso perfezionamento dell'uomo mediante la perfezione della ragione e della filosofia": se la perfezione è perseguita attraverso l'astrazione dei rapporti, essa non è per l'uomo, ma contro l'uomo. È allora ben difficile trovare un vero e perfetto filosofo. Perché è difficile che la filosofia si sappia rapportare alla poesia: eppure questo rapporto è la sola condizione perché la ragione non sia contro l'uomo. Nel seguito delle sue osservazioni, Leopardi ci ha fornito nello Zibaldone l'abito del "vero filosofo":
Pensiero poetante Ciò che richiede il tempo della crisi non è né l'invocazione della filosofia, di una nuova filosofia, né della poesia, di una nuova poesia: esso richiede piuttosto l'incontro tra pensare poetante e poesia pensante, perché è in gioco un dominio del simbolico. Il percorso leopardiano intreccia ricerca poetica e tormento spirituale, nel quale la poesia, pur con tutte le sue ombre, appare forse l'unica strada per raccontare il mistero della natura.Leopardi ha ben chiara l'affinità tra poesia e filosofia, ed elogia il loro scambievole rapporto. Tra gli appunti dello Zibaldone esprime l'importanza dell'una per l'altra, anche se la filosofia muove verso il vero mentre la poesia verso il bello:
Il dialogo tra pensare e poetare, il cosiddetto "pensiero poetante", comporta in Leopardi lo smembramento del potere di una ratio che, spossessandosi delle passioni e delle illusioni, pretende di perseguire una perfezione della civiltà in nome di un "perfezionamento dell'uomo". La critica della ratio per il recanatese è la critica di un modo di conoscenza che va profilandosi come forma di potere, dunque esclusivo, scorporante, oppressivo. La critica della ragione, in nome del pensare poetante e della poesia pensante, è da lui condotta nell'orizzonte della interpretazione della natura. Nello scenario di questa critica compaiono le figure dell'"antico", il sapere della morte, figure di un discorso che va oltre la linea del Settecento illuminista, e fanno della scrittura leopardiana una critica permanente delle forme del potere. Tali osservazioni riguardo al pensiero poetante possono parere eccessive nel confronto coi testi leopardiani, ma le domande che investono un frammento provengono da altri frammenti: un testo non è mai chiuso in una scrittura come quella dello Zibaldone, che si tiene sempre lontana dalla trattazione definitiva, dall'ambizione del sistema, dell'opera come cerchio concluso. Maurizio Marchese Fonti: Antonio Prete, Il pensiero poetante - saggio su Leopardi, Feltrinelli, Milano 1980. Giacomo Leopardi, Zibaldone di pensieri, Biblioteca Donzelli, Roma 2014. |
|
Post n°1658 pubblicato il 10 Maggio 2018 da blogtecaolivelli
Fonte: Internet Si impegnò a fondo nel miglioramento della propria formazione culturale che gli studi irregolari non avevano consentito di coltivare adeguatamente; in questa prospettiva si colloca negli anni 1927-1928 la frequenza di un corso serale di lingua e letteratura francese presso il Circolo filologico, in piazza dei Peruzzi, e proprio a questi anni risalgono le sue prime esperienze di scrittore. Lasciata alla fine del 1929 la casa di via del Corno, dove era andato ad abitare con la nonna nel 1926, si trasferì nell'abitazione del padre, vicina allo studio del pittoreOttone Rosai. L'amicizia con quest'ultimo risultò di fondamentale importanza per Pratolini, che proprio grazie a Rosai compì le prime scoperte letterarie. Inoltre, frequentando lo studio di Rosai, si legò in amicizia con i suoi giovani allievi - quali Bruno Becchi e Renzo Grazzini - e conobbe Aldo Palazzeschi e Romano Bilenchi. Da questo momento Pratolini decise di dedicarsi agli studi e all'attività letteraria. Durante i primi anni trenta iniziò a dedicarsi da autodidatta alla lettura e scrisse i primi racconti; dal 1932 cominciò a collaborare con il settimanaleIl Bargello - fondato nel 1929 da Alessandro Pavolini -, nel quale pubblicò alcuni racconti, poi in gran parte ristampati, recensioni di libri, film, spettacoli teatrali, mostre di pittura ma soprattutto articoli di carattere politico-culturale. Vasco Pratolini nacque nel 1913 a Firenze, nel quartiere popolare di via de' Magazzini, da una famiglia operaia, rimanendo orfano della madre a cinque anni nel 1918. La partenza del padre per la guerra lo costrinse a vivere dai nonni, presso i quali restò anche dopo il secondo matrimonio contratto dal padre al rientro dal conflitto; compì gli studi elementari dapprima presso le Scuole pie fiorentine, dalle quali venne espulso per indisciplina, poi nella scuola elementare pubblica U. Peruzzi, in via Magliabechi. Dai dodici ai diciotto anni, dopo la morte del nonno, avvenuta nel maggio 1925, fu costretto ad interrompere gli studi a causa di gravi problemi economici, che lo costrinsero ad esercitare fino al 1931 i mestieri più disparati per sopravvivere: garzone di bottega, venditore ambulante, barista, non trascurando mai il suo grande amore per i libri. Lesse inizialmente Dante eAlessandro Manzoni, poi Jack London, Charles Dickens, Mario Pratesi, Federigo Tozzi, e crebbe in un ambiente letterario fiorentino influenzato dalla rivista Solaria e dai movimenti cattolici francesizzanti. Nell'aprile 1935, affaticato dal troppo lavoro e della vita sregolata, Pratolini si ammalò di tubercolosi polmonare e fu ricoverato nel sanatorio Villa Bellaria di Trento, dal quale uscì definitivamente guarito nel 1937. Tornato a Firenze riprese a frequentare Elio Vittorini e Romano Bilenchi. Al caffè Giubbe rosse conobbe Eugenio Montale. Nel 1938, insieme ad Alfonso Gatto ed Enrico Vallecchi, diede vita alla breve, ma eccezionale esperienza di «Campo di Marte», la rivista intorno alla quale si raccolsero le forze più vive dell'ermetismo italiano che, dopo solo un anno di vita, sarà costretta dalla censura fascista a sospendere le pubblicazioni; nel numero di ottobre dello stesso anno della rivista «Letteratura», fondata e diretta da Alessandro Bonsanti, pubblicò Prima vita di Sapienza, poi confluito, in versione accorciata, in Tappeto verde. Nell'ottobre 1939, si trasferì a Roma dove trovò impiego presso la Direzione generale delle belle arti del Ministero dell'educazione nazionale; per integrare lo stipendio ministeriale fu costretto comunque a cercare nuove collaborazioni editoriali. Nell'aprile 1941 sposò Cecilia Punzo, una giovane attrice napoletana. Negli stessi giorni uscì, presso l'editore Vallecchi di Firenze, Il tappeto verde, un libretto in cui Pratolini raccolse quanto della sua produzione gli premeva in quel momento salvare, a cui seguono: Via de' Magazzini (1942), edito anch'esso presso Vallecchi, Le amiche (1943), Il Quartiere (1944). Nell'ottobre 1941, il Ministero dell'educazione nazionale lo nominò professore di storia dell'arte presso il Conservatorio G. Verdi di Torino, prima di essere distaccato nel 1943 all'Istituto d'arte A. Venturi di Modena. Risiedette per un mese circa a Parma e successivamente a Fermo, presso una sorella della moglie, dove mise mano ad una prima stesura di Cronache di poveri amanti. Nel luglio seguente tornò a Roma, dove strinse contatti con intellettuali militanti comunisti, iniziando così la propria partecipazione alla Resistenza. Dal settembre 1943 fino al giugno dall'anno successivo fu responsabile politico del Partito Comunista Italiano (PCI) per il settore Flaminio-Ponte Milvio. Nel 1944 nacque la figlia Aurelia. In questo periodo partecipò ai lavori per la fondazione della casa editrice La nuova biblioteca, che nel dicembre 1944 pubblicò Il Quartiere. Tra l'autunno 1944 e la primavera del 1945 lavorò con Luchino Visconti, Michelangelo Antonioni, Giuseppe De Santis e Antonio Pietrangeli alla sceneggiatura di un film che Visconti non avrebbe peraltro mai portato a termine. Nel luglio 1945 morì il fratello Ferruccio e nello stesso mese Pratolini andò a vivere a Milano, dove era stata trasferita la redazione de «La settimana», restandovi fino alla fine dell'anno e collaborando al quotidiano «Milano Sera». Alla fine del 1945, decise di abbandonare il giornalismo e si trasferì a Napoli dove, insegnando storia dell'arte presso l'Istituto statale d'arte Filippo Palizzi, rimase fino ai primi mesi del 1952. Interrotta nel frattempo la stesura di Cronache di poveri amanti, si dedicò a Cronaca familiare, opera scritta di getto tra il dicembre 1945 e il gennaio 1946. Riprese quindi la stesura, per l'ultima e decisiva volta, delle Cronache, che finì di scrivere a settembre. Nel dicembre dello stesso anno tornò a Milano, in cerca di collaborazioni e nella speranza di essere assunto a «Tempo», settimanale diretto da Arturo Tofanelli. Il 5 gennaio 1947, il manoscritto di Cronache di poveri amantiricevette a Lugano il premio Libera stampa 1946. Di ritorno a Napoli dette un'ultima revisione alle Cronache e si mise a lavorare al saggio-inchiesta su Firenze Cronache fiorentine 20° secolo, destinato ad un numero speciale sull'Italia della rivista francese Les Temps Modernes, fondata da Jean Paul Sartre, edito anche nel dicembre 1947 da Elio Vittorini ne «Il Politecnico»; ad ottobre, pressoMondadori, pubblicò Mestiere da vagabondo. In questo periodo progettò due romanzi, entrambi non portati a termine: Il sabato è festa - una sorta di continuazione in ambiente studentesco e non operaio delQuartiere - e Cronaca napoletana. Nell'ottobre 1947 cominciò a scrivereUn eroe del nostro tempo; aderì quindi all'Alleanza della cultura, fondata a Firenze il 20 febbraio 1948, e nel settembre dello stesso anno scrisseLe ragazze di Sanfrediano, che sarebbe apparso nella rivista romana «Botteghe Oscure». Nel 1949 uscirono Un eroe del nostro tempo (febbraio) e la seconda edizione di Via de' Magazzini (maggio). Con Luchino Visconti e Suso Cecchi d'Amico lavorò al trattamento e alla sceneggiatura di Cronache di poveri amanti, idea cinematografica poi lasciata da Visconti e ripresa da Carlo Lizzani che vi avrebbe ricavato un celebre film uscito nel 1953. Nell'aprile 1950 si recò a Parigi in occasione dell'uscita della traduzione francese di Cronache di poveri amanti. Nel novembre 1951 si ritirò nella solitudine di Procida, dove rimase fino a metà gennaio 1952 per lavorare aUna storia italiana. Sempre nel 1952 si pose in aspettativa dall'insegnamento, lasciò Napoli e nell'aprile si trasferì definitivamente a Roma, dove continuò a lavorare a Una storia italiana, che sarebbe poi divenutaMetello. Dall'aprile al novembre 1952 fu nella redazione del settimanale «Vie Nuove» come critico d'arte. In ottobre pubblicò, presso le edizioni Atlante di Roma, i racconti Gli uomini che si voltano e Diario di Villa Rosa, poi confluiti nel Diario sentimentale, edito da Vallecchi nel 1956. Nel 1952 apparve la prima edizione in volume deLe ragazze di Sanfrediano e nel luglio 1954 uscì, presso le Edizioni di cultura sociale di Roma, Il mio cuore a Ponte Milvio. Nel febbraio 1955, presso Vallecchi, vide la luce Metello, primo volume della trilogia Una storia italiana; al romanzo fu assegnato il premio Viareggio. Nel 1956 presso Vallecchi pubblicò Diario sentimentale, l'ultimo libro di Pratolini stampato dal vecchio editore fiorentino. Nell'ottobre 1956 si recò in Polonia, dove partecipò al congresso dell'Unione degli scrittori. Il 7 giugno 1957 l'Accademia nazionale dei Lincei gli conferì il premio Antonio Feltrinelli per le Lettere. Durante l'estate 1958 collaborò con Luchino Visconti e Suso Cecchi d'Amico al soggetto di Rocco e i suoi fratelli, film che sarebbe uscito nel 1960. Nei mesi di novembre e dicembre 1958 a Capri pose fine a Lo scialo - seconda opera della trilogia Una storia italiana -, che avrebbe continuato a rivedere fino al febbraio 1960; il romanzo venne edito presso Mondadori, suo nuovo editore, nel maggio 1960 e nell'anno successivo vinse il Premio internazionale Veillon. Cominciò quindi a lavorare al terzo volume di Una storia italiana, che nell'ottobre 1966 sarebbe uscito presso Mondadori col titolo Allegoria e derisione, e a Gli anni ribelli, poi edito nel 1963 come La costanza della ragione, libro che ricevette il Premio Marzotto. Nel 1967 pubblicò nell'«Almanacco dello Specchio» dodici poesie sotto il titolo di Calendario del '67 e preparò per gli Oscar Mondadori un'edizione profondamente riveduta de Lo Scialo, poi stampata nel marzo 1976. Nel 1980 raccolse ne Il mannello di Natascia gli inediti versi giovanili. Nel 1982 lavorò alla revisione diAllegoria e derisione, la cui edizione sarebbe uscita nel febbraio 1983 sempre nella collana degli Oscar. L'11 giugno 1983 la facoltà di Magistero dell'Università di Firenze gli conferì la laurea honoris causa. Nel 1985 pubblicò Il mannello di Natascia e altre cronache in versi e prosa (1930-1980), in cui confluirono i versi scritti negli ultimi anni con l'aggiunta delle precedenti raccolte poetiche; il libro ricevette il premio Viareggio per la poesia. Il 6-7 luglio 1985, in occasione di un convegno su Pratolini e il cinema, il Comune di Firenze gli consegnò il Fiorino d'oro. Nel 1988 gli furono assegnati il Premio Letterario Ori di Taranto-Una vita per il romanzo e il Premio Pirandello per la narrativa. Ricevette inoltre il premio Penna d'oro della Presidenza del Consiglio dei ministri. A seguito dell'aggravarsi delle condizioni di salute, Vasco Pratolini morì nella sua casa romana la mattina del 12 gennaio 1991. È sepolto al Cimitero delle Porte Sante presso la basilica di San Miniato al Monte di Firenze. |
|
Post n°1657 pubblicato il 10 Maggio 2018 da blogtecaolivelli
Fonte: Internet Scrittura In Cronaca Familiare Pratolini prosegue il cammino iniziato con Il tappeto verde, scandendo le tappe della sua fanciullezza patetica e avventurosa attraverso la narrazione della genesi e dello sviluppo, fino al tragico epilogo, della sua difficile relazione con il fratello Ferruccio. I due vengono separati nei primi anni dell'infanzia, dopo la morte prematura della madre, e Ferruccio è allevato dal maggiordomo di un ricco barone inglese, che gli impartisce un'educazione rigorosa e severa; Vasco è invece allevato con grande affetto dalla nonna. I due fratelli si ritrovano dopo alcuni anni, e un delicato affetto fraterno cancella le antiche incomprensioni. La scrittura di Pratolini è tersa e sorvegliata, improntata a un sapiente e raffinato lirismo, vicino al ritmo della prosa d'arte. Cronache di poveri amanti è un romanzo ambientato quasi interamente in Via del Corno, negli anni 1925-1926. I personaggi sono i consueti del repertorio pratoliniano: giovani proletari alle prese con esperienze sentimentali e con la durezza della loro difficile condizione sociale. Sullo sfondo si apre lo scenario della Firenze nei primi anni del fascismo, una città in lotta per l'affermazione di ideali politici e umani contrastanti. Come in quasi tutti gli altri romanzi di Pratolini l'ambientazione storica è la cornice esterna di storie soggettive e di vicende sentimentali, e consente al lettore di entrare in contatto con un periodo ormai trascorso e di riviverne l'atmosfera e gli umori. Pratolini, in questo romanzo a sfondo autobiografico, descrive lo sconvolgimento della realtà popolare fiorentina negli anni dell'affermazione del fascismo, legando la storia di Firenze alle drammatiche vicende italiane. Un eroe del nostro tempo narra la dolorosa storia di una vedova costretta a trasferirsi in una via di Firenze in cui non conosce nessuno e dove fatica ad inserirsi: ella ha sempre avuto al suo fianco persone dal carattere forte (prima il padre e poi il marito) le quali le hanno sempre consigliato di diffidare degli sconosciuti, soprattutto se non appartengono a un determinato partito politico: quello fascista. La donna vive così le sue prime settimane segregata nella sua nuova abitazione, senza parlare con nessuno. Le sottili mura del suo appartamento le permettono di sentire ciò che avviene nella casa vicina ed ella inizia a seguire con attenzione sempre maggiore i movimenti del giovane Sandro, un ragazzo rimasto orfano del padre, costretto a diventare adulto prima del tempo. Tra i due inizia una relazione che porterà la donna, succube del forte carattere del giovane, ad annullare sé stessa per il suo innamorato. Sullo sfondo, soprattutto nelle vicende che riguardano la vita lavorativa di Sandro, riemerge una Firenze dilaniata dalla lotta tra fascismo e comunismo. Con questa opera incomincia il trapasso da un lirismo-regionale ad una "storia italiana" che verrà poi espanso nei lavori successivi. Metello racconta la storia di Metello Salani, un orfano allevato da contadini che si trasferisce ancora ragazzo aFirenze per trovare lavoro. Partecipa a degli scioperi, al movimento socialista e al nascente movimento operaio nel periodo che intercorre fra il 1875 ed il 1902. In parallelo si sviluppano le vicende affettive del protagonista che finirà per sposare Ersilia. Metello è il primo volume di una trilogia che si intitola Una storia italiana e che comprende come secondo capitolo Lo scialo e come epilogo Allegoria e derisione. Con lo Scialo lo scrittore descrive la storia della borghesia ai tempi dell'avvento del regime fascista. Il protagonista rinuncia ai suoi ideali giovanili socialisti per opportunismo e convenienza. Ma al centro dell'attenzione dell'autore vi è proprio la borghesia, che grazie al fascismo raggiunge una posizione di privilegio sociale. Rispetto al capitolo precedente della trilogia, la struttura del romanzo appare più composita e meno compatta. Pratolini ha curato opere di Mario Pratesi (L'eredità), Victor Hugo (Cose viste), Charles-Louis Philippe (Bubu di Montparnasse), Jules Supervielle (Il ladro di ragazzi), Raffaele Viviani (Poesie) e due antologie per la scuola media: Quello che scoprirai (in collaborazione con Luigi Incoronato, Vallecchi, 1953) e Il Portolano (con Sergio Checconi e Franco Mollia, Calderini, 1983). Archivio Pratolini Vasco: l'archivio è suddiviso in due parti; la prima, donata dalla famiglia, viene conservata presso ilGabinetto scientifico letterario G. P. Vieusseux. Archivio contemporaneo Alessandro Bonsanti, la seconda, costituita da manoscritti/dattiloscritti e altri materiali, viene conservata presso l'Università degli studi di Siena, Facoltà di lettere e filosofia, Biblioteca. Vasco Pratolini è un autore che ha tentato di tradurre l'atmosfera neorealista in una precisa poetica. È uno degli iniziatori del neorealismo, la corrente della quale furono massimi esponenti Italo Calvino, Elio Vittorini e Cesare Pavese. La produzione letteraria giovanile risente dell'ambiente fiorentino in cui Pratolini si era formato. Nei suoi racconti si coglie un aspetto originale, tipico del suo stile, che lo differenzia da tutti gli altri scrittori neorealisti; si nota infatti un forte impatto narrativo e una riscoperta della realtà cittadina non contrapposta al mondo contadino, ma descritta come luogo corale di sentimenti (amore, amicizia e solidarietà) ed esperienze comuni ad ogni uomo. Successivamente, grazie anche all'esperienza politica della Resistenza ed al clima che contraddistingue ildopoguerra, la produzione di Pratolini si consolidò sempre più verso un tipo di racconto che si allarga via via dalla città alla storia collettiva. Il romanzo di Pratolini accolto dal maggiore successo di pubblico fu Metello, stampato nel 1955, che si aggiudicò il Premio Viareggio. |
|
Post n°1656 pubblicato il 10 Maggio 2018 da blogtecaolivelli
Fonte: Internet
Anch'io come un'altra persona che ha comemntato prima, ho assistito un sabato mattino di più un anno e mezzo fa ad una trasmissimone che deniglava il libro tradotto in film.. io però avevo già letto il libro, libro con molteplici personaggi, divertente la donna Capo che invecchiando lancia palloncini d'acqua ridendo!! libro da leggere, ma solo per coloro che amano la lettura!! p.s. va letto in poco tempo,leggerlo in più periodi non rende! Wanna Vitale, Villa di Briano (Ce), 9/11/'04Ho letto cronache di povere amanti per via della prof ke ogni mese ci da un libro da leggere...tra una settimana dovrei relazionarlo ma nn so come riassumere tutte le vicende di via del corno .,è impossibile.l'ho trovato molto appassionante sembra di vivere nella mia stessa strada.... Chiara, Roma, 04/03/'04per me e' IL libro...tanto che ci sto scrivendo la mia tesi di dottorato in Germania... Sergio Catellani, (sergiocatellani@libero.it), Reggio Emilia, 10/12/03Riassumere questo romanzo è non solo impossibile, ma ritengo anche inopportuno. Semmai è un'opera da ampliare intimamente, seguendo l'onda lunga delle emozioni che si susseguono e che, leggendole, possiamo ritrovare comunque in tutti noi. Pamela, Grosseto, 27/09/'03Ho letto "cronache di poveri amanti"perché distrattamente, un sabato mattina, guardavo il film su rai3 e sentivo il successivo commento che osannava il libro e che denigrava,(giustamente),il film. Sono uscita immediatamente a comprarlo e l'ho amato subito, ho amato la sua lirica, ho odiato la Signora!Mi sembra di conoscere via del corno, mi sembra di eserci stata da sempre e ora, come uscirne? Chiara, Cuneo, 20/08/'03Ho letto "Cronache di poveri amanti" mentre ero in Francia, in Erasmus. Avevo molti libri da studiare, per "dovere", ma ho lasciato perdere ogni altra lettura e in due giorni l'ho terminato. L'abilità descrittiva di Pratolini mi ha fatto "traslocare" in via del Corno. Come abbandonare la via dopo aver sofferto e gioito con i suoi abitanti? Benedetta, Livorno, 18/08/'03A quanto pare ho l'onore di essere la 1a a dare un commento sul romanzo di Pratolini...Bé,ho appena finito di leggere questo libro assegnatomi x le vacanze estive dalla scuola e sul quale sarebbe mio compito elaborare una relazione.Ma come si fa a sintetizzare e mettere per scritto tutte le tumultuose emozioni che si rincorrono insieme agli eventi durante la lettura del libro?"Cronache di poveri amanti" è un romanzo da leggere senza prendere più il respiro x meglio gustarsi sua stessa impostazione di CRONACA,appunto.Un romanzo senza limiti di tempo il cui finale aperto sottolinea il continuo susseguirsi degli eventi e quindi della vita"con i suoi annessi e connessi":i problemi,i dolori,le gioie,gli amori,i tradimenti |
AREA PERSONALE
MENU
CHI PUņ SCRIVERE SUL BLOG
I messaggi e i commenti sono moderati dall'autore del blog, verranno verificati e pubblicati a sua discrezione.