Vento notturnoI veri maestri non lasciano tracce, sono come il vento notturno, che ci sconvolge e ci lascia immutati, trascina con sé ciò che pensavamo di essere e non siamo mai stati e ci rende ciò che siamo sempre stati, fin dall'inizio. ____________________________________________ [blog per la consulenza filosofico-esistenziale] |
AREA PERSONALE
CERCA IN QUESTO BLOG
MENU
I MIEI LINK PREFERITI
TUTTI INSIEME PER L'ABRUZZO
I MIEI BLOG AMICI
ULTIMI COMMENTI
CHI PUò SCRIVERE SUL BLOG
IN RICORDO DI UNA GRANDE VOCE. ANDREA PARODI
TAG
DAVID SYLVIAN - SILVER MOON
RASTRELLI CELLO QUARTET - PIAZZOLLA - OBLIVION
|
Post n°1 pubblicato il 22 Luglio 2009 da randagiamente
Apri una breccia, e allargala se puoi, nel muro dell'egoismo, nel muro dell'indifferenza, nel muro della paura, nel muro della diffidenza, nel muro della delusione, nel muro del pregiudizio, nel muro del risentimento. Apri una breccia e fa' entrare l'aria nuova fa' entrare il sole, fa' entrare gli altri. Non sei in pericolo, non hai nulla da perdere ma tutto da guadagnare. Non soffocare la tua giovane pianta pensando di proteggerla. Lascia che si disseti con la pioggia, che si fortifichi al sole. Il tuo giovane spirito si arricchirà di ogni incontro che farai, di ogni differenza che saprai accettare, di ogni divergenza che t’impegnerai ad appianare di ogni contrasto che avrai la forza di ricomporre, perché unire non è facile quanto dividere. Apri una breccia, come fai ogni volta che sorridi, e nutri di sorrisi la tua fiducia. L'unico rischio che correrai sarà di diventare ogni giorno un po' più forte, ogni giorno un po' più saggio, ogni giorno un po' più felice, ogni giorno un po' più te stesso. Siamo tutti pulcini ancora dentro l'uovo. Apri una breccia, e vivi. |
|
Post n°2 pubblicato il 22 Luglio 2009 da randagiamente
(Ad una cara amica) I sentimenti... già, i sentimenti. Non è facile attraversare i loro territori con passo leggero... Ho cercato, in tutti questi anni di capirci qualcosa, come accade a tutti, e forse ci ho provato anche con maggiore impegno e applicazione di altri. Ma devo dire che forse l'unica cosa che tuttora mi è abbastanza chiara è che ogni discorso sui sentimenti è e non può essere altro che un discorso a posteriori. Nel senso che non si può parlare di qualcosa che prima non si sia provato sulla propria pelle. I sentimenti sembrano veramente l'antitesi della razionalità, sembra che lo facciano apposta a scombinare qualunque discorso logico, sembrano veramente essere fatti per smentire e ribaltare ogni senso, ogni minimo ordine faticosamente raggiunto nella nostra povera testolina. E quindi come parlarne, e soprattutto, ha poi senso parlarne? E sembra che, più uno si sforza di pianificare, programmare, inquadrare e fare ordine nella sua vita, più devastante sarà il caos che si troverà ad affrontare una volta che si sia imbattuto, all'improvviso (e rigorosamente senza preavviso), in un'esperienza come può essere quella d'innamorarsi. Quello che so (sempre per esperienza) è che i modi dell'amore sono infiniti, non uno per ogni persona esistente sulla faccia della terra, ma molti di più: uno per ogni relazione diversa che ogni persona di questo mondo può avere con ogni altra persona di questo mondo. Ogni rapporto è unico, e in ogni rapporto ci troviamo di fronte ad un nuovo, inatteso e imprevedibile "me stesso", che fa i conti con un nuovo, inatteso e imprevedibile mondo, racchiuso nella persona che abbiamo davanti. E non sappiamo come ci muoveremo in questo mondo, non sappiamo come reagiremo alle situazioni, e lo verificheremo man mano, e questo sarà il nostro grande obiettivo: scoprirci scoprendo l'altro, conoscerci conoscendo l'altro, specchiarci nell'altro e offrirci, a nostra volta, come specchio dove l'altro possa guardarsi, cercando di essere specchi il più possibile lisci e puliti, senza macchie, senza ombre. E so anche che ci sono sentimenti più o meno nobili: c'è chi si dà completamente all'altro, con fiducia e coraggio, e chi invece usa e sfrutta l'altro per mettere una pezza sui propri limiti e insicurezze; c'è chi ama disinteressatamente, ed è felice nel dare amore a fondo perduto, e chi "ama" solo se contraccambiato con interessi da usuraio; c'è chi è capace di star solo con se stesso, e starci anche bene, e proprio per questo decide che è giunto il momento di mettersi alla prova in un amore finalmente adulto, e chi non ha nemmeno mai provato a star solo, perché se non ha qualcuno vicino va nel pallone, e passa la sua vita a trastullarsi con rapporti puerili e inconcludenti. Credo che, insomma, forse l'unico obiettivo serio che possiamo porci è quello di cercare di crescere. Perché un amore più grande ha bisogno di una persona più "grande". E credo che essere più grande, crescere e diventare migliore sia, o dovrebbe essere, un dovere morale. E che se riuscirò a crescere un pochino, crescerà con me e si trasformerà con me anche la mia capacità di amare. Ma questa crescita passa attraverso la mia capacità di superare delle prove, perché non c'è crescita se non c'è travaglio, se non c'è sofferenza. E dobbiamo quindi avere l'atteggiamento del guerriero, pronto a combattere, pronto a morire, coraggioso, inflessibile e spietato innanzitutto con se stesso. E non c'è prova che ci impegni maggiormente di quella che passa attraverso i sentimenti, i rapporti con chi amiamo. Ma dovrei, devo, essere felice per ogni prova che la vita mi propone, proprio perché è per me occasione di crescita. E più "grande" diventerò, più saranno dure le prove, perché è giusto che sia così. E se qualche volta mi sembrerà di non farcela, se sarò sfiduciato e scoraggiato, se mi sembrerà che la prova stavolta era davvero troppo dura, se mi sentirò bersagliato, bastonato, distrutto, annientato, se mi sembrerà di non avere davvero più la forza di reagire... beh... ci sono sempre gli amici, no?
|
|
Post n°3 pubblicato il 23 Luglio 2009 da randagiamente
- Il mito del toro bianco di Pasifae
Ciò che per me è peculiare del filosofo è quella sorta di perversione che gli rende impossibile accontentarsi di ciò che appare, qualsiasi cosa appaia, in qualunque modo appaia. Quel voler guardare sempre “dentro” le cose. Quel non fermarsi mai alla prima evidenza, ma, immediatamente, anche se gli si presentassero innanzi due alternative tra le quali poter tranquillamente scegliere, aggirarsi inquieto alla ricerca di una possibile terza opzione. Insomma quella vocazione a rompere gli schemi (e a volte non solo quelli…), anche se da lui stesso appena creati. |
|
Post n°4 pubblicato il 25 Luglio 2009 da randagiamente
Mi rendo conto che, in tempi come questi, in cui si verifica un innalzamento dell’Ego al di sopra di qualsiasi altro valore, con tutto ciò che questo comporta (egocentrismo ed egoismo sono concetti troppo vicini per poterli distinguere chiaramente), parlare di abbandono dell’Ego possa apparire quantomeno paradossale. Ma ritengo sia proprio questo, invece, il momento giusto per iniziare a parlarne, proprio perché ormai la gente sta perdendo completamente il senso di una qualunque possibile alternativa a questa mentalità imperante. Bisogna iniziare, con pazienza ma con decisione, a far capire, prima di tutto a chi ci sembra maggiormente disposto ad ascoltare, che l’autoaffermazione dell’Ego è uno dei mali peggiori con cui ci troviamo a fare i conti in questo periodo storico nella nostra cosiddetta civiltà occidentale. Bisogna far capire a questi volenterosi, innanzitutto, che il loro stesso predisporsi all’ascolto delle nostre parole altro non è che una momentanea messa tra parentesi del loro Ego. Ascoltare significa accettare l’Altro dentro di sé. Ma se c’è difesa ad oltranza del proprio Ego, non vi può essere reale disposizione all’ascolto, in quanto questo comporterebbe l’accettazione del rischio di poter anche essere modificati da ciò che si ascolta. L’accettazione del rischio di cambiare. E se c’è difesa del proprio Ego, c’è chiusura ad ogni cambiamento. Perché laddove c’è autoaffermatività dell’Ego c’è già, implicitamente, una contrapposizione in atto con un Tu ostile, e non vi può essere quindi alcun reale atteggiamento di ascolto. Perché in ogni atteggiamento proteso alla costruzione del proprio Ego, l’Altro può essere visto solo come limite, come ostacolo, come fastidio, come disturbo. Al contrario, in ogni autentico atteggiamento di ascolto si dà il coraggio di un’apertura, che altro non è che un abbandono delle proprie difese, un mettersi in gioco, un affidarsi all’altro, che risulterebbero inconcepibili nell’ottica dell’autodifesa dell’Ego. Questo accettare di aprirsi, questo affidarsi, questo porsi nelle mani dell’altro è strettamente legato a valori fondamentali della vita di ogni essere spirituale, prima che di ogni buon cristiano, quali l’amore, l’umiltà, la fede. L’elemento essenziale che accomuna l’amore alla fede è infatti quel donare se stessi che è l’esatta antitesi della coltivazione dell’Ego. Chi si considera molto importante, e attribuisce quindi alla propria persona un ben preciso valore, prima di donarsi vorrà sicuramente sapere se varrà la pena di spendere se stesso per qualcuno o qualcosa, che poi, fatalmente, non verranno mai considerati tanto importanti da richiedere una tale, così ingente donazione. Al contrario, la persona umile, che, per definizione, non attribuisce mai troppa importanza a se stessa, sarà lieta di dare il suo tempo, il suo impegno, le sue energie, per aiutare qualcun altro, o in qualunque altra occasione in cui venga richiesto il suo aiuto. Tutti questi aspetti sono strettamente legati. L’“Io aperto”, che tu auspichi, è in realtà un “non-Io”, perché l’Io è chiusura, individuazione, delimitazione, contrapposizione all’Altro. Se non c’è un Tu non può esistere un Io, e se c’è apertura all’altro non c’è un Io né un Tu, ma solo un Noi. Come ho intenzione di spiegare approfonditamente nel mio prossimo tentativo letterario, la vita è relazione, e l’unico modo per essere e sentirsi veramente vivi consiste nell’identificarsi non con questo strano oggetto, statico e morto, utile solo ai nostri altrettanto morti e rigidi schemi mentali, che chiamiamo Io, bensì proprio con la nostra capacità di relazione e di scambio, di comunicazione con gli altri, con l’ambiente in cui ci muoviamo, parliamo, ascoltiamo, amiamo. Ognuno di noi è soltanto un nodo di relazioni. Tutto questo si può esprimere in altre parole, dicendo che la nostra vita sarà tanto più ricca quanto più saremo in grado di abbandonare l’Io a favore del Noi. Tu dici: “Abbiamo bisogno di un Io… che ci renda unici davanti alla vita… Immaginare gli uomini senza un Io sarebbe come vederli tutti uguali, senza bagaglio, senza sogni, senza…”. Ma mia cara, come fai a non vedere che intorno a te c’è già un mondo pieno di strani esseri (non chiamiamoli uomini, per carità!) davvero tutti uguali, davvero senza sogni, senza speranze, senza valori, senza dignità! Esseri totalmente incapaci di ascoltare, in quanto totalmente disinteressati a ciò che un altro può avere da dire, esseri incapaci di concepire e di emettere alcuna frase che non inizi con la parola “Io”. Il guaio è che la nostra dignità di uomini ce l’abbiamo tutti, ma non ci è data se non in potenza: sta a noi scoprirla, faticare per costruirla e renderla forte e salda. Ma questo si può ottenere solo con gli strumenti di cui ti ho appena parlato: amore, umiltà e fede. Non certo con il diffusissimo culto dell’Ego, che rappresenta l’esatto contrario di questi valori, e che anzi è la precisa causa dello stato di cose di cui sopra! Non è un mistero che le persone veramente “grandi” sono normalmente molto umili e disponibili, mentre, dal punto di vista umano, le persone che si danno una grande importanza si rivelano spesso, al contrario, piccole piccole. La nostra unicità di esseri umani non è già data, ma si costruisce, grazie a un serio e duro lavoro di ricerca spirituale. Senza questa fatica, siamo tutti uguali, maschere senza volto, burattini senz’anima. Ma l’atteggiamento di autentica ricerca interiore presuppone la consapevolezza di una carenza, di una mancanza. Chi sente di possedere, non cerca ulteriormente, se non per avidità. Quindi la vera ricerca presuppone l’umiltà, il sapere di non essere qualcosa di già dato, bensì soltanto un progetto. E chi umilmente cerca in se stesso, umilmente riconoscerà di avere bisogno di aiuto, e umilmente si rivolgerà, quindi, al di fuori di sé, verso l’altro. E quest’apertura, consentita proprio dall’umiltà, cioè dalla svalutazione consapevole di ogni forma di importanza data a noi stessi, sarà il primo passo verso quella disposizione alla relazione con l’altro, alla comunicazione, allo scambio, che è alla base di tutte le varie forme dell’amore. Se poi quest’apertura, derivante dalla percezione del nostro limite, della nostra insufficienza, del nostro essere finiti, mortali, peccatori, diventa relazione con il mistero del divino, allora questa stessa apertura potrà a buon titolo essere chiamata fede. |
|
Post n°8 pubblicato il 06 Settembre 2009 da randagiamente
|
|
Post n°10 pubblicato il 17 Settembre 2009 da randagiamente
Botticelli, Natività mistica, London National Gallery. Tra i filosofi che più di altri sono normalmente considerati i più strenui paladini della Ragione come facoltà suprema dell'essere umano, e che per questo vengono semplicisticamente bollati di "razionalismo", un posto d'onore è sicuramente occupato da G. W. F. Hegel. La vera mistica, quella che deriva dalla tradizione platonica e neoplatonica, e attraverso i grandi maestri medioevali, Eckhart e Cusano, arriva fino a Giordano Bruno e a Spinoza, per essere poi ripresa dall’idealismo tedesco, si identifica senz’altro con la Filosofia. Il comune modo d’intendere i due termini come antitetici trae le sue origini dalla condanna di questi grandi maestri come atei e panteisti da parte delle religioni ufficiali, e la conseguente attribuzione del carattere di “mistico” solo alle varie manifestazioni “eccezionali”, attinenti al sentimentalismo religioso e a fenomeni visionari o “paranormali” di vario genere, che divenne orientamento generale a partire dalla “sconfitta della mistica” e dalla sua emarginazione dal mondo cattolico, che risale alla fine del Seicento. In realtà, tra la mistica speculativa e la vera filosofia non c’è alcuna differenza, come ci insegna tutta la meritoria opera di Marco Vannini, il quale, ad esempio, citando un passo dell’Etica di Spinoza, in cui si dice tra l’altro che «l’amore di Dio verso gli uomini e l’amore intellettuale della mente verso Dio sono una sola e medesima cosa», sinteticamente conclude: «Siamo qui, come è evidente, in presenza di un misticismo allo stato puro, che coincide con il perfetto razionalismo». |
|
Post n°15 pubblicato il 20 Settembre 2009 da randagiamente
http://firmiamo.it/gino-strada-nobel-per-la-pace clicca su questo indirizzo per firmare la petizione. |
|
Post n°16 pubblicato il 06 Gennaio 2010 da randagiamente
"La mia libertà finisce dove comincia la tua. Sembra un bel principio. In realtà proclama tutta l'insufficienza umana del liberalismo, libertà dei forti, e peggio che mai del liberismo, libertà dei divoratori. Significa, quel detto, che le nostre libertà sono separate: non si sostengono l'una con l'altra. Peggio, sono alternative: perché cominci la tua deve finire la mia. E quindi viceversa: perché io possa cominciare ad essere libero, tu devi finire di esserlo. Essere libero vuol dire non avere l'altro tra i piedi. E' la libertà dall'altro.” (Alessio Patti) Quando si leggono le tesi dei principali autori, cristiani o meno, sul libero arbitrio, e quindi sulla libertà dell’uomo, non si capisce mai bene quale sia il concetto di libertà cui essi si riferiscano. Sembra inoltre che l’idea stessa di cos’è l’uomo, e quando, a quali condizioni esso si possa chiamare tale, sia già data, e che la sua libertà non consista altro che nella possibilità di scegliere “arbitrariamente” e indifferentemente il bene o il male (questa è per lo più l’idea del libero arbitrio). La motivazione che viene addotta per giustificare questa concezione è che se l’uomo non fosse libero di scegliere il male non avrebbe alcun merito nello scegliere il bene, ossia che l’uomo “deve” essere libero di agire per il bene o per il male, altrimenti non avrebbero più senso la virtù o il peccato, la salvezza o la dannazione, il paradiso e l’inferno (concezione “retributiva” della morale). A me quest’idea di libero arbitrio sembra francamente orribile e molto poco “cristiana”. La sua origine, a mio avviso, sta nel senso di appartenenza ad un ristretto gruppo di “eletti”, i quali, essendo gli unici giusti, gli unici a conoscere il bene, pretendono di meritare (solo loro) la beatitudine eterna (che poi sarebbe una specie di “gratitudine” divina), mentre vorrebbero, più o meno inconfessabilmente, veder bruciare i “pagani” (tutto il resto dell’umanità, o giù di lì) tra le fiamme eterne dell’inferno. Mi spiego. Per definire cosa sia un uomo libero bisogna prima chiarire cos’è un uomo, e cosa lo renda libero, in cosa consista la sua libertà. Banalmente: un uomo è libero, innanzitutto, quando non è schiavo. Purtroppo non nasciamo tutti e sempre liberi, anche se è molto diffusa e quasi assiomaticamente accettata l’idea della libertà come tratto distintivo dell’essere umano. Invece, purtroppo, taluni (ahimè, la gran parte) nascono schiavi. Alcuni nascono in condizioni di assoluta miseria, nella difficoltà o impossibilità, talvolta, ad accedere alle più elementari, basilari necessità (cibo, acqua, vestiti, una casa). Altri invece queste necessità le vedono soddisfatte, ma solo queste: si può nascere in un paese più fortunato, ma essere ugualmente lontani dal fondamentale diritto ad un’infanzia ed un’adolescenza serene, essendo esposti ad un ambiente (certi quartieri, certe periferie, ad esempio, di moltissime grandi o piccole città in tutto il mondo) in cui si può crescere fisicamente, ma lo si fa immersi nell’abuso, nella sopraffazione, nella violenza, nell’ignoranza, nella delinquenza diffusa. Chiediamoci: un bambino che nasca e cresca in queste condizioni, quando avrà raggiunto la maggiore età sarà, solo per questo, nelle condizioni ottimali e sufficienti per poter essere definito un “uomo libero”? Sarà forse nelle condizioni ottimali per poter scegliere “a sua discrezione” il bene o il male? Qualcuno ha detto che “un bambino diventa ciò che vive”. Ma allora, che tipo di uomo diventerà chi ha la sventura di nascere e crescere in un ambiente in cui la “normalità” è rappresentata dalla violenza, dal sopruso, dall’ignoranza? Un uomo dovrebbe, innanzitutto, essere posto, fin dal momento della sua nascita, nelle condizioni di poter diventare “un uomo”. Un uomo, prima di essere “libero di”, deve essere “libero da”: dalla fame, dalla miseria, dalla violenza, dall’odio, dalla sopraffazione, dall’ignoranza. In una parola, come abbiamo visto, dal male. Allora, forse, si potrà parlare di “uomo libero”. Ma questa sua “libertà” coinciderà, appunto, con il suo esser libero dal male e, grazie a ciò, con il libero e pieno sviluppo della sua “umanità”. Un uomo non si può definire libero solo perché dispone della possibilità di fare questo o quello a suo arbitrio. Un uomo è libero quando ha avuto e ha la fortuna e la possibilità di sviluppare appieno le sue potenzialità di essere umano. Un uomo sarà tanto più libero quanto più crescerà circondato e avvolto dall’affetto di una famiglia, in un ambiente in cui poter trovare attenzione, rispetto, stimoli positivi, incoraggiamento, sostegno, incitamento a dare il meglio di sé. In una parola, amore. Se entriamo in quest’ottica, vedremo allora come sia stridente e assurda l’idea del libero arbitrio. Direi che l’espressione stessa diventa un ossimoro. La vera libertà è libertà dall’arbitrio. Libertà non significa possibilità di scegliere il male, ma trovarsi nelle condizioni in cui sia possibile (e a quel punto diventi semplice e naturale) scegliere il bene. Ripeto: un uomo libero non è tale in quanto “libero di”, ma in quanto “libero da”. In quanto libero dal male. Si potrebbe obiettare che le condizioni di grave disagio da noi indicate non possono portare fatalmente ed immancabilmente ad un certo ben preciso esito, in quanto rimane sempre e comunque, anche se tra le mille difficoltà del caso, uno spazio, per quanto esiguo, alla libera scelta del singolo. Qui l’argomentazione deve essere attenta. Noi non stiamo negando che questo spazio esista. Stiamo negando che esso coincida con il concetto classico di libero arbitrio. La libertà non è quella “situazione felice” che ci consente di scegliere indifferentemente, a nostro piacimento, il bene o il male. La libertà è il bene. Certamente, anche chi si trova a vivere nelle condizioni più disagiate può arrivare a scegliere il bene. Ma lo fa nell’esatto istante in cui sceglie di essere libero. La libertà non è il presupposto per la scelta del bene, ne è piuttosto la conseguenza.[1] La libertà non è, come tanti pensano, un tratto originario dell’umanità. Se esiste un tratto originario, è più credibile che esso sia la schiavitù, basti pensare ad un neonato umano, che, a differenza di quasi tutte le specie animali, possiede, alla nascita, un grado di autonomia pressoché nullo, dipendendo totalmente da altri per tutte le proprie necessità, anche le più basilari. Un cucciolo di cane o di gatto vanno autonomamente verso la mammella della madre, mentre il cucciolo d'uomo non sa fare nemmeno questo. La libertà, quindi, non è qualcosa di già dato, fin dall’inizio. Al contrario, la libertà è un affrancarsi dalla schiavitù, è lo sviluppo graduale di un'autonomia, una conquista, faticosamente costruita, mattone su mattone, dal nostro costante impegno e dalla nostra inesausta tensione al bene. Inoltre: siamo esseri mortali. Quando scegliamo, lo facciamo sempre nel dubbio e nell’incertezza. Quante volte, in tutta la nostra vita, abbiamo la fortuna di fare una scelta nell’assoluta certezza e sicurezza di scegliere per il bene? Ossia, quando mai accade, nella vita di un uomo, di incontrare e riconoscere in maniera inequivocabile il “bene” (un bene che non sia il nostro solito bene condizionato, limitato, valido per noi o per qualcuno che ci è vicino, che però spesso, fatalmente, viene a coincidere con il male per qualcun altro)? Azzardo: mai. Freud sosteneva che, svolgendosi la nostra vita interiore per il 90% a livello inconscio e solo per il rimanente 10% nella coscienza, le nostre azioni sono nella stessa proporzione determinate da motivi inconsci, che poi abbiamo il nostro bel daffare a interpretare coscientemente e giustificare razionalmente. I motivi veri delle nostre scelte ci rimangono per lo più sconosciuti, e il vero “intellettualismo etico” è quello di chi pensa che ogni nostra azione sia pensata e voluta consapevolmente. La nostra volontà ha una libertà d’azione enormemente più limitata di quanto non pensi la stragrande maggioranza dei filosofi.[2] Quando scegliamo, siamo sempre “strattonati” da ogni parte, dai nostri istinti, dai nostri desideri, dalle nostre pulsioni, passioni, emozioni. Dai nostri pregiudizi, dai nostri sensi di colpa. Il nostro bene non è mai un bene assoluto, ma sempre un bene finito, relativo. Relativo perché limitato, relativo perché riguarda sempre qualcuno che ci è caro, o noi stessi. Può corrispondere a ciò che io considero bene per me, in quel determinato momento, in quella determinata situazione. Ma può, allo stesso tempo, essere male per chi mi sta vicino, e io posso anche non rendermene conto, perché sono solo un essere umano, esposto a fraintendimenti ed errori. Si può fare il male (e anche il bene) senza volerlo. Oppure si può sceglierlo, volerlo e cercarlo, ma allora, vi chiedo nuovamente: pensate che chi agisce in questo modo sia una persona “libera”? Tutt’altro. Il male, verso gli altri o verso se stessi, viene scelto sempre e solo a causa di una carenza di libertà. Chi fuma sa di farsi del male, ma continua a farlo perché, come si dice comunemente, è “schiavo del fumo”. Il male è un deficit di libertà. Il male è una carenza. Principalmente d’amore. Chi vive nell’amore non è affatto “libero” di scegliere il male, perché la libertà esiste solo nell’amore, e scegliere il male vorrebbe dire rinunciare alla propria stessa libertà, e rendersi schiavo. La Libertà è solo nell’amore, e si definisce solo come possibilità di riscattarci dal male. Chi ama veramente è “libero dal male”, così come dal “bene relativo”, perché desidera, vuole, brama, solo il bene non per sé, ma “di per sé”. In questo senso, “libero arbitrio” è un ossimoro, perché il concetto di libertà che abbiamo descritto fa a pugni con l’arbitrio. L’uomo libero è, innanzitutto e soprattutto, libero dal male. Il Dio del libero arbitrio è un dio che ci mette alla prova, un po’ perfido, tendendoci sempre qualche trabocchetto, un dio che ci interroga, e ci promuove o ci boccia a seconda di come gli rispondiamo. Ma il Dio che noi preghiamo, invece, è un buon padre, il Padre Nostro, cui chiediamo, con fiducia e speranza: “... e non c’indurre in tentazione, ma liberaci dal male.” Amen. [1] Non ho ancora incontrato, a tutt’oggi, un pensatore che abbia concepito in questo modo l’idea di libertà. Sarei grato a chi avesse suggerimenti in merito… [2] Sbaglia quindi, a mio avviso, anche Kierkegaard, quando critica le tesi socratiche argomentando che se esse fossero vere il male non esisterebbe. E sbaglia per difetto, vedendo cioè solo la metà del problema: non solo il male assoluto in realtà non esiste, ma nell’agire dell’uomo perlopiù non esiste nemmeno il bene, proprio perché in realtà non esiste, o quantomeno è sempre molto insufficiente, la consapevolezza dei veri motivi che ci portano ad agire in un modo piuttosto che in un altro! È questo che aveva intuito Kant quando scrisse: “forse non è mai esistita un’azione veramente morale”. |
|
Post n°17 pubblicato il 09 Aprile 2010 da randagiamente
Ogni discorso sul dono s’imbatte in modo quasi ineluttabile in alcuni termini che all’idea del dono stesso sono strettamente correlati. Due fra questi, probabilmente i più importanti, sono “reciprocità” e “riconoscimento”. Nell’ambito di approcci che hanno rivelato esiti anche molto diversi tra loro, come quello sociologico e quello più strettamente filosofico, si è parlato molto del problema della reciprocità, nella discussione, che ha attraversato quasi tutto il Novecento, sul tema del dono. Il dono è stato persino definito da qualcuno, in modo vago ma difficilmente confutabile, “una qualche forma di reciprocità”, in base all’osservazione che difficilmente esiste un atto di donazione che non presupponga, anche se dilazionata nel tempo, una qualche necessità di ricambiare il dono con un contro-dono da parte del beneficiario iniziale, il quale, nel momento stesso in cui accetta ciò che gli viene offerto, viene a trovarsi immediatamente in una condizione di debito verso il donatore. Ma esiste a mio avviso un’incongruenza in questo tipo di osservazione. Un conto è ricercare, come spesso è stato fatto, l’origine del fenomeno del dono, tramite indagini di antropologia culturale, in cui si sono analizzati fondamentalmente i rituali di popolazioni arcaiche. Altro è, invece, cercare di definire ciò che costituisce l’essenza dell’esperienza di dono. Partiamo, perseguendo questo secondo obiettivo, dal presupposto che, per cercare l’essenza di un concetto, bisogna purificarlo da ogni elemento inquinante. Se vogliamo, e secondo me dobbiamo, definire il dono in contrapposizione al semplice scambio di tipo commerciale, che ne costituisce non il contrario, ma il contraddittorio, allora dobbiamo innanzitutto mettere in risalto l’aspetto che più di ogni altro rappresenta la differenza cardine tra i due fenomeni. E ci sembra di poter identificare questo aspetto nell’implicazione di tipo emotivo, che caratterizza, o meglio, dovrebbe sempre caratterizzare, ogni vero atto di dono. Non si può, infatti, pretendere di giungere all’essenza di alcunché, fondando l’analisi sulle sue patologie e anomalie. Al di là delle frequenti dilatazioni e degenerazioni del concetto, l’atto donante in senso proprio deve investire innanzitutto un imprescindibile aspetto emozionale. E in tale atto, per definizione compiuto per-altri, non deve essere presente alcun risvolto utilitaristico, alcun per-sé, pena il suo slittamento verso qualcosa d’altro, che non può più essere chiamato dono. Se il dono è puro, e lo è quando l’intenzione donante è pura, esso è rivolto non certo ad una persona qualunque, ma ad una persona che viene ritenuta degna e meritevole della nostra attenzione, del nostro rispetto, della nostra stima, del nostro amore. Il vocabolario stesso utilizzato dagli autori che hanno parlato del dono è lo stesso vocabolario dell’amore. Il dono puro è rivolto ad una persona che riveste un’importanza che va salvaguardata, curata. Una persona cui si “vuole bene”, per la quale, cioè, si desidera il bene. Il primo e più immediato significato del dono è proprio questo simboleggiare e rappresentare, attraverso un oggetto perlopiù materiale, questi nostri sentimenti, trasposti nell’oggetto stesso, nei confronti di una persona che ai nostri occhi incarna una qualche forma di valore. Il dono quindi implica, innanzitutto ed essenzialmente, un riconoscimento di valore nei confronti del donatario. La dinamica del dono però, come qualcuno ha sottolineato, si regge sui tre momenti della donazione, dell’accettazione e dello sdebitamento. E, come si è giustamente detto, perché tale meccanismo sociale funzioni, questi tre momenti sono tutti necessari, in un certo senso obbligatori. Ma questo tema dell’obbligo ad accettare e successivamente a ricambiare ha portato più di qualcuno fuori strada nelle sue considerazioni sul fenomeno del dono. M. Mauss, autore del famoso “Saggio sul dono” del 1923, intravede nel fenomeno del dono una sorta di equilibrio tra obbligo e libertà. Equilibrio concettualmente ben problematico, visto che i due termini sono pressoché antitetici. Infatti il dono, ben lungi dall’essere vincolato da obblighi, è essenzialmente un atto libero, e questa libertà è simboleggiata proprio dalla dilazione, anch’essa elemento tipico di ogni donazione. Non si è fatto, a mio avviso, abbastanza attenzione a questo aspetto, che invece è uno dei più caratteristici e specifici dell’atto donante, il quale non può accettare una restituzione immediata, pena il suo snaturarsi in scambio, e in tal modo svilirsi. Fanno eccezione certi casi particolari, ad esempio le visite ufficiali tra personaggi con alte cariche istituzionali, in cui è prevista una cerimonia di scambio di doni, oppure anche, in ambito familiare, il caso simile ma eccezionale costituito dal Natale. Se esistesse un vero e proprio obbligo codificato, il ricambiare avverrebbe immediatamente. Ma in tal caso si perderebbero proprio quelle peculiarità che meglio di tutte le altre contraddistinguono il dono rispetto, appunto, al semplice scambio: la sorpresa, la libertà e la gratuità del gesto. La dilazione dello “sdebitamento”, invece, è proprio l’elemento che sta a simboleggiare la volontà di mantenere il donatario, almeno formalmente, libero dall’obbligo di ricambiare, in modo tale che, quando la restituzione, attraverso il contro-dono, avverrà, essa avrà i caratteri di un nuovo dono, e non dello “sdebitamento”, termine che abbiamo mantenuto tra virgolette in quanto fuorviante.
Se quindi, come abbiamo detto, l’elemento forse principale implicato nell’atto del dono nella sua espressione più pura è il riconoscimento del valore dell’altro, ecco che l’idea che prima sembrava costituire un problema, cioè come tenere insieme la gratuità e la libertà del dono con una sorta di “reciprocità obbligata”, si può forse sciogliere con questa considerazione: chi dona opera implicitamente un riconoscimento di valore nei riguardi del beneficiario, e questo stesso riconoscimento implica necessariamente la formale salvaguardia, da parte del donatore, della libertà dalla restituzione del donatario. Ma, allo stesso tempo, chi dona si aspetta, si potrebbe dire che esige, parallelamente, l’accettazione e la valorizzazione del suo dono, cioè uno speculare giudizio di valore relativo al gesto compiuto. E poiché nel dono stesso è presente in qualche modo la persona del donatore, essendo l’oggetto una certa proiezione di chi lo dona, l’accettazione del dono e l’attribuzione di valore al gesto implicano contemporaneamente un conferimento di valore al donatore. Ecco che allora la forma della reciprocità viene a coinvolgere non tanto e non direttamente il gesto del dono in sé, ma l’atto del reciproco riconoscimento. L’atto donante e l’aspetto della reciprocità sono quindi tenuti insieme dalla figura intermedia del riconoscimento di valore reciproco e dal formale riconoscimento della reciproca libertà dalla restituzione.
Ogni relazione tra persone è un processo dinamico. E ogni processo dinamico, di qualunque genere esso sia, così come qualsiasi forma di vita organica, ha bisogno di essere alimentato per continuare a sussistere. Una relazione, esattamente come un essere vivente, ha bisogno di essere nutrita e ha bisogno di respirare. E la dinamica del dono è l’aria fresca di cui ogni relazione ha bisogno per sopravvivere. Una solida strutturazione di un io stabile e capace di amare è stata collegata da Melanie Klein[1] al sentimento della gratitudine provato durante l’infanzia da chi è stato accudito e a sua vota amato. Durante la propria storia, questo io avrà la possibilità stabilizzarsi e consolidarsi, alternando in modo sempre più consapevole processi di introiezione e di proiezione di una ricchezza interiore che verrà così elargita e re-introiettata, in modo sempre più sicuro. Anche l’io infatti, o la coscienza, sono processi dinamici, che vanno nutriti per rafforzarsi. Anche l’io ha bisogno di alimentarsi e di respirare. Quell’alternanza che la Klein identifica, di introiezione e proiezione, non è altro che l’alternanza del respiro dell’io vivente. Ma diciamolo meglio: non è corretto dire che l’io ha bisogno di questi scambi continui con il suo ambiente per vivere. L’io, in realtà, consiste in questi scambi. L’io è definibile solo come relazione, quindi è, propriamente, questa relazione continua. L’io è il suo stesso respiro. Il reciproco riconoscimento è il fondamento di ogni forma di relazione, il primo passo dell’uno verso l’altro per andare ad aprire insieme, ogni volta, un nuovo orizzonte di significato ad un’esistenza che non si può mai, in alcun modo, considerare né definire prescindendo dal costante rapporto con l’altro da sé. Vivere significa essere in relazione. La vita è relazione. Relazione di dipendenza da chi dà a noi la vita, inizialmente. E poi costruzione, col tempo, di una possibilità di relazione sempre più bilanciata nel computo del dare-avere, sino a giungere, con la crescita e la maturazione personale, alla capacità di una relazione puramente donativa, in cui il piacere di dare sia la regola e la misura della nostra capacità di amore verso chi ci è caro. Il lungo percorso che ci porta lentamente alla nostra maturazione come esseri umani è il cammino verso relazioni in cui la nostra autonomia si afferma nella capacità di dare anziché chiedere. Il percorso più autentico dell’essere umano è un cammino di apertura, un cammino verso l’amore. Il cammino verso il dono di sé.
[1] M. Klein, Invidia e gratitudine, 1957, trad. it. di L. Zeller Tolentino, G. Martinelli, Firenze 1985. |
|
Post n°18 pubblicato il 22 Novembre 2010 da randagiamente

Prima di figliare, il tempo riposava in seno all’Essere, come pura idea. Entrò allora un potere senza pace, l’Anima, vogliosa di trasferire in un diverso la visione suprema. Essa non era paga che la totalità del mondo ideale le fosse presente in blocco e in eternità, ma voleva poterla vedere a frammenti e a successioni: così ella pose nel tempo se stessa e impose alla creatura del mondo di servire il tempo in cui l’aveva immersa. (Plotino, Enneadi, III, 7, 11)
Con l’anima, dunque, cessa l’immobilità dell’essere, per quel divenire temporale che gli atti creativi scandiscono senza calcolo e riflessione alcuna. La creazione, dice Plotino, “non è intelligente”, non conosce nessi logici e con-seguenze “perché è prima di ogni nesso e di ogni conseguenza”, perciò scorre senza fatica e con esuberanza, al di fuori di ogni calcolo, in nulla simile ai geometri che disegnano i loro piani, perché “io non faccio figure di sorta, ma contemplo; e le linee dei corpi si disegnano come se cadessero da me”. Estranea all’immobilità del concetto, per la quale le cose sono date nel loro significato una volta per sempre, “l’anima non è mai vecchia per le cose, così come le cose non sono mai vecchie per l’anima”. Ma per questo è necessario che le cose trasgrediscano le loro definizioni e si offrano come irradiazioni di immagini rinvianti a quel futuro che non è tanto il tempo che ancora ci attende, quanto quell’ulteriorità di senso che anche le più comuni esperienze non cessano di diffondere; per questo con l’anima “andiamo con stupore di fronte all’inconsueto, senza cessare di stupirci anche delle nostre esperienze già note”. Le esperienze dell’anima, infatti, sfuggono a qualsiasi tentativo di fissarle e disporle in successione ordinata, perché, al di là di ogni progetto razionale, l’anima sente che la totalità è sfuggente, che il non-senso contamina il senso, che il possibile eccede sul reale, e che ogni progetto che tenta la comprensione e l’abbraccio totale è follia. Nel riconoscimento di questa follia è la libertà dell’anima e la sua possibilità più propria. Amica del “demone maligno” che insidia il cogito cartesiano, l’anima fa resistenza a ogni razionalizzazione, perciò in Occidente è straniera. Il Dio che essa conosce non è il Dio che è uscito da un cogito a garanzia delle idee della ragione, ma è un Dio che non ci protegge dalla follia, e perciò consente di recuperare la sorgente a partire dalla quale ragione e follia hanno la possibilità di determinarsi e di dirsi. Questa sorgente è il simbolo, che, nel suo sorgere ambi-valente, è linguaggio dell’anima.
U. Galimberti, La terra senza il male (adattato).
|
INTENZIONI
Mi piace immaginare questo blog come un luogo di magia.
La magia che si cela in ogni nuovo incontro, in ogni nuovo scambio, in ogni neonato rapporto tra esseri umani.
Vorrei che chi passa di qui lasciasse un semino su questa terra. Io mi impegno a inumidirlo. Fra tanti, magari, qualcuno germoglierà e fiorirà. Ma dev'essere un semino autentico, non riciclato. Una piccolissima parte di voi.
Qui sopra c'è una dicitura pretenziosa: consulenza filosofico-esistenziale. Non sorridete, mettetevi in gioco. Non fate discorsi intelligenti, ma discorsi veri. Raccontate le vostre gioie e le vostre cicatrici, anziché esibirvi in pubbliche masturbazioni mentali (per quello basto io...). Ci capiremo. E sarà bello, ve lo assicuro.
r.
"BUON SENSO..."
"Quando più di due persone si dicono d'accordo con me, comincio a temere di aver detto qualche idiozia..." (O. Wilde)

AMORE E VOLONTà
"L'anima nobile, l'anima che ama infinitamente, non ha più volontà, è disappropriata di se stessa e del suo volere. Chi vuole non ama. La fine della volontà, che è sempre e comunque egoistica, significa fine dell'amore come desiderio. Ma se questa fine avviene per la traboccante ricchezza dell'amore stesso, l'anima cessa di amare perché diventa essa medesima Amore." (M. Vannini, Il volto del Dio nascosto)
AMORE E RAGIONE
La ragione discrimina, l’amore assimila.
La ragione separa e distingue, l’amore fonde e confonde.
La ragione difende, l’amore si arrende.
La ragione si arrocca e s’impone, l’amore cede senza condizione.
La ragione definisce e chiarisce, l'amore sfuma contorni e colori
di un mondo sognante.
AMORE E UMILTà
L’amore nasce solo quando e se l’io fa un passo indietro, passo che consiste nell’anteporre il bene di un altro al nostro. Ma ciò non si verifica se non attraverso l’umiltà. Chi s’impone non ama, questa è una verità semplice ma inconfutabile. Il che non significa doversi porre in una condizione di inferiorità o sudditanza, ma anzi in una posizione molto diversa, che consiste in una capacità di accettazione incondizionata, priva di giudizio e di pregiudizio, atteggiamento concesso esclusivamente alle persone forti, perché, al contrario, non c’è persona più fragile e meschina di chi ha bisogno di imporsi sugli altri per affermare se stesso. Laddove invece l’umiltà, che pur viene spesso scambiata dagli ignoranti per arrendevolezza e passività, è, al contrario, la virtù di chi veramente sa dare e sa darsi.
SI AMA ANCHE SENZA CONOSCERE
"Amo una cosa sola, e non so cosa sia:
perché non la conosco, per questo io l’ho scelta."
(A. Silesius, Il pellegrino cherubico)
PER TUTTI I SUPERSTIZIOSI CHE SI DICONO CREDENTI
"Non voglio aver nulla a che fare con un amore che sia per Dio o in Dio. Questo è un amore che il puro amore non può tollerare; perché il puro amore è Dio stesso." (S. Caterina da Genova)
SENZA PERCHé
Non ha un perché la rosa: fiorisce perché fiorisce, questo è tutto. Non bada a sé e non chiede se qualcuno la vede. (A. Silesius, Il pellegrino cherubico)
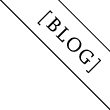






Inviato da: princi2008
il 03/08/2013 alle 12:57
Inviato da: randagiamente
il 02/04/2013 alle 08:31
Inviato da: princi2008
il 31/03/2013 alle 17:22
Inviato da: randagiamente
il 19/09/2009 alle 17:23
Inviato da: lisa
il 19/09/2009 alle 15:43