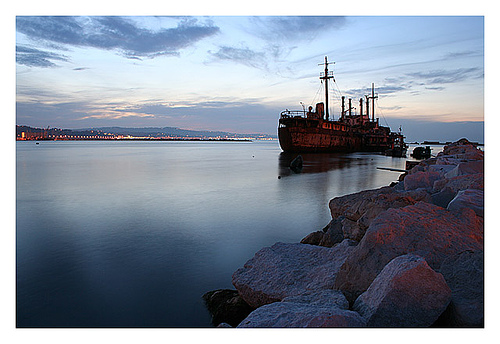«Questa è terra russa» Sono stati uccisi padri davanti ai figli, figli davanti ai padri
Bernard-Henri Lévy
20 agosto 2008
 La prima cosa che colpisce appena si esce da Tbilisi è l'inquietante assenza di qualsiasi forza militare. Avevo letto che l'esercito georgiano, sconfitto in Ossezia, poi sbaragliato a Gori, aveva ripiegato sulla capitale per difenderla. Ebbene, giungo nei sobborghi della città. Avanzo di 40 chilometri sull'autostrada che taglia il Paese da Est a Ovest. Di questo esercito che si ritiene essersi concentrato per opporre una resistenza accanita all'invasione, quasi non si vede traccia. Qui c'è un posto di polizia. Più lontano, un gruppo di soldati in uniformi troppo nuove. Ma non un'unità combattente. Non un pezzo di difesa antiaerea. Nemmeno quel paesaggio di blocchi e sbarramenti che, in tutte le città assediate del mondo, dovrebbero ritardare l'avanzata del nemico. Un dispaccio annuncia che i carri armati russi si dirigono verso la capitale. L'informazione, ritrasmessa dalle radio e alla fine smentita, crea un disordine incredibile e fa sì che le rare automobili che si erano avventurate fuori della città tornino indietro. Ma il potere, stranamente, sembra aver abbassato le braccia. Forse l'esercito georgiano c'è, ma è nascosto? Pronto a intervenire, ma invisibile? Siamo in una guerra dove l'astuzia suprema è, come nelle guerre dimenticate d'Africa, di apparire il meno possibile? O il Presidente Saakashvili ha scelto di non combattere, come per mettere europei e americani davanti alla proprie responsabilità e alle proprie scelte («pretendete d'essere nostri amici? Ci avete detto cento volte che con le nostre istituzioni democratiche e il nostro desiderio d'Europa il nostro governo — in cui siedono (fatto unico negli annali) un primo ministro anglo-georgiano, ministri americano-georgiani, un ministro della difesa israelo-georgiano - era il primo della classe occidentale? Ebbene, è il momento di provarlo»)? Il fatto è che la prima presenza militare significativa nella quale ci imbattiamo è un lungo convoglio russo, almeno cento veicoli, giunto tranquillamente a rifornirsi di benzina in direzione di Tbilisi. Poi, a quaranta chilometri dalla città, all'altezza di Okami, ecco un battaglione, sempre russo, appoggiato da un'unità di blindati che ha il compito di impedire il passaggio ai giornalisti in una direzione e ai profughi nell'altra. Uno dei profughi, un contadino ferito alla fronte ancora inebetito dal terrore, mi racconta la storia di questo villaggio, in Ossezia, da dove è fuggito a piedi tre giorni fa. I russi sono arrivati. Sulla loro scia, le bande di osseti e cosacchi hanno saccheggiato, violentato, assassinato. Come in Cecenia, hanno raggruppato giovani uomini e li hanno imbarcati in camion verso destinazioni sconosciute. Sono stati uccisi padri davanti ai figli. Figli davanti ai padri. Nelle cantine di una casa fatta saltare con bombole di gas, si è scoperta una famiglia che è stata depredata di tutto quello che aveva tentato di nascondere, si sono fatti mettere gli adulti in ginocchio prima di giustiziarli con una pallottola in piena testa. L'ufficiale russo, responsabile del check point, ascolta. Ma se ne infischia. Ha l'aria di chi ha bevuto troppo e se ne infischia. Per lui, la guerra è finita. Nessun pezzo di carta — cessate il fuoco, accordo in cinque o sei punti — cambierà nulla alla sua vittoria. E quel poveraccio di profugo può raccontare quel che vuole.
La prima cosa che colpisce appena si esce da Tbilisi è l'inquietante assenza di qualsiasi forza militare. Avevo letto che l'esercito georgiano, sconfitto in Ossezia, poi sbaragliato a Gori, aveva ripiegato sulla capitale per difenderla. Ebbene, giungo nei sobborghi della città. Avanzo di 40 chilometri sull'autostrada che taglia il Paese da Est a Ovest. Di questo esercito che si ritiene essersi concentrato per opporre una resistenza accanita all'invasione, quasi non si vede traccia. Qui c'è un posto di polizia. Più lontano, un gruppo di soldati in uniformi troppo nuove. Ma non un'unità combattente. Non un pezzo di difesa antiaerea. Nemmeno quel paesaggio di blocchi e sbarramenti che, in tutte le città assediate del mondo, dovrebbero ritardare l'avanzata del nemico. Un dispaccio annuncia che i carri armati russi si dirigono verso la capitale. L'informazione, ritrasmessa dalle radio e alla fine smentita, crea un disordine incredibile e fa sì che le rare automobili che si erano avventurate fuori della città tornino indietro. Ma il potere, stranamente, sembra aver abbassato le braccia. Forse l'esercito georgiano c'è, ma è nascosto? Pronto a intervenire, ma invisibile? Siamo in una guerra dove l'astuzia suprema è, come nelle guerre dimenticate d'Africa, di apparire il meno possibile? O il Presidente Saakashvili ha scelto di non combattere, come per mettere europei e americani davanti alla proprie responsabilità e alle proprie scelte («pretendete d'essere nostri amici? Ci avete detto cento volte che con le nostre istituzioni democratiche e il nostro desiderio d'Europa il nostro governo — in cui siedono (fatto unico negli annali) un primo ministro anglo-georgiano, ministri americano-georgiani, un ministro della difesa israelo-georgiano - era il primo della classe occidentale? Ebbene, è il momento di provarlo»)? Il fatto è che la prima presenza militare significativa nella quale ci imbattiamo è un lungo convoglio russo, almeno cento veicoli, giunto tranquillamente a rifornirsi di benzina in direzione di Tbilisi. Poi, a quaranta chilometri dalla città, all'altezza di Okami, ecco un battaglione, sempre russo, appoggiato da un'unità di blindati che ha il compito di impedire il passaggio ai giornalisti in una direzione e ai profughi nell'altra. Uno dei profughi, un contadino ferito alla fronte ancora inebetito dal terrore, mi racconta la storia di questo villaggio, in Ossezia, da dove è fuggito a piedi tre giorni fa. I russi sono arrivati. Sulla loro scia, le bande di osseti e cosacchi hanno saccheggiato, violentato, assassinato. Come in Cecenia, hanno raggruppato giovani uomini e li hanno imbarcati in camion verso destinazioni sconosciute. Sono stati uccisi padri davanti ai figli. Figli davanti ai padri. Nelle cantine di una casa fatta saltare con bombole di gas, si è scoperta una famiglia che è stata depredata di tutto quello che aveva tentato di nascondere, si sono fatti mettere gli adulti in ginocchio prima di giustiziarli con una pallottola in piena testa. L'ufficiale russo, responsabile del check point, ascolta. Ma se ne infischia. Ha l'aria di chi ha bevuto troppo e se ne infischia. Per lui, la guerra è finita. Nessun pezzo di carta — cessate il fuoco, accordo in cinque o sei punti — cambierà nulla alla sua vittoria. E quel poveraccio di profugo può raccontare quel che vuole.
Vicino a Gori, la situazione è diversa e improvvisamente diventa tesa. Ai margini della  strada, jeep georgiane nei fossati. Più lontano, un tank carbonizzato. Ancora più lontano, un check point più importante del precedente, che blocca il gruppo di giornalisti al quale ci siamo uniti. Soprattutto, ci dicono chiaramente che ora non siamo più i benvenuti. «Siete in territorio russo — abbaia un ufficiale gonfio d'importanza e di vodka —. Può andare avanti solo chi è accreditato dalle autorità russe». Per fortuna, sbuca un'auto del corpo diplomatico. È dell'ambasciatore dell'Estonia. A bordo, oltre all'ambasciatore, c'è il Segretario del Consiglio Nazionale di Sicurezza, Alexander Lomaia, che ha l'autorizzazione di andare a cercare i feriti dietro alle linee russe, e accetta di farmi salire in macchina insieme alla deputata europea Isler-Beguin e a una giornalista del Washington Post. «Non posso garantire la sicurezza di nessuno, previene. È chiaro?». È chiaro. E ci stringiamo nell'Audi che si dirige verso Gori. Dopo altri sei check point, arriviamo a Gori. Non siamo al centro della città. Ma dal punto in cui Alexander Lomaia ci ha lasciati prima di ripartire, da solo, per recuperare i feriti, possiamo vedere incendi a perdita di vista. I razzi illuminanti che, a intervalli, rischiarano il cielo e sono seguiti da brevi detonazioni. Ancora il vuoto. Odore di putrefazione e di morte. Poi, l'incessante rimbombo di blindati e auto civili piene di miliziani riconoscibili dalla fascia bianca attorno al braccio e dai capelli trattenuti da una bandana. Gori non appartiene a quell'Ossezia che i russi pretendono di essere venuti a «liberare». È una città georgiana. Ebbene, l'hanno bruciata. Saccheggiata. Ridotta a città fantasma. Svuotata. «È logico, spiega il generale Vyachislav Borisov, mentre nel fetore e nella notte aspettiamo in piedi il ritorno di Lomaia. Siamo qui perché i georgiani sono degli incapaci, la loro amministrazione è crollata e la città era in preda ai saccheggiatori. Guardate...». E su un cellulare mi mostra alcune foto di armi, di cui sottolinea pesantemente l'origine israeliana. «Credete forse che potevamo lasciare questo bazar senza sorveglianza?». Nell'accendersi una sigaretta fa sussultare il piccolo carrista biondo che si era addormentato nella torretta. «Abbiamo convocato a Mosca il ministro degli Esteri israeliano. Gli è stato detto che, se continuava a rifornire i georgiani, noi avremmo continuato a rifornire Hezbollah e Hamas». Avremmo continuato...Che confessione! Passano due ore. Due ore di sbruffonate e di minacce. Finché torna Lomaia e ci affida un'anziana signora e una donna incinta che ha portato via dall'inferno incaricandoci di accompagnarle a Tbilisi.
strada, jeep georgiane nei fossati. Più lontano, un tank carbonizzato. Ancora più lontano, un check point più importante del precedente, che blocca il gruppo di giornalisti al quale ci siamo uniti. Soprattutto, ci dicono chiaramente che ora non siamo più i benvenuti. «Siete in territorio russo — abbaia un ufficiale gonfio d'importanza e di vodka —. Può andare avanti solo chi è accreditato dalle autorità russe». Per fortuna, sbuca un'auto del corpo diplomatico. È dell'ambasciatore dell'Estonia. A bordo, oltre all'ambasciatore, c'è il Segretario del Consiglio Nazionale di Sicurezza, Alexander Lomaia, che ha l'autorizzazione di andare a cercare i feriti dietro alle linee russe, e accetta di farmi salire in macchina insieme alla deputata europea Isler-Beguin e a una giornalista del Washington Post. «Non posso garantire la sicurezza di nessuno, previene. È chiaro?». È chiaro. E ci stringiamo nell'Audi che si dirige verso Gori. Dopo altri sei check point, arriviamo a Gori. Non siamo al centro della città. Ma dal punto in cui Alexander Lomaia ci ha lasciati prima di ripartire, da solo, per recuperare i feriti, possiamo vedere incendi a perdita di vista. I razzi illuminanti che, a intervalli, rischiarano il cielo e sono seguiti da brevi detonazioni. Ancora il vuoto. Odore di putrefazione e di morte. Poi, l'incessante rimbombo di blindati e auto civili piene di miliziani riconoscibili dalla fascia bianca attorno al braccio e dai capelli trattenuti da una bandana. Gori non appartiene a quell'Ossezia che i russi pretendono di essere venuti a «liberare». È una città georgiana. Ebbene, l'hanno bruciata. Saccheggiata. Ridotta a città fantasma. Svuotata. «È logico, spiega il generale Vyachislav Borisov, mentre nel fetore e nella notte aspettiamo in piedi il ritorno di Lomaia. Siamo qui perché i georgiani sono degli incapaci, la loro amministrazione è crollata e la città era in preda ai saccheggiatori. Guardate...». E su un cellulare mi mostra alcune foto di armi, di cui sottolinea pesantemente l'origine israeliana. «Credete forse che potevamo lasciare questo bazar senza sorveglianza?». Nell'accendersi una sigaretta fa sussultare il piccolo carrista biondo che si era addormentato nella torretta. «Abbiamo convocato a Mosca il ministro degli Esteri israeliano. Gli è stato detto che, se continuava a rifornire i georgiani, noi avremmo continuato a rifornire Hezbollah e Hamas». Avremmo continuato...Che confessione! Passano due ore. Due ore di sbruffonate e di minacce. Finché torna Lomaia e ci affida un'anziana signora e una donna incinta che ha portato via dall'inferno incaricandoci di accompagnarle a Tbilisi.
 Il presidente Saakashvili, affiancato dal suo consigliere Daniel Kunnin, ascolta il mio racconto. Siamo nella residenza presidenziale di Avlabari. Sono le due del mattino, ma i suoi consiglieri sono efficienti come in pieno giorno. È giovanissimo. Di una giovinezza rivelata dall'impazienza dei gesti, lo sguardo febbrile, i bruschi scoppi di risa. Del resto, tutti sono molto giovani. Ministri e consiglieri sono borsisti di fondazioni tipo quella di Soros, i cui studi a Yale, Princeton, Chicago sono stati interrotti dalla Rivoluzione delle Rose. È francofilo e francofono. Appassionato di filosofia. Democratico. Europeo. Liberale nel duplice senso — americano ed europeo — della parola. Di tutti i grandi Resistenti che ho incontrato nella mia vita, di tutti i Massud o Izetbegovic di cui ho preso le difese, è quello più evidentemente estraneo all'universo della guerra, ai suoi riti, ai suoi emblemi, alla sua cultura. Ma vi fa fronte. «Lasciatemi precisare una cosa, mi interrompe con improvvisa gravità...Non bisogna lasciar dire che siamo stati noi a iniziare la guerra...Siamo al principio di agosto. I miei ministri sono in vacanza. Io mi trovo in Italia, per una cura dimagrante e sono sul punto di partire per Pechino. Ecco che, sulla stampa italiana, leggo: «Preparativi di guerra in Georgia». Ha capito bene: sono lì, tranquillo, in Italia e leggo che il mio Paese sta preparando una guerra! Sentendo che c'è qualcosa che non va, torno subito a Tbilisi. E cosa vengo a sapere dai miei servizi segreti? Che i russi, nel momento stesso in cui riempiono le agenzie stampa di queste chiacchiere, stanno svuotando Tskhinvali dei suoi abitanti, ammassano truppe, trasporti di truppe, addetti al rifornimento di nafta in territorio georgiano e fanno passare colonne di carri armati attraverso il tunnel Roki, che separa le due Ossezie. Allora, supponga di essere responsabile di un Paese e di apprendere tutto questo. Che fare?». Si alza, risponde a due cellulari che suonano contemporaneamente, ritorna, stira le gambe. «Al centocinquantesimo carro armato posizionato di fronte alle vostre città, si è obbligati ad ammettere che la guerra è cominciata e, malgrado la sproporzione delle forze in campo, non si ha più scelta...». Con l'accordo dei suoi alleati, gli chiedo? Avvertendo i membri di quella Nato di cui le hanno sbattuto la porta in faccia? «Il vero problema è quel che è in gioco in questa guerra. Putin e Medvedev cercavano un pretesto per invaderci. Perché? Primo: siamo una democrazia e quindi incarniamo, per quanto riguarda l'uscita dal comunismo, un'alternativa al putinismo. Secondo: siamo il Paese dove passa il Btc, l'oleodotto che collega Baku a Ceyhan via Tbilisi; di modo che, se cadiamo, se Mosca mette al mio posto un impiegato di Gazprom, voi europei sarete dipendenti al cento per cento dai russi per l'approvvigionamento energetico. Terzo: guardi la mappa. La Russia è alleata dell'Iran. Anche i nostri vicini armeni non sono lontani dagli iraniani. Immagini che a Tbilisi si installi un regime favorevole alla Russia. Avremmo un continuum geostrategico che andrebbe da Mosca a Teheran. Spero che la Nato lo capisca.
Il presidente Saakashvili, affiancato dal suo consigliere Daniel Kunnin, ascolta il mio racconto. Siamo nella residenza presidenziale di Avlabari. Sono le due del mattino, ma i suoi consiglieri sono efficienti come in pieno giorno. È giovanissimo. Di una giovinezza rivelata dall'impazienza dei gesti, lo sguardo febbrile, i bruschi scoppi di risa. Del resto, tutti sono molto giovani. Ministri e consiglieri sono borsisti di fondazioni tipo quella di Soros, i cui studi a Yale, Princeton, Chicago sono stati interrotti dalla Rivoluzione delle Rose. È francofilo e francofono. Appassionato di filosofia. Democratico. Europeo. Liberale nel duplice senso — americano ed europeo — della parola. Di tutti i grandi Resistenti che ho incontrato nella mia vita, di tutti i Massud o Izetbegovic di cui ho preso le difese, è quello più evidentemente estraneo all'universo della guerra, ai suoi riti, ai suoi emblemi, alla sua cultura. Ma vi fa fronte. «Lasciatemi precisare una cosa, mi interrompe con improvvisa gravità...Non bisogna lasciar dire che siamo stati noi a iniziare la guerra...Siamo al principio di agosto. I miei ministri sono in vacanza. Io mi trovo in Italia, per una cura dimagrante e sono sul punto di partire per Pechino. Ecco che, sulla stampa italiana, leggo: «Preparativi di guerra in Georgia». Ha capito bene: sono lì, tranquillo, in Italia e leggo che il mio Paese sta preparando una guerra! Sentendo che c'è qualcosa che non va, torno subito a Tbilisi. E cosa vengo a sapere dai miei servizi segreti? Che i russi, nel momento stesso in cui riempiono le agenzie stampa di queste chiacchiere, stanno svuotando Tskhinvali dei suoi abitanti, ammassano truppe, trasporti di truppe, addetti al rifornimento di nafta in territorio georgiano e fanno passare colonne di carri armati attraverso il tunnel Roki, che separa le due Ossezie. Allora, supponga di essere responsabile di un Paese e di apprendere tutto questo. Che fare?». Si alza, risponde a due cellulari che suonano contemporaneamente, ritorna, stira le gambe. «Al centocinquantesimo carro armato posizionato di fronte alle vostre città, si è obbligati ad ammettere che la guerra è cominciata e, malgrado la sproporzione delle forze in campo, non si ha più scelta...». Con l'accordo dei suoi alleati, gli chiedo? Avvertendo i membri di quella Nato di cui le hanno sbattuto la porta in faccia? «Il vero problema è quel che è in gioco in questa guerra. Putin e Medvedev cercavano un pretesto per invaderci. Perché? Primo: siamo una democrazia e quindi incarniamo, per quanto riguarda l'uscita dal comunismo, un'alternativa al putinismo. Secondo: siamo il Paese dove passa il Btc, l'oleodotto che collega Baku a Ceyhan via Tbilisi; di modo che, se cadiamo, se Mosca mette al mio posto un impiegato di Gazprom, voi europei sarete dipendenti al cento per cento dai russi per l'approvvigionamento energetico. Terzo: guardi la mappa. La Russia è alleata dell'Iran. Anche i nostri vicini armeni non sono lontani dagli iraniani. Immagini che a Tbilisi si installi un regime favorevole alla Russia. Avremmo un continuum geostrategico che andrebbe da Mosca a Teheran. Spero che la Nato lo capisca.
Venerdì mattina. Con Raphaël Glucksmann, Gilles Hertzog, la deputata europea,  decidiamo di tornare a Gori che, a seguito dell'accordo di cessate il fuoco redatto da Sarkozy e Medvedev, i russi avrebbero cominciato a evacuare e dove noi dovremmo raggiungere il patriarca ortodosso di Tbilisi e dove sembra che centinaia di morti siano abbandonati a cani e porci. Ma il patriarca è introvabile. I russi non hanno sgombrato. E stavolta siamo bloccati a venti chilometri da Gori, quando una vettura davanti a noi viene presa di mira da una squadra di irregolari che, sotto l'occhio placido di un ufficiale russo, fanno scendere i giornalisti e strappano loro cineprese, soldi, oggetti personali e il loro veicolo. Notizia falsa, quindi. Il solito balletto di notizie false, nella cui arte gli artefici della propaganda russa sembrano decisamente essere diventati maestri. Ci dirigiamo verso Kaspi, a metà strada fra Gori e Tbilisi, dove l'interprete della deputata ha la propria famiglia e dove la situazione appare più calma. In realtà, ci aspettano altre due sorprese. Prima di tutto, le distruzioni. Ma distruzioni che, ora, non prendono di mira prioritariamente le case e le persone. Che cosa, allora? Il ponte. La stazione. La ferrovia, che un gruppo di addetti alla logistica sta già riparando, guidati dalla sua stanza dal capo meccanico, gravemente ferito all'anca. Il sistema di comando elettronico del cementificio Heidelberg, a capitali tedeschi, colpito da un missile a guida laser. «Lì c'erano 650 operai, mi dice il direttore della fabbrica Levan Baramatze. Oggi, solo 120 di loro sono potuti venire. Il nostro apparato produttivo è a pezzi». A Poti, i russi hanno affondato la marina georgiana. Hanno colpito in tre punti l'oleodotto Btc. Qui, a Kaspi, hanno appositamente colpito i centri vitali di un'economia da cui dipende, indirettamente, quella della regione e del Paese. Terrorismo mirato. Volontà, ancora, di mettere il Paese in ginocchio. Poi, seconda sorpresa, i carri armati. Siamo alle porte della capitale. Condoleezza Rice, in questo momento, sta tenendo una conferenza stampa. Ecco che improvvisamente appare, volando a bassa quota sopra gli alberi, uno degli elicotteri da combattimento il cui arrivo è sempre un cattivo segno. Subito dopo, gli abitanti rimasti a Kaspi si ritrovano per la strada, davanti alle case e vengono velocemente imbarcati nelle vecchie Lada. Tutti urlano, a chi vuole ascoltare e in particolare al nostro autista, che i russi arrivano e che bisogna fuggire. Dapprima non ci crediamo. Invece, i carri armati ci sono. Sono esattamente cinque. Oltre ad un'unità del genio che comincia a scavare trincee. Il messaggio è chiaro. Rice o no, qui i russi sono a casa loro. Si dispiegano in Georgia come su un terreno di conquista. Non è esattamente come l'invasione di Praga. È la sua versione XXI secolo: una versione lenta, a colpi di umiliazioni, intimidazioni, panico...
decidiamo di tornare a Gori che, a seguito dell'accordo di cessate il fuoco redatto da Sarkozy e Medvedev, i russi avrebbero cominciato a evacuare e dove noi dovremmo raggiungere il patriarca ortodosso di Tbilisi e dove sembra che centinaia di morti siano abbandonati a cani e porci. Ma il patriarca è introvabile. I russi non hanno sgombrato. E stavolta siamo bloccati a venti chilometri da Gori, quando una vettura davanti a noi viene presa di mira da una squadra di irregolari che, sotto l'occhio placido di un ufficiale russo, fanno scendere i giornalisti e strappano loro cineprese, soldi, oggetti personali e il loro veicolo. Notizia falsa, quindi. Il solito balletto di notizie false, nella cui arte gli artefici della propaganda russa sembrano decisamente essere diventati maestri. Ci dirigiamo verso Kaspi, a metà strada fra Gori e Tbilisi, dove l'interprete della deputata ha la propria famiglia e dove la situazione appare più calma. In realtà, ci aspettano altre due sorprese. Prima di tutto, le distruzioni. Ma distruzioni che, ora, non prendono di mira prioritariamente le case e le persone. Che cosa, allora? Il ponte. La stazione. La ferrovia, che un gruppo di addetti alla logistica sta già riparando, guidati dalla sua stanza dal capo meccanico, gravemente ferito all'anca. Il sistema di comando elettronico del cementificio Heidelberg, a capitali tedeschi, colpito da un missile a guida laser. «Lì c'erano 650 operai, mi dice il direttore della fabbrica Levan Baramatze. Oggi, solo 120 di loro sono potuti venire. Il nostro apparato produttivo è a pezzi». A Poti, i russi hanno affondato la marina georgiana. Hanno colpito in tre punti l'oleodotto Btc. Qui, a Kaspi, hanno appositamente colpito i centri vitali di un'economia da cui dipende, indirettamente, quella della regione e del Paese. Terrorismo mirato. Volontà, ancora, di mettere il Paese in ginocchio. Poi, seconda sorpresa, i carri armati. Siamo alle porte della capitale. Condoleezza Rice, in questo momento, sta tenendo una conferenza stampa. Ecco che improvvisamente appare, volando a bassa quota sopra gli alberi, uno degli elicotteri da combattimento il cui arrivo è sempre un cattivo segno. Subito dopo, gli abitanti rimasti a Kaspi si ritrovano per la strada, davanti alle case e vengono velocemente imbarcati nelle vecchie Lada. Tutti urlano, a chi vuole ascoltare e in particolare al nostro autista, che i russi arrivano e che bisogna fuggire. Dapprima non ci crediamo. Invece, i carri armati ci sono. Sono esattamente cinque. Oltre ad un'unità del genio che comincia a scavare trincee. Il messaggio è chiaro. Rice o no, qui i russi sono a casa loro. Si dispiegano in Georgia come su un terreno di conquista. Non è esattamente come l'invasione di Praga. È la sua versione XXI secolo: una versione lenta, a colpi di umiliazioni, intimidazioni, panico...
 L'incontro avviene alle quattro del mattino. Saakashvili ha trascorso la fine della giornata con la Rice. La vigilia con Sarkozy. All'una come all'altro si dice grato per i loro sforzi, per il loro interessamento e per la loro amicizia. Il Presidente ha un'aria malinconica. Forse si interroga sullo strano atteggiamento dei propri amici. Per esempio, sull'accordo di cessate il fuoco che ha ottenuto l'amico Sarkozy e che è stato redatto a Mosca, a quattro mani, con Medvedev. Saakashvili rivede col pensiero il Presidente francese, qui, in questo stesso ufficio, così impaziente di farlo firmare. Lo sente alzare la voce, quasi gridare: «Non hai scelta, Misha, sii realista; quando i russi arriveranno per destituirti, nessuno dei tuoi amici alzerà un dito per salvarti». E che strana reazione quando lui, Misha Saakashvili, ha ottenuto che chiamassero comunque Medvedev, il quale ha fatto rispondere che stava dormendo. Erano solo le 9, ma dormiva ed era irraggiungibile fino all'indomani mattina: anche il Presidente francese si è infuriato; l'amico francese non ha voluto aspettare. Fretta di rientrare? Troppo sicuro che l'essenziale fosse di firmare, qualsiasi cosa, ma firmare? Non è così, pensa Misha, che si negozia. Non è così che ci si comporta con gli amici. Ho visto questo documento. Ho visto le annotazione manoscritte dei due presidenti, georgiano e francese. Ho visto il secondo documento, sempre firmato da Sarkozy e affidato a Condi Rice, a Brégançon, affinché lo consegnasse a Saakashvili. Ho visto infine il memorandum di note redatte in serata da parte georgiana e giudicate vitali. Rice ha ottenuto — e non è un dettaglio — che fosse cancellata qualsiasi allusione al futuro «statuto» dell'Ossezia. Ha ottenuto — e non è trascurabile — che fosse precisato che il «perimetro ragionevole» — all'interno del quale le truppe russe erano autorizzate, nel primo documento, a continuare il pattugliamento per garantire la sicurezza dei russofoni della Georgia — divenisse un perimetro di «qualche chilometro». Ma dell'integrità territoriale della Georgia non si parla in alcun documento. Quanto al legittimo aiuto portato ai russofoni, tremiamo all'idea dell'uso che ne sarà fatto quando saranno i russofoni dell'Ucraina, dei Paesi Baltici o della Polonia a ritenersi minacciati a loro volta da una volontà «genocida»... È l'americano Richard Holbrooke, diplomatico di grosso calibro e vicino a Barak Obama, ad avere l'ultima parola: «In questa vicenda aleggia un cattivo odore di pacificazione forzata e di accordi di Monaco». O siamo capaci di alzare veramente la voce e di dire, in Georgia, basta a Putin. Oppure, l'uomo che è andato, secondo le sue stesse parole a «inseguire fin nei cessi» i civili ceceni, si sentirà in diritto di fare la stessa cosa con qualunque suo vicino. È così che si devono costruire l'Europa, la pace e il mondo di domani? (Corriere della Sera - traduzione di Daniela Maggioni)
L'incontro avviene alle quattro del mattino. Saakashvili ha trascorso la fine della giornata con la Rice. La vigilia con Sarkozy. All'una come all'altro si dice grato per i loro sforzi, per il loro interessamento e per la loro amicizia. Il Presidente ha un'aria malinconica. Forse si interroga sullo strano atteggiamento dei propri amici. Per esempio, sull'accordo di cessate il fuoco che ha ottenuto l'amico Sarkozy e che è stato redatto a Mosca, a quattro mani, con Medvedev. Saakashvili rivede col pensiero il Presidente francese, qui, in questo stesso ufficio, così impaziente di farlo firmare. Lo sente alzare la voce, quasi gridare: «Non hai scelta, Misha, sii realista; quando i russi arriveranno per destituirti, nessuno dei tuoi amici alzerà un dito per salvarti». E che strana reazione quando lui, Misha Saakashvili, ha ottenuto che chiamassero comunque Medvedev, il quale ha fatto rispondere che stava dormendo. Erano solo le 9, ma dormiva ed era irraggiungibile fino all'indomani mattina: anche il Presidente francese si è infuriato; l'amico francese non ha voluto aspettare. Fretta di rientrare? Troppo sicuro che l'essenziale fosse di firmare, qualsiasi cosa, ma firmare? Non è così, pensa Misha, che si negozia. Non è così che ci si comporta con gli amici. Ho visto questo documento. Ho visto le annotazione manoscritte dei due presidenti, georgiano e francese. Ho visto il secondo documento, sempre firmato da Sarkozy e affidato a Condi Rice, a Brégançon, affinché lo consegnasse a Saakashvili. Ho visto infine il memorandum di note redatte in serata da parte georgiana e giudicate vitali. Rice ha ottenuto — e non è un dettaglio — che fosse cancellata qualsiasi allusione al futuro «statuto» dell'Ossezia. Ha ottenuto — e non è trascurabile — che fosse precisato che il «perimetro ragionevole» — all'interno del quale le truppe russe erano autorizzate, nel primo documento, a continuare il pattugliamento per garantire la sicurezza dei russofoni della Georgia — divenisse un perimetro di «qualche chilometro». Ma dell'integrità territoriale della Georgia non si parla in alcun documento. Quanto al legittimo aiuto portato ai russofoni, tremiamo all'idea dell'uso che ne sarà fatto quando saranno i russofoni dell'Ucraina, dei Paesi Baltici o della Polonia a ritenersi minacciati a loro volta da una volontà «genocida»... È l'americano Richard Holbrooke, diplomatico di grosso calibro e vicino a Barak Obama, ad avere l'ultima parola: «In questa vicenda aleggia un cattivo odore di pacificazione forzata e di accordi di Monaco». O siamo capaci di alzare veramente la voce e di dire, in Georgia, basta a Putin. Oppure, l'uomo che è andato, secondo le sue stesse parole a «inseguire fin nei cessi» i civili ceceni, si sentirà in diritto di fare la stessa cosa con qualunque suo vicino. È così che si devono costruire l'Europa, la pace e il mondo di domani? (Corriere della Sera - traduzione di Daniela Maggioni)
*******************************************************************
Continua a piovere....
"Who'll stop the rain?"
Buonanotte!
Mago