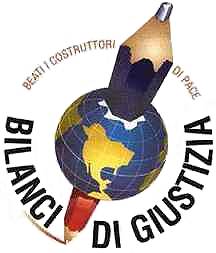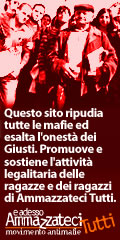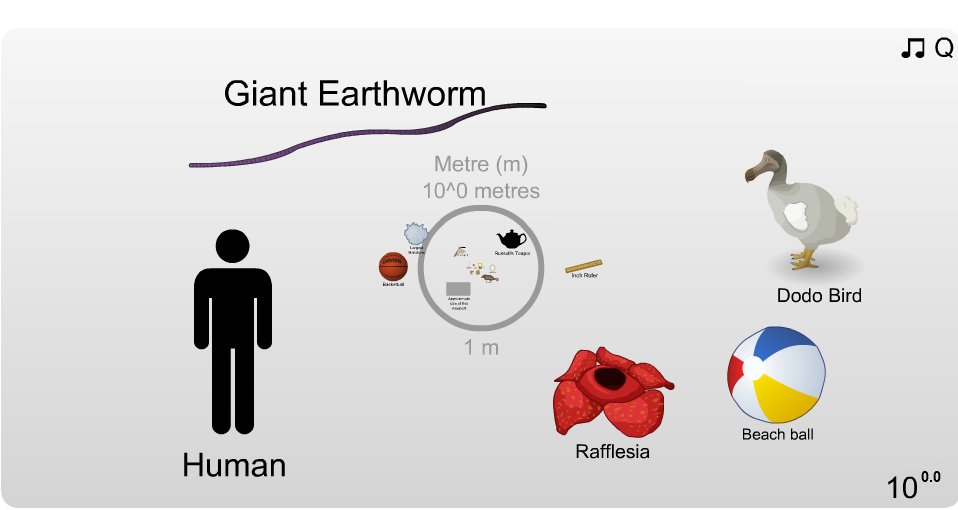|
Creato da m_de_pasquale il 05/10/2009
"il sapere ha potenza sul dolore" (Eschilo) ______________ "Perchè ci hai dato sguardi profondi?" (Goethe)
|
|
"La filosofia guarda da un altro livello cose, problemi, sofferenze, desideri, piaceri. E qui cade la solitudine del filosofo che non gode come gli altri, non soffre come gli altri, perchè non guarda le cose al livello dove le vedono gli altri. Per questo il filosofo è solo e incompreso. Della solitudine ringrazia ogni giorno gli dèi che gli tolgono di torno gli abitatori del tempo; dell'incomprensione si rammarica, non per sé ma per gli altri che non sanno quello che dicono e fanno." (Galimberti)
| « la felicità cerca il god... | felicità della giusta misura » |
i soldi fanno la felicitÓ?
Post n°50 pubblicato il 09 Maggio 2010 da m_de_pasquale
Nel post precedente, citando Aristotele, si diceva che molti intendono la felicità come ricchezza e del resto, oggi, è opinione comune che i soldi facciano la felicità. Se il desiderio finchè è insoddisfatto ci provoca tensione, sofferenza, col denaro possiamo realizzare i nostri sogni, possiamo entrare in possesso delle cose che vogliamo; questo ci fa provare una sensazione di appagamento, di completezza e perciò ci diciamo felici. L’esercizio del potere grazie al denaro ci rende felici perché ci permette di modificare la realtà secondo i nostri desideri come sostiene Marx: “Ciò che mediante il denaro è a mia disposizione, ciò che io posso pagare, ciò che il denaro può comprare, quello sono io stesso, il possessore del denaro medesimo. Quanto grande è il potere del denaro, tanto grande è il mio potere. Le caratteristiche del denaro sono le mie stesse caratteristiche e le mie forze essenziali, cioè sono le caratteristiche e le forze essenziali del suo possessore. Ciò che io sono e posso non è quindi affatto determinato dalla mia individualità. Io sono brutto, ma posso comprarmi la più bella tra le donne. E quindi io non sono brutto, perché l’effetto della bruttezza, la sua forza repulsiva, è annullata dal denaro. Io, considerato come individuo, sono storpio, ma il denaro mi procura ventiquattro gambe; quindi non sono storpio. Io sono un uomo malvagio, disonesto, senza scrupoli, stupido; ma il denaro è onorato, e quindi anche il suo possessore. Il denaro è il bene supremo, e quindi il suo possessore è buono; il denaro inoltre mi toglie la pena di essere disonesto, e quindi si presume che io sia onesto. Io sono uno stupido, ma il denaro è la vera intelligenza di tutte le cose, e allora come potrebbe essere stupido chi lo possiede? Inoltre costui potrà sempre comperarsi le persone intelligenti, e chi ha potere sulle persone intelligenti non è più intelligente delle persone intelligenti? Io che col denaro ho la facoltà di procurarmi tutto quello a cui il cuore umano aspira, non possiedo forse tutte le umane facoltà? Forse che il mio denaro non trasforma tutte le mie deficienze nel loro contrario? E se il denaro è il vincolo che mi unisce alla vita umana, che unisce a me la società, che mi collega con la natura e gli uomini, non è il denaro forse il vincolo di tutti i vincoli? Non può esso sciogliere e stringere ogni vincolo? E quindi non è forse anche il dissolvitore universale? Esso è tanto la vera moneta spicciola quanto il vero cemento, la forza galvano-chimica della società”. Il possesso è anche godimento perché ho neutralizzato l’ignoto riducendo la realtà a qualcosa sotto il mio controllo, è sicurezza perché esercito il controllo sulle cose. Ma quando il denaro acquista un potere così estremo non potrebbe trasformarsi in un potere su di me? Aristotele ci mette in guardia: “Chi si dedica al guadagno è sottoposto, in un certo senso, a costrizione, ed è chiaro che la ricchezza non è il bene che cerchiamo”. Pensiamo di liberarci dal bisogno col possesso e quindi di essere felici, ma in realtà viviamo una costrizione: siamo dipendenti dal possedere. Come spesso accade i primitivi sono più saggi di noi ed esiste una interessante cerimonia che si celebra in alcune tribù di nativi americani: il potlatch. Si tratta di una cerimonia rituale in cui vengono ostentate pratiche distruttive di beni considerati di prestigio. Se il possesso favorisce l’accumulo ed il conseguente senso di “sicurezza” perché ci si sente padroni, e ciò fa sì, anche, che si accentuino le differenze sociali perché il possesso è disuguale, col potlatch si favorisce la distruzione di quanto accumulato ristabilendo una situazione di uguaglianza e maturando un senso di sicurezza non più derivante dal possesso, ma dall’intensificarsi delle relazioni sociali favorite dalla gratuità manifestata nella ostentazione della distruzione dei beni. Insomma è come se si lanciasse il messaggio: la felicità non viene dalle cose che si posseggono ma dal rafforzamento delle relazioni che si instaurano con gli altri. Continueremo a pensare che il modello sociale dominante fondato sull’imperativo della crescita (ovvero dell’accumulo, del profitto, del predominio della categoria dell’utilità, della centralità del denaro) possa assicurare una felicità personale e pubblica? Si può essere felici da soli nel senso di perseguire una dimensione privata della felicità prescindendo da quella di tutti? La centralità del denaro che fa diventare merce tutte le cose (tutto ha un prezzo!) non rischia forse di ridurre a merce ciò che non può essere mercificato (ad esempio le relazioni tra le persone)? Non si rischia di essere posseduti (più che essere possessori) dal denaro stravolgendo, così, il nostro sguardo sul mondo che alla fine coglie le cose solo per quanto sono utili e non per quello che sono? Si può parlare di felicità quando siamo pieni di cose e difettano i rapporti? C’è la possibilità di svincolarsi dalla tirannia della logica mercantile che riduce tutto a merce incentivando la ricerca del profitto? Secondo Pallante sì: “In tutte le epoche storiche e in tutti i luoghi del mondo dove si sono formati stabilmente gruppi umani a partire dai nuclei familiari, insieme agli scambi mercantili sono state realizzate forme di scambio non mercantili basate sul dono e sulla reciprocità. Seppure in assenza di regole scritte, gli scambi non mercantili si sono dovunque fondati su tre principi: l’obbligo di donare, l’obbligo di ricevere, l’obbligo di restituire più di quanto si è ricevuto. Pertanto, la dinamica del dono e del controdono crea legami sociali. In questa sfera rientrano il dono del tempo, delle capacità professionali, della disponibilità umana, dell’attenzione, della solidarietà, ma non il baratto, che ha dato origine agli scambi mercantili. La parola comunità è composta da due parole latine: la preposizione cum, che significa con e indica un legame, e il nome munus, che significa dono. La comunità è un raggruppamento umano unito da forme di scambio non mercantili. Se le società fondate sulla crescita del prodotto interno lordo non possono non sostituire in continuazione gli scambi fondati sul dono e la reciprocità con merci equivalenti, inducendo a credere che questi spostamenti siano fattori di progresso, una società libera da questo vincolo economico e mentale, da questa camicia di forza, ridimensiona gli scambi mercantili a ciò che non può essere più vantaggiosamente autoprodotto e scambiato sotto forma di dono. La sua struttura produttiva si può paragonare a una figura geometrica composta da tre cerchi concentrici. Il cerchio interno rappresenta l’area dell’autoproduzione di beni e servizi. La prima corona circolare l’area degli scambi fondati sul dono e la reciprocità. La corona circolare esterna l’area degli scambi mercantili. In essa le filiere più corte sono più interne e le merci si dispongono progressivamente verso l’esterno man mano che aumentano le intermediazioni commerciali e la distanza tra i luoghi in cui sono prodotte e i luoghi in cui vengono consumate. Le società fondate sulla crescita allargano progressivamente questa area rosicchiando il terreno alle altre due. Una società fondata sulla decrescita estende le due aree interne ridimensionando la terza”. Per leggere l’intero documento La decrescita felice. Esercizio. Rifletti attentamente sulla seguente mappa concettuale che partendo dalla differenza marxiana tra valore d’uso e valore di scambio, tenta di sviluppare un ragionamento sulle conseguenze della logica dell’accumulo, del profitto nella società contemporanea: viaggia tra i suoi collegamenti, approfondisci quelli che ti sembrano più interessanti, inventane di nuovi. (Felicità - 3 precedente successivo) |
- sitografia generale
- video storici
- video dal 1900 ad oggi
- storia antica
- storia medievale
- storia moderna
- storia del novecento
- tutti i documenti cattolici
- dizionario di storia antica e medievale
- dizionario di storia moderna e contemporanea
- dizionario di storiografia
- dizionario di economia
- dizionario del cittadino
- storia di san severo
Tag
Area personale
Menu
CAMPI FILOSOFICI
2012: il sacro, tremendum e fascinans
2011: l'altra faccia del potere
2010: inseguendo la felicità
2009: l'equivoco dell'amore
mail: m_de_pasquale@libero.it
un'altra informazione?
- report
- presa diretta
- servizio pubblico
- anno zero
- w l'italia
- current tv online
- c'era una volta
- iene
- doc 3
- il fatto quotidiano
- lettera43
- cadoinpiedi
- il post
- linkiesta
- agoravox
- giornalettismo
- articolo 21
- liberainformazione
- la voce
- carta
- peace reporter
- nigrizia
- narcomafie
- altreconomia
- arcoiris tv
- wikileaks
- paolo barnard
- tzetze
- YouReporter
- i segreti della casta