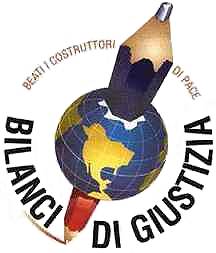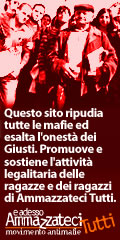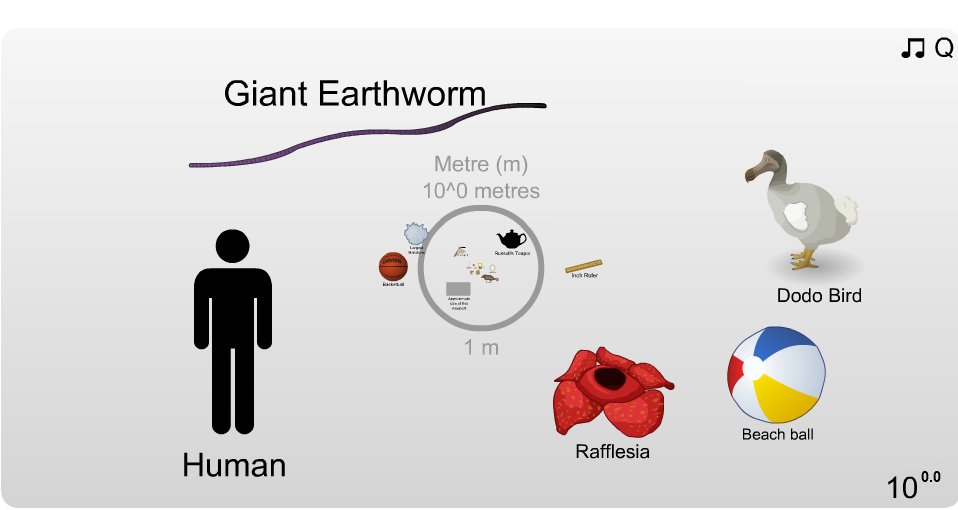|
Creato da m_de_pasquale il 05/10/2009
"il sapere ha potenza sul dolore" (Eschilo) ______________ "Perchè ci hai dato sguardi profondi?" (Goethe)
|
|
"La filosofia guarda da un altro livello cose, problemi, sofferenze, desideri, piaceri. E qui cade la solitudine del filosofo che non gode come gli altri, non soffre come gli altri, perchè non guarda le cose al livello dove le vedono gli altri. Per questo il filosofo è solo e incompreso. Della solitudine ringrazia ogni giorno gli dèi che gli tolgono di torno gli abitatori del tempo; dell'incomprensione si rammarica, non per sé ma per gli altri che non sanno quello che dicono e fanno." (Galimberti)
| « inculati contenti | amore, follia e sacro » |
|
Post n°46 pubblicato il 03 Aprile 2010 da m_de_pasquale
Le religioni sono nate soprattutto per far fronte all’esperienza più angosciante della nostra vita: il divenire. Il fluire inesorabile ed irreversibile del tempo verso la morte. L’uomo – sin dalle origini – ha cercato di neutralizzare l’opera del tempo: simboli, riti primitivi parlano di inghiottimenti da parte di mostri, di ritorno nell’oscurità del ventre, di immersione nelle acque, come ritorno nella notte cosmica per poter essere ricreati, rigenerati. Una nuova nascita che annulla l’opera del tempo restaurando l’integrità aurorale. Scrive lo storico delle religioni Eliade: “Lo schema iniziatico – sofferenze, morte e resurrezione – ricorre in tutti i misteri … L’uomo delle società primitive ha cercato di vincere la morte trasformandola in un rito di passaggio [pasqua deriva dall’ebraico pèsach che significa passaggio]... la morte viene ad essere considerata come la suprema iniziazione …. o meglio: generazione, morte e risurrezione sono considerati i tre momenti di un unico mistero, ed ogni sforzo dell’uomo arcaico è stato impiegato per dimostrare che tra questi tre momenti non vi deve essere soluzione di continuità. In uno di questi tre momenti non ci si può fermare. Il movimento, la rigenerazione si susseguono all’infinito”. L’uomo, osservando la vita della Natura e sentendosi solidale con essa, legge la sua vita individuale all’interno dei dinamismi della natura. C’è un rapporto simbiotico tra uomo e Terra (homo-humus): se la Terra è viva perché è fertile, tutto quello che esce dalla terra è dotato di vita, e tutto quello che torna alla terra è nuovamente fornito di vita. Si seppelliscono i morti nella terra perché essa li rigenererà. Dice ancora Eliade: “vita e morte sono solo due momenti diversi nel destino totale della Terra-Madre; la vita altro non è che il distacco dalle sue viscere, la morte si riduce ad un ritorno alla propria casa”. Successivamente il punto di vista della natura passerà in secondo piano rispetto a quello dell’esistenza individuale (antropocentrismo); l’uomo, non più simbioticamente unito alla natura, avrà bisogno d’interpretare la sua vicenda non più come parte di un tutto (=natura) che lo comprende, ma come parte che si distingue dal tutto e che addirittura sottomette alla sua signoria: non gli basteranno più quei miti e riti che leggevano la sua morte come momento della grande vita della natura, non accetterà che la sua vita individuale sia come una delle tante vite che nascono nella natura e che finiscono per ricrearne altre. Avrà bisogno di sostenere la sua immortalità contro l’esperienza certa della sua mortalità. Il Dio che si incarna, che muore e risorge diventa il potente simbolo della vittoria sulla morte individuale e la conseguente promessa dell’immortalità per ogni uomo al di là dell’esperienza certa della sua morte individuale. Dobbiamo intendere così la vicenda di Cristo? Certamente fa comodo perché si riesce a trovare la risposta al problema più angosciante: la nostra morte individuale. La convinzione che la morte è neutralizzata dalla resurrezione di Cristo fa dire a Paolo: “La morte è stata ingoiata per la vittoria. Dov’è, o morte, la tua vittoria? Dov’è, o morte, il tuo pungiglione?”. Goethe non cede a questa proiezione del desiderio e continua a pensare che la natura ospiti l’individuo come colui che dovrà morire la cui morte è solo l’anello necessario alla catena della vita: “Natura! Da essa siamo circondati e avvinti, né ci è dato uscirne e penetrarvi più a fondo. Senza farsi pregare e senza avvertire, ci rapisce nel vortice della sua danza e si lascia andare con noi, finchè siamo stanchi e le cadiamo dalle braccia. Crea eternamente nuove forme; ciò che è qui non era ancora mai stato, ciò che era non ritorna. Tutto è nuovo, e tuttavia sempre antico. Viviamo nel suo seno e le siamo estranei. Parla incessantemente con noi e non ci rivela il suo segreto. Costantemente operiamo su di essa e tuttavia non abbiamo alcun potere sulla natura. Sembra che abbia puntato tutto sulla individualità eppure niente le importa degli individui. Costruisce sempre e sempre distrugge, e la sua officina è inaccessibile. In essa è eterna vita, divenire e moto e tuttavia non progredisce. Si trasforma eternamente e non vi è momento di quiete. Il suo spettacolo è sempre nuovo, perché essa crea sempre nuovi spettatori. La vita è la sua invenzione più bella e la morte è il suo artificio per avere molta vita. Essa avvolge l’uomo nell’oscurità e lo sprona eternamente verso la luce. Non conosce né passato né futuro. Il presente è la sua eternità”. Anche Nietzsche, come Goethe, abbandona ogni ipotesi di immortalità individuale per salvaguardare l’individuo; riprendendo un atteggiamento profondamente greco e non cristiano, sostiene l’accettazione del dolore indipendentemente dal suo senso e dalla sua destinazione sostituendo al Crocefisso Dioniso che gioca la vita insieme alla sua distruzione e trae vita dalla distruzione: “Qui faccio intervenire il Dioniso dei Greci: l’affermazione religiosa della vita, della vita intera, non della vita rinnegata e dimezzata. Dioniso contro il crocefisso: eccovi l’antitesi. Non è una differenza in base al martirio – solo essa ha un altro senso. La vita stessa, la sua eterna fecondità e il suo eterno ritorno determinano la sofferenza, la distruzione, il bisogno di annientamento. Nell’altro caso il dolore, il crocifisso in quanto innocente valgono come obiezione contro questa vita, come formula della sua condanna. Si indovina che il problema è quello del senso del dolore: del senso cristiano o del senso tragico. L’uomo tragico afferma anche il dolore più aspro: è abbastanza forte, ricco e divinizzatore perciò. Il cristiano nega anche il destino più felice in terra: è tanto debole, povero e diseredato da soffrire di ogni forma di vita. Il Dio in croce è una maledizione della vita, un’esortazione a liberarsene. Il Dioniso fatto a pezzi è una promessa alla vita: essa rinascerà e rifiorirà eternamente dalla distruzione”. |
https://blog.libero.it/phronesis/trackback.php?msg=8649230
I blog che hanno inviato un Trackback a questo messaggio:
- sitografia generale
- video storici
- video dal 1900 ad oggi
- storia antica
- storia medievale
- storia moderna
- storia del novecento
- tutti i documenti cattolici
- dizionario di storia antica e medievale
- dizionario di storia moderna e contemporanea
- dizionario di storiografia
- dizionario di economia
- dizionario del cittadino
- storia di san severo
Tag
Area personale
Menu
CAMPI FILOSOFICI
2012: il sacro, tremendum e fascinans
2011: l'altra faccia del potere
2010: inseguendo la felicità
2009: l'equivoco dell'amore
mail: m_de_pasquale@libero.it
un'altra informazione?
- report
- presa diretta
- servizio pubblico
- anno zero
- w l'italia
- current tv online
- c'era una volta
- iene
- doc 3
- il fatto quotidiano
- lettera43
- cadoinpiedi
- il post
- linkiesta
- agoravox
- giornalettismo
- articolo 21
- liberainformazione
- la voce
- carta
- peace reporter
- nigrizia
- narcomafie
- altreconomia
- arcoiris tv
- wikileaks
- paolo barnard
- tzetze
- YouReporter
- i segreti della casta