Schwed RaccontaSu e giù per la tastiera |
C'ERA UNA VOLTA MONTALCINO

JIGA MELIK E IL SIG. SCHWED
Jiga Melik è l'alter ego intermittente dello scrittore Alessandro Schwed. Il signor Melik nasce nel 1978 nella prima e provvisoria redazione del Male, un ex odoroso caseificio in via dei Magazzini Generali a Roma. Essendo un falso sembiante di Alessandro Schwed, Jiga Melik si specializza con grande naturalezza nella produzione di falsi e scritti di fatti verosimili. A ciò vanno aggiunti happening con Donato Sannini, come la consegna dei 16 Comandamenti sul Monte dei Cocci; la fondazione dell'Spa, Socialista partito aristocratico o Società per azioni, e la formidabile trombatura dello Spa, felicemente non ammesso alle regionali Lazio 1981; alcuni spettacoli nel teatro Off romano, tra cui "Chi ha paura di Jiga Melik?", con Donato Sannini e "Cinque piccoli musical" con le musiche di Arturo Annecchino; la partecipazione autoriale a programmi radio e Tv, tra cui la serie satirica "Teste di Gomma" a Tmc. Dopo vari anni di collaborazione coi Quotidiani Locali del Gruppo Espresso, Jiga Melik finalmente torna a casa, al Male di Vauro e Vincino. Il signor Schwed non si ritiene in alcun modo responsabile delle particolari iniziative del signor Melik.
MIO FIGLIO MI HA AGGIUNTO SU FACEBOOK - ROMANZO


LA SCOMPARSA DI ISRAELE - ROMANZO
LINK DOVE VIVO
- Fahrenheit
- Il Tizio della Sera
- romanzo LO ZIO COSO
- La Scomparsa di Israele
- Corriere della Sera
- Critica letteraria
- libri su libri
- i suoni della memoria
- IBS
- settimanale L'AZIONE p. 7
- Il Piccolo - recensione teatrale "Alla ricerca dello zio Coso"
- Il Messaggero Veneto - Giornata della Memoria Intervista ad Alessandro Schwed
- anobii
- libero di leggere
- articolo sul Foglio
- roma
- IL MALE
- il Male su facebook
AREA PERSONALE
TAG
MENU
I MIEI BLOG AMICI
|
Post n°20 pubblicato il 29 Gennaio 2011 da Jiga0
Romanzo sui giorni dell'IRA
Della rivolta repubblicana irlandese contro l'occupazione inglese, conosciamo le cronache televisive degli ultimi decenni: esplosioni, camionette rovesciate. In Europa, l'Ira è una vicenda remota. Ora la riattraversa con noi Roddy Doyle in"Una vita da eroe": la storia di Henry Smart, ex bombarolo, romanzescamente designato come uomo di fiducia di Michael Collins, eroe dell'indipendenza irlandese. Smart non è un demone: è un popolano diffidente, uno solitario, un eroe senza saperlo. Dopo la giovinezza con la dinamite in mano, lascia l'isola e sta metà vita in America, derelitto prima, e scheggia impazzita di Hollywood poi. Il romanzo lo incontra nel 1951, quando torna in Irlanda dopo ventinove anni di assenza. Ha da fare un sopraluogo e scrivere la sceneggiatura della sua vita di ribelle per John Ford, il regista di "Ombre rosse". Si tratta di capire chi sia stato Smart, e non è facile perché non lo sa neanche lui. Ha sofferto così tanto che ha dimenticato i nomi dei propri familiari. L'unica amicizia di Henry è con la gamba di legno, coprotagonista del romanzo: Smart la toglie, la rimette, ne ha cura, compra stivali di coccodrillo per farne indossare uno a lei. Le vuol bene. Quando ormai anziano, in Irlanda, è vittima di un attentato e smarrisce la protesi, è preoccupato come per una parente. Smart è estraneo alla realtà, soprattutto quella di Hollywood, e scrivere con Ford il film sulla sua vita di ribelle, è lotta furibonda. Ford, ex cocciutissimo irlandese, un giorno si è visto recapitare Henry perché lo salvasse, dopo che era stato ritrovato da qualche parte d'America senza memoria. Smart fa riunioni di sceneggiatura davanti agli impenetrabili occhiali da sole di Ford, litiga, se ne va per giorni. Ricorda i tempi selvaggi nell'Ira, la sua esistenza americana, drop out con la moglie e i due figli. Sa di essere caduto dal treno dove era con loro e aver perso la gamba. Da allora non ha più visto i figli piccoli, e neanche la moglie - sua ex maestra, più grande di diversi anni e venuta con lui dall'Irlanda - andavano insieme in bicicletta, lui la portava in canna, rapinavano uffici postali con la mitragliatrice piazzata sul manubrio. La prima parte del libro è l'ardua ricostruzione della vita di Smart, la cronaca dei continui dissensi con Ford, i sospetti e le ombre verso il maestro del cinema che si fa raccontare le antiche azioni partigiane, le canzoni che cantavano, le donne amate, ma poi addomestica, arrotonda, chiama altri sceneggiatori, tradisce il racconto del ribelle. Ford poi lo spiegherà personalmente a Henry: addomesticare la Storia, inventarla, è un bene, la rende popolare come è successo al western che grazie a lui è divenuto saga e ha dato un'identità all'America. I dialoghi tra Ford e il testardo Henry sono surreali, tra botte da orbi, dita rotte, spuntini all'alba e offese sul set dove passa quel lungagnone di John Wayne. Il film sarà una pasticca zuccherata. A metà dei '60, Smart va a invecchiare in Irlanda. Fa il giardiniere da un'anziana vedova che gli rimanda ricordi. Ne diviene furtivamente l'amante, al riparo degli sguardi intrusivi dei vicini parrocchiani. A un tratto è agganciato dalla nuova Ira, usato come immagine dell'antico eroe della libertà. Il passato è una ventosa, non lo lascia - ma il passato ha doni per lui. Ritrova l'antica moglie, volto cangiante: la vedova di cui è divenuto amante senza rendersi conto chi fosse, e a sua insaputa lo ha ritrovato, gli ha dato lavoro, lo ha accudito. Durante l'infinito coma ospedaliero della moglie, incontra la figlia anziana. Poi Smart è fiabescamente vecchio, ha 108 anni. Un mitologico ultracentenario eroe d'Irlanda. Adesso, può morire. Alessandro Schwed
il Foglio, 28 gennaio 2011 |
|
Post n°19 pubblicato il 26 Gennaio 2011 da Jiga0
NARRANDO DIVENTEREMO LE CANDELE DELLA MEMORIA Alessandro Schwed, fiorentino, famiglia ebraica di origine ungherese, negli anni Settanta fondatore di radio e circoli underground, è Jiga Melik come storica firma della satira, da Il Male in avanti. Scrittore di romanzi, collabora con Il Foglio e con il Secolo XIX. La sua storia personale s'intreccia alla Shoah: tredici i famigliari perduti nei campi di sterminio. Dal suo romanzo del 2005, "Lo zio coso", è tratto lo spettacolo, regia del triestino Alessandro Marinuzzi, ospitato da Akropolis, stagione del teatro Club di Udine, domani alle 21 al Palamostre, per "La Shoah e oltre". Titolo, "Alla ricerca dello zio coso". Coso..., qualcuno in quel romanzo è rimasto senza parole. Dice Schwed: "Alla morte di mio padre ho temuto che scomparisse con lui il legame di tenerezza che mi univa alla generazione precedente, mentre mi narrava della sua vita. Così ho smesso di resistere ai ricordi e ho cominciato a scrivere, attingendo ai miei elementi personali: ho parlato della discesa verso l'abisso della Shoah, sperimentata dalla mia famiglia. Mio padre scampò con la sorella al lager, ma molti nostri famigliari morirono. Il risultato è il racconto di un viaggio in Ungheria che si articola attraverso incontri e reminiscenze confuse, compiuto da tre ambigui personaggi maschili. Il 'coso' narrante incontra il 'coso' negazionista in treno, durante la ricerca di un parente sopravvissuto allo sterminio della sua famiglia. In bilico fra Ungheria, Italia e Israele, decide di scrivere la sua storia e quella dello zio coso, quello vero. Ne verrà fuori una atroce e paradossale caduta nell'oblio, in cui l'io narrante perde addirittura le caratteristiche individuali, perfino le parole, e finisce per confondersi con l'ambiente circostante". Una satira antinegazionista che fa riflettere sui fantasmi del passato, la tentazione di credere che niente di quanto raccontato dai sopravvissuti sia mai esistito e che rivela gli incubi del presente. Ma com'è la Giornata della Memoria per Schwed, quali sono le sue paure? "Temo che il passato scompaia. Che non rimangano strumenti per le generazioni future. La memoria non si commemora, si evoca. Per farlo, occorrono degli sciamani che recuperino la storia. Gli artisti sono spesso i più adatti a farlo, per questo ho amato questo progetto teatrale. Quello del popolo ebraico è un dramma che riguarda l'intera umanità, perciò può, deve essere ricordato attraverso le persone. In Israele c'è un modo per identificare i figli dei Salvati. Gli uomini e le donne che consumano la propria esistenza raccontando cosa è accaduto si chiamano "candele della memoria". Il 'mestiere' delle vittime poi è spaventoso, è un contagio che scivola spesso in patologia, in malattie che passano da una persona all'altra, perché evocare il male continuamente, è terribile. Anche il mio giorno della memoria è doloroso e mi sconvolge, ma nonostante questo credo profondamente che raccontare sia mio dovere". Fabiana Dallavalle
Il Messaggero Veneto, 26 gennaio 2011 |
|
Post n°16 pubblicato il 20 Gennaio 2011 da Jiga0
Un romanzo sull'Israel after Un film dalla forma apparente di libro: "Il diritto al ritorno", dell'olandese De Winter, scrittore politicamente scorretto. Prossimi anni Venti, un romanzo sull'apocalisse israeliana: tra fantascienza, thrilling, visione politica finale e la tragedia di un uomo cui sparisce l'amato figlio piccolo. Eroso psicologicamente, svanito nella geografia, sotto piogge di razzi e attentati, ora lo Stato di Israele è la città-Stato di Tel Aviv. Gli abitanti folle di vecchi, poi prostitute, i soldati, medici. Striminziti confini sono controllati da tecnologie che leggono il dna. Scenario alla Blade Runner, ma fatti e persone sono autenticati dal ritratto ai modi e le voci della realtà israeliana. Una coppia di particolari detective è specializzata nella ricerca di bambini scomparsi da anni. Uno di loro, il protagonista, è vicino alla mezza età: Bram Manhein. Bram sta per Abraham. Di origine olandese, immigrato in Israele. Il suo anziano padre fu nobel per la fisica. Flash-back. Il 2004. Un Bram trentenne è docente di storia all'università di Tel Aviv, e pacifista. Ha una moglie di bellezza straripante, un figlio neonato, vita glamour. Bram polemizza con la politica israeliana e col vecchio padre che vuole durezza coi palestinesi, mentre lui cerca il dialogo. "Ora pensa la realtà, a cucinarti", sussurrano le righe. Infatti c'è che la moglie è andata a prendere il bambino all'asilo nido, Bram è in taxi, e c'è che arriva la notizia di un attentato e lei non risponde al cellulare. Bram si tuffa in strada. Corrono ambulanze, c'è una lunga colonna di fumo, corpi dilaniati, grida. Bram è davanti all'asilo in fiamme, il suo urlo primordiale sale al cielo. Poi moglie e figlio sono salvi, ma la stanchezza degli israeliani precipita sulle sue spalle, e le sue spalle sono fragili. L'offerta di una cattedra a Princeton allontana la famiglia negli Usa. Lì c'è una casa di campagna appena comprata. Farebbe sognare. Però è un cantiere permanente: spese continue, le piccole tasche di docente, notti insonni, incubi premonitori raccontati allo psicanalista freudiano. In una improvvisa fiaba nera che già tambureggia, mentre la bella moglie è all'estero e lui è in giardino al telefono, il bambino sparisce di casa. Di lui nessuna traccia, come se il corpo fosse d'aria. Dissolto così piccolo, mentre cominciava a offrire al padre le prime parole e la prima dolcezza. Bram precipita in una vertiginosa assenza di ragione: si sente inadeguato come è sempre stato inadeguato alle aspettative del padre. Non risponde al telefono alla moglie lontana, la lascia all'oscuro della tragedia in atto. E' nel terrore. Sparisce anche lui. Emigra nella fantasia più scollegata dalla realtà. Vaga nelle città americane. Vorrebbe trovare il figlio tramite uno stato di trance col mondo dei numeri - maniacali il due e l'otto. Lo cerca in highways e in strade fornite di cifre correlate alla data di sparizione del figlio. Pagine di interiorità di una storia che abbraccia ogni angolo del'umano e ne fa una sorta di grandioso cinema di carta. Barbone, dorme nei parchi, mangia alle mense per la gente di strada. La bella moglie è sparita dalle pagine: si sa che ha divorziato e siamo interessati a Bram, Bram sta male. La narrazione non è più sulla fine di Israele, ma sulla fine di un padre. Siamo in una nuova storia di viandanti e di hobos. Bram, la sola costante dell'avvincente romanzo, viene ritrovato e condotto in Israele. Adesso, entriamo nel genere thrilling. Bram ricostruisce su internet l'identità del rapitore del figlio, un pedofilo. Va negli Usa, torna in segreto nel vicinato rurale dell'ex casa americana e lo ammazza come un cane. Ritorna a Tel Aviv, cerca di cominciare a vivere. Riecco il presente blade runneriano. Ma c'è la normalità? La prostituta conosciuta in un bar forse lo ama, la vita di volontario in ambulanza, il socio dal corpo per metà protesi in titanio, tutto lo spinge verso il figlio: il lettore lo sente. Si alza lo sguardo sul jihad mondiale, le vie del fanatismo, il fallimento della politica israeliana di un tempo - il nostro. De Winter racconta di un padre e intanto proietta le immagini di una cupa Israele futura, e la nazione potrebbe non avercela fatta, né con la speranza di pace né con i fuochi di guerra. Del diritto ebraico al Ritorno, dell'ancestrale appartenenza del figlio scomparso a Israele, leggerete. Alessandro Schwed
Il Foglio, 20 Gennaio 2011
|
|
Post n°15 pubblicato il 16 Gennaio 2011 da Jiga0
Divagazioni sul ritrovamento in Israele dei denti di un uomo di 400.000 anni fa Se le cose stanno così, Genesi deve essere riconsiderato. Non è più il testo allegorico dell'inizio del mondo e della presenza umana, ma un diario storico-geografico. Di questo ci parlerebbe, se sapessimo che c'è stata, la grandiosa scoperta dell'archeologia israeliana negli ultimi giorni del 2010: il rinvenimento dei resti di un Homo Sapiens vissuto quattrocentomila anni fa. Gli ancestrali molari di un tale che magari era Adamo. I denti del nostro potenziale progenitore si trovavano in una cava presso Rosh Ha-Hayin, nella parte centrale di Israele. Però la ragguardevole notizia è sparita e non ne discutiamo. Non è sparita per cattiva volontà, è che i media non hanno la sensibilità antropologica per assorbire la notizia dell'improvvisa veridicità delle storie di Genesi, e accade come con le allergie alimentari che respingono un cibo a prescindere dal fatto che sia un manicaretto. Il nodo decisivo del ritrovamento deriva dal fatto che i quattrocentomila anni del Sapiens israeliano sono il doppio dei duecentomila del Sapiens africano, finora archiviato come il più antico. Se le analisi in corso lo confermeranno, il racconto dell'Eden, che Genesi colloca fra il Tigri, l'Eufrate e due fiumi sconosciuti, combacerebbe con la realtà antropologica e geografica chiamata Israele e più in generale con la regione mesopotamica. Oppure, detto alla Cormac McCarty, la Bibbia, quel volume che galleggia nei comodini degli alberghi americani, a un tratto racconta in diretta la prima vicenda umana. Non ci interessa tanto che facesse l'Homo Sapiens nelle sue ore; e se come racconta Kubrik in "2001, odissea nello spazio" raccattasse un osso da terra e spaccasse la testa ai simili che gli contendevano la pozza d'acqua; né che ciò avvenisse proprio sotto la grotta dove la notte giaceva ammucchiato coi suoi: vecchi, coetanei, madri, dei bambini figli di tutti quanti. E neanche sapere che un Sapiens, o il succedaneo, il Sapiens Sapiens, stesse meditativo a fissare la luna imprendibile, falce un giorno e tondo qualche tempo dopo. Il fatto è che la Bibbia a un tratto esce dalla nebbia dell'allegoria ed entra nella luce solare, e noi esseri umani, i destinatari comuni di una storia di cui il Libro sarebbe bussola e orologio, dobbiamo cogliere l'occasione. Raziocinare. Riferendosi alla recente scoperta, il Rabbino Disegni fa notare come la definizione stessa di "homo sapiens" potrebbe ispirarsi alla traduzione latina della Bibbia dove compare una volta in Proverbi, 20.5, per tradurre l'espressione ebraica "ish tevunà", uomo di sapienza. Se ci fossimo per davvero orientati, Proverbi, 20.5 è il passo in cui è scritto che l'uomo saggio non si lascia ubriacare - il che, riferito all'esistenza reale dei luoghi di Adamo ed Eva, ha il sapore di una sbornia di quattrocentomila anni, a causa della quale abbiamo dimenticato l'indirizzo di casa. Mentre l'indirizzo c'è. Per ritrovarlo, dovremmo riprendere in mano il Genesi e interrogare i suoi punti oscuri che dunque non sono parole esoteriche, ma incrostazioni e magari cadute del testo che offuscano la lettura: sul racconto dell'Inizio è finita la polvere di quattrocentomila anni - è questa la data esatta dell'oblio. L'oblio della cacciata dal Giardino, dal sogno di una preesistente felicità. Tempo indimenticabile ma dimenticato, per quanto sia stato dipinto e raccontato infinite volte. Se il Genesi è storia e geografia, non è un fatto religioso chiedersi che avvenne ai giorni di Adamo ed Eva. Quei due che ci furono davvero.
Pare che tutto fosse meravigliosamente a portata: l'acqua di quel gran fiume da cui originano i fiumi; la frutta su alberi verso i quali bastava alzare la mano; il clima, grazie al quale non c'era esigenza di coprirsi - da nudi si stava bene. Finché non sopraggiunse una specie di risveglio violento, la mente dell'uomo cessò di trasognare. Si accese. Scoprì il piacere e che il piacere porta al concepimento di figli, e che dunque il gioco non è solo gioco ma molto di più; e che allora le creature che volano, nuotano, galoppano, e noi altri, non nasciamo perché c'è la pioggia o passa un airone, ma in seguito alla congiunzione tra la donna e l'uomo, avendo la donna notato e raccontato che tutte le volte che lei e lui giacciono insieme e il suo ciclo si interrompe, c'è una gravidanza. E sempre di un risveglio violento deve aver fatto parte la scoperta che la vita passa come le foglie verdi che brillano e poi, rapide, si seccano. Sola consolazione, la vita prosegue in altri come noi, nuove brillantissime foglie verdi, simili alle foglie che eravamo: i figli. In quel tempo così remoto da non poter ricordare, le due persone consapevoli dopo generazioni di primati, non sapevano quanto dura vivere e che esiste la morte. Scoprirono che i giorni non sono gioco, ma esistenza che scorre e poi sparisce. Può darsi che Adamo ed Eva, rimessi a viva forza sotto i nostri occhi con il ritrovamento di un Sapiens "biblico", siano stati il primo frutto evoluto di una catena di frutti evoluti; la provenienza finalmente umana di una rozza specie precedente, destinata ad approfondirsi in Adamo ed Eva, a divenire noi, e dopo chissà chi nel futuro. Nel primo punto della Storia, questo maschio e questa femmina umani, frutto di inconsapevoli Sapiens, o chissà chi del passato, magari pesci gettati sulla spiaggia, avevano due caratteristiche: ignoravano e finalmente apprendevano. Ignoravano che la sessualità, la gravidanza e il dolore connesso al parto; che la potenza della felicità, dato che la felicità è rara, che la libertà di sbagliare; che tutto questo facesse parte della vita quando si smette di essere bambini instradati dai genitori e bisogna fare da soli. Ed è quando cessa la pura illusione e ci si sveglia bruscamente: "I loro occhi si aprirono, e si resero conto di essere nudi". Il che avviene a ogni generazione. Forse scherziamo con il mito della fanciullezza perduta. Non sappiamo davvero che svegliarsi è libertà e dolore tremendo. In mezzo al primordiale corrispettivo di sentimenti come i nostri, dolore, paura, curiosità, gioco - adesso vediamo in modo nitido quei due, Adamo ed Eva, perché li vediamo come persone di tutti i giorni, che girano con quelle foglie sul pube da qualche parte della Mesopotamia o di Israele - erano la nuovissima umanità. Bambini. Loro e quelli dopo di loro trovarono davanti a sé la responsabilità di essere i primi a imparare e i primi a insegnare l'esperienza ai figli. Dire a chi viene dopo che fosse successo dal giorno in cui Padre Adamo e Madre Eva, numero Uno e numero Due della specie consapevole e non puramente istintiva, dunque non una specie animale, avevano scoperto la libertà; spiegare che erano nati Caino e Abele e con la famiglia e con i figli la solitudine si era allontanata, e che tutto il vivere, si era chiarito, fosse bello e tremendo. Permanendo nel racconto dell'Inizio, in questo luogo che avrebbe una geografia e un racconto che coincide con la geografia, viene da interrogarsi su come sia avvenuta la comparsa di Eva - spuntata dal desiderio di Adamo che la solitudine finisse; venuta fuori da chissà dove, quando poco prima non c'erano che la propria voce e la Voce creatrice. Anche se poi, fatalmente, le prime parole umane che risuonano in Genesi sono di Eva che risponde al serpente - il quale chiede se Dio abbia vietato di mangiare il frutto della vita. Le prime parole umane rese note perché generano la prima scelta: un errore immane. L'inizio delle ebbrezze e delle consapevolezze. Il nostro irrinunciabile destino. Del resto, nelle generazioni si vede che si verifica in modo biologico di imparare molto disobbedendo e poco obbedendo; di apprendere dalla libertà usata male più che da una disposizione applicata in modo mite ma cieco. Siamo nati da un atto immaturo; una scelta ormonale, compiuta nell'adolescenza del genere umano, nell'Età delle Pulsioni. Torniamo ad Eva e alla sua comparsa. Il testo, che a tratti ora ci appare come un thrilling, dice che mentre Adamo dorme, Dio gli prende una costola dal petto e ci fa Eva. Insomma prende da Adamo e fa qualcuno che prima era una non utilizzata parte interna, e interiore, di Adamo - come il maschile è parte non utilizzata del femminile. Guardo dentro di me, e a un tratto sono qui, a credere che nel petto mi manca una parte che ci dovrebbe essere. Mi tocco le costole: è qui che manca, qui: no, qui. Da qualche parte dovrebbe esserci un avvallamento, la parte sottratta che è diventata Eva - e il femminile manca al maschile e il maschile manca al femminile. Ciò significa che prima della comparsa di Eva, nella porzione di terra tra Israele, Tigri ed Eufrate, che noi potremmo chiamare Mondo, girava un uomo solitario, impazzito di tristezza. Uno tutto solo che dava il nome a quanto incontrava di creature e piante. Onomatopee con cui si faceva compagnia, in modo che quando lui pensava a qualcuno o qualcosa, potesse evocarne il suono, e allora il qualcuno e la qualcosa erano lì con lui - potenza della memoria. E' dunque probabile che Adamo, nel Giardino, senza Eva con cui parlare, vagasse come un rabdomante in cerca invece che di pozzi, dei nomi da dare. Vedesse un albero e lo chiamasse albero, i pesci guizzare e li chiamasse pesci. Che lui desse nomi alle parti della realtà in relazione appunto al suono che le genera: la miglior compagnia che la grande e molteplice realtà possa farci - mio figlio chiamò l'acqua brum brum forse perché l'acqua scese dal cielo dopo un tuono, brum brum. Diceva brum brum e invece di avere paura, rideva. La notte, quando era buio e Adamo era solo al mondo, e i pesci e gli alberi non si vedevano, Adamo diceva i nomi della realtà, si rasserenava e dormiva in compagnia di confidenti parole. E tante volte si sarà chiesto: ma perché sono nato solo? E poi che senso avesse di essere unico assieme a tanti altri che invece erano coppie, due esseri del tipo maschio e femmina che vivono insieme; animali cresciuti con lui e divenuti amici che a un certo punto si univano e dopo partorivano. Le pecore, i cervi, i volatili, non condividevano le sue scoperte, le emozioni che lui ricordava stagioni intere. E gli animali amici non agivano in parità con lui. Erano sottomessi, anche amichevoli; giungevano facendo un fischio, però non modulavano la voce per fare parole con cui definire lago il lago e pietra la pietra. Gli animali non saziavano la sete spirituale: la smorzavano. Non gli davano futuro. Erano una sua pallidissima imitazione. Un cerchio di abitudini.
Adamo non poteva continuare così da solo, ma continuava. Penso a questo con una nuova convinzione, come a fatti ora visibili - so che qualcuno fu davvero solo in un posto esistito per davvero e chiamato Eden, prima del Negev o del Giordano, e magari era quel tale con quei molari vecchi quattrocentomila anni - Adamo. E non penso più ad un allegoria, ma alla vita umana ordinaria nel primo momento della Storia, trasformata nel racconto dei racconti, in modo di insegnare e tramandare. E mentre gli animali giravano in coppie, quell'Adamo malinconico e ancora senza Eva girava da solo; e mentre fra gli animali c'erano due tipi per specie ed erano in compagnia, e una parte della coppia era la dolcezza e la forza - il femminile - e l'altra era la forza e una certa solitudine, perché il maschile è solo, incongruo e pensoso, Adamo non aveva l'altra parte di sé. E questa era una cosa sempre più curiosa: che i viventi fossero sempre presenti nel numero di due, e lui sempre uno, mai con accanto qualcuno di simile: ma solo. Non era arrabbiato: era abituato ad essere solo con tutto intorno, forse a imitazione della solitudine-non solitudine divina - "lo creò a immagine divina, maschio e femmina li creò", Gen. 1.28. Ma Adamo non era contento. Cominciò ad essere meno schiamazzante; non saltellante come una lepre quando era di fronte a una lepre; o trillante come un uccello quando era di fronte a un uccello. Si depresse. Zittì. Era senza desideri - conobbe l'essere triste e deve essere stata la prima tristezza della Storia: l'idea che i giorni non fossero che quelli. E chissà cosa deve avere pensato le notti, supino, mentre guardava l'immenso cielo lontano. Non era una cosa buona. "Non è bene che l'uomo sia solo". (Gen. 2.18), dice nel testo la Voce che Adamo sente sempre, Pensiero che fa le cose. Ed ecco che vedo Adamo, forse dove ora c'è la stazione degli autobus di Tel Aviv, o a Damasco, allora non c'erano confini. Lo vedo al risveglio mattutino. Si tira su e accanto a sé c'è questo corpo. Una persona, spuntata da chissà dove. E' lì, quasi come lui - ma femmina. Poi, dopo lo sconcerto, l'entusiasmo: Adamo prende per mano Eva e corre. C'è una come lui con cui dare nome a nuovi animali e posti. E lì deve essere iniziata una lunga età del gioco: Adamo corre con Eva, con lei vanno a scoprire tutto. Eva è un qualcuno di così uguale: nel corso del sonno notturno deve essergli stato presa dal petto. Adolescente, contenta nel gioco, ad un passo dall'accensione dei sensi. Femmina. Chi è quest'Eva, chi è questo Adamo, devono essersi chiesti uno dell'altra ma non uno all'altra. Prima devono imparare a parlare insieme. Se avessero conosciuto le parole, si sarebbero raccontati o no di avere avuto lo stesso destino, di essere stati soli fino a quel momento, che Eva era arrivata da un bosco, aveva visto Adamo dormire nella radura e si era sdraiata accanto a lui perché finalmente c'era uno come lei? Certo, se avessero potuto ricordarlo, si sarebbero rivisti mentre venivano abbandonati o smarriti nella natura da dei goffi primati; una tribù di non consapevoli che camminavano a quattro zampe. Se chi li aveva abbandonati, avesse saputo parlare e avesse parlato ad Adamo ed Eva, avremmo saputo che erano stati dimenticati a terra fra gli alberi di un bosco, come quando cade un sasso di mano e non ci mettiamo a cercarlo, perché è solo un sasso. Magari fu proprio questa la causa del salto evolutivo: la loro lunga, precedente solitudine durante la quale iniziare a interrogarsi e sviluppare il pensiero e la curiosità, strappandosi al sonno della ragione. E in questo pezzo centrale di Israele, più a sud, più a nord, dopo il Giordano, prima, che importa: fu da queste parti la prima patria umana di cui parla il racconto che ora va indagato come un diario. In seguito, le generazioni dei vecchi si misero a ricordare, a onorare la differenza fra i propri progenitori, primi esseri pensanti, e il mondo semi-animale da cui i progenitori erano giunti per poi liberarsene. I vecchi che erano stati giovani cominciarono a sapere più di quelli che erano nati da poco, dunque ad essere sapienti; e i vecchi colsero la differenza tra le cose ordinarie e il disegno che doveva pur essere all'origine di tutto: il frutto di una volontà superiore, che vede molto più lontano, e infatti è collocata alla stessa altezza del cielo, figura di un'altezza spirituale a malapena afferrabile. I vecchi dicevano che la volontà superiore aveva una voce e non un corpo. Una voce non comune che parlava dentro Adamo come se fosse a un passo; non voce di uomo, ma sopra l'umano: voce di un mondo sovrumano. E questa voce non dimostrabile, sentita in modo nitido nel sonno come nei giorni, era del Creatore del Giardino, della luna e delle stelle, degli animali. Di tutto. Finché ci fu la capacità di sentire la Voce, devono aver detto i vecchi, finché uomo e donna seppero vedere e sentire chi non si vedeva però si sentiva, vissero una continua giovinezza. Ma parlare al serpente parlante, spirito d'inganno perché il serpente di solito non parla, parlare all'inganno dei mutevoli sensi, alla voce del piacere invece che alla Voce della creazione, spiegarono i vecchi, coincise con l'essere espulsi dal Giardino e dall'infanzia: e i frutti sugli alberi che erano sempre stati sufficienti e con i figli da sfamare non bastarono; fu necessario andare in un posto con più frutta, lasciare il luogo della perfetta divagazione spirituale. Imparare che se si seminavano i figli, si poteva seminare la frutta; che si potevano pascolare le pecore perché dove c'era abbondanza d'erba, c'erano più latte, più forza e più figli. Ma c'era fatica, e c'era anche omicidio. A vedere il mito del racconto biblico calato in un'effettiva terra, si vedono bene partenze e abbandoni, sangue sparso, le cose comuni però ai tempi dell'Eden. E dopo l'infanzia umana, scorre familiare davanti a noi l'apprendimento umano. A quanto pare, recidendo la gola alle pecore, dando loro la morte, con tutto che belavano e avevano una voce simile a un canto, si vedeva che tagliandone il corpo in quarti, si poteva metterne le carni sul fuoco nato da un fulmine e vegliato per essere tenuto acceso, e cucinare le carni. Ardendo, mandavano odore gradevole. Il cibo era caldo, saporito e dava forza. Veniva l'allegria alla figliolanza ed era cosa buona - frase che diceva sempre la Voce quando aveva creato una cosa nuova. E se questa cosa era buona per gli uomini, doveva essere offerta alla Voce che crea la vita. Capite, spiegarono i vecchi, dopo la cacciata, vivere poteva essere bello. Quasi bello: bastava ricordarsi come fosse la purezza dell'infanzia, quando la Voce giungeva in noi. Ma il più delle volte era impossibile ricordare il modo di sentire la Voce, di farsi raggiungere. C'era sempre da combattere: avere freddo, stancarsi, dover dormire e alzarsi per tempo; usare la luce del giorno prima che cadessero di nuovo le tenebre, approfittare della vecchiaia per raccontare. I vecchi dicevano tra le lacrime che Adamo ed Eva si accorsero che il loro corpo diventava secco come i rami secchi, da ultimo il sangue non correva e i corpi umani erano come quelli degli animali ormai vecchi trovati senza vita nel bosco: fermi forse per dormire e con lo spirito da un'altra parte. Allora nasceva la domanda: noi altri che non siamo gli animali, abbiamo pensieri e non siamo ripetizione come brucare e pascolare, dove andiamo quando si muore, e chi ce lo dice dove andremo? A questa domanda, i vecchi rispondevano: Padre Adamo e Madre Eva dissero che dove andremo questo lo poteva sapere solo la Voce, che loro avevano conosciuto.
Ecco, se tutto ciò è il residuo di fatti remoti e non un'allegoria, non potrebbero davvero esserci stata la Voce e il suo primo magistero? Perché non dovrebbe essere autentico il racconto della Voce che crea dalla materia dentro di te? Non è forse questo un figlio, un crearsi di materia nella tua carne? E la più grande speranza non potrebbe essere quella Voce che si fa sentire nel nostro quotidiano buio, insegna, protegge, ed è Dio? Se non è Dio, si usa dire, è la coscienza che si interroga con le nostre parole. Su questo punto, il racconto dell'Inizio si fa imprendibile. Aderirvi non è un fatto di ragione, di ipotesi, ma pura libertà: se sentire con Adamo ed Eva la voce che non si sa da dove origini; se non volerla sentire; o sentirla, provare a ingannarla e non riuscirci. "Dov'è tuo fratello?". "Non lo so", rispose Caino. Allora tutto si svolgeva in una grandiosa paura dell'ignoto, tutto era ignoto. Al sopraggiungere della sera, il sentimento del timore doveva essere quello dei bambini, perché col buio tutto sparisce. Ma questo non basta a spiegare una fantasia così dialettica come i dialoghi tra l'uomo e la Voce. L'aver definito insegnamento quanto viene, o sembra venire dall'alto, il primo distillato di sapienza su come si vive, viene dall'esperienza delle generazioni o dalla Voce che dice partorirai con dolore, conoscerai la fatica? Adamo ed Eva furono spinti a viva forza nel mondo. Nel mondo, il suono della Voce andava e veniva, e adesso che a parlare erano in tanti, la Voce poteva essere frutto d'immaginazione, persino di una pazzia. E si dovette scegliere quale delle due fosse la cosa vera: se l'immaginazione o quella realtà come senza fine. E da allora è stato così: chiedersi se Dio sia un'immaginazione, oppure il Libro scriva di un'effettiva realtà iniziale in cui Adamo visse dalle parti di Rosh-Ha-Ayin, aveva ottimi molari e il Creatore dell'universo gli insegnò a parlare.
ALESSANDRO SCHWED
il Foglio, 14 Gennaio 2011
|
|
Post n°14 pubblicato il 11 Gennaio 2011 da Jiga0
Come è noto, il Times aveva anticipato alcune parti del libro del fisico Stephen Hawking, appena uscito nel Regno Unito: The Grand Design (Il progetto grandioso). L'opera spiega l'ultima scoperta del professore: l'universo è nato a causa della legge di gravità. La notizia ha avuto grande eco. In parte, va detto, perché nell'immaginario mediatico, l'unico rimasto a disposizione, il professore è sì un grande scienziato, ma più che altro è una star, persino protagonista dei Simpson e di Futurama. Poi quel nome, la mente e la carriera sono circondati dall'alone di una malattia degenerativa che si sovrappongono al lavoro del professore e a nostro modesto avviso lo sopraffanno. In Italia, dove il libro non è uscito, naturalmente le pagine di Hawking sono già state discusse. E' accaduto sul forum on line di un grande giornale - senza avere letto il libro, ma sentendo di averlo letto. Non è cosa nuova. Accade in spiaggia o sul treno che si discutano i romanzi avendo letto i titoli e non le pagine vere e proprie; e dai giornali, alle Tv, ai forum, ognuno assente alla scoperta per sentito dire da una catena di sentito dire in arrivo dal Regno Unito, dove il volume è in libreria da due mezz'ore. Dunque, tutti assentono che fu la gravità. Ci si domanda se non averci pensato sia grave. Ma siamo di fronte a due indiscutibili meriti del dibattito on line: mostrare cosa pensino le persone, credendo di pensare; offrire una discussione sulla scienza, sviluppata come una seduta spiritica. E dunque, con la stessa evidenza di quando si sogna di sapere qualcosa di mai saputo, tutti hanno notato come Hawking abbia nettamente risolto il problema della nascita dell'universo. Nel forum, la scoperta che l'universo è nato a causa della legge di gravità è stata percepita come una vicenda di tipo domestico, ad esempio riparare il lavandino quando si intasa - che fra l'altro è complicatissimo e si deve chiamare l'idraulico. Ma quello che ha fatto da levatrice al dibattito non è l'annuncio che la legge di gravità abbia creato l'universo, ma che il professore ha detto che Dio è inutile. Al sentire questa notizia metafisica che uccide la metafisica, vero balon d'essai editoriale, i dibattenti del forum si sono entusiasmati. Disgraziati e ingenui. Non capiscono quanto abbia da fare il professore ora che deve riempire il vuoto lasciato dalla partenza di Dio. Sta a lui, uomo sofferente, e per crudele contrappasso scienziato di fama e star arciricca, perseverare sino a offrirci una visione pop, magari anche con un musical, di come sia nato il cosmo e che vi fosse prima che la legge di gravità si mettesse a ballonzolare. Sarà dura, spiegarlo: non essendoci più Dio, nessuno ha lasciato appunti sul tavolo d'ingresso. Adesso che un libro è stato lanciato con l'argomento blandamente immenso che Dio è inutile, è difficile immaginare cosa potrà essere escogitato nel mondo editoriale per attirare altri interessi. Ma come tutti, ora anche io sento di capire. Immaginiamo che un autore di thrilling debba presentare il suo nuovo romanzo, "Mario aveva appetito. Una comune storia di cannibale". Lo scrittore crede di essere sul punto di riscuotere un enorme successo. Illuso. Il cannibalismo è acqua fresca ai tempi nostri. E nonostante sul risvolto di copertina sia scritto che la vicenda del killer cannibale è la vera storia dello scrittore, alla presentazione del volume non viene nessuno. Verso le una, nella sala da pranzo della conferenza stampa si presenta un critico letterario e chiede se le "Polpettine all'ambigua" previste al rinfresco antropofago per i media (la casa editrice ritiene le polpettine all'ambigua un'elegante citazione delle persone cucinate nel romanzo), siano davvero accompagnate da un contorno di carote, o è una provocazione. L'autore risponde con un sorriso ambiguo che è tutto autentico, anche le carote. A queste parole, il critico abbandona la sala. Vergogna, grida l'editore, lei fugge davanti alla differenza antropofaga! Ci mancherebbe, risponde il critico, io adoro la carne umana, è che se mangio le carote mi riempio di bolle. A riguardarci non è la guasconata mediatica dell'inutilità di Dio. Ci interrogano le numerose mail sul libro, comparse nel forum: brevi disquisizioni di tono ed età più o meno liceale sul fatto che ora che Dio non c'è, le religioni se lo prendono in un luogo meno misterioso dell'inizio dell'universo. E infatti, del dibattito incuriosiscono i contorni. Intanto, come al solito nelle chat, "Dio", nome proprio maschile, viene pedantemente scritto con la d minuscola. Però, non si può fare ameno di notare che ove siano menzionate divinità come Giove o Pallade Minerva, innestate tra la grande letteratura di tutti i tempi e un'idea precedente e scarsamente esplorata di Dio e delle virtù, di solito prevale il rapporto con la letteratura e le iniziali sono maiuscole, come accade per D'Artagnan, Robinson Crusoe oppure Oblomov. Ed è esclusivamente al Dio degli ebrei e dei cristiani che viene riservato il trattamento della lettera iniziale minuscola. Non così per Shiva o Visnù. E neanche per la dea Kalì. Verso lei, anzi, c'è un enorme rispetto. Né lo scempio delle minuscole, avverrebbe mai per divinità animistiche. Se dovesse essere trattata la storia di Gazonka, un dio sasso marrone, siatene certi che verrebbe scrupolosamente scritto GAZONKA, tutto in lettere maiuscole, per non offendere la sensibilità della pietra. Scivolando per le vie del negazionismo spirituale, i giovani dibattenti si firmano Eresiarca, Nightshade '90 (traduzione: Ombra della Notte '90, quasi come Tex, il cui nome indiano era Aquila della Notte). Se no, Popper, Congo, Leo-Pat, Safidy, Southsun, Ragù, El Topo e il per niente lapidario Cosmo Gioioso. Poi ci sono Andrea, Flavio, Mario, Annina, e così via. Un certo, ricorrente Ciccio, chiaramente ispirato al garzone di Nonna Papera, interviene: "...il concetto di un dio è inutile dal tempo della pietra. Se non so spiegare per quale motivo ci siano i fulmini o perchè si è generato l'universo, non ho nessun valido motivo per pensare che ci sia un'entità superiore, con tutta una serie di caratteristiche ben delineate, tipiche di ogni religione". Flavio non si risparmia. Assorto davanti alla solitudine del pc, si chiede fumettisticamente: "Uhm, era il caso di intitolare il libro 'Design'?". FS Muniello, forse un controllore delle Ferrovie dello Stato, scrive tra slang ed erudito: "Diciamo che mo' per i deisti non rimane altra possibilità che pensarla come Epicuro...". Nightshade '90 scrive Dio con la iniziale maiuscola, ma spara: "Dio era inutile sin da prima, anche se non sappiamo cosa abbia creato l'universo, è sempre più semplice presupporre che l'universo sia increato che presupporre che sia stato creato dall'essere tal dei tali con il talento di essere increato". La fila delle mail prosegue, però mi sono fermato a quella di Tonii, due i, che alle 17:53 del 2 settembre 2010 scrive: "Che idea bizzarra che l'universo sia stato creato! sembra veramente un'incrostazione giudaico-cristiana" (senza la maiuscola alla esse di "sembra": in chat o su email la minuscola fa sempre stile). E se nella disanima mi sono fermato qui, non è stato per la mancanza della esse maiuscola dopo il punto esclamativo, ma per la definizione "incrostazione giudaico-cristiana". Non mi è semplice digerirla. Che può avere acceso l'insulto morbosamente creativo, rivelazione di un'insofferenza presente in tutti i forum? Forse l'astio nasce dalle questioni morali messe di traverso dalla Chiesa sull'autostrada del relativismo. Se no, questa viscerale opposizione alla cultura ebraica e cristiana potrebbe essere una risposta alle intolleranze a chi non crede, non è battezzato, non si sposa in chiesa: sofferenza storica del paese dei Guelfi e dei Ghibellini; o la contrapposizione è dovuta a un presente dove le religioni sono percepite da molti come elemento di sanguinosa divisione. Infine, a tali fattori potrebbe unirsi la consueta componente anti-ebraica, mascherata da insofferenza culturale. E quest'ennesima esibizione di sprezzo alle religioni ci interroga. Intanto, si tratta di rancore-bandiera: di Orgoglio Ateo. Ti sputa addosso per conto di un totalitarismo laico che rigetta i credenti come specie più che reazionaria: regressiva. Cavernicoli superstiziosi che gridano alle stelle invece di tracciare equazioni. In verità, più che discutere una grande scoperta dell'astrofisica, il dibattito si nutre della frase: "Dio è inutile": il disorientamento che intende generare, eccita. Ora, vorremmo capire se nello scontro in atto da tempo tra la legge naturale e la nuova legge di de-responsabilità, stia affermandosi la crescita matura dell'odio allo spirituale. Una cultura del dispetto a Dio e ai suoi seguaci. Succede che per una folla insorgente che andrebbe censita, e che ha iniziato a radunarsi nel secolo dei lumi, la ricerca scientifica è la sola certezza contro la ragnatelosa superstizione chiamata religione. Ma ora che la china che se ne viene dalla Bastiglia a qui è stata percorsa e siamo in un mondo senza umanesimo, fatto di scienza, fantascienza e dilagante fiction, paradossalmente si va affermando in modo incontrollato una convinzione fideistica: quanto viene dalla terza rivoluzione industriale, e digitale, porta la conoscenza a un sapere superumano e digitale, che spazza via le religioni come un'immensa ramazza. E con la sfera spirituale, di cui ad esempio si occupava il filosofo, anche comunista, Benjamin, grande studioso della mistica ebraica, viene sradicato quello che incrosta il presente con il passato: Genesi, le lettere di Paolo, Dante...Ciò che è scritto in latino, (in ebraico poi non se ne parla), e quanto è scritto in forma morale o moraleggiante, è accusabile all'istante di stregoneria oppiacea. E come per un lungo e recente tempo postbellico si diceva fascista a chi non la pensava da comunista, oggi chi non è ciecamente con la Scienza, è uno stregone creazionista. Stop. Tuttavia, il compatto fronte ideologico della Post-Storia non risponde alla domanda basilare: che movimento dal Niente ha creato la legge di gravità? Ma poi, nonostante l'orgoglioso silenzio ateo su cosa sia successo prima dell'Inizio, nel mondo che chiamerei della EA, Era Anestetica, sono la scienza, la playstation, il gossip, il calcio e la guerra in Tv, a dare emozioni che sembrano risposte. Ciò è riscontrabile in un immenso bar-sport dove un tifoso della scienza polemizza col barista, che crede in Dio anche dopo che al tiggì hanno detto che è inutile: "Pino, hai sentito o no che Dio non c'è. Capito, non c'èèè". Un altro avventore inzuppa il cornetto nel cappuccino e gorgoglia: "Serie B". Regna un'illusione de-regolata, simile a quella di Babele (ho letto il Genesi decine di volte: sono creazionista?) per cui è verità ciò che si sviluppa in una conoscenza basata sui numeri e dotata di sola sensibilità autoreferenziale, fuori perfino dalla Storia. Non è ricevibile, neanche allegoricamente, la memoria mitopoietica, la storia del popolo ebraico, il Cristo, i Padri della Chiesa, o il Manzoni, reo di aver scritto, non importa se molto bene, un romanzo morale. A guidare tutto, deve, deve, essere la scienza, che bolle democraticamente ogni cosa - senza riguardi. Giacobina e stalinista di uno stalinismo che Stalin non avrebbe osato sognare. E a proposito, scorrendo le mail, ascoltando i discorsi dei giovani amici dei giovani figli, di affollati social forum a un tratto deserti e poi a un tratto strapieni, si può vedere che le leggi scientifiche, le scoperte e i gossip ufologici sono adorati in un posto dove non si vede il cielo - il salvaschermo. E nello stesso spirito con cui all'indomani della Bastiglia si provvide a sostituire i nomi dei mesi con altri appellativi, sostituendo a un potere e una religione degenerati, un degenerazione-religione del potere. Dunque, nel forum su Hawking, un rinnovato Terrore: il richiamo all'ingresso parigino nella modernità, la via alla ghigliottina, solo canone classico rimasto in piedi grazie alle misure intramontabili del collo. Come in un libro di fantascienza della vecchia collana di Urania, a Hawking viene offerta una devozione da Messia digitale. E lui si offre come un Unto Algebrico che propone di desertificare secoli di chiostri e uomini assorti con una battuta alla Clint Eastwood. Diverso sarebbe stato se Hawking avesse detto: "Dio è inutile" e nel buio fosse partito un mandolino alla Morricone, seguito da un sibilo di pallottola. Di fronte a certe parole di denegazione al fosforo, viene in mente l'intimo Sasso Spicco nel seno della terra umbra. Francesco vi si avviluppava come in un utero primigenio. Cercava Elohim, Creatore e Pluralità. Gli scientisti on line lo avrebbero chiuso al manicomio. E nell'ora del trionfo della Scienza, la religione è percepita come una veste striminzita nella quale non si riesce ad entrare. Ai devoti della scienza (a chi ritiene che le inquietudini su da dove veniamo e dove andiamo siano esaurite dagli esperimenti di teletrasporto), i margini spirituali sono quelli di un dio minuscolo e scritto in minuscolo, aristotelico e remotissimo nel suo chissàdove del motore immobile. Un dio senza speranza e sentimenti. Un dado per il brodo rimasto nella credenza da trenta miliardi di anni; un coso ammuffito, vegetante al centro di un vortice, in una galassia sigillata e senza numero di telefono; un corpaccione informe che va da un buco nero all'altro, nella reggia implodente di Antimateria. Di fronte alla Scienza e al rasoio tagliente della ragione, ciò che è spirito, l'indimostrato, quello che è in me ma non si sa in che parte di me, ma poi le religioni, la tensione a una geografia sconosciuta, è bazzecola da parrocchia. Ed è curioso che alla storia della fede, umanesimo di umanesimi e spericolate immaginazioni, si contrapponga un razionalismo ultranano. Ed è appunto curioso come sia sempre sui forum di questa o quella per me pari sono, che nel medesimo birignao si accetti-immagini-invochi l'arrivo degli alieni come un bene fatalmente salvifico. Senza più scrutare gli incontri di Abramo che siede davanti alla tenda e aspetta di essere incontrato dall'insondabile, e ci lascia intravedere di intravederLo, ora siamo immersi in una percezione che rigetta l'invisibile e poi siede in attesa di essere incontrata da alieni mai visti, a parte al cinema. Da un capo all'altro del web, una cosa chiamata community, e che poi non si conosce reciprocamente in modo effettivo, crede che dalle stelle arriveranno flotte; dibatte su immensi ideogrammi di sfere e triangoli che compaiono nei campi di grano; manda in onda il filmato girato dagli astronauti sull'altra parte della Luna: vi si vede una donna aliena, viaggiatrice stellare, coricata in un sonno provvisorio nella sua capsula spaziale schiantata al suolo. E' morta o no? si chiedono commossi. E' una specie di fede, eppure nessuno vi perseguita. Qualche volte esagerate. Dite e credete che siamo nati da un'inseminazione stellare piovuta dal cielo, lo proclama Voyager, la vostra Chiesa. E tutti: oooh, ahhh. Quanto possibilismo verso qualcosa che potrebbe essere vero, ma ancor più, non vero per niente: l'arrivo in astronave del migliore dei mondi. E secondo teorie provate perché lo ha detto Mario, l'umanità potrebbe derivare, è il famoso anello mancante, da una modifica genetica realizzatasi nel corso di un'ancestrale unione sessuale con gli alieni. I quali, copulando con le nostre antichissime pre-donne, modificarono l'homo sapiens in Uomo, sottraendolo allo stadio di scimmia imprigionata in un destino di liane e reumatismi che avrebbe terrorizzato Darwin. Non possiamo esimerci dal raccontare la delusione che verrà dopo l'arrivo degli alieni, la cui precedente unione sessuale con i nostri avi si configura come stalking e anche come plagio intergalattico. Ma stavolta, quando arriveranno, per loro sarà dura. Non come l'altra volta, quando planarono sulle nostre colline e dopo avere parcheggiato il disco volante, sedussero alla rinfusa le nostre ave e i nostri avi-scimmia. Gli scientisti sarebbero meno fiduciosi negli extraterrestri, se potessero vedere quanto siano brutti adesso gli alieni a causa della catastrofe genetica procurataci reciprocamente e all'insaputa, La catastrofe genetica reciproca fu questa: quando loro ci hanno inseminato, modificato e fatti diventare uomini come erano loro, noi li abbiamo inseminati, fatti regredire e diventare scimmie come eravamo noi. A vedere come sono gli alieni ora, rimarreste senza fiato. Viaggiano svestiti e pelosi a bordo di grandi proiettili maleodoranti. Non hanno gli oblò. Sono cretini. La speranza generale sarebbe questa.
Alessandro Schwed il Foglio, Ottobre 2010
|
|
Post n°13 pubblicato il 30 Dicembre 2010 da Jiga0
A proposito di lei. La sola speranza è stata offerta dalle suore, spingendo la carrozzella nonostante vi fosse appoggiata una persona dai contorni scomparsi, e che proprio quella loro pietà faceva tornare a esistere. Era questo a brillare: che una catastrofe fosse protetta. Per il resto, in questa desolatissima fine, di lei non sappiamo come e quanto possa avere sofferto tra la deriva inarrestabile della rianimazione e l'autostrada degli abissi giudiziari, precipitando per anni nella proto-esistenza di quell'involucro. Ora, qualche frammento di notizia fa capire dove fosse arrivato il deterioramento, dal quale lei è stata spinta via per il tramite di un editto giudiziario che in definitiva emette di togliere il cibo a una persona, la quale per constatazione virtuale ormai non è più una persona. Il fatto è che il fluire di un processo vitale non è la vita, e non è una persona - tuttavia sono immessi gli zuccheri, c'è il processo vitale e sembra la vita e la persona sembra nella vita; poi sottrai gli zuccheri, e sembra un decorso e sembra solo che finisca la corsa - ma è la morte. Vale a dire che non è la programmata dismissione delle forze vitali, e a tale termine i fluidi cessano di prorogarsi - ma un insondabile crimine della repubblica. Del fatto che lei non rispondesse al canone di persona in vita, i giudici che hanno emesso la sentenza di svincolo sono certi in forza del codice che è inoppugnabile. Pur tuttavia, il codice è anche interpretabile, ed è stato sentenziato da una corte che invece lei esistesse in quanto persona e la morte non le fosse comminata; e tuttavia ancora, altri controsentenziarono che invece come persona non esistesse dato che vegetava: e cioè, lei era concettualmente pari a una pianta. Di fronte a questa violenta incertezza giudiziaria, in una pausa della quale il soggetto è morto per il prevalere di un'interpretazione, forse converrebbe vedere come il soggetto abbia abitato il più fitto dei misteri: che lei fosse tragicamente viva e che fosse anche tragicamente morta; che continuasse a vivere essendo morta da un pezzo, e che continuasse tremendamente a morire essendo viva. E dalla ridda dei tuttavia emersi dai controtuttavia, altri proclamano che se uno è malato da non essere più una persona, ma una pianta, appare un controsenso non aiutarlo a dissolversi mediante la nostra intelligenza. Ma io domando: deve servire a questo la nostra intelligenza, dopo avere scoperto il fuoco, la ruota, la legge naturale, la scrittura, il diritto, l'elettricità, la penicillina, inventato il computer e trovato la sequenza del dna? E si presenta il caso verosimile che se a una qualsiasi delle persone che sostenevano che la creatura fosse una pianta, ora venisse chiesto: "Per favore creami subito una foglia di lattuga, perché ne ho un estremo bisogno", saremmo nella merda. Non lo saprebbe fare. Il vero problema è che quando diciamo che una persona ormai è un vegetale, lo facciamo perché non sappiamo dove sia mentre ci è davanti e respira senza che nei respiri ci sia un alito sensato. Così. Dato che non sappiamo niente di come si metta praticamente in atto la vita, né perché la vita ci debba abbandonare. D'altra parte, mentre lei giaceva con lo sguardo vuoto, o sedeva sulla sedia a rotelle e procedeva sospinta dalla suore, non possiamo dire che non esistesse. C'era. Ma non sapevamo dove rintracciarla, domiciliarla, tassarla, censirla, richiamarla ai doveri civici, mentre pareva ristagnare come muschio. Ma esisteva: lo faceva all'interno di un ordine che ignoriamo, anche quando sapessimo a memoria Platone, il Diritto Romano e la Commedia di Dante. Forse, lei e gli altri sono i vegetanti per la miseria sconvolgente di non possedere nemmeno un'espressione idonea a definirli. E che povertà è questa, quando in mancanza di meglio sarebbe bastato dire che lei era una donna così malata da respirare senza saperlo. Ma non siamo in grado di affacciarci su una tale realtà personale. Una pianta irrorata di sangue, che esige zuccheri; forse più pianta che persona. Ma non sappiamo niente neanche delle piante da poter dire quanto fosse pianta e quanto persona - e forse è per questa catastrofe che è stata una stagnante sentenza a recidere questa incomprensibile radice metafisica. Eppure i suoi piedi erano qui, i polmoni si gonfiavano e svuotavano qui, qui era la temperatura corporea, i residui del bel volto - tutto qui. E dunque non sappiamo chi sia una pianta: noi le piante le innaffiamo, le curiamo, le potiamo, le concimiamo; in generale, argomentiamo circa le piante e diciamo che la pianta sente chi l'ama e chi no; ci chiniamo su di lei - la pianta è quasi sempre bassa. E di nuovo in generale, c'è chi l'innaffia e chi proprio sente che la sta nutrendo, e chi non sente di nutrirla e corre a casa a darle l'acqua come un genitore in pena. E per un turbine della coscienza sentimentale, andiamo nei boschi, guardiamo intorno furtivi e abbracciamo gli alberi; e rimaniamo in silenzio convinti di ascoltarli e che in quel momento qualcosa di solenne stia passando tra noi. Poi un giorno un amico ci chiede il favore di innaffiargli le piante perché deve partire e c'è da prendersi cura dei gerani e dell'amata azzalea. L'amico si raccomanda di non innaffiare mai all'ora di punta, che d'estate fa malissimo; dice di essere delicato col getto d'acqua che può scalzare la terra. Parte, e ogni giorno prima del tramonto sono dalla sua edera, dai gerani. Dall'azzalea. Nell'appartamento deserto, ristagna la solitudine delle vegetanti piante grasse; e sono senza scopo anche le piante sul terrazzo, pur essendo tante e così vicine. Le piante non vogliono stare tra loro - ma per noi; e io, che sono lì a sostituire il mio amico, le vezzeggio. Parlo con loro, ciangotto come con i bimbi. Guardo un geranio, mi chino sul suo silenzio e lo colmo d'acqua. E quando il pavimento del terrazzo è un corso d'acqua e la terra è nera in modo abbagliante, sono felice di quella sazietà acquitrinosa. Sul terrazzo la morte è stata cacciata. Eppure può succedere che nonostante l'acqua e le parole, la pianta secchi. Lei vuole l'acqua solo da quella mano, dal respiro che conosce. Non è detto che la sappia nutrire un tizio che entra in casa con le chiavi in prestito, se ne va, torna il giorno dopo e innaffia con la sigaretta in bocca. La pianta, vegetante per acclamazione, sente la pazienza quotidiana. Mentre noi, che siamo a lutto per la fine di una pergola; che ci avviliamo per la sparizione della grande macchia rossa di papaveri che a primavera era in quel campo, e da qualche anno non c'è più; che nella vicinanza tra un campanile e un cipresso scorgiamo il dialogo protratto tra la chioma e le pietre - noi per la vegetante non eravamo disposti a interrogarci se magari il suo corpo parlasse quel linguaggio che affidiamo a un geranio. Il punto è che quando una persona esce dal binario biologico e trapassa allo stato vegetativo, scivola fuori dalla forma di persona. E' senza forma, è declassata. Priva di funzioni, di forma, senza certezze mediche e giuridiche, è un fantasma. Succedeva che la sua corteccia cerebrale fosse necrotizzata; che non rispondesse, non parlasse, non vedesse, non sentisse - e poi curiosamente ci fosse. Può darsi che sentisse la realtà quanto lo può fare un pioppo - ma noi non sappiamo quanto senta un pioppo. Può darsi che accettasse di buon grado il liquido con gli zuccheri che ogni giorno filtrava nelle sue fibre. Può darsi che vegetasse proprio come quegli ulivi messi in fila che sembrano entità sulla collina. Ma noi che facciamo battaglie per le balene, per i pellicani intontiti dalle macchie di petrolio sul piumaggio; che ci commuoviamo della striscia di muschio su un muretto - e che è il muschio? una muffa vegetante che si attacca alla pietra. Che mettiamo in costosi acquari, piccoli pesci accesi come fiori, e li consumiamo con lo sguardo perché vengono a guardarci, e forse ci riconoscono - noi, non sappiamo chi sia e dove sia una persona che vegeta. Ma anche avessimo sbagliato a considerare vivo quel corpo, quella pietà significava irrigare di coraggio i vecchi e i malati. Purtroppo è stata lasciata fluire attraverso il grumo liofilizzato di un comma, il codicillo per cui la sua esistenza aliena non fosse assimilabile allo spirito costituente. Infine, non è in questione il sentimento del padre per la figlia. Non ci sogniamo di valutare una stratosferica stanchezza, il funerale mancato, un silenzio che bucava i timpani. Che una figlia prima parlasse, venisse al mare, corresse, litigasse, e a un tratto fosse un testardo niente. Apparisse una buccia senza frutto. La questione della Vegetante è quella generale: che pietà l'è morta. "Io l'amo", "Bisogna vedere se è costituzionale". "E' viva", "Bisogna vedere se è legale". "E' morta", "Consultiamo il codice". Il padre di lei, per favore amiamolo, perché non è stato certo amato. Ma lasciato nella progressiva desertificazione e condannato. Avremmo dovuto, tutti, farne le veci, associarci e ciascuno portare una parte di lei. Una lunga catena di relazioni sarebbe arrivata sino a questo padre, a dargli il cambio, e il senso. In ogni caso, invece della friabile legge, a un tratto a lei ha pensato il Giardiniere. L'ha portata nei suoi campi.
Alessandro Schwed Il Foglio - 17 febbraio 2009 |
|
Post n°12 pubblicato il 30 Dicembre 2010 da Jiga0
Forse gli anni Trenta. Una cittadina della provincia francese. Marie-Thérèse è entrata nell'adolescenza. Sua madre, la signora Plasse, è una vedova indurita da un matrimonio di ripiego: il vero amore le fu sottratto dalla sorella. C'è una religiosità arida e una casa dove le stanze sono fatte di ossessioni invece che di mattoni. Arriva Manuel, adolescente anche lui, figlio orfano del mancato marito della signora Plasse: ragazzo brutto, inquieto e sadicamente rimproverato dalla zia di essere brutto. Garzone in un tugurio che è la libreria del paese, ama in segreto la cugina, appena uscita dalla superficiale idea che lei sarà suora. A strapparla da una fede senza basi e da una falsa vocazione sono il cinismo autoritario della madre e lo scandalo derivato dalle avance indesiderate del cugino, tubercolotico come in un melodramma sprovvisto di sentimentalismi. Una passeggiata notturna chiesta dalla cugina fa deragliare la traballante salute di Manuel che tenta un timido approccio, ed è respinto. I due ragazzi sono sconvolti da qualcosa che non è minimamente avvenuto e ha fine quanto di spensierato era rimasto delle due infanzie. Sono i preamboli del romanzo quasi surrealista "Il visionario", di Julien Green, uscito ora in Italia, ma edito nel '34 in Francia, dove lo scrittore e drammaturgo americano visse tutta la vita, stimato da Breton e Benjamin, divenendo poi accademico di Francia. Dopo la passeggiata, Manuel si ammala e le pulsioni di eros sono poca cosa: dalle sue inadeguatezze nasce un'enorme sofferenza - è a lei, alla sofferenza, che siamo affacciati come ad una finestra, nella vita. Turbata, Marie-Thérèse si confessa da un gigantesco prete, una specie di commissario di polizia che trasfigura in colpa il suo turbamento per la passeggiata notturna col cugino, ma lei non avrebbe da confessare se non che non conosce la vita e che il ragazzo si è ammalato a causa della passeggiata. Ma vediamo che tutti sono come malati, schiacciati da un angoscia tossica: la signora Plasse ce l'ha con la vita, il confessore teme la colpa - l'angoscia è la nostra malattia terminale. Il religioso accusa la bambina della colpa che lei avrebbe potuto commettere se fosse avvenuto quanto non è avvenuto per un'inezia, e la sua paura genera la paura della bambina: una catena di paure che appare senza fine. E' l'inizio di un serrato tango romanzesco, danza con la morte e quanto la circonda: religione, paure, stanze sudice dietro le facciate normali; e spiare la morte degli altri per avere notizia di che proveremo e di cosa vi sia dopo. Ne "Il visionario" c'è la bellezza visionaria della letteratura, che racconta i turbini ravvisabili solo dalla letteratura: gli stati in cui viviamo, che vanno e vengono in noi, vestiti di normalità: scoppi d'ira, pulsioni sessuali inconfessabili, sublimazioni, fede fittizia. La voce narrante diventa quella di Manuel, e c'è il balzo del romanzo, un capitolo intitolato "Ciò che avrebbe potuto essere". La penna del ragazzo, ovvero di Julien Green, scrive nella terra di confine tra realtà e sogno - la doppia vita di chi immagina un mondo parallelo e ne scrive, la doppia vita di chi fa il romanziere. Manuel immagina sino a farci dimenticare che immagina, e l'immaginazione diventa realtà: va a vivere in un castello accanto al villaggio, in un sali e scendi di scale e torri che ricalca la tortuosità irrazionale dell'esistenza. Si emancipa oniricamente da schiavo, a valletto, a confidente, ad amante della contessa. Spia con gli altri l'agonia dell'anziano uomo recluso in una torre e che nessuno vede, ma di cui tutti sanno, come un relitto indimenticabile: il castellano, l'uomo che un tempo era potente. La sua esistenza ormai involontaria, designificata da una debolezza assoluta, dai dolori, dall'attesa impotente della morte, fa impazzire i figli e gli abitanti del castello perché questo è il futuro di tutti. Come scrisse Benjamin, "Proust evoca l'ora magica dell'infanzia, Green fa ordine nei nostri più remoti territori". Alessandro Schwed 30 dicembre 2010 , Il Foglio
|
|
Post n°11 pubblicato il 12 Dicembre 2010 da Jiga0
Insomma, andai a vedere Sannini di cui si parlava in giro. Entrai. Presi posto. La luce vacua sulla piccola platea svanì. Niente era consono al luogo come quel momentaneo arcibuio, e prima infatti era stato come nei sogni sedersi in fondo a un pozzo, tra delle sedie vuote. Il pubblico tossì perché quello rimaneva pur sempre un teatro, e si tossiva. Dal buio si passò alla luce: e c'era un uomo. Non alto; la barba folta e i capelli erano neri come il circostante pozzo. Capelli un poco lunghi, ravviati all'antica, col pettine e una passata d'acqua. Sotto il riflettore, il volto era latteo. Dal pullover blu, paricollo, spuntavano le punte aguzze di un colletto bianco. Indossava comuni jeans, fra le mani teneva un quaderno arrotolato. Sembrava un bardo irlandese. Recitò il monologo "Io e Majakovskij". Appariva serio, appariva austero; ma iniziò a parlare di vicende personali che intersecavano in modo a dir poco minimale l'esistenza epica del poeta russo: era il tappeto volante di Donato e il pubblica sbottava in colpi di riso gioioso. Tornai più volte a vedere il teatro del volto di Sannini, e diventammo amici. Veniva a trovarmi al Male. Avanzava timido nello stanzino dove scrivevo: "Sandro...disturbo?". Scrutava con discrezione quello che stavo mettendo sul foglio della gigantesca macchina da scrivere. Osservato di sbieco il mio foglio, lanciata un'oziosa occhiata alla finestra, si concentrava: "Ceniamo insieme stasera?". Mi guardava, e aggiungeva: "Sandro". Per Donato, cenare con gli amici era la cosa importante e il simbolo del suo teatro avrebbe potuto essere la tavola imbandita con tutti gli amici intorno, immagine dell'agapé cristiana cui Donato in modo svagato ma perdurante e certo sembrava appartenere. Ci trovavamo a cena su un marciapiede storto di Roma. C'erano Carlo Monni, Daniele Costantini, e sulla tovaglia un amico vitreo: il fiasco del rosso. Più tardi, ce ne andavamo con il passo che talvolta esitava, e giunti alla macchina, mentre stava infilando la chiave nello sportello della 127 blu, Donato diceva: "Stasera, ho davvero esagerato". Non era preoccupazione, era il distico della sera. A tavola, non parlava molto. Stava rintanato in un assorto silenzio e affettava assennato la carne; versava il vino ai commensali e a sé, e mentre la cena aveva corso, guardava la tovaglia, irreversibilmente pensoso. Osservava gli altri di sottecchi. Fingeva educato interesse alle parole di qualcuno che la sparava grossa e che non faceva che parlare; più tardi, a casa, quando quello se n'era andato, ne difendeva le opinioni proprio perché erano indifendibili. Non che Donato fosse bastian contrario, aborriva i linciaggi. Ma prima, a tavola, iniziava la cena con un sorriso, che passando dal primo, al secondo, alla frutta da sbucciare paziente, declinava nella smorfia della catastrofe quando tutti si alzavano e la cena era finita: perché ecco, una volta che si era stati a tavola con amici, con nemici, con gli sconosciuti e i conosciuti, osti gentili e osti carogna, serviti da camerieri delle molteplici periferie romane, uomini col ciuffo appassito e il corsetto, quando tutto questo era concluso e la notte era fonda, cosa altro rimaneva se non rotolare a casa? Ma nel mentre della cena, e della quotidiana comparsa di Sannini a Roma, aggrondato o lieve che fosse, Donato ascoltava il prossimo come non ho visto fare se non da certi frati. Per il resto, lui non apparteneva al mondo degli adulti che a tavola raccontano le prodezze sessuali, o se no le barzellette. Donato non diceva di sé. Di sé, diceva sul palco, dove c'erano poesie su ragazze come ninfe, spiate sotto una luce che poi era l'insegna di un bar. Ciò detto, era generoso, onesto e acuto. Nonostante l'apparente, e teatrale lentezza, era alacre: a patto che il lavoro si svolgesse nelle ore in cui saliva il suo tono, ma questo è degli artisti. Aveva un'idea, e l'avanzava con delicato entusiasmo, poi si faceva serio e guardava in giro: valutava se l'idea venisse amata. In ogni caso, avuta l'idea, diventava triste e taceva come se a un tratto si fosse ricordato di essere in lutto; come se pensasse di avere sparato senza uno scopo e oltretutto non fosse rimasto altro da fare. Dopo il ristorante, andavamo a casa di Donato, dove abitava anche Monni. Ci sedevamo su delle poltrone-sacco che mi pare fossero azzurre e parlavamo di idee. Molti progetti non sarebbero stati attuati, salivano come bolle verso il soffitto e dopo qualche istante erano dissolti, ma qualcosa resisteva e avrebbe tentato di diventare teatro. Qui non si tratta di rievocare quelle occasioni pubbliche note a tutti, gli spettacoli di Donato furono visti da tanti e con successo. Semmai, potrei dire della prima volta di Donato a un happening del Male, quando inscenammo di consegnare ad Andreotti il primo premio planetario per lo humor nero. Eravamo al Pincio. Come fosse un funzionario preposto esclusivamente ad amministrare la cerimonia, Donato fece un discorso di benvenuto preannunciando l'arrivo imminente della delegazione spagnola, preannunciata a sua volta da numerosi squilli di tromba e schioccar di nacchere. La delegazione era continuamente sul punto di arrivare, ma non arrivava, e gli squilli di tromba si ripetevano. Poi parlò un generale della Nato con gli occhiali a specchio, era Charles Monnier (Monni) e voleva comprare immediatamente il Lazio. Poi parlò Benigni, poi venne la polizia. A proposito degli ultimi due, la polizia e Benigni, a notte fonda Benigni arrivava a via Bonghi come per un'imboscata, e faceva uno scherzo in cui Donato fingeva di cadere. Verso le due del mattino, suonava il campanello. Donato andava al citofono e si sentiva una voce gracchiare per la casa: "Sannini! Polizia!!... Apri!!!...Lo sappiamo che sei lì!..Apri senza tante storie, o veniamo noi e sono cazzi!!". Donato era al citofono e sbarrava gli occhi. Gridava: "Ragazzi, la polizia!!", Poi entrava Benigni e anche quella notte Donato lo accoglieva con le braccia conserte. Modulava un saluto al limite del bisbiglio: "Robertino...che piacere...mi ero davvero spaventato". Il piccolo pubblico presente rideva di Donato che prendeva per i fondelli Benigni della mancata beffa, e faceva come lo zio che si prenda bonariamente gioco dell'inesperienza del nipotino.
Donato era il Presidente. Prima che esistesse l'organizzazione non operativa denominata Socialista partito aristocratico, o Società per azioni, di cui divenne presidente, era già il Presidente. E questo perché primeggiava nel rispettare gli altri; non dava peso a chi scambiava il candore quasi mistico per dabbenaggine; apprezzava sorridendo, o dando l'impressione di sorridere, chi lo criticava. Poi magari esprimeva le sue riserve in esilaranti spettegolate che erano dei taglia e cuci teatrali, fatti più che altro per divertire gli amici. Il Presidente non umiliava beceri, asini e prepotenti; non sgomitava per andare a finire sotto i riflettori televisivi. Non urlava, se non in rari, incomprensibili frangenti, ad esempio se nella credenza era finito il tonno e Monni si era dimenticato di andare a comprarlo. Che allora, si sentiva la voce di Donato attraversare il corridoio, e cupa: "Carlo!...Il tonno!!", come se Monni avesse dimenticato di andare al funerale di un cugino. Donato era il Presidente perché dava come se non stesse dando, ma invece dava: idee, ascolto, pazienza, tempo, il tetto e la tavola, la lettura privata delle poesie di Gottfried Benn e di Cardarelli. C'era sempre qualcosa di prezioso in uscita da lui, come se la sua testa fosse il rubinetto di un costante, stillante dare. Era un giovane uomo educato in profondità, inadattabile a questo evo come un garibaldino senza più guerra di liberazione. Inoltre, il Presidente Sannini aveva la voce gentile; era gentiluomo in mezzo ai cannibali, ai ladri di idee, agli avvelenatori che finirono per ucciderlo. Perché Donato soffriva di spaesamento nello stare al mondo, ma casa sua era il porto dei diseredati, volti sconosciuti che facevano la loro comparsa in cucina, o apparivano dormienti in salotto, sfilavano in corridoio con degli occhi scavati e poi non si vedevano più. Donato si infilava discretamente la mano in tasca e con un gesto che non era ravvisabile, l'abitudine a dare in fretta, una porzione di denaro cambiava tasca. Il prossimo era il testo teatrale che Donato studiava.
Ma vorrei prendere le mosse dall'Spa, da questa sua invenzione non teatrale in senso classico, ma assai teatrale, perché Donato ebbe la capacità di capire dove potesse arrivare il teatro mettendo una buccia di banana tra i piedi dell'ideologia. Non era satira politica, ma uno specchio dell'immensa sconfitta umana. Donato capì lo happening del Male e lo elevò. Se ne impossessò subito, dato che era una maschera naturale. Dovette solo fare l'altro sé stesso che veniva fuori appena c'era un'occasione per andare in scena. Donato era entusiasta di operare all'aperto, tra la cronaca. Colse come era importante fare un balzo ed essere subito dove aveva senso essere, e lì, in quel momento, accendere le luci e fare il commediante, con la sua forza di decomporre comicamente la realtà e far brillare la miccia del riso. Nel 1981, l'anno che venni via dal settimanale satirico Il Male, ebbi la fortuna di essere con lui e lavorare con lui nel segno dell'amicizia e mi ritrovai a fare l'Spa, il nostro partito. Una forza politica appositamente esangue e fallimentare, concepita da noi due per noi due, esclusivamente per subire disfatte rovinose e mostrare la noncuranza socialista e aristocratica. Una volta che il partito fu partito (uno dei nostri slogan), Donato si fece vedere molto poco, se non in qualche preambolo elettorale delle regionali-Lazio, in vista delle quali ci eravamo costituiti. A Teleroma 56, il Presidente parlò con allegria della nostra imminente disfatta. Sembrava un mistico precipitato nel corpo di un commediante. Il Presidente dell'Spa si vide in modo nitido solamente all'inizio delle regionali, quando ci recammo al congresso socialista all'Eur, con la Fiat 127 del Presidente, che era un po' come la 313 di Paolino Paperino. Una volta arrivati al Palazzo dei Congressi, distribuimmo i volantini scissionisti della federazione giovanile di Milano, che invitava ad unirsi immediatamente all'Spa. Donato si sdraiò per terra come un non violento gandhiano con la maglietta Lacoste, e si mise a fare il cadavere. Ogni tanto il suo braccio destro si alzava di scatto e porgeva un volantino a chi stava passando. Fece così anche Monni, ma la sua presenza era più corporea e squisitamente ineducata. Il Presidente non compariva mai: semmai scompariva a settimane. "Ma si vedrà il presidente?", chiedevano alle Tv libere romane. "Chissà", dicevo con un sorriso svagato. A Donato non interessavano tanto le elezioni regionali, quanto immergere la punta di un piede nello stagno chiamato Regionali-Lazio, ritirare inorridito il piede e protestare perché l'acqua era troppo fredda. Non era semplice, tutto questo nostro non fare. Dovevamo avere riunioni di lavoro. Donato estraeva un quadernuccio a quadretti, spiegazzato, e si dava a scribacchiare con la bic, blu e sfinita. Buttava giù righe distratte, come se fosse stato un barone che faceva occasionalmente il conto al banco della verdura. Scriveva, e gettava un'occhiata di sottecchi per vedere se avessi notato la perfezione ieratica della disgrazia di fare il conto. Perché quando c'era da lavorare, recitava anche in privato: era sempre in parte. E non era l'uomo del grande teatro, ma il grande teatro tutto in un uomo.
Ecco come avvenne la sua nomina a Presidente dello Spa, che è quanto si deve fare per ricostruire una stagione artistica come quella: raccontare i dettagli, le ombre, non i massimi sistemi. Perché, se avete notato, i massimi sistemi sono sempre quelli, e le persone cambiano, diverse come sono tra loro. E Donato era unico. La sera dell'acclamazione a Presidente, a casa sua c'eravamo noi due. Donato mi disse: "Che ne diresti, Melik - quando c'era da lavorare mi apostrofava col nome d'arte, se no mi chiamava Sandro - che ne diresti, Melik, se fondassimo il Socialista partito aristocratico, o Spa, Società per azioni?". L'idea era bellissima. "Va bene - dissi - tu potresti fare il presidente per acclamazione dell'assemblea dei soci". "Ma non ci sono ancora i soci", fece notare Donato che quando voleva, aveva i piedi per terra. A tale obiezione, feci contro-notare che se per questo ancora non c'era neanche il partito. "Ma che deve fare il presidente del Socialista partito aristocratico?" - mi chiese con un'ombra di incipiente preoccupazione. Gli dissi che il Presidente non doveva fare niente, ci mancava anche questa; se un Presidente fosse stato costretto a lavorare, sarebbe stato un pessimo esempio per tutti. E Donato fu Presidente del Socialista partito aristocratico. Dopo la nomina, mangiò una scatoletta di simmental.
Avevo letto della vita ribaldamente bislacca di Jarry nei bar di Parigi, e Donato mi pareva Jarry senza la pistola per sparacchiare, paracadutato a Roma: umorista e umorale, creatore di un personale re Ubu e una realtà parallela intrinsecamente non violenta, capitale umana di una dolce nazione di marmellata di bosco. E a questo proposito, l'inoffensività di Donato, ecco che accadde al secondo festival internazionale dei poeti, a Roma. Era un periodo più che successivo allo Spa. Donato era stracolmo di un'invincibile tristezza. Aveva inaugurato un suo continuo soliloquio di cui si capiva poco, perché era pronunciato più dentro di sé che fuori da sé, e quel che si sentiva a malapena, era a fior di labbra. Il mio grande amico ormai era sempre più ingovernabile e avulso. Una sera, doveva recitare poesie con l'attore e poeta Victor Cavallo, un protagonista di quegli anni, artista dalla vita eccessiva. Come un cospiratore, Donato mi disse in un canto che quella sera finalmente avrebbe fatto qualcosa contro qualcuno. Non capivo contro chi avrebbe potuto fare e poi non mi pareva possibile. Ma temetti, e mi posi vicino a lui. A un certo momento delle letture, quando fu il momento di declamare, Donato estrasse un minuscolo temperino, con una lama talmente infinitesimale che non era possibile vederla. Chissà dove se l'era procurato. Alzò il temperino come fosse stato il coltello luccicante di un film di Brian De Palma, dove, nella notte, un'ombra aggredisce qualcuno in un parco, ma l'aggressione implode perché la lama è troppo piccola e l'omicida rimane sorpreso di non sapere come aggredire la vittima. L'effetto era esilarante e tragico. Il Presidente stava male e proprio in quel momento fece qualcosa di bellissimo.
Nel 1981, il Male aveva indetto una pubblica manifestazione di tre giorni al Testaccio, "Miseria '81". Si trattava di allestire al Mattatoio rappresentazioni che avessero come tema la noia mortale a Roma. Con Donato decidemmo di andare in cima al Monte dei Cocci, la collinetta del Mattatoio fatta di un cumulo di cocci rotti e vetri, accumulati in decenni di vita testaccina; una volta giunti "lassù", cioè sessanta metri dal livello del mare, ci saremmo rivolti al popolo e avremmo elargito i sedici comandamenti. Donato ne scrisse dieci. A me ne vennero sei. Per questo i comandamenti furono sedici. Su un modesto mangianastri fu registrata la voce di Monni che faceva Dio e diceva sedici comandi. Non vi era niente di blasfemo, era una rappresentazione della modestia della condizione umana, posta di fronte alle stelle così lontane e a qualsiasi pensiero su ciò che si dovrebbe fare. Dei comandamenti di Donato, ricordo questo: "Non desiderare la roba d'altri...scusa, ma che devo desiderare la mia di roba, che ce l'ho già??!". La cosa si presentava semplice. Si sarebbe svolta di notte, noi due saremmo stati in cima al Monte dei Cocci, illuminati da un fascio di luce, lontani e mitologicamente insignificanti. Il pubblico/popolo sarebbe stato sotto, nell'arena, ad accogliere la legge, e la voce preregistrata di Monni avrebbe scandito i sedici comandamenti. Quando venne il momento, ci mettemmo addosso un lenzuolo per dare una patina storica all'avvenimento. Si offrì di accompagnarci un artista non ben definito del teatro off romano, che poi nella vita faceva il ladro di appartamenti. Disse che ci avrebbe accompagnato dato che l'erta che conduceva in cima al Monte dei Cocci era impervia, soprattutto al buio, e con tutti i cocci che c'erano se uno ci fosse cascato sopra si sarebbe fatto un gran male. A sentire questo, Donato cominciò a innervosirsi: la tentazione di lasciar perdere si fece forte; credo che in realtà lo mettesse di cattivo umore l'umore greve della folla: quell'aria presuntuosa e di scherno totale e a prescindere, lo contrariava. Ma evidentemente volevamo andare, perché poi andammo. Scortati dal ladro di appartamenti, che aveva una torcia elettrica e la spianò nel buio, prendemmo per l'erta e ci avviammo come per un safari, vestiti tutti e due da Mosè. In effetti, la via era sia accidentata che scoscesa. Procedere non era uno scherzo, ma una piccola scalata da compiere andando gattoni, appoggiandosi in modo casuale sul terreno dato che il ladro puntava la torcia nei punti sbagliati. In ogni caso, dove era possibile mettere le mani, non solo c'erano dei cocci, ma si presentavano ortiche. Quanto alla salita, noi due non eravamo certo sportivi. Donato procedeva davanti a me, un po' appesantito, e ansimava brontolando senza sosta per le ortiche, i sassi, i cocci, il caldo, il sudore, l'arsura, il fastidio del lenzuolo che faceva inciampare e la mancanza di luce, commentando che era una cosa del tutto inutile, quella che stavamo facendo, una vera follia, un suicidio, l'estinzione del teatro e di due poveracci venuti dalla Toscana. Mentre salivamo, a breve distanza del mio busto piegato in due che procedeva, c'era Donato, di cui sentivo la voce costantemente maldisposta all'impresa. Il suo corpaccione a un certo punto prese a sdrucciolare e tornare indietro, e dopo alcuni infruttuosi tentativi di procedere la sua voce passò dal brontolio precedente a una serie di imprecazioni che si andò allungando a un punto tale da sembrare che invece di respirare come fanno tutti, lui dicesse parolacce. Eravamo bloccati e Donato non smetteva di dire parolacce. Il ladro di appartamenti che ci doveva accompagnare, invece di dedicarsi al suo compito, che era illuminare la via, iniziò a ridere dello sproloquio infinito di Donato. La torcia elettrica prese a tremare per via delle sue risate, a un certo punto cadde e rotolò dabbasso, tra i cespugli, verso il punto da cui eravamo partiti. Rimanemmo al buio, su quella china, e il buio era denso. Chiedemmo al ladro se mancava tanto alla cima. Non rispose nessuno. Lo chiamammo ancora, urlammo il suo nome: niente. Se n'era andato. Si prospettava la possibilità, se non volevamo rischiare di cadere rovinosamente di sotto e morire, di fermarci a mezza costa, o dove ci trovavamo, e aspettare il giorno. Mentre stavo cominciando a chiedere scusa a Donato per averlo coinvolto in qualcosa del tutto priva di controllo, gli feci d'altra parte notare che c'era qualcosa di magnifico in tutta la situazione, e che poco prima, mentre salivamo e lui sacramentava, avevo pensato che un giorno avremmo raccontato la nostra avventura, quella tarasconata senza pari, ai figli e ai nipoti, e sarebbe stato magnifico. E infatti, è magnifico. "Sandro...Sandro", disse Donato. Credevo che stesse rimproverandomi, invece mi faceva notare che si vedeva l'arena illuminata ed eravamo arrivati. In cima alla collina poi, davanti ai nostri occhi, si ergeva una gran croce di legno, fatta alla buona, che dominava il Mattatoio senza che nessuno lo sapesse. Il Presidente era avvolto in un lenzuolo bianco e ora me l'indicava. La registrazione della voce di Monni cominciò a scandire i sedici comandamenti, la folla rideva lontana e quello che avrebbe dovuto apparire magnifico, pieno e realizzato, era vuoto e miserabile. Donato si era messo contro la croce e più la piccola folla lontana rideva, più il suo distacco diveniva totale. Mentre le risate bucavano il buio e giungevano sino a noi con un'eco rallentata, come se il mondo fosse lontano migliaia di anni, Donato cominciò a fare il saluto romano alla folla che rideva ai comandamenti, rideva a Donato in croce, rideva di tutto senza un vero perché, e il mio amico e io ci mettemmo a gridare a perdifiato alla folla: fascisti, fascisti. Il mondo stava precipitando su di noi. Sembrava che non esistesse più alcun rapporto tra le risate lontanissime che avevamo generato noi stessi, e l'effettiva vita. A scendere, si fece alla svelta. La gente faceva complimenti e i nostri lenzuoli erano coperti di fango.
Al Verano, ad aspettare Donato Sannini all'uscita della camera ardente, eravamo in quattro: Ulisse Benedetti, direttore artistico del Beat 72, Carlo Monni, Daniele Costantini, e io. Gridammo "Viva il presidente", perché il Presidente continuasse a vivere.
ALESSANDRO SCHWED
( dal libro "CHI DIO? LA POESIA? MISTERIOSAMENTE " Titivillus editore) |
|
Post n°10 pubblicato il 09 Dicembre 2010 da Jiga0
Per il giorno della Shoah devi fare "il calcolo di quanto valga al chilo essere ebrei". Con una musica che sembri un muggito Sono un ebreo del mondo, sono uno in mezzo al popolo d'Israele; sono uno attendato nella patria ovunque dei Rotoli. Uno della Nazione d'Aria. E vengo a dirvi che la memoria è un organismo vivente; non la globalità dei ricordi, ma una rete di trasmissioni, disturbata dalle continue interferenze del presente. Sulla soglia del giorno in cui il popolo d'Israele ripensa la Shoah insieme all'Israele sparso nel mondo, sale il ricordo; e anzi, assale. E dice cosa succeda nell'intimo del popolo ebraico, in queste date poste a lasciare un segno che non sia cancellabile. La Sciagura ebraica ora sta appoggiata sulle spalle della seconda generazione della Shoah; su noi, che abbiamo conosciuto i salvati e diviso con loro la vita che è seguita - una stagione di ombre. E questo quindici maggio è un tremito, un altro giorno di ricostruzione delle emozioni; dato che la Storia non sarebbe una immensa topografia, dove ognuno colloca le proprie variabili, ma l'indirizzo esatto di quello che fu sentito. Il frangente in cui le generazioni finalmente si collegano, e l'ultima censisce l'eredità. Il quindici maggio o il ventisette di gennaio sono un improvviso ritorno alla percezione completa della realtà. Il passato svela di non essere lontano: vive nascosto in noi. Piomba sulla vita, si sovrappone come una coperta - e regna. I giorni prima ha luogo una tortuosa battaglia, e il campo di scontro è in noi stessi; agli assalti della memoria, rispondono i contrattacchi di una paura grigia e io provo a non ricordare. Ma a un tratto sono collegato a un rombo assordante. Voci dicono oioi, dicono Yankele, Moishele. I vagoni passano sotto all'arco di ferro con la scritta che il lavoro rende liberi, e ogni volta mi prendo il volto tra le mani e faccio uno di loro, uno d'Israele - e lo sapevo che sarebbe successo. Per giorni i rumori di fuori giungono sfocati: la televisione biascica il repertorio dei volti al filo spinato visti l'anno prima, e quello prima ancora, come se a morire fossero sempre gli stessi; davanti alle lapidi i sindaci hanno mani dietro la schiena. In Italia la sera del 27 gennaio c'è una fiction, altri ebrei vengono salvati da una brava persona, e l'Europa pullula di brave persone e mi domando come mai morimmo tutti. E' in quei giorni intorno alla fine di gennaio che sono in giro e porto nelle scuole il mio romanzo che parla della memoria colpita a morte; del fatto che la Storia svanisce con le parole e i nomi, e che un mostro sta partorendo l'Astoria. Vado in giro e parlo dello strazio del popolo ebraico; la mia voce è stentorea, e là fuori, nella remota realtà, ci sono io che galleggio davanti a un microfono - e dentro un urlo che non è decente. Cosa devo dire, può darsi che il mondo sappia. Per lo più la gente ha da fare: ricordarsi di pagare il telefono, i bambini da portare a chitarra; la giornata è un catino e dentro al catino stagna una materia informe. E' la Shoah. E io lo sapevo che sarebbe successo. C'è il rispetto, e l'educazione, come quando passa un funerale e la gente si toglie il cappello, poi il funerale è passato e uno si rimette le mani in tasca. Scocca la prima ora e alcuni dicono subito che ci sono stati anche altri genocidi. In un bar uno sbuffa che non ne può più di questa Shoah, e lo sapevo che sarebbe successo. Qualcuno ha letto Primo Levi, ma c'è la folla debordante: nelle strade, in una sala d'aspetto, al mare sotto l'ombrellone; e non sa cosa sia stata questa Shoah, e nemmeno chi siano gli ebrei. E una signora che aiutava la mamma, ero piccolo, mi faceva il bagno, smise di strusciarmi la schiena e mi chiese come mai non avessi la coda. Qualcuno chiede perché gli ebrei abbiano ucciso Rabin - sale a galla questa domanda e mi trovo in un giorno qualsiasi degli ultimi duemila anni, e il suono è lo stesso della domanda del perché gli ebrei non vogliono stare con gli altri, perché sono così ricchi - perché hanno ucciso Gesù. E finisce che si sente bene il rumore dell'avversione antica. Il rumore delle parole dei nostri padri, il controcanto della scrittura di Kafka, l'anello del Bolero di Ravel. E io lo sapevo che sarebbe successo. Ma nelle scuole è bello parlare della Shoah - dato che la giovinezza è una città aperta, e se ti colleghi alle emozioni universali, se fai apparire la vita, i ragazzi ascoltano. Tengono gli occhi a terra, vedono il fondo del male. A volte dopo ci abbracciamo, sconosciuti con sconosciuto, e mescoliamo lacrime. Circa la memoria e circa la solennità, ho appreso tutto da mio padre. Per le cene di Pessach, lui non poteva fare a meno di ricordare. Sedevamo a tavola, e nell'intervallo del racconto della fuga dall'Egitto, mio padre piegava la testa e raccontava; e io imparavo che azione fosse il ricordare. La guerra appena finita era un tempo remoto. Un altare omicida, immenso e inspiegabile come il monolito di "Odissea nello spazio". E su questo altare, l'intero mondo - i nomi della nostra famiglia, l'amore e l'amicizia di gente sconosciuta; ogni età della vita, le giovinezze e l'infanzia promettente - tutto era stato sacrificato da uomini venuti a portarci via, con gli stivali e gli elmetti segmentati. Esseri che dicevano ja, dicevano juden. Ringhiavano. La notte entravano nelle case, strappavano i bambini dalle braccia delle madri, li tiravano per aria, sparavano con il mitra - e la nostra carne era cacciagione. La cacciagione veniva colpita e allora i bambini smettevano di volare. Quelle sere di Pessach ormai erano passati quindici, venti anni, tutto era lontano e tutto era appena successo; e anche adesso, tutto è appena successo e la Storia è una normale sequela di giorni più impolverati del solito. Ma sono in mezzo al popolo d'Israele, e quel giorno di gennaio, o in altri improvvisi giorni, tutto questo è in me; mi aspetta in fondo a una cantina a cui è possibile accedere scendendo da certe scale buie. Succede perché lo dice il calendario; perché vedo una foto; perché siedo in poltrona davanti a mio figlio e penso a mio padre in poltrona davanti a me. O viene la notte e devo sognare che buttano giù una porta, gridano raus, e le mie gambe sono immobili. Perciò il quindici maggio, o il ventisette di gennaio, sono i giorni in cui non vorrei esserci, ma poi succede che ci sono - e io lo sapevo che sarebbe successo. Un altro giorno della Memoria - capisco un'altra volta che il bene è una parentesi; una cosa ignota; un pensiero un poco stupido dell'infanzia. E anche se sei preparato che il lupo della memoria ti entra in casa, e non lo fai entrare, e lo scacci, quando poi viene coi denti aguzzi dei ricordi, hai paura - sapevi che il lupo sarebbe venuto un'altra volta, e non hai saputo prepararti. Sei di nuovo caduto nella trappola di giocare a una vita normale. Non c'è ebreo che non abbia ricevuto il morso iniziatico dei ricordi. Come se chi non lo riceve non sia davvero ebreo - ma uno spazio umano preso in affitto da qualcuno. Perciò quando si avvicinano le date della Memoria, comincio a sbuffare, a girarmi da un'altra parte. Non voglio vestirmi di nuovo da errante, fare quei sogni; vivere nella fatica delle altre generazioni; passare il terrore a mio figlio. Ma un uomo che non si colleghi con le proprie emozioni, è come un bicchiere bucato: è inutile. Perciò mi collegherò di nuovo ai ricordi e lo farò per mio figlio - perché il mondo si calmi; perché niente vada perduto e si voglia bene a Israele. Ma sale quell'urlo forsennato, il sangue si gela. La vita è friabile come un biscotto; una colossale menzogna che pronunci ogni giorno, quando dici che tutto va bene. Devi fare un'altra volta il calcolo di quanto venga al chilo essere ebrei; quanto pesa nei giorni e quanto pesò alle persone che hai amato e non ci sono più, e non ti possono dire: a me pesò così e così. Oddio, sospiri, e ricominci a vivere quei giorni come se fossero ora - e io lo sapevo che sarebbe successo. Il 27 gennaio di quest'anno, dovevo andare in un istituto tecnico agrario di Grosseto, dove insegna un mio caro amico. Claudio. Mia moglie mi ha accompagnato alla stazione. Ho fatto il biglietto, è arrivato il treno e mentre salivo ho dato un pugno nell'aria. Erina è sapiente, e ha detto ma no, poi sarai contento. Mi sono fidato e sono partito. Però mentre i binari cominciavano a correre con gli alberi, e la collina si allontanava, io sentivo male. Ma ecco che alla stazione di Grosseto, sul marciapiede, c'è un mio amico che per l'appunto fa lo scrittore, si chiama Luigi. E' lì a prendere dei suoi amici olandesi; scendo e lo chiamo, Luigi!, con gratitudine, come se mi fossi trovato sulla Muraglia Cinese e mentre ero in cima a quei chilometrici spalti, dall'altra parte del mondo, mi fossi trovato davanti al portone amichevole di casa mia - per dire come mi sentivo lontano finché non ho trovato Luigi, forse per caso, sul marciapiede della stazione di Grosseto. Gli ho detto che dovevo fare, mi ha guardato e voleva portami in giro; ma ci siamo seduti a bere un tè nella domesticità della piccola stazione. Poi l'ho salutato, ho detto ciao, e ciao aveva un buon sapore di tranquillità. Fuori dalla stazione c'era Claudio, e a quanto pare il mio viaggio era oliato a dovere, come un meccanismo che non può che fare la sua corsa, e la corsa era partita bene; c'erano amici che si davano il cambio per prendermi alla stazione, e i miei vecchi lassù stavano facendo un gran lavoro. Claudio mi ha detto: senti, prima di tutto andiamo a comprare la frutta. Mi ha fatto salire in auto e sono rientrato nella deliziosa vita. Questo posto della frutta era un negozio grande, i soffitti alti, con barricate di cassette di arance. Un caveau di tarocchi, verza, e amichevoli patate; a volte anche la frutta e la verdura ti vengono a prendere alla stazione e ti danno una pacca sulle spalle. Lì al negozio c'erano due a servire, amici di Claudio. Due fratelli. Ora hanno questo negozio, ma prima facevano il mercato. Aspetta, fa uno di loro, senti qui, e mi passa un'arancia. A quell'ora della sera il negozio era belle e vuoto. Lui mi passa l'arancia, l'addento, è così dolce - eppure è materia di questo mondo. Claudio dice che il giorno dopo vado a scuola sua a parlare per il ventisette; che sono ebreo. Uno dei fratelli mi guarda a dritto, come dire: allora te ne intendi. E comincia a raccontato della Pasqua del 1943, del bombardamento di Grosseto; che la gente andava in giro con le carriole e dentro le viscere dei figli. L'ortolano racconta, ha la barba lunga di fine giornata, e la voce maremmana si spacca in due. Dopo siamo andati via con la spesa, e sulla porta, il fratello che era stato zitto, invece di dire buona sera come di solito nei negozi, mi ha stretto un braccio. E siamo andati a casa di Claudio. Lui vive da solo alla penultima rampa di una palazzina di qualche piano. A casa sua c'è sempre una fila di amici di passaggio che vanno al nord e al sud dato che Grosseto è una tappa intermedia. Canoisti, frati, pellegrini per Santiago, uomini della Croce Rossa con cui è andato in Iraq. Studenti che sono stati a scuola con lui e gli vogliono bene. Stavolta c'ero io. Siamo andati sul terrazzo perché doveva ritirare i panni. Aveva un fagotto sotto il braccio. L'ha aperto, era un grande corno di bue. Questo qui, mi fa, stava in una fattoria in mezzo a dei mucchi d'ossa. L'ho fatto svuotare, mi fa, e adesso lo so suonare. Senti, mi fa. Era buio, saranno state le sette e mezza di sera. Si è avvicinato alla ringhiera del terrazzo e ha portato il corno alla bocca. C'era uno scirocco anormale per gennaio, dolce. Questo mio amico ha gonfiato le gote, ed è venuto su un muggito lungo, tranquillo. A guardare in fondo e lontano, si vedevano le luci dell'Amiata. Allora, gli ho detto, domani portalo a scuola che lo suoniamo - come se fosse possibile suonare un corno in due; ma era un suggerimento arrivato da posti dove il vento è un amico, le arance fanno le carezze e il corno si suona insieme. Il mattino dopo, Claudio mi mostra come è fatta la scuola. Le aule sono piene, le lezioni in corso; nei corridoi girano ragazzi con la faccia allegra e il mio sollievo è grande. L'istituto è un vasto anello quadrato percorso da un corridoio: ai lati esterni del corridoio girano le aule, a quelli interni le vetrate. Cammini e oltre i vetri, dall'altra parte dell'anello, ci sono porte spalancate; si vedono aule, i ragazzi a lezione, e si alzano mani a salutare Claudio. C'è sempre del buono in una scuola. L'aula magna è deserta, ho un'ora per raccogliere i pensieri. E' il ventisette gennaio 2007; ho una moglie e un figlio su una collina della provincia di Siena; mio padre e mia madre sono sepolti a Haifa. I miei fratelli e i miei nipoti vivono sparsi in Israele. Io sono qui, dall'altra parte del mare, in una scuola. Sto per collegarmi all'essenza di cosa sia successo sessant'anni fa alla vita ebraica; sentire sul serio che accadeva quando fummo buttati sui vagoni-merci: i milioni di allora, noi di adesso che ricordiamo e le generazioni di poi, che ricorderanno dalle nostre bocche le vite dei nostri padri. Intanto però, sento i respiri asmatici di quei giorni e lo sapevo che sarebbe successo. Tra poco arriveranno i ragazzi, parlerò del romanzo, della Shoah che intossica il presente della quarta generazione ebraica. Allora vado alla lavagna e scrivo: "Di padre in figlio". L'aula magna è piena. La mia bocca parla tutta la mattina. Ci sono poche domande. Hanno bisogno di ascoltare. Poi è la fine, c'è un applauso. Lo fermo. Il battito delle mani si gela. Grazie ragazzi, ma questa è una giornata di un lutto immenso. Il popolo ebraico, dico, è nello strazio. Vorrei fare una cosa con voi. Se volete. Fanno di sì con la faccia, come i bimbi. Dunque si alzano senza un gemito di sedia. Claudio, faccio. Claudio viene alla cattedra; ha il corno sotto braccio. Adesso il corno di quella mucca maremmana è diventato shofar, l'antico corno sacerdotale. Dico che stiamo per ricordare i sei milioni di ebrei scomparsi, questi padri e queste madri, questi nostri bambini che non sono cresciuti. Questo intero popolo della cui presenza siamo stati rapinati. Per il primo milione di ebrei, dico. Claudio gonfia le gote. Un lungo suono buca da parte a parte la stanza, esce e buca Grosseto e la marina, e l'anno 2007 appena cominciato; e torna a quei giorni - e quei giorni tornano accanto a noi. Il mio cuore è immobile, forse sono morto, e forse la scuola mi tiene dentro alla vita. Una parte di me continua a pensare - a Sandor, a Eliezer, a Shlomo, a Lea, come a una ignota parte di me stesso rimasta nuda e da rivestire, come anomali figli più anziani del padre; penso a mio padre salvato e sommerso lo stesso. Ai nomi che non ricordo, se non li scrivo. Per il secondo milione di ebrei, dico. Il suono parte ancora, un lungo sospiro. Per il terzo milione, dico - e questa volta la voce si spezza. I ragazzi guardano a terra. Per il quarto milione, per il quinto. Per il sesto. Siamo arrivati ad Auschwiz. L'aula magna si svuota in silenzio. Alessandro Schwed il Foglio,14 aprile 2007 |
|
Post n°9 pubblicato il 08 Dicembre 2010 da Jiga0
Howard Jacobson, "Un amore perfetto". Cargo. Pagine 382.
Due trame, in un romanzo di Howard Jacobson. Il grande umorista britannico, ora insignito del Man Booker Prize, prestigioso premio letterario inglese, intinge la penna nell'inchiostro disossigenato della malinconia ebraica, dove è difficile vedere oltre a ciò che esiste: e ciò che esiste, ormai è il deserto. Il romanzo è "Un amore perfetto", e le due trame sono queste: la prima, la storia cinerea di Felix, un uomo bisognoso fino all'ultima fibra di perdere l'amore della moglie, costruendone il tradimento come un orologiaio. Dato che per lui il solo modo di amare è soffrire. La seconda trama invece non appare, traspare; ed è la dimostrazione di come l'umorismo sia segretamente incinto della tragedia. Se Ionesco diceva che ogni tragedia è reversibile in farsa, qui dalla farsa sorge la tragedia. Il romanzo è augurato da quello humor dell'understatement che ha reso celebre gli inglesi: sottotono fluido dove la scrittura controlla la lingua e predispone trappole - e proprio nella parte in cui il romanzo di Jacobson finge di esistere per farci ridere, va reso merito alla traduzione di Milena Ciccimarra. E lo humor va. Dopo averci presentato a un funerale il personaggio di Marius, uomo bello, cupo e coi baffi che il nostro anti-eroe spingerà in segreto tra le braccia della moglie facendone l'amante, costui, disegnato davanti alla fossa come indecifrabile sostegno di un'appassita vedova, nel corso della successiva cena funebre flirta sguaiatamente con due ragazzine. E' umorismo a gogò, nel resoconto dell'apprendistato sentimentale del Felix adolescente, che vediamo lasciato bruscamente nel buio del cinema da una coetanea che riteneva di avere conquistato, avendo iniziato a tenerne la mano; invece lei lo abbandona per uno sconosciuto emerso dal buio e subito baciato. La seconda trama che dicevamo è l'innesco delle trappole che fanno inciampare il lettore nel riso e poi lo precipitano nella sofferenza. A un tratto, l'umorismo magistrale scivola via da "Un amore perfetto", ed è sulla sua base che poggia il racconto dell'amore perverso voluto da Felix. Scorrono a lampi la giovinezza sua e del nonno, entrambi col fatale nome di Felix. Uomini che li dovrebbero educare, vogliono che i due ragazzi, del tutto inermi, abbiano una relazione con le proprie mogli - dato che solo il tradimento attesta la bellezza della donna amata; solo la perdita, teoreticamente attestata da citazioni di Bataille, dà coscienza di come grande sia l'amore perduto. Preambolo al dramma è una discussione estetica con la moglie su un Otello appena visto, dove una regia eccessiva indica la volontà del personaggio di essere tradito. Ci trasferisce al dramma della ripetizione dei destini la scoperta che Marius, il tipo senza morale della cena funebre, fosse l'amante della vedova, da lui carpita al marito e abbandonata da anziana. E siamo nella sequela del dramma attuato da Felix: solitario deus ex machina, che elabora con crescente successo il tradimento della moglie con Marius. Fra i tre, inconsapevole e consapevole, nasce la scorrevole relazione adultera durante la quale, spossessato di sé stesso, Felix entra in ciò che Jacobson chiama la subrealtà: un mondo catatonico di totale schiavitù psicologica. La moglie e l'amante, sdoganati dallo humor, sono accolti dal protagonista nella propria casa, in una vicinanza feroce che fa sentire nitidamente l'abbandono. Nella fine crepuscolare, decomposta come materia andata a male, è dato intuire come la gelosia sia visionaria, la realtà sempre inavvicinabile e la verità il più grande tradimento che esista. Memorabile, in uno squarcio del libro, la commemorazione umoristica di quel peculiare amore. "Eravamo una famiglia felice. Noi tre assieme".
Alessandro Schwed Il Foglio, 30 Novembre 2010 |
|
Post n°8 pubblicato il 08 Dicembre 2010 da Jiga0
|
|
Post n°7 pubblicato il 04 Dicembre 2010 da Jiga0
Israele chiude tutto e se ne va. Difficile negare che questa notizia, se chiamarla notizia ha un senso, da noi allieti inconfessati strati dell'opinione pubblica. Una notizia che è un annuncio della Storia e che in queste settimane sta facendo il giro del mondo, e ancora per qualche tempo, forse, lo farà: l'atto con il quale la Knesset, il Parlamento di Gerusalemme, ha deciso all'unanimità, in una immensa solitudine, l'autoscioglimento dello Stato di Israele.
|
|
Post n°6 pubblicato il 22 Novembre 2010 da Jiga0
Dal 1600, c'è un ufo a Montalcino. Il fatto insolito e il luogo, il paese del bel bere, potrebbero far pensare che la notiziola sia sorta alla fine di una bicchierata, e che sia stata una combriccola di devoti alla bottiglia a comporre la verità che da quattro secoli c'è un apparecchio alieno nella chiesa di san Pietro. Ma la notiziola è autentica: a Montalcino c'è un oggetto volante non identificato, e lo sanno in una venticinquina. La gente passa accanto alle mura della chiesa dove l'ufo è stato messo a dimora, e fa come se là dentro non ci fosse nulla. Tira dritto. La chiesa, che si chiama san Lorenzo in san Pietro, è di proprietà del quartiere Pianello, il quale grazie a un'ostinata raccolta di fondi ancora in corso, la sta restaurando, e ogni tanto ci fa dire messa. Vi dicevo che in paese la storia dell'ufo non ha attecchito. Non è come per la leggenda del lupo mannaro, che le notti andava a bagnarsi giù alle fonti, ululava, ululava e la gente si serrava in casa, quella sì è una storia che conoscono tutti. Dunque l'ufo sta in chiesa, velato dalla penombra. Non che sia parcheggiato tra le navate, in attesa che il viaggiatore alieno si svegli dall'ibernazione, metta in moto e riparta bucando la cupola. Le cose sono diverse: l'ufo si trova in un dipinto. E' stato pennellato nella parte superiore di una pala d'altare, lavoro di un pittore di scuola senese, Buonaventura Salimbeni, detto anche Ventura, che in occasione del Giubileo del 1600 fece l'opera. La titolò "La glorificazione dell'Eucarestia". E oggi, anche se da una cinquantina d'anni ne discutono gli ufologi di tutto il mondo, che classificano l'oggetto come volante e non identificato, e anche se l'oggetto medesimo ormai troneggia nei siti ufologici della Rete, nonostante tutto questo, a Montalcino il quadro è ignorato assieme al suo enigma. L'ufo di Salimbeni è una sfera bluastra, collocata tra il Cristo e Dio Padre. Si presenta grande dal piede al ginocchio, e va detto che per quanto appaia misteriosa, la sfera costituisce un motivo ricorrente della pittura barocca: l'allegoria dell'universo mediante il 'globo del creato'. Di solito, si trova posizionata tra il Padre e il Figlio, sotto la colomba bianca dello Spirito Santo. Nei dipinti, la sfera può apparire trasparente, quasi fosse di vetro, o presentarsi di un blu fondo come la notte. Però, anche se i due scettri dell'imperio universale, nelle mani del Cristo e del Padre, sono elementi ricorrenti nella pittura sacra del periodo, conducendo un'attenta osservazione, gli scettri medesimi risultano inchiavardati nel polo superiore della sfera. Inoltre, la parte inferiore della sfera ospita una sorta di lente telescopica che proietta l'immagine della colomba-Spirito Santo negli occhi del Pontefice, assiso giù in Terra tra l'assemblea della Chiesa che sta in adorazione dell'Eucarestia. Ma il punto è che il globo del Salimbeni, l'universo, appare come uno Sputnik. La sola differenza è che ha due antenne invece di quattro. La pala sta in una navata laterale. La gente viene per le rare messe dei quartieranti, o in visita personale, si siede tra i banchi e non fa caso al dipinto. Del resto, nelle innumerevoli chiese antiche dei paesi e dei borghi italiani ci sono quadri, capitelli, rosoni, e non vengono guardati perché sono sempre stati lì, confusi con le giornate. Un uomo va in quella sua chiesa per tutta la vita e succede come a casa, che uno non vede per anni il colore di una parete, eppure la parete è sempre stata lì, ogni giorno. E a Montalcino l'ufo non lo vede nessuno, dato che è stato sempre lì, ogni giorno. Ma negli anni '60, ci fu un'eccezione. A un tratto, se ne accorsero due ragazzi del paese, Claudio Boccardi e Roberto Cappelli, e a loro sembrò subito lo Sputnik finito in un quadro molto antico. Ma il periodo del loro avvistamento pittorico non è certo. La memoria cambia forma come le nuvole, l'aspetto dei ricordi muta un giorno con l'altro, nella stessa persona, e da una persona all'altra. Così, un pomeriggio l'ufo sarebbe stato scoperto ai tempi delle medie, e il giorno dopo, a ripensarci, a metà del liceo - forse. Per loro, e per quelli che lo sanno, è come se un giorno fosse stato scoperto un ordigno tondo come il satellite sovietico, proprio dentro a quel quadro che c'era sempre stato.
San Lorenzo in san Pietro è annidata nel fitto del paese basso. Le vecchie case con gli orti accuditi guardano la Valdorcia, e il paese diventa un borgo che nei punti più in basso confina con la campagna. Talvolta, davanti ai portoni, vi sono piante tenute dritte con una corda legata alla maniglia. L'estate cammini solleticato dall'ombra in stradicciole che si chiamano vicolo del Mistero, dove l'ombra sembra aumentare, e a un passo si accanisce il sole. La chiesa sta su una delle erte assiepate ovunque, la gente spinge paziente le gambe, e sale, e i vecchi sospirano: "Sali e scendi, sali e scendi". La notizia del quadro con l'ufo, rimbalza in casa mia un pomeriggio di fine giugno, buttata lì da Giovanni che è mio figlio, e l'ha saputo da un amico. Allora vado su http://www.save-san-pietro-montalcino.com/poster_it.htm C'è la pala di Salimbeni, cliccata dagli ufologi di tutto il mondo che l'hanno trasferita sui loro siti e ora troneggia on line, tra avvistamenti sigariformi e quell'arcaico bassorilievo d'astronave con dentro un pilota spaziale davanti a mille manici, il cruscotto. Però, non riesco a capacitarmi come sia possibile che a Montalcino ci sia l'ufo del Salimbeni, io non lo sapessi affatto, e ora mi sia ridotto a visitarlo on line, quando si trova dietro casa, nella piccola chiesa di san Pietro che sfioro tornando dalla spesa. Devo subito vederlo, questo quadro, mi piacerebbe fare una veglia paesana sul caso dell'ufo del Pianello. Vorrei farmi raccontare come fu e come non fu che qualcuno scopri un ufo in mezzo a una pala d'altare dell'anno 1600; sapere cosa disse questo e cosa disse quello il giorno della scoperta; e cosa si dice adesso che la chiesa è frequentata e nessuno fa caso al Salimbeni. Già mi immagino una veglia mobile tra i montalcinesi, e il piacere di mettersi in strada con le mani in tasca, e prendere il fresco che viene, come quei gentili colpi di maestrale, che l'uomo si mette sul canto di una via, tra il refrigerio, e parla e sorride come se la conversazione andasse a vento. Però a volte basta anche una finestra aperta, con le tende che si gonfiano, e in modo scrupoloso perder tempo con gli amici - ore felici. La sera chiamo il farmacista Salvioni, che è del Pianello. Ah bene, vuoi vedere il Salimbeni, certo, e mi consiglia di telefonare al Vimercati. Il Vimercati è un milanese trapiantato fra le Crete, ruvido e attivo. Al Pianello lo chiamano Vim. Dice che in chiesa ci sono i lavori e il quadro è coperto dalla plastica, ma la visita si farà. C'è il silenzio di un paio di giornate, e mentre mi chiedo se davvero riuscirò a vedere l'ufo con le mani in tasca nel fresco della chiesa del Pianello, con efficienza paesana incontro per strada, proprio accanto a san Pietro, Claudio Boccardi, il primo avvistatore dell'ufo di Salimbeni. E' del Pianello, lo sa di già che vorrei vedere la pala d'altare, l'ha saputo da quello che glielo ha detto quell'altro, a Montalcino non servono tante telefonate. Boccardi racconta di quando era ragazzo e vide il quadro con quella specie di sputnik e allora ci portò il Cappelli. Mi dà appuntamento al pomeriggio dopo, sul sagrato, sorride, sorridiamo, e sono lanciato nell'occasione della veglia che sta per cominciare a Pianello. Anche se poi sarei del quartiere Travaglio, e l'estate e l'autunno, quando c'è il torneo di tiro con l'arco, siamo nemici e digrigniamo i denti. Però, le sere prima del torneo, se vai sul poggio dell'ospedale e guardi i tetti affollati sulla collina con sopra le chiazze d'oro dei lampioni, dagli angoli salgono ai tetti e dopo nell'aria le canzoni dei quartieranti a cena sulle vie di pietra, e c'è un momento che i canti aerei confluiscono in un unico canto, e l'eco delle voci è una sola voce che va e viene, libera come una nube. E quella è Montalcino. Il pomeriggio dopo, scendo lungo le ombre dei tetti, vado all'appuntamento. Nei vicoli non c'è nessuno, dalle finestre accostate esce il ciangottio dei televisori. Ad aspettarmi in chiesa, tra la penombra e la frescura, c'è Boccardi. Mi racconta di nuovo di quando vide l'ufo del Salimbeni, e oggi gli pare sia successo alla fine del liceo - forse. Arriva il presidente del quartiere, Faneschi, poi il Vimercati che mi regala subito una bottiglia di rosso. Gli dico che non ho fatto nulla per meritarla. Prendila, mi fa, e la prendo. Come si fa, a rifiutare il vino. C'è anche il padre di Lorenzo, un amico di mio figlio, altri saluti, altri sorrisi. Parliamo dell'ufo, parlano tra loro dei lavori in chiesa, c'è schiamazzo e la magnifica allegria. In una navata c'è la pala del 1600, coperta da uno spesso telone di plastica, ma la scena del quadro oltrepassaa i rigidi panneggi. In alto, da sinistra a destra, ci sono il Cristo e il Padre. Siedono sulle nubi. Il Redentore ha il volto di giovinetto e la barba castana. Il petto nudo è drappeggiato da una veste rosa che scurisce sulla spalla sinistra. Suo Padre è un vecchio pensoso. Non ha più i capelliì, ha una lunga barba bianca, disordinata come quella degli anziani. Lo avvolgono panni cilestrini. A guardarlo, sopraggiunge la tenerezza dei figli per i padri divenuti vecchi. La sfera dell'universo è tra il Padre e il Figlio, con le due antenne imperniate nella parte superiore della sfera; nella parte inferiore, a sinistra di chi guarda, c'è la lente di un gran cannocchiale che proietta un fascio di luce sul Papa, che riceve negli occhi l'immagine della Colomba, il Paràclito; e per quanto la Chiesa in assemblea adori l'Eucarestia, il campo di forze del quadro si congiunge sulla macchina aliena. "Quando dissi al Cappelli che a san Pietro, c'era un ufo mimetizzato nel quadro del Salimbeni - dice il Boccardi, e Vimercati è in strada che palpa le pietre del vecchio pozzo che va rimesso a posto - quando glielo dissi, era il gioco fantastico di qualche pomeriggio. Lui si appassionò, e il resto, tutto quello che poi è venuto, è merito suo. Lui cominciò ad approfondire, contattò gli ufologi in Italia, fece studi. E quando a Montalcino nacque quella rivista di astronomia, archeologia e ufologia, Gli Argonauti, furono organizzati convegni sull'ufo di Buonaventura Salimbeni. Ne scrissero sui giornali, vennero ufologi da tutto il mondo, e ancora adesso, ogni tanto, ne parlano in Tv. Un anno fa ne hanno riparlato a Voyager". Chiedo al presidente del quartiere se ricorda la prima volta che vide l'ufo in chiesa. "Per la verità, non ricordo quando ci ho fatto caso, o quando l'ho saputo, ma non mi ero mai accorto di quella cosa nel quadro. Sai, uno viene qui, e il quadro è un quadro della chiesa come quegli altri, poi sì, dopo ne parlavamo, ma così". Dice queste cose mentre saliamo a visitare i locali del quartiere, la cucina, le stanze per la refezione e le riunioni sociali. Sui muri, incorniciate, ci sono le foto in bianco e nero degli anni Settanta, le gare di tiro con l'arco. Gli chiedo se ha tirato le frecce, mi dice di sì e gli brillano gli occhi.
Roberto Cappelli lo vedo che arriva in piazza. Abbiamo appuntamento. Ha le scarpe da ginnastica rosse, verdi i pantaloni coloniali, una camicia fantasia. Potrebbe essere uno della beat generation. Però mi ricordo di Evutsenko al festival della poesia di Castel Porziano, quando recitò come un futurista la poesia sulla pace nel mondo, non era certo beat, ma ancora comunista, e la camicia era lo stesso come quella del Cappelli. Che ha una barba bianca e rada. Il volto smagrito. Gli occhiali da ex professore di scuola, per trentatrè anni fra i banchi delle scuole medie dell'Amiata e di Montalcino. No, non assomiglia a Evtusenko, per niente. Questa somiglianza che non si vede dipenderà dal fatto che anche lui è un appassionato dell'esistenza. Da due decenni fa il giornalista, fruga nel senese e ne trae cronaca. Lo ricordo d'inverno, con una specie di colbacco, che porta da mangiare ai gatti randagi di Montalcino. Lo guardo, eppure mi viene in mente Gregory Corso, che però aveva tutto un altro fisico. Ci sediamo sotto la verticale dell'antica torre comunale, al Bar delle Logge. Ciao come stai, ciao come stai, bene e tu, bene e tu. E' trafelato, ha appena finito il giro dei gatti. Gli dico che deve essere un grosso impegno, questo dei gatti. Mi risponde con fierezza che è difensore degli animali del comune di Montalcino. Lo dice come un antico bardo, anche quando illustra il menù quotidiano dei trenta gatti raminghi. Pollo cotto, pollo crudo e croccantini. Sì, lo ricordo d'inverno che scende per le piagge ventose e porta il rancio ai gatti dell'underground montalcinese. Chino presso certi anfratti che uno passa e non vede, che per saperli bisogna conoscere la vita felina, e il paese palmo a palmo. Un mattino di febbraio, Montalcino era deserta e il maestrale tirava schiaffi ai cantoni. Si doveva smettere di camminare e rifiatare ai portoni. E nella piaggia più ventosa di tutte, dove stanno i vecchi della commenda e tante volte si sente l'odore della refezione, lui era lì che quasi imboccava i gatti, a una finestrella. E per tutte queste cose, per la camicia estrosa, le scarpe rosse, non mi stupirei se ora si mettesse a parlare di ufo in versi liberi, e allora sarebbe proprio Gregory Corso. Ma poi che ci posso fare se parla ed è romanzesco, uno della letteratura appena sortito da una pagina; che salta da uno scaffale, vola oltre un davanzale; atterra sul marciapiede, davanti a te che passavi, dice voilà e racconta una storia. Per tutte queste ragioni, ammesso che siano ragioni, non c'è niente di meglio che essere a veglia con il Cappelli, seduti al bar sotto la torre del comune, e ascoltare la storia degli ufo a Montalcino. Però, ora che ci penso, Cappelli mi fa venire in mente il Don Chisciotte, la cui vita era stupefatta dalla propria stessa innocenza. Ma intendiamoci, non è che siccome il Cappelli è un personaggio romanzesco, allora racconterà una storia inverosimile sugli alieni, e ce la spasseremo altezzosi come antropologi. E' proprio il contrario: dato che il Cappelli è romanzesco, eppure esiste, è davanti a noi, al bar, e parla, la sua storia sull'ufo del Salimbeni sarà reale, visionaria e verosimile come lui. E ci sono persone che costituiscono il ponte materiale tra noi e l'inimmaginabile, persone che sono l'assoluto a un tiro di schioppo.
"Non ricordo di essere andato in San Pietro a vedere il Salimbeni con Claudio Boccardi, ma può darsi. Eravamo ragazzi, eravamo amici, anche ora lo siamo, diamine. Passavamo insieme le giornate, e non ricordo se fu lui a dirmi dell'Ufo, ma cosa conta? Penso di avere visto il quadro dopo le medie, al liceo, e allora ho cominciato ad occuparmi di questo oggetto misterioso che stava nel quadro di Salimbeni. E quando uscì la nostra rivista, Gli Argonauti, facemmo convegni sull'enigma del quadro, vennero ufologi dall'estero, e importanti pubblicazioni internazionali cominciarono a scrivere dello sputnik in un dipinto barocco, sì, ricordo la rivista argentina Atom, il Giornale dei Misteri, di Firenze, tanti". Bevo un succo di frutta alla pesca, lui un febbrile caffè. Concordiamo che il quadro appare come una specie di premonizione per comunicare che nel futuro si sarebbe realizzata la comunicazione globale, a partire dall'epoca del famoso satellite sovietico a cui, appunto, la sfera di Salimbeni tanto somiglia. Con un linguaggio da dimostrazione euclidea, il professor Cappelli entra nel merito e illustra come sulla sfera che noi chiamiamo Universo siano presenti linee di sutura, sia in senso orizzontale che verticale, e che le due antenne poste sulla sommità superiore sono fissate alla sfera medesima per mezzo di vere e proprie rondelle. "Del resto - chiosa - bisogna anche dire che nel 1600 a Roma ci furono diversi avvistamenti ufo". E in effetti, a proposito di ufo e artisti, il mio amico pittore, Claudio Sacchi, mi dice al telefono che nelle Vite di Vasari si racconta come il Cellini avesse avvistato travi infuocati nel cielo. "Però, ecco, io cominciai ad appassionarmi degli ufo non a causa del quadro del Salimbeni, ma di una cosa che mi capitò quando avevo ventidue anni. Un avvistamento qui a Montalcino". Il succo di frutta smette di scendere in gola. "Era il !968, e una sera, era buio fatto, io stavo tornando a casa. Salii per le piagge, e quando fui su alla Fortezza, vidi due piccoli oggetti". "Volanti?" chiedo in trance, un poco instupidito - voglio esser certo che mi si stia raccontando proprio quello che desidero. "Sì. Due piccoli oggetti volanti". Bene, il succo di frutta riprende a scendere, gelida delizia. "Erano verso la pineta, volavano nervosi come mosche. Stavano molto in alto, andavano a zig zag come se facessero delle evoluzioni: a scatti. Questa cosa sarà durata trenta secondi, un minuto. Li vidi andare molto in alto, a ovest, tra la pineta e il monte Amiata. E un'altra volta - prosegue Cappelli-Corso, Cappelli-Evtusenko, Cappelli-Don Chisciotte, mentre la mia veglia paesana diventa sempre più ufologica - vedo un oggetto luminoso sulla verticale del Bar del Cacciatore". "Proprio qui", dico assertivo, e indico il cameriere che gira fra i tavolini, perché il Bar del Cacciatore era l'attuale Bar delle Logge. "Sì, proprio qui. L'oggetto volante si fermava e ripartiva, si fermava e ripartiva. E un'altra volta ancora - insiste il professore tra la barba rada - vidi due oggetti a forma di sigaro. Uno dei due proseguì in direzione sud, verso Roma, e l'altro a ovest, verso il mar Tirreno. Anche a mio padre è successo di vederli, e guarda, lui era un laico di ferro". Il succo di frutta scende sempre più placidamente, mentre l'ufologia si trasfigura, diviene saga di generazioni che avvistano dischi volanti, macchine aliene, proiettili extragalattici, senza pilota, con pilota, se no guidati con la mente, trasportati da energie sconosciute, superiori, in movimento tra l'Amiata e il cosmo. "E sicché una volta, negli anni Cinquanta, era pieno giorno, e mio padre stava sulla circonvallazione assieme a degli operai, hai visto no, ai cantieri Fanfani, e sicché avvistano un globo di luce, un oggetto metallico, splendente, capito, un oggetto splendente, che si fermava e ripartiva a velocità prodigiosa". Mi guarda Cappelli, lui stesso ancora colpito. Forse, viene mosso più dal mistero incontrato da suo padre che dai propri. "Ma in definitiva, come mai - dico - quello del Salimbeni è da considerare un ufo?". Cappelli si mette a spiegare di nuovo, ha il piglio del vecchio insegnante che faceva l'ufologo e tra l'altro ha scritto il libro 'Gli ufo in provincia di Siena'. "Allora, c'è una branca dell'ufologia che si occupa di apparizioni di ufo nei tempi antichi. E in effetti, se noi andiamo ad osservare la sezione superiore del quadro, sulla sfera che chiamiamo Universo noteremo importanti particolari, che non sono inerenti al motivo allegorico della Trinità. Infatti, sulla sfera sono presenti linee di sutura in senso orizzontale e verticale, che suggeriscono in dettaglio un oggetto meccanico". Non mi lascio sfuggire l'occasione, e gli chiedo come sia cominciata la sua attività ufologia. Allora inizia un'avventura nell'avventura. Un fiabesco momento in cui come su una slitta di Babbo Natale, arrivarono degli ufologi e si stabilirono vicino a Montalcino, nel bel paese di Trequanda. E lì facevano riunioni, e ci andava anche il Cappelli undergorund, il Caelli detective, che niente esclude e tutto cerca e coglie di quanto sta nel mondo e meglio ancora, fuori dal mondo. C'era dunque questo gruppo ufologico a Trequanda, un paese della corona di bei paesi vicini a Montalcino. "Durante la riunione, per mezzo del procedimento della scrittura automatica, parve di entrare in contatto con un'entità stellare Noi di Montalcino andavamo a queste sedute di scrittura automatica e all'entità facevamo domande di scienza, di tecnica, di medicina. Una sera volli mttere alla prova l'entità e portai un atlante stellare per vedere se sapesse indicare la propria provenienza in modo esatto. L'entità dettò il nome di una stella. Guardai l'atlante, e c'era proprio il nome della stella".
Vado a casa di Maurizio Cecchini, che era nella redazione degli Argonauti. Ha poco più di quarantanni, fa il primo cantiniere dai Barbi, ma è un astronomo. Vive in cima al paese, accanto al Duomo, e a Montalcino non c'è posto più vicino alle stelle. Si arriva in vetta da una scalinata lunghissima che parte dal fondo del paese. Davanti al sagrato, una terrazza di pietra incornicia le colline dirimpetto, e sotto c'è la pioggia dei tetti. Ceccherini è sulla porta, i capelli appena grigi, il volto di ragazzo. In salotto riposa un affusto di cannone, è il basamento del telescopio. Mi sorride al tavolo di casa. C'è sua moglie, sorella di una maestra delle elementari di mio figlio, anche lei maestra. La notte il primo cantiniere dei Barbi torna astronomo, punta il telescopio e guarda stelle a scelta. Mi mostra un suo tabellario di osservazioni sul transito di Venere sul sole, la data è l'8 giugno 2004. Vi sono annotati gli orari dei passaggi, misurazioni, i colori assunti dal pianeta durante il transito sul Sole, i cambiamenti intervenuti nel corso del fenomeno. Ripercorriamo insieme il caso dell'ufo di Salimbeni, e Ceccherini dice che è un mistero irrisolto. La sfera potrebbe davvero essere un ufo, come no. Gli chiedo se abbia partecipato a qualche riunione del gruppo di Trequanda. "Sì - dice Ceccherini con qualche distacco - non sono contrario alla possibilità di esistenze aliene, non lo sono mai stato. Perciò andavo a Trequanda. Lì, c'erano sessioni di scrittura automatica e questo Argon che comunicava con il nostro gruppo. Era plausibile, era interessante, e non mi sottraevo ad alcuna curiosità. Sono una persona aperta, e verifico tutte le ipotesi. Argon diceva di essere esponente di una civiltà extragalattica che utilizza un'energia più pura della luce".
Il mattino dopo incontro per strada Bruno Bonucci, ex professore, conoscitore attento della storia montalcinese. Un uomo maturo, lo sguardo giovane. Sempre elegante. Da anni studia tra gli archivi, i carteggi e le cronache, dove stessero un tempo le piazze, le vie, e le mura fatte e disfatte di Montalcino - come fosse il paese. Lo trovo davanti alla farmacia del dottor Salvioni, parla con un amico. Chiedo se ha un momento, che gli dovrei parlare. E' quasi l'ora di pranzo, sto tornando a casa con i sacchetti della spesa, e lui me ne prende uno. Si avvia, e mi fa: "Facciamo la strada insieme?", come fossimo due ragazzi che tornano da scuola. La veglia è ambulante e chiedo camminando perché secondo lui i montalcinesi non siano interessati all'ufo di Salimbeni. "Allora - mi fa - l'unico ufo che io ricordi, è quello che precipitò su Montalcino all'inizio degli anni Settanta. I pezzi finirono tutti nell'orto del Duomo. Non si sapeva che roba fosse, vennero le autorità, analizzarono in segreto, e non se ne seppe più nulla", dice. Ma è toscano, gli occhi stuzzicano sornioni, e sotto i baffi candidi il labbro trema di una risata contenuta. "Poi, sul fatto che la gente qui non si interessi all'ufo del Salimbeni, agli articoli del Cappelli sugli ufo, agli articoli dei giornali sull'ufo di Montalcino, e ai programmi Tv sull'ufo del Salimbeni, che posso dire, non lo so come mai. Forse - sospira deliziosamente teatrale - c'è questo fatto. Che verso i compaesani che a un certo punto diventano famosi, i montalcinesi provano un grande, grandissimo dolore". Per strada trovo anche Luigi Anania, produttore di un brunello encomiabile, scrittore, amico. Ha le vigne a sud, prima di Sant'Angelo in Colle, dove il tramonto è viola, la luce diurna è briosa e fa dimenticare l'inverno. A fine estate, il vento s'infila per la sua collina ripida, addensata di viti da non veder la terra, allora appare una distesa mobile, rigonfia dalle ondate delle vigne. Ed è come se sotto l'aia, a un tratto, ci fosse un mare ripido. Ora siamo sul cantone della curva proprio sotto a San Pietro, e gli dico dell'ufo, della veglia mobile. Sorride. Più che altro gioisce della veglia mobile. Alla curva passa un codazzo d'auto. Si ferma. Tutti salutano, ognuno conosce tutti. C'è anche Romano che ha fatto qualsiasi nostro trasloco. Arriva un vento fresco e va sempre meglio. Allora ciao, allora ciao. L'ultima tappa è da Mirella, al negozio di alimentari del chiasso: devo comprare l'olio. Trovo Gabriele della banca, e Maurizio, del negozio di vestiti indiani. Fanno la spesa. Parlano del meraviglioso tempo che sta facendo a Montalcino, che ora c'è quel fresco anche durante il giorno. Parlano del fresco e sorridono, quasi ridono, e forse viene tutto da lì. Che quando tutto è bello, è perché si parla sotto un cielo bello. Delle volte ci passasse un ufo. Se non passa, lo invitiamo noi.
Alessandro Schwed Il Foglio, 10 agosto 2008
|
|
Post n°3 pubblicato il 21 Novembre 2010 da Jiga0
Quando mi morì Jimi Hendrix ero a novantuno giorni da diciannove anni.Stavo al mondo coi capelli più che lunghi, i pantaloni più che rotti e l'aria più che fiera.Penso che fosse mattina, ero nel bagno con le piastrelle gialle dei miei genitori, avevo fatto la doccia e stavo ascoltando la radio. Poteva succedere che durante la giornata, tra i programmi per i gentili ascoltatori e gli avvallamenti melodici delle canzoni italiane, frangenti asfittici in cui dovevo ascoltare "lei mi darà un bambino", venisse su una chitarra rabbiosa - segnali di esistenza. Perciò, niente di insolito che il diciotto settembre millenovecentosettanta stessi ascoltando la radio. Ero sempre a caccia di rock. Dicevo che mi sarei laureato sul blues, andavo dal professore di musicologia, un esangue esperto di Palestrina che intendevo rivitalizzare ai colpi di armonica di un musicista nero che si chiamava Howlin Wolf, gli sciorinavo sul tavolo la bibliografia intorno a Leroi Jones, quello de "il Popolo del blues", e lui faceva segno di sì. Com'è ovvio, in facoltà ci andavo per occuparla, se no stavo sul prato del chiostro di piazza Brunelleschi. C'era una giovinetta molto bella coi capelli alla Angela Davis che mi metteva le margherite tra i capelli, e nessuno di noi due aveva il coraggio di dire che era innamorato. All'alba tornavo a casa dopo avere ascoltato i miei amici dei gruppi rock fiorentini che suonavano allo Space Elettronic, un ex garage sotto la cupola di un paracadute, dove per dire suonarono i Canned Heat. A un tratto, nel bagno giallo dei miei genitori, una voce femminile dentro la radio disse schietta che era morto Jimi Hendrix. L'avevano trovato morto nel letto (se no la vasca da bagno, ma la vasca da bagno era di Jim Morrison. La gente del rock è morta in bagno molte volte e questo mio appannamento dipende dalla mitologia, però anche dalle condizioni della mia memoria). Non poteva essere vero, ma quella continuava a dire che Jimi Hendrix era morto a Londra e poi che le autorità, il medico legale, che il corpo del musicista, che le cause, e che all'improvviso. L'unica cosa che alla radio non dicevano era che non poteva essere vero. Ero davanti allo specchio, ero io, ero tagliato in due. Che sarebbe successo da questo momento in poi? All'improvviso mi trovavo a un confine sconosciuto. Qualcuno mi stava scacciando dalla mia terra. Poi la radio deve essere passata ad altro; fatuità; un varietà radiofonico; parole dette da estranei che amavano le canzoni di quel Dino. Stavo immobile, senza fiato, come se mi avessero infilato in un ascensore di ghiaccio e adesso scendessi come un proiettile al centro della terra. Ero lì davanti allo specchio del bagno giallo, poi a un certo punto devo avere lasciato un lamento, come nelle tragedie; come quando un messaggero porta la notizia che è morto Teseo, è morto Achille, e dopo inizia il lamento per il lutto, e gli uomini e le donne camminano avanti e indietro, e le braccia sono rivolte al cielo, e il cielo non risponde, c'è solo la morte. Mi pare che mia madre sia venuta di corsa alla porta del bagno, che io urlavo "no". Ero lì nel bagno giallo dei miei genitori che credevo di essere a posto, uno già adulto, e invece a un tratto dovevo imparare a camminare. La mamma avrà chiesto diverse volte che stesse succedendo ("Tutto bene?... Allora?..."), e io appoggiato alla porta del bagno, dall'altra parte, devo averle risposto che mi era morto Jimi Hendrix. "...Ora come faremo?... che schifo...". Non c'è niente di più puro del melodramma dell'adolescenza che finisce, una tenera parte invisibile si stacca dal corpo e se ne va. Ero lì allo specchio del bagno giallo, stavo per divenire un giovane uomo, e sarò stato sicuro in modo assiomatico che non mi avrebbe potuto capire nessuno; che noi saremmo stati soli per sempre, tutta la generazione e io, ma ovvio, più io che tutta la mia generazione. Con la mamma avevo confidenza, nonostante lo scarto tra i nostri interesssi estetici. Lei: Cronin, Natalino Otto e Giuseppe Verdi. Io la chitarra col distorsore, PG Woodehouse, e il buon soldato Schweyk. Lei avrà cercato di essere complice, avrà fatto una di quelle domande da mamma: "Ma come è successo, quel povero ragazzo!". Solo che stavolta non volevo sapere subito come fosse successo - ma subito perché. Lui era la centrale elettrica della musica mondiale, ed eravamo rimasti al buio. Senza Jimi Hendrix, senza la fender bianca, con le corde rovesciate, da mancino. Avrei pianto e nessuno mi avrebbe capito, soprattutto gli amici di incerta amicizia. Quelli che a un certo punto si fermavano. Loro non amavano Hendrix sul serio e io sarei stato un imbecille solitario. Il giorno che al cinema Ariston di Firenze avevano cominciato a dare "Woodstock", alle tre ero già lì, e degli amici nemmeno l'ombra. Avevano da fare, sì, ma da fare che? Si può dire che poi questi miei amici fossero divisi in due gruppi, a parte la ragazza bella che mi metteva i fiori in testa. C'erano i finti vispi e i dormienti puri. I finti vispi con i libri di Marx, le foto in bianco e nero sviluppate nello sgabuzzino, Quaderni Piacentini; i dormienti puri: e allora gli esami dati con regolarità funesta, tornare a casa e subito il telefono e la fidanzata - come stai carotino? Se no, in giardino a controllare le candele della moto, o in cantina a rifare la parte del basso in Penny Lane. Io ero con Hendrix. Hendrix era l'esistenza. Era "Sulla strada" di Kerouak alla fine dei Sessanta; era andare alle prove dei gruppi rock e infilare la testa negli amplificatori Marshall per non perdere il distorsore, e riconoscere alla prima svisata se la chitarra era una gibson o una fender. E quel giorno, al cinema Ariston, i miei amici non c'erano. Al primo spettacolo, c'erano seicentomila persone sulla spianata, io e un altro paio di capelloni. Dopo che ebbi visto i Ten Years After, pervenni all'assolo dell'inno americano, e sullo schermo c'era solo la mano di Jimi che andava sulla leva del distorsore e faceva arrivare a Woodstock le bombe del Vietnam, e dopo iniziava una musica gentile e la spianata di Woodstock rimaneva da sola, cullata dalla fender bianca, e il film finiva sfiorato dalle mani di Jimi Hendrix. Rimasi in platea per tutte le proiezioni di quel giorno e di quella notte. Mi sono trovato nel mondo del rock intorno ai sedici anni. C'era questo mio amico, che si chiamava Guglielmo, aveva la barbetta a punta e ascoltava solo John Coltrane e Archie Shep. Insomma il jazz più dolce e rabbioso che ci fosse. Io ero interessato, ma sino a un certo punto, non sentivo il segnale. Andavo in cerca di qualcosa d'altro, e se avessi potuto confessarlo, la scossa musicale l'avevo ricevuta da Celentano. A Sanremo. Si era presentato di spalle, si era girato, e più che cantare come gli altri, aveva quasi detto nel microfono: "Con ventiquattromila baci". Avevo intercettato l'idea e l'avevo messa da parte. Sicché passano gli anni, e un giorno arriva a casa questo mio amico Guglielmo, lo strambo che ascoltava i barriti dei sassofoni dalla mattina alla sera. Era venuto a dire una cosa. A Guglielmo brillavano gli occhi, i suoi erano di Milano, aveva la erre blesa e a ripensarci era il prototipo dell'appassionato di jazz. Mancava solo che fumasse la pipa, ma eravamo sui quindici anni e avevamo appena smesso i pantaloni corti. La pipa l'avrà fumata dopo. Mi fa Guglielmo, mezzo ridendo come sempre: "Ho ascoltato una cosa pazzesca. Ti farà impazzire. E' tritolo". Era un trentatré doppio dal vivo di un gruppo rock inglese. I Cream. Andai da Alberti e lo comprai a scatola chiusa, sulla parola di Guglielmo. Tornai a casa e lo misi sul Lesa. Dalle casse venne fuori lo sparo di una musica finalmente elettrica: cioè con un rapporto tra il suono e l'energia che lo liberava. Ricordo di avere pensato: "Ma allora questa cosa esiste!". La chitarra di Eric Clapton cominciò a ringhiare dentro a un impasto di libertà e potenza lenta, e mi sentivo vivi i capelli, le braccia, vive anche le scarpe. Poi c'era un rombo, era Jack Bruce al basso, dentro a delle sequenze discendenti e ascendenti che avevo sentito solo nelle fughe di Bach. E questo tormento della foresta urbana, la batteria di Ginger Baker. Era come ascoltare una intera fabbrica che si era messa a fare il rock col suono del cortocircuito. Una musica vivente. Non ci potevo credere. Buon Dio, esclamai con le mani sul volto, Guglielmo è un santo. Sarà stata la fine del 1967, e avevo scoperto che la mia generazione aveva una musica come nessuna generazione ne aveva mai avuta. Jimi Hendrix lo dovetti scoprire. Vidi la copertina, comprai "Are you experienced?" e me lo portaia casa. Non c'era niente di più potente e forsennato, ormonale e malinconico, umano e marziano. Quello lì faceva parlare ogni angolo delle emozioni della giornata, solo che erano con le iniziali maiuscole: se era tristezza, era la Tristezza, se era una festa era la Festa. Non si poteva dire che lui arrivasse sul palco e si mettesse a fare dei pezzi sincopati, quello lo facevano gli altri. No, Hendrix suonava, e ti chiedevi cosa avessero fatto gli altri per anni e tu con loro. Semmai era illogico che a un certo punto la musica finisse e lui se ne andasse, e noi rimanessimo in mezzo alla casuale vita. Non era accettabile che la corrente si attenuasse su "off", lui eseguisse un inchino e sparisse nel buio. E questa è stata la mia prima giovinezza. Casa nostra era a pianterreno. Aprivo le finestre, mettevo il volume a livelli, diciamo così, imponenti, poi partiva "Foxy lady". Jimi alla fine del testo, diceva: "Come on the Gipson", forza con la Gibson, che poi era lui, e sotto forma di chitarra, toglieva la museruola allo spirito. Allora, dalle finestre aperte di casa la sua chitarra se ne andava per la via, e io speravo non solo per quella via, ma che andasse in giro per tutte le vie della città, poi in aria, verso le finestre dei secondi e terzi piani, fino ai tetti. Volevo che la gente sul marciapiede, quelli sulle macchine che andavano a lavorare, gli adulti dormienti, i vicini di casa, tutti quelli che passavano, sapessero che al mondo c'era il rock e che esisteva Jimi Hendrix. Lo ascoltavo in piedi, non ero così pusillanime da stare in poltrona come se in tivù ci fosse stato il tenente Sheridan, mentre sul pedale dello wha wha era in corso "Vodoo Chile". Stavo in piedi, se no camminavo per il salotto. Con le mani mimavo la corsa sulle corde della chitarra, prendevo un scopa della mamma, la imbracciavo e svisavo per tutto il bastone, e alla prima lancinante svisata mi piegavo su me stesso, mi rialzavo, scuotevo i capelli, singhiozzavo, ridevo: era un'ascesi elettrica. Non mi importava di essere ridicolo, o inadeguato, o goffo e neanche ci pensavo; anzi, non pensavo e basta. E poi ascoltare Jimi e tenere la mani in tasca sarebbe stato contronatura. Avevo una chitarra acustica su cui a volte facevo due note e un pomeriggio, ascoltando "Wild thing", la spaccai sul pavimento. Poi uscivo dal trance e andavo alla finestra a vedere se qualcuno si stava fermando ad ascoltare - non c'era mai nessuno. Il traffico continuava a scorrere; la città a farsi gli affari suoi. All'epoca di Jimi Hendrix con i miei amici partivamo e andavamo ai concerti per tutta Italia. Io registravo con un mangiacassette che spesso mi masticava il nastro. Se il nastro si salvava, dalla musica asfissiata dal fruscio, emergevano i miei commenti. C'era la registrazione di un assolo al flauto traverso di Jan Anderson, quello dei Jethro Tull che suonava su una gamba sola, come un trampoliere. Anderson aveva questo modo che ansimava nel flauto, e nel mezzo dei singulti si sentiva la mia voce nasale: "Mio Dio, è meraviglioso". Era la mia protratta adolescenza. Una mescolanza viscerale tra comico e tragico e finì con la morte di Jimi Hendrix. Ma in quel tempo che era vivo, ce ne andavamo in giro io e un mio amico di immensa mole, Riccardo. Aveva i capelli nerissimi fino a metà della schiena, io biondi e anch'io a metà della schiena. Riccardo suonava il blues e il rock sull'organo Hammond, e lo faceva molto bene, io andavo a trovarlo e gli dicevo: "Suona". La notte andavamo intorno, nei locali e poi a cominciare il giorno alla stazione. Ora, dato che ero parecchio biondo, facevamo questo scherzo di dire che io ero Johnny Winter, quel chitarrista texano coi capelli bianchi, in visita a Firenze. Ci credevano tutti e facevo anche gli autografi. Aprimmo un locale underground. Più che altro fu merito di un ragazzo, era alto due metri, un chitarrista fenomenale. Si chiamava Aldo, detto Aldù, ma era Frank Zappa che abitava in piazza Indipendenza, a pochi metri dalla sede del Movimento sociale, e la sera a riaccompagnarlo avevo paura. Aveva la fender, suonava con gli Zero e mescolava Giuseppe Verdi al rock-blues. Il locale fondato da Aldù si chiamava la Buccia, ma non esisteva. Era la sala di una casa del popolo dalle parti della fabbrica del Nuovo Pignone. Durante la settimana c'erano quelli del Pci a giocare a carte, ma la domenica si passava dal tressette al distorsore. Durò un mezzo inverno. Aprivamo anche alle quattordici, e c'erano trecento persone in fila. Suonavano due gruppi, gli Zero e gli Elettric Mud, Letame Elettrico. Io stavo davanti a un tavolo che era messo sopra una spianata di tavoli e mandavo le mie registrazioni di rock. C'era la pasta al sugo e il biglietto costava quattrocento lire. Ma stavo raccontando di quel giorno che mi morì Jimi Hendrix, che in televisione e alla radio dicevano poco, e che c'era un'arietta di scandalo. Mentre era la fine dell'idea che la musica fosse tutto, la sola polis, la sola politica, e la musica stava per ricominciare a essere una materia da affrontare seduti. Il giorno dopo che era morto Hendrix, presto al mattino, corsi dal giornalaio. Presi la Nazione. Trovai la pagina. Leggevo in mezzo alla strada, camminando, fermandomi. Avevano pigiato la notizia nelle pagine degli esteri, come se Jimi fosse stato un semplice capo di stato, un reucolo del belgetto. C'era un pezzo su tre colonne e una stinta foto in bianco e nero. Il titolo recitava: "E' morto Jimi Hendrix, il famoso cantante di rock'nroll". Era il secondo giorno che non c'era, e già lo stavano riammazzando. Non si rendevano conto che era passato Caravaggio col plettro, e chissà quando sarebbe successo di nuovo. La distanza tra la Nazione e quello che io chiamavo "noi" era incolmabile. Per l'appunto loro erano una nazione e noi un'altra. Noi la gioventù di Woodstock e loro una tipografia! Presi l'Olivetti di mio padre, misi Band of Gipsies sul piatto Thorenz a cinghia, Jimi alla fender, Buddy Miles alla batteria, Billy Cox al basso, e c'era "Machine Gun" e faceva tidatta tidatta diridà, tidatta tidatta diridà. Mi misi a scrivere il necrologio. Scrivevo, correggevo, piangevo, riscrivevo. Quel giorno non mangiai. A tarda notte il pezzo era pronto. Il motivo per cui contavo sulla pronta pubblicazione era che secondo me era commovente e che casa mia si trovava a duecento metri dalla redazione. Era tutto veramente semplice. Bastava attraversare il viale, costeggiare il cinema-teatro Cristallo, ignorare le foto in bianco e nero delle ballerine in bikini con gli enormi glutei delle donne italiane del 1970, attraversare un altro viale, e impattare la portineria della Nazione. La mattina dopo pressai in una busta le tre cartelle sulla morte di Hendrix, attraversai i due viali e arrivai alla redazione. Mi avvicinai al vetro della portineria e dissi al signore che stava dall'altra parte: "Per favore, consegni con urgenza questo alla redazione. E' sulla morte di Jimi Hendrix", e feci passare la busta dentro a un buco. Lui fece un cenno col capo. Molto bene, pensai, è fatta. Il mio necrologio su Jimi Hendrix non fu mai pubblicato. Può darsi che questa sia la volta Buona. Alessandro Schwed Il Foglio,16 settembre 2006
|
|
Post n°2 pubblicato il 21 Novembre 2010 da Jiga0
Schwed Un padre racconta il suo adolescente virtuale. Torna col suo vero nome,Jiga Melik:un randez-vous fra generazioni, intelligente,sentimentale,ironico
Ecco il Lungo,un bucaniere su Facebook Passa.Garantito che passa. Anche se finché si è dentro sembra impossibile riuscire a riaffiorare da quell abisso fatto non di acqua ma di una materia vischiosa e pesante. E invece, prima o poi arriva un nuovo giorno che all' apparenza non ha nulla di diverso dalla cupa e interminabile sequenza di quelli chel hanno preceduto, eppure sì. Perché è vero: l' adolescenza a un certo punto finisce. Può ripresentarsi talvolta in età pre-senile, per lo più nel genere maschile, dove dà sintomi bizzarri quali giacche troppo sgargianti, acquisti inconsulti e sorrisi ebeti spalmati in faccia. Ma di solito se ne va per non tornare più e allora in famiglia si ricomincia a vivere. Perché l' adolescenza è una faccenda decisamente complicata per chi si trova ad attraversarla, ma lo è egualmente e forse persino di più per chi è costretto a sedersi sul fiume e aspettare che passi .Il grosso guaio è che qui non esistono regole. Chi ha avuto l' ardire di mettere al mondo più di un figlio può attestarlo: tutto imprevedibile, nessun precedente che tenga, e ogni volta ci sitrova più impreparati di prima. C è la fase dark e quella iperattiva: tanto un muso lungo quanto la risata elettrica possono durare comodamente anni. L' adolescente è capace di manifestare comportamenti socialmente caotici (la casa piena di gente a qualunque ora del giorno o della notte) ma anche forme di eremitaggio degne di un monaco stilita nel deserto. In ogni caso, è una fatica improba, per un paio di comuni mortali quali sono di solito dei genitori. Il Lungo, ad esempio, adolescente stazionato per qualche tempo a casa di Alessandro Schwed, è del genere di ultima generazione: si ciba di ultracorpi da frigorifero e predilige la realtà astratta dei social network .Tipo Facebook per essere chiari. Se non fosse che questi luoghi virtuali lui li chiama "piazza" e non ha una precisa percezione della differenza che corre (forse) fra la realtà corporea e quella schematica. Il grande vantaggio del Lungo è, oltre a un residuo di dolcezza che ricorda la remota radiazione di fondo dell' universo, un padre che lo descrive in modo molto convincente. Alessandro Schwed è il nome vero del mitico Jiga Melik oltre chel autore dello strepitoso Lo zio Coso. In Mio figlio mi ha aggiunto su Facebook ci racconta che cosa succede quando un bel ,anzi inquietante, giorno ti entra in casa "un ragazzo lungo e magro, un allampanato bucaniere con la chitarra elettrica, quarantacinque di piede", che sostituisce tuo figlio: La chiave di tale incontro (si fa per dire) intergenerazionale, sarà quella piazza virtuale mica per niente inventata da uno poco più che adolescente,e dove si fanno amici, ci si parla ,si spettegola, si curiosa. Facebook è nato qualche tempo fa per loro, e per un certo periodo è stato off limits per gliover venticinque. Poi a poco cico si è affacciati - non pochi,come chi scrive, per spiare biecamente i propri figli. I quali hanno dapprima ignorato le nostre, adulte e tendenziose, richieste di amicizia, come a dirci che quello non era un postoper noi. Finché, a un certo punto, si sono arresi proprio come fa il Lungo, decretando così un roseo lieto fine alla storia. Schwed ritrae questo mondo, virtuale e reale, con ironia e partecipazione, con slancid intelligenza e di sentimento egualmente ripartiti. La storiasua e del Lungo è anche piena di colpi di scena, scoperte storiche, riconciliazioni sommarie; è insomma una storia tremendamente avvincente, più o meno come quelle che tutti noi alle prese con un adolescente abbiamo vissuto fra le mura di casa, con l' incubo che non finissero più. E invece, per fortuna,non è così Elena Loewenthal |
|
Post n°1 pubblicato il 21 Novembre 2010 da Jiga0
"Questo libro raccoglie la migliore tradizione dell'umorismo yiddish, parla di famiglia, e ne parla in modo surreale. Avendolo seguito romanzo dopo romanzo, sin dalle sue prime pubblicazioni, considero Alessandro Schwed l'ultimo scrittore yiddish in lingua italiana". Con queste parole Francesco Cataluccio, scrittore e critico letterario, ha introdotto la presentazione di "Mio figlio mi ha aggiunto su Facebook", ultima fatica di Alessandro Schwed, il Giga Melik della rivista satirica "Il male" negli anni Settanta. Un'opera in cui l'autore tratta tematiche sempre più centrali nella società del XXI secolo: la relazione tra la tecnologia e i rapporti umani, l'impatto del duo playstation-Facebook sulla vita degli adolescenti, la loro trasformazione improvvisa che investe i genitori, spesso incapaci di gestire la situazione. "Più che di qualsiasi altro argomento però, il mio romanzo vuole parlare dell'inadeguatezza - ha sottolineato l'autore alla libreria Centofiori di Milano - L'inadeguatezza di un padre che all'improvviso scopre nel figlio una persona che non riconosce più, un gigante con il 45 di piede. E che cerca di trovare una risposta adeguata a questa inadeguatezza, che è poi una risposta basata sull'amore che prova per lui". Alla fine il padre, diventato anche lui un patito frequentatore dei social networks, verrà aggiunto dal figlio tra i contatti di Facebook, in un momento catartico che segna l'inizio di un nuovo dialogo tra i due, e conclude il libro. "Nei secoli passati, scrivere storie inventate era considerato contro la morale, per cui i grandi autori cercavano escamotage per rivestire i propri romanzi di una patina di verosimiglianza - ha proseguito Schwed - La verosimiglianza rimane per me una caratteristica fondamentale, perché penso che nel momento in cui io credo a quello che scrivo, ci crederà anche il lettore". Infatti tra il pubblico, diverse persone hanno dimostrato di sentire particolarmente vicino il problema del rapporto con i figli adolescenti, nonché il modo in cui "Mio figlio mi ha aggiunto su Facebook" tratta la questione. Un tema particolarmente attuale in un mondo in cui, ricordano Schwed e Cataluccio, per i ragazzi è sempre più difficile riuscire a sviluppare la propria identità come persone e non come membri di un gruppo. "Nel mio libro, il Lungo (questo è il soprannome che il padre ha dato al figlio ndr) lascia la scuola. Quello dello studio è un punto molto importante - ha evidenziato ancora Schwed - Ovviamente l'istruzione è una preoccupazione fondamentale per un genitore. Però alle volte bisogna chiedersi quanto il frequentare la scuola ci interessi perché desideriamo che i nostri figli imparino, e quanto invece diamo per scontato che vadano a scuola solo perché, a livello sistemico, si fa così. Bisogna sempre cercare di dare ai ragazzi la possibilità di diventare le persone che vogliono essere, secondo la propria personalità, seguendo la propria strada". Rossella Tercatin
|

CAN EXPRESS - VOLUME SCANDALISTICO PER CANI



CERCA IN QUESTO BLOG
IL FRIGO GIA' PIENO
CHI PUò SCRIVERE SUL BLOG
I messaggi e i commenti sono moderati dall'autore del blog, verranno verificati e pubblicati a sua discrezione.
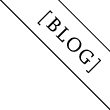





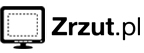
 La prima volta che vidi Donato fu a Roma, in una sorta di grotta o pozzo, allestito sotto il teatro Alberico. Era il 1978, il pozzo era l'Alberichino, piantato nelle profonde cavità di Roma, dove non potevano fare la guardia né Castel Sant'Angelo né la cupola paziente di San Pietro. Donato recitava in questo antro dostojewskiano, tra un forte odore di terra smossa e calce viva. Era un luogo indeterminato ed esterno a tutto. Il mio futuro grande amico declamava il suo umorismo in fondo a questo pozzo buio, la dogana teatrale tramite la quale si entrava nel regno che di giorno e di sopra non è percepito. Lì era riuscita ad atterrare, ovvero, sotto-atterrare, l'eccentrica macchina dei nuovi monologhi, al plausibile confine fra catacombe e resti di ville patrizie. Dunque, se il teatro Alberico era in superficie e off, l'Alberichino era ancora più off, era off off. Si trovava così sepolto nel tufo che dalla superficie non giungevano neanche gli applausi del sovrastante Alberico.
La prima volta che vidi Donato fu a Roma, in una sorta di grotta o pozzo, allestito sotto il teatro Alberico. Era il 1978, il pozzo era l'Alberichino, piantato nelle profonde cavità di Roma, dove non potevano fare la guardia né Castel Sant'Angelo né la cupola paziente di San Pietro. Donato recitava in questo antro dostojewskiano, tra un forte odore di terra smossa e calce viva. Era un luogo indeterminato ed esterno a tutto. Il mio futuro grande amico declamava il suo umorismo in fondo a questo pozzo buio, la dogana teatrale tramite la quale si entrava nel regno che di giorno e di sopra non è percepito. Lì era riuscita ad atterrare, ovvero, sotto-atterrare, l'eccentrica macchina dei nuovi monologhi, al plausibile confine fra catacombe e resti di ville patrizie. Dunque, se il teatro Alberico era in superficie e off, l'Alberichino era ancora più off, era off off. Si trovava così sepolto nel tufo che dalla superficie non giungevano neanche gli applausi del sovrastante Alberico.







Inviato da: Jiga0
il 20/03/2012 alle 21:32
Inviato da: Jiga0
il 20/03/2012 alle 21:26
Inviato da: Jiga0
il 20/03/2012 alle 21:17
Inviato da: Jiga0
il 08/07/2011 alle 13:51
Inviato da: sergio
il 07/07/2011 alle 14:20