Schwed RaccontaSu e giù per la tastiera |
C'ERA UNA VOLTA MONTALCINO

JIGA MELIK E IL SIG. SCHWED
Jiga Melik è l'alter ego intermittente dello scrittore Alessandro Schwed. Il signor Melik nasce nel 1978 nella prima e provvisoria redazione del Male, un ex odoroso caseificio in via dei Magazzini Generali a Roma. Essendo un falso sembiante di Alessandro Schwed, Jiga Melik si specializza con grande naturalezza nella produzione di falsi e scritti di fatti verosimili. A ciò vanno aggiunti happening con Donato Sannini, come la consegna dei 16 Comandamenti sul Monte dei Cocci; la fondazione dell'Spa, Socialista partito aristocratico o Società per azioni, e la formidabile trombatura dello Spa, felicemente non ammesso alle regionali Lazio 1981; alcuni spettacoli nel teatro Off romano, tra cui "Chi ha paura di Jiga Melik?", con Donato Sannini e "Cinque piccoli musical" con le musiche di Arturo Annecchino; la partecipazione autoriale a programmi radio e Tv, tra cui la serie satirica "Teste di Gomma" a Tmc. Dopo vari anni di collaborazione coi Quotidiani Locali del Gruppo Espresso, Jiga Melik finalmente torna a casa, al Male di Vauro e Vincino. Il signor Schwed non si ritiene in alcun modo responsabile delle particolari iniziative del signor Melik.
MIO FIGLIO MI HA AGGIUNTO SU FACEBOOK - ROMANZO


LA SCOMPARSA DI ISRAELE - ROMANZO
LINK DOVE VIVO
- Fahrenheit
- Il Tizio della Sera
- romanzo LO ZIO COSO
- La Scomparsa di Israele
- Corriere della Sera
- Critica letteraria
- libri su libri
- i suoni della memoria
- IBS
- settimanale L'AZIONE p. 7
- Il Piccolo - recensione teatrale "Alla ricerca dello zio Coso"
- Il Messaggero Veneto - Giornata della Memoria Intervista ad Alessandro Schwed
- anobii
- libero di leggere
- articolo sul Foglio
- roma
- IL MALE
- il Male su facebook
AREA PERSONALE
TAG
MENU
I MIEI BLOG AMICI
|
Post n°101 pubblicato il 17 Agosto 2014 da Jiga0
Molto noto per la sua attività satirica, Alessandro Schwed si inserisce nel filone dei “bestiari” umoristici con una sorprendente e toccante fiaba metropolitana Massimo Onofri (l’Avvenire, 18 luglio 2014) Esiste un filone tenue, non privo di risultati interessanti, di vocazione umoristica, che carsicamente percorre la nostra storia letteraria servendosi, per i suoi scopi di furiosa satira sociale, degli animali, i quali arrivano a sconvolgere l’ordinario corso della vita umana: mentre la decostruiscono dentro un’evidenza euforica che scardina ogni ipocrisia sociale. Avevo letto, tre anni fa, con vero gusto, il primo romanzo di un bravo critico e scrittore, Fabrizio Ottaviani, intitolato semplicemente e significativamente La gallina. Arriva ora di Alessandro Schwed – già molto noto negli ambienti del giornalismo libero e iconoclasta con lo pseudonimo di Jiga Melik – un libro esilarante, La via del pavone: ne è protagonista un mite architetto di interni di 42 anni, Giulio Campennì, coniugato con Ionta, funzionaria editoriale di 34, entrambi tiranneggiati dalla madre di lei, Nelly, “un genio dell’imperialismo familiare”, detta anche “la Faraona” (o “Napoleone”), la quale, vedova dell’operoso architetto Nelson, “regna su quattro palazzi e ottanta famiglie della Garbatella”. Che cosa accade, a casa Campennì, alle otto e mezza d’una mattina d’estate di “caldo africano”? Che la prepotente suocera, in procinto di partire con la figlia per le vacanze al lago, si presenta alla porta di casa con un pavone al guinzaglio: potrebbe, di grazia, il gentile genero accudirlo, in sua assenza, senza dimenticare di fissarlo almeno tre volte al giorno, a orari rigorosamente prestabiliti, di modo che possa così dispiegare con la coda, egotistico e indifferente, la sua magnificente coda?
Comincia così un romanzo davvero irresistibile e turbinoso: perché l’impudente e insolente pennuto, non appena le due donne se ne sono andate, approfittando di un momento di distrazione dell’ancora inebetito e rassegnato Giulio e d’una finestra socchiusa, s’invola goffo ma sicuro del fatto suo, sul terrazzo condominiale del palazzo dirimpetto, per atterrare quasi subito sul tetto di un tram. L’angosciatissimo architetto non ha alternative: se non quella di provare a recuperarlo, mentre, uscendo di corsa, si chiude fuori di casa, scoprendo poi di aver dimenticato le chiavi. Situazione grottesca fino all’implausibile: eppure di straordinaria iper-realtà, se è vero che, attraverso la fuga del pavone e la rincorsa parossistica e disperata di Giulio, ci imbattiamo in una folla di personaggi con cui Schwed ci consegna un ritratto del Paese irredimibile e dei suoi odierni e quotidiani deliri, ma anche dei suoi sorprendenti scatti di solidarietà. Basterebbe pensare a quel carnera di “Spizzichino Elvio”, il centurione in costume per i turisti che lavora ai Fori imperiali, il quale si offre di aiutare “gratisse” il povero Giulio, sollevandolo sul tetto del tram. Pagine che, da sole, giustificano il prezzo del libro: “Rega’…per cortesia…il pavone è persona sensibile”. Non fosse che, a un certo punto, arriva il ventunenne Riccardo, “il frutto di una relazione a dir poco estemporanea” avuta da Giulio con la bella Franca a soli 23 anni quando studiava a Firenze. Un rapporto, tra padre e figlio, che è stato Riccardo a volere con ostinazione: accettando persino la clandestinità, a tutela del capriccio di Nelly. Sarà ancora il pavone a dettare il sorprendente finale: per suggellare, contro ogni viltà, e finalmente nella verità, quello che è ormai diventato il romanzo d’una struggente telemachia. |
|
Post n°100 pubblicato il 17 Luglio 2014 da Jiga0
Il calciatore che passava in mezzo al corpo dei terzini di Alessandro Schwed (Il Foglio, 17 luglio 2014) Lo vediamo correre, Messi. Calciare la palla, avere davanti un avversario e già averlo alle spalle come un fatto a stento accaduto. In campo, alla premiazione sugli spalti, nel sottopassaggio degli spogliatoi, stringe la mano ad arbitri, esterni, ministri, notabili Fifa, miss, regine, fotografi. E sono oltrepassati. Saluta chi ha davanti. Tutti. Rapido, asettico. Non per educazione, per automazione. Si accommiata che sta incontrandosi. Lo sguardo oltrepassa chi incontra: può darsi che pensi o che stia contando il numero di gradini che ha salito e poi scenderà. Un lampeggiare di aprire e di chiudere proviene dalla bocca. È la sua chiostra dentale. Sorride. Non che sorrida e si soffermi in un brillar d’occhi: è la traduzione della nozione di sorriso. Fatto. Ora proseguo. Vado altrove e ciò che doveva essere, è stato. Io ho sorriso. mi hanno visto in Cina. Un gesto meticoloso, rapido, forse doloroso. Il dolore che costa è cancellato dall’anestesia di quando può calciare. Sorride come se si spalancasse una saracinesca senza il negozio alle spalle. Quando il sorriso è concluso, e ciò accade immediatamente, la saracinesca ripiomba in basso, ed è come se niente sia accaduto. Messi è già due passi altrove da dove ha sorriso. Sulla sua scia, una voce cordiale quasi esistente si accomiata: signore e signori, grazie. La vostra escursione sul Sorriso di Messi si è conclusa. Leo è a tre passi, vale a dire a trenta milioni di chilometri. Irraggiungibile. In viaggio verso un’equazione. Ma qualcosa di prima continua ad accadere: un rimbombo oltrepassa le nuvole, in arrivo dalle profondità dello spazio, come se enormi chiavi avessero provveduto a richiudere Il ferro titanico del suo volto e il mondo riecheggiasse ancora del nome, Messi, essi, essi….Chi è mai il signore di Messi, e cos’è Messi, è forse una nazione? Poi Messi gioca a calcio. In una realtà sincronizzata con la nostra, parallela e allo stesso tempo asimmetrica, stanziata in un altrove il cui indirizzo non è mai pervenuto. Scarta un mediano, poi due terzini e questo si compie in una sorta di scivolamento progressivo, un movimento fluido sull'erba, un trascorrere sdrucciolante e indecifrabile alla fine del quale l'avversario è alle sue spalle. A quel punto, vorremmo capire come ciò sia potuto avvenire, se si sia trattato davvero di un movimento o dell'utilizzazione di una curvatura spazio-temporale, ma è troppo tardi: Messi è qualche metro dopo. Così potremmo dire che Messi e la sua opera attengono alla magia di un antico mago. Oppure, a una sconosciuta civiltà di calcianti. Maradona no, lui si vedeva cosa stesse facendo, era un calciatore alla decima potenza. Quando superava un avversario, lo beveva correndo. Era un circense, un giocoliere, un fromboliere, un titano basso, un clown irascibile, un uomo che piange. Maradona spiegabile, Messi inspiegato.
|
|
Post n°99 pubblicato il 16 Giugno 2014 da Jiga0
Lo sfondamento di Casaleggio (The Huffington Post, 14 giugno 2014) di Jiga Melik Qualcuno deve avere detto a Grillo che le europee si vincevano a Livorno. Quella convinzione euforica non è farina del suo sacco. Deriva dal pensiero virale di Casaleggio, il quale in un documento recente afferma che si vince perdendo. Si tratta di una riflessione epocale sulle cose che si sentono chiaramente anche se purtroppo non le vede nessuno. Qualcosa che inserisce di diritto Cinque Stelle nel filone del profetismo apocalittico. Vincere perdendo! Magnifico. Secondo un calcolo statistico virale, se Casaleggio e Grillo nel 2094 saranno vivi, vinceranno le elezioni. Onestamente, anche se è virale, è un fatto misterioso che i due arrivino rispettivamente a 140 e a 148 anni. Eppure, nessuno saprebbe dire cosa sia maggiormente senza spiegazioni, che arrivino a 150 anni o che arrivino a governare. Nel suo saggio "Vince chi perde" Casaleggio scrive che se una massa virale di energia pari a ix desidera che un alpinista sia invece una teleferica, appena l'alpinista si auto-chiarifica, diventa una teleferica, e col tempo può arrivare tranquillamente a posata di alluminio. E così, dal primo luglio, in decine e decine di due città italiane gruppi di trecento ma anche una persona si riuniranno in salotti e palestre, creeranno un fluido di uno vale uno, e arriveranno a un punto così madornale che Grillo e Casaleggio nel 2094 governeranno l'Italia. Approfondiamo. All'inizio sarà come per quei disagi momentanei che sembrano un malditesta, poi ti tagliano gli orecchi e non senti più neanche la parola "melassa". E tramite un sensibile salto logico, il documento prosegue: "E basta con l'ingiustizia che possono votare anche i pensionati". Insomma, analizza Casaleggio con l'acume che lo rende distinguibile a secoli di distanza, se vince chi perde, il Movimento sfonda. È chiaro che dopo la sconfitta del 25 maggio, ci sarà bisogno di un qualche ripensamento sugli assetti interni, perché nessuno nega che la disfatta derivi dal modo di Casaleggio di comunicare quello che noi esseri umani chiamiamo speranza. Ed è andata anche bene, perché chissà che sarebbe successo se Casaleggio oltre a Berlinguer avesse fatto dire alla gente anche Qui Quo Qua. In particolare, i militanti nutrono dubbi che l'idea di "Vince chi perde" possa farsi largo nell'opinione pubblica contemporanea. Con tutto che i maggiori circoli virali europei hanno confutato il pregiudizio che Gianroberto abbia la mente logorata da un numero esorbitante di capelli di nailon. A tale riguardo, il notiziario semestrale dell'osservatorio psichiatrico della Brianza, da anni vicino a Casaleggio, racconta il caso del custode del teatro "La Luisa" di Lissone. Un uomo che ha tantissimi capelli sintetici trapiantati. Da anni si propone inutilmente di raggiungere la luna saltando da uno scaleo, ma poi prevale la ragione, esce di casa e ci va a piedi come farebbe chiunque. Al documento "Vince chi perde", si aggiunge la svolta della notte del 29 maggio, quando Grillo ha ricevuto in sogno una telefonata personale di Stalin. I due statisti hanno parlato a lungo del nuovo assetto europeo e il dittatore georgiano si è raccomandato col suo collega di allearsi con i vivisezionatori ungheresi, gli evasori del Principato di Monaco e i moderati inglesi a favore dell'impiccagione. Stalin era in visita di cortesia ed è rimasto estremamente affascinato dall'idea di Grillo di contenere l'arrivo dei clandestini a Lampedusa con delle iniezioni letali subacquee. Ma veniamo al piano di Grillo per l'Europa, che ha registrato anche il consenso di Napoleone: il Movimento si allea coi separatisti inglesi, la Scozia finalmente si separa dalla Gran Bretagna, la Gran Bretagna finalmente si separa dall'Europa, la Francia finalmente torna alla monarchia assoluta e alla pirateria sugli oceani, la Germania finalmente invade di nuovo la Polonia, il Principato di Monaco finalmente conquista la Liguria, e il merito di tutto è di Grillo.. Ora, in Europa serviranno idee e siccome non è facile, a Sant'Ilario si è optato per le sedute spiritiche, dove Gianroberto va in trance vestito da vecchia signora. Del resto, da cosa nasce cosa. Anche la grande idea di aprire il parlamento come una scatola di tonno era emersa da una conversazione di Casaleggio con il fantasma di un caseificio. Sere fa, tanto per fare un esempio, si è riunita l'intera direzione nazionale. C'erano Grillo, Casaleggio e un'anziana vicina di casa che si fa sempre prestare il sale e poi si ferma a dormire. Con in testa il cappellino da baseball, Casaleggio ha letto i fondi del caffè per sapere dallo spirito di un falegname come giocare in borsa coi soldi dei parlamentari. D'un tratto, una figura spirituale a base di limoncello e baco messicano piccante è atterrata sulla tastiera del computer e dopo aver suonato il claxon, ha profetato la vittoria alle elezioni del 2094. Ora non solo questa è una cosa molto incoraggiante, ma presenta un vantaggio. Nel 2094, quelli che adesso fanno il tiggì, o lo guardano, saranno tutti morti, e se Grillo e Casaleggio non vincono le elezioni, non se ne accorge nessuno. |
|
Post n°98 pubblicato il 13 Aprile 2014 da Jiga0
L'avventura della vita e quella del nuovo romanzo / recensione de “La via del pavone – alla disperata ricerca di un pennuto a Roma”, Mondadori di Paolo Russo (la Repubblica-Firenze, 23 marzo 2014) L’avventura estiva del protagonista Giulio è complicata dalla gestione di un bizzoso pavone L’ARCHITETTO Giulio Campennì, con l’accento sulla i, vive a Roma ma è di Firenze. È nato là, figlio d’un oculista che per amore di Romea, bellissima tedesca che scattava splendidi b/n e declamava Rilke, andò a vivere in Bengala. A Roma, dov’è arrivato appena laureato, l’architetto Campennì vive con Ionta, la moglie editor, capace, bella, innamorata ma, ahilui, dotata di madre ovvero suocera vivente: Nelly, ricchissima, cafona e dittatoriale, specie nel ruolo di ex — ma non troppo — padrona dell’attico dove vive la coppia, cui fu donato dal defunto Nelson D’Ancona, dolcissimo marito di quell’arpia burina, quasi una caricatura. Che andando in vacanza con la figlia, un bel dì d’estate affida Ginko (sì, proprio come l’ispettore di Diabolik), il suo costosissimo, ingovernabile pavone al goffo, sfuggente, pavido Giulio. Tanto lui resta a Roma per lavorare, chiuso nel suo mondo d’interni, il solo in cui si senta comodo e che sa, infatti, progettare. In realtà Campennì, protagonista de La via del pavone, quinto libro di Alessandro Schwed, resta a Roma per rivedere l’adorato 21enne figlio Riccardo che viene da Firenze apposta. Nato da una giovanile notte d’amore, amato da Ionta che però l’ha tenuto nascosto a Nelly per timore del suo niet al matrimonio, è stato Riccardo ad “imporsi” al padre anni prima con una lettera. Inevitabile che il ragazzo arrivi mentre il padre è assillato dalla altrettanto inevitabile fuga del pavone, e più ancora dalle temutissime rappresaglie della suocera. Racconto molto romanesco, specie nell’infilata di gerghi, luoghi e variopinte comparse dell’eterna città-set (su tutte il gigantesco centurione “der Colosseo” Elvio Spizzichino, summa di saggezza ebraica e ironia trasteverina), che si succede lungo la caccia al pavone. Ma è da Firenze che arriva Riccardo, e con lui la brezza d’affetto che cambierà la vita di tutti. D’altronde, intorno alla città ruota da sempre la vita di Schwed, dalla giovanile militanza nel Manifesto agli intrecci dei suoi precedenti libri, dall’amor fou per la Fiorentina alle amicizie con Carlo Monni e Donato Sannini. Senza scordare però gli anni romani lungo i quali, come Jiga Melik, fu colonna del Male, il settimanale che prima e meglio di tutti coniugò, fra ‘77 e ‘82, satira politica e creatività fuori di testa, dadaismo e critica sociale; si vedano le ancora irresistibili false prime pagine dei quotidiani d’allora. Ebreo la cui famiglia d’origini ungheresi ha visto tredici dei suoi sparire nei lager, alla difesa e ricerca di quella memoria l’autore, che ne scrive con lucida passione su varie testate, ha dedicato in particolare il suo lunare, dolente secondo romanzo Lo zio coso, seguito dal “ritorno a casa” del reportage La scomparsa d’Israele. Da anni Schwed vive a Montalcino con la compagna Erina Lo Presti, una delle storiche “Galline”. E da quella pace collinare trasmette una scrittura limpida, riflessiva, mutevole e sorprendente, che da qualche tempo serve anche il teatro di Andrea Kaemmerle; una laica, ferma appartenenza alla cultura ebraica, che attraversa, con sferzante humour, anche la cameristica, borghesissima quotidianità de La via del pavone. E sarà proprio la sua fuga finale, quella vera, a indicare a Giulio la via della riscossa e dell’età adulta.
|
|
Post n°97 pubblicato il 16 Marzo 2014 da Jiga0
Tag: 2001 Odissea Nello Spazio, Arte, Culture, Fantascienza, futuro, Kubrik, Macchine, Marziani, Megalopoli, Notizie, Razzi, Robot, Spazio, Tech, Urania, William Burroughs Reportage dalla città che è Milano, ma poi è Bangkok, Berlino, New York (Huffington Post, 16-03-14) di Alessandro Schwed Ecco gli automi. Tra due anni in alcuni stati Usa circoleranno autobus guidati da robot, si stanno mettendo a punto le leggi necessarie. Non è un esperimento, ma un'immane impresa da cento miliardi di dollari l'anno. E così arriva in città il processo di automazione industriale iniziato trent'anni fa e che trasformò l'operaio in un simulacro dell'800. I robo-bus non saranno i manichini di fibra con sotto la "pelle" circuiti e lucine accese, i pupazzi del cinema dalla fisionomia umanizzata; ma scatole elettroniche messe da qualche parte. Al posto del conducente ci sarà il vuoto. I robot-bus saranno in grado di procedere nel traffico, frenare, accelerare, bloccare un uomo agitato, cambiare destinazione in caso di emergenza. Sembra fantascienza, si diceva ancora poco fa per indicare qualcosa di impossibile che poi si mostra. Ora si è mostrato e la luce della fantascienza è opaca come una vecchia lampadina. E se da tempo negli appartamenti circolano dischi a rotelle con sensori anti-urto che ingoiano la sporcizia senza essere sospinti da nessuno, non ci vorrà molto perché in casa arrivino anche i robot del cinema, semi-umani con testa e arti: i vecchi maggiordomi in plastica dura, con la telecamera incorporata. Sbrigheranno la cucina, stireranno, faranno quello che non faremo più: lavorare. E' presumibile che prendano il posto novecentesco di baristi, fornai, farmacisti, pompieri, chirurghi, postini e coadiuvatori sessuali. La fantascienza incartapecorisce. Rimane intatta la possibilità dell'incontro con i marziani, ma la loro attesa è una sonnolenta abitudine. Crostacei in un guscio celeste invaderanno e protesteremo perché sono i soliti granchi che parlano. Negli anni '60 la fantascienza era nei libretti Mondadori di Urania, sul banco del giornalaio. Nelle pagine, i razzi scivolavano tra le stelle trainati da vettori dai nomi suggestivi: motori a magnete, a radiante, a propulsione termoionica. I film di fantascienza erano meno potenti. Cartone floscio fino al '68, quando divampò il Kubrik di "2001. Odissea nello spazio". Sullo schermo di un economico cinema di terza visione, vidi la steward della nave spaziale camminare a lievi balzi per un corridoio e capovolgersi nel vuoto gravitazionale per entrare in un altro vano dove il sotto diventava sopra e il pavimento si faceva soffitto. Quel "tangibile" cambio di prospettiva mi fece capire che eravamo al confine di un'epoca nuova. Il cinema prometteva un evo rivoluzionario e una bellezza inaudita. Sarebbero iniziati i viaggi nelle stelle, i robot avrebbero sostituito l'uomo e ci sarebbe stato da divertirsi. Nuovi bucanieri, tesori inauditi, nuovi romanzi, diceva William Burroughs, beat. Trascorsi tredici anni dal 2001 di odissea nello spazio e quarantacinque dalla visione del film, settimane fa mi succede di partire per la megalopoli di Milano. Abito a Montalcino, nella campagna senese, e per raggiungere Milano in treno bisogna andare tortuosamente a Firenze. Alla stazione di Firenze si scende dal regionale e si sale su quel missile. La stazione è alle spalle. Probabilmente siamo partiti. Il sussurro è il motore, il display sulla parete recita "La velocità attuale è di 300 chilometri orari". Lo so, è patetico, ma aia. Sull'autostrada accanto, le macchine sono alle spalle, poi atterro a Milano Rogoredo. Ma se ero a Firenze? Scendo dal mio razzo ed è improprio vedere una stazione e non un anello orbitante da cui si riparte per le galassie. Nell'umida sera terrestre, stupisce che la gente non cammini capovolta come nei corridoi delle astronavi, non galleggi per aria, e vada ancestralmente a piedi. Dovrei andare all'ex Palazzo del Ghiaccio. "Prendi il Passante Ferroviario, è facilissimo" mi ha istruito un amico d'infanzia che ora vive a Milano, addestrandomi all'esistenza di realtà ignote. Mi guardo intorno, il bar-biglietteria è chiuso. Riesco a comprare il biglietto per il Passante solo dopo che un'eroica funzionaria delle ferrovie mi soccorre, decriptando il funzionamento della macchina in touch-screen che vende i ticket per i mezzi di superficie. La funzionaria dice "mezzi di superficie", e intravedo monoliti, guglie di vetro, auto volanti, brevi stati di sonno rigenerante in apposite cuccette. Mi apposto sul marciapiede in attesa del Passante Ferroviario. Ce n'è uno ogni sei minuti. A Montalcino, perché succeda qualcosa bisogna attendere il rintocco del quarticello dal campanile. Tre minuti al Passante: i binari lucidi mi porteranno ancora più in città di quanto non sia città il luogo dove mi trovo - ma la città non ha fine, avvolge la Terra come una coperta di rotaie. E' quella la Città. Milano, Londra, Tokio sono simulacri del tempo antico, ora siamo Uno. Nel futuro dove al presente mi trovo, la linea scintillante dei binari è correlata a una successiva ferrovia correlata ad altre ferrovie successive correlate al mondo intero in mezzo a monitor digitali con la pubblicità e voci afone dagli altoparlanti. Mi attendono i mondi interni di Milano. Il Passante Ferroviario perviene silenzioso nella sera. Non si tratta di salire: il marciapiede è situato al livello dello scompartimento ed è come passare dalla gran stanza della stazione di Rogoredo alle stanze del treno. Parto verso l'arcaico ex palazzo del ghiaccio, fondato all'inizio del '900 da una famiglia di Rom milanesi. Le porte scorrevoli del Passante si aprono e mi incamerano. L'interno è arido e lindo come quello di un cargo spaziale - è ora di cena, non c'è nessuno. Un altro ronzio silenzioso deve essere il motore: come farò ad accorgermi di essere arrivato? Magari siamo ancora fermi all'asteroide di Rogoredo. No, stiamo andando, deduco circospetto, meditando sul fruscio di una galleria. Scivoliamo verso tutti gli altrove della megalopoli. L'interno del Passante non richiama un bus, ma la camera di lancio di un missile e le file dei sedili deserti sono per i passeggeri pronti ad essere catapultati su Milano con un raggio di luce. Un serpentone di parole iridescenti avverte che sono arrivato, un altro display della catena di display che accompagna il mio approdo al golfo di Milano, la megalopoli del sud d'Europa, un tempo nota per le cotolette impanate e ora per il traffico di razzi fruscianti. Le porte si aprono, sono sputato sul velluto del marciapiede. Nessuna illuminazione contraddice la notte. E' semplicissimo arrivare, ha illustrato il mio amico, ma non si vede niente a parte il buio. Mi dico paesanamente che chi lingua ha, a Roma va e qualcuno mi spiegherà come arrivare al Palazzo del Ghiaccio. Ma non c'è nessuno, solo fari di auto. Quasi quasi torno in Toscana - già, ma se poi sbaglio strada e finisco in Polonia? Diseredato della luce dei lampioni, non vedo grande differenza dal luogo dove mi trovavo due minuti fa, quando ho preso il Passante. Nel nuovo tempo al buio della crisi fantascientifica tutto è uguale: la pensilina di Rogoredo, il mercato ortofrutticolo, le arterie stradali, le vie senza la targa, le macchine che sfrecciano. Da qualche parte, forse da una strada, brilla l'insegna miracolosa di una rosticceria. Vado. Mi accoglie nel calore del pollo alla brace e delle parole lombarde della padrona. Ai tavoli apparecchiati, nessuno. Mi chiedo chissà cosa faranno di questi arrosti. "Vada là - sorride - dove vede i finestroni illuminati, e arriva al Palazzo del Ghiaccio". Eh sì, nel futuro di umano ci saranno solamente le donne. Fuoriesco. La notte della megalopoli è uguale alla notte di altre megalopoli, e la notte di Shanghai è uguale a quella di Lione che è uguale a quella di Parigi che è uguale a quella di Milano. Attraverso l'incrocio, transitando indifferente a velocità, chilometraggi e numeri, dato che sono i numeri a fare la differenza, le distanze, i minuti, i fruscii, non le forme dell'agglomerato. Il buio è una minestra densa e l'evidenza del giorno una chimera da cui mi separano dodici lunghe ore. Per terra erbacce, come mai una vita vegetale? Radi individui avventurosi procedono sul marciapiede in giacche a vento di un materiale che non è lana, cotone, non verde di loden, grigio di impermeabile, blu di cappotto. Non angora o cammello - non stoffa, e non sciarpe. Ma zip luccicanti sopra una fibra sintetica il cui nome finirà per ix e comincerà con zeta. Camminano nella notte con il volto aureolato dall'iphone. Vecchio presente, dove sei?
|
|
Post n°96 pubblicato il 06 Marzo 2014 da Jiga0
Un pavone in fuga a Roma tra umorismo e centurioni di Fabrizio Ravelli Giulio Campennì, progettista di interni poco amante della realtà esterna, che scruta con un binocolo, si ritrova a inseguire per le vie di Roma un pavone fuggitivo. Il pennuto gli è stato affidato dalla imperiosa suocera Nelly Terracina, incarnazione del prototipo di madre ebraica autoritaria. E il protagonista, campione di inadeguatezza, scoprirà una Roma sconosciuta, affollata di personaggi fra i quali campeggia il gigante Elvio Spizzichino, di professione figurante centurione per le foto dei turisti. Alessandro Schwed, in anni giovanili autore satirico nella redazione del Male con lo pseudonimo di Jiga Melik, infila con questo La via del pavoneun altro capitolo di una narrazione nel segno dell’umorismo paradossale. Un campo poco frequentato dalla letteratura italiana, che Schwed percorre con felicissima proprietà di toni. Autore, con Lo zio Coso, di un bellissimo romanzo della memoria, e con La scomparsa di Israele di un amaro grottesco storicoumoristico, con questo suo pavone in fuga sceglie la comicità dell’assurdo. Il risultato è parecchio divertente e preciso, qualcosa fra Zavattini e Chagall alla romanesca. (La Repubblica, 2 gennaio 2014)
|
|
Post n°95 pubblicato il 18 Febbraio 2014 da Jiga0
Alla ricerca del pavone di Adam Smulevich (Febbraio 2014, Pagine Ebraiche)) Osservare i piccoli movimenti della realtà, quasi indecifrabili a occhio nudo. Ed elaborarli dal proprio osservatorio giocando con le parole, le situazioni, i personaggi. Questa la molla che ha spinto Alessandro Schwed a una nuova prova letteraria intrisa di humour e sentimento. In La via del pavone, edito da Mondadori, l’autore racconta la storia di un architetto agorafobico in cerca di un pavone – affidatogli dalla terribile suocera Nelly Terracina, detta “la Faraona” – che dalla terrazza del suo appartamento decide (lo sventurato) di prendere il largo e avventurarsi per le strade di Roma. Attorno a questo scalcinato inseguimento urbano, ricco di colpi di scena, prendono forma i tanti mondi e le tante sfumature della Capitale. Un tocco leggero li offre al lettore attingendo a piene mani dal vissuto personale, dagli anni di Jiga Melik e dell’esperienza al Male, straordinario laboratorio di satira che avrebbe segnato un’epoca. Roma, i suoi segreti, le sue contraddizioni: una varietà nella quale ad emergere è – a più riprese e in modo palese – l’imprescindibile componente ebraica che ne anima da sempre la quotidianità. Che si tratti di protagonisti in carne e ossa o di espressioni idiomatiche, il riferimento è infatti costante. E così la terribile Faraona diventa il veicolo ideale per sfatare quello che l’autore ritiene un cliché: la yiddish mame, la mitica e superprotettiva madre ebrea tratteggiata da tanta letteratura di successo, non sarebbe una peculiarità ashkenazita ma, sostiene Schwed, patrimonio di un’umanità più ampia e sfaccettata. L’autore ci scherza su, proiettando la Faraona in una dimensione di tipo imperialista. Soprattutto nei rapporti con lo sventurato cognato, incapace di opporsi in modo adeguato allo strapotere della suocera. “Mamma – scrive l’autore – è arduo associare questa parola, golfo di tenerezza, a Nelly Terracina. Invece è plausibile associare Nelly Terracina a ‘cactus’, ‘tagliola’ e onestamente anche a ‘soda caustica’. Semmai è più naturale associare ‘papà’ a Nelson (il marito di Nelly, da poco scomparso, ndr), generoso e mite. Certo, mai visti due sposi così diversi: Nelly Napoleone Terracina e Nelson Zucchero D’Ancona”. Altro personaggio leggendario è Elvio Spizzichino, figurante centurione davanti al Colosseo e formidabile ambasciatore del linguaggio giudaico-romanesco. Sarà al fianco dell’architetto Campennì in alcuni passaggi chiave della vicenda: tenterà vanamente di recuperare il pavone dal tetto del tram numero 3 (partito da Ostiense e arrestatosi proprio davanti al Colosseo), lo seguirà in una folle rincorsa in moto (con indosso l’abito da centurione, fatto che non passerà inosservato) e involontariamente disturberà la quiete della sonnolenta via delle Pesche (strada immaginaria, ma inserita in un contesto del tutto verosimile). “Spizzichino un personaggio umano e ricco di sensibilità, un puro di cuore. È uno dei personaggi cui sono più affezionato”, spiega Schwed. Anche perché, attraverso la iniziative che adotta ma anche nei dialoghi con Campennì, l’autore sviluppa uno dei temi a lui più cari: il rapporto tra uomini e animali, la simbiosi possibile e anzi inevitabile tra i due mondi. Un incontro che ha il sapore della spiritualità. “Tu – dice Spizzichino all’architetto – potresti esse’ un giusto tra le nazioni, potresti... qui c’è del mistero, c’è. Fai pensare: l’animale non è tuo, e va bene, ciò lo abbiamo capito, ma se dobbiamo aggiustare la situazione è necessario che me lo dichi: a lui ce vuoi bene? Io so che ce lo vuoi, te se legge come la Torà, e allora, abbi pazienza: dichilo!... Ho visto come ce sei rimasto prima, quanno che è scappato. Voi due siete legati”. E All’architetto che oppone una tenua resistenza, conferma: “Voi due, lo sento nell’interiorità dell’interiore, siete legati. Lui te sta a chiede ‘na cosa. Che cosa, Campe’?” Campennì non ha la minima idea di che stia succedendo da qualche ora, ma gli pare che ci sia qualcosa di vero nelle parole del gigante. “Capisci che intendo archite’? Se è così, quello se fa ritrovare, se fa!”. Dodici sono gli anni trascorsi da Schwed, fiorentino, a Roma. Un ricordo che è ancora vivo, specie delle indimenticabili avventure vissute nel rione di Trastevere con quartier generale vicolo del Cedro, una di quelle viuzze – a pochi metri dalla più popolata Santa Maria in Trastevere – dove ancora oggi persistono antiche tradizioni e antiche modalità comunicative tra residenti. Una traccia di quell’esperienza la si trova in tutto il libro. È anzi il filo conduttore di una lettura piacevole dalla prima all’ultima pagina. “Amo Roma – dice Schwed – amo i suoi molti volti, amo le incredibili situazioni che possono generare nei suoi diversi quartieri. Una città a strati, che non può lasciare differenti. Nel libro ho cercato di rendere questo sentimento e allo stesso tempo la complessità di un mondo che vale la pena di esplorare partendo dai segnali superficialmente meno visibili”.
|
|
Post n°94 pubblicato il 16 Febbraio 2014 da Jiga0
Il viaggio di più scritture di Angelo Pasquini Cominciamo parlando di umorismo. Perché è stato l’umorismo che ha legato Sandro e me per parecchi anni. Un’epoca un po’ lontana, parliamo del decennio tra la fine degli anni Settanta e la fine degli anni Ottanta. A quei tempi, per me, per la mia famiglia, per i nostri amici, Sandro era solo ed esclusivamente Jiga Melik, lo pseudonimo con il quale firmava i suoi pezzi sul “Male”. L’umorismo ci legava nel lavoro –scrivevamo spesso insieme per il “Male”, dividevamo la stessa stanza in redazione, formavamo una di quelle strane coppie di scrittori umoristici appunto, che si incontravano e si incontrano spesso nella commedia cinematografica, nel varietà, nella satira. In certi casi acuti, e il nostro lo era, succede che l’affinità umoristica finisca per creare un legame più forte, esclusivo e settario di quello che deriva dal militare nello stesso partito o dal partecipare della stessa confessione religiosa. Una battuta ben riuscita, una battuta “perfetta”, aveva per noi il valore che può avere l’illuminazione per un filosofo o la scoperta per uno scienziato. Avevamo talmente alzato l’asticella nei parametri di valutazione di ciò che poteva essere definito davvero “umoristico”, che poco si salvava, oltre a quello che facevamo noi sul “Male”, nel panorama della comicità e della satira di quel tempo. Erano anni di estremismo, e il nostro era umorismo estremo. 1. Questa premessa serve a chiarire che quando leggo un nuovo romanzo, un racconto o un articolo di Sandro Schwed mi sento in un territorio familiare. Riconosco gli stilemi del suo umorismo e mi compiaccio di poter intraprendere un nuovo viaggio in un paesaggio apprezzabile fino in fondo solo se si è forniti di lenti speciali, una sorta di visione piacevolmente allucinatoria, come quella che si ottiene con gli occhiali assistendo ai film in 3 D. “La satira –diceva pressappoco William Thackeray- è lo sviluppo coerente di un assunto assurdo.” Quando la satira è efficace, il paradosso diventa credibile, il falso s’invera. L’assunto più o meno assurdo della storia che si racconta in questo romanzo è la fuga di un pavone dalla terrazza di un attico di un condominio romano. Da qui inizia il viaggio del protagonista e dei lettori in una Roma contemporanea, nella quale però a tratti si intravedono barlumi di un’epoca molto cara all’autore, quella degli ultimi decenni del secolo scorso. Su Roma, sui romani, e sul romanesco, inteso come lingua gergale parlata da molti personaggi del libro, con sfumature differenziate e colorite con molta grazia e acume, vorrei soffermarmi perché si tratta non del fondale della storia, ma di una specie di super-personaggio collettivo, un Idra con migliaia di teste, che spuntano da ogni anfratto per partecipare all’epopea della fuga del pavone, e del suo inseguimento da parte dell’imprevidente affidatario, l’architetto Giulio Campenni, fiorentino come Sandro Schwed. Non è un caso che il carattere romano, l’ironia tagliente, la maschera cinica e beffarda, l’umorismo sardonico o bilioso, siano stati compresi e rappresentati con grande efficacia da scrittori non romani. Vengono in mente naturalmente i grandi del Novecento: Gadda e Pasolini. Ma anche gli autori del cinema e della commedia in particolare, convenuti a Roma nel dopoguerra da tutta Italia: Flaiano abruzzese, Sonego veneto, Risi lombardo, Monicelli toscano. Quella Roma -palcoscenico o set cinematografico permanente, abitato da due milioni e passa di caratteristi e di comparse, veri professionisti della gag e della battuta- l’ho ritrovata con grande piacere in questo libro. Anche Sandro Schwed ha sciacquato con successo i panni nel Tevere. Creando una sua galleria di personaggi, come il gigantesco ebreo romano Elvio Spizzichino, di mestiere centurione al Colosseo. Il rimpianto è che a volte Roma non sembri più così, ma che attualmente stia passando, come succede ogni tanto a tutti noi, un periodo intermittente di cattivo umore. 2. Oltre che all’ispirazione comica che nasce da Roma e dai romani mi sembra che questo libro sia debitore anche a un altro aspetto importante della formazione umoristica di Sandro, quella pertinente alla cultura e all’ambiente ebraico. Nella “Via del pavone” campeggia la figura di Nelly Terracina, detta “Napoleone”, figura che il protagonista fatica ad associare alla parola “mamma” (è la mamma di sua moglie), ma che piuttosto, secondo l’autore, “è plausibile associare a “cactus”, “Tagliola” e onestamente anche a “Soda caustica”. Un personaggio che sparisce di scena quasi subito, in viaggio con la figlia verso una meta di vacanza, ma che, come legittima proprietaria del pavone scomparso, incombe sul resto del romanzo come una spada di Damocle, ossessionandone il protagonista. Questa minacciosa e divertentissima super-matriarca ricorda la mamma tirannica del lunatico Woody Allen che, in un episodio del film collettivo “New York Stories”, ricompare dopo la morte come fantasma nel cielo di Manhattan, continuando a tiranneggiare il figlio con i suoi consigli non richiesti. 3. Maternità avvolgente, paternità sfuggente. Nel mondo de “la via del pavone” le proprietà, il denaro e il potere si tramandano di madre in figlia. Gli uomini, esclusi da questo cerchio magico, sono sfuggenti, o letteralmente in fuga. Sradicati, deterritorializzati, prolificano ma sfuggono alla paternità. Uno addirittura riparato da decenni in India, per scelta esistenziale, il padre del protagonista; quest’ultimo invece vive a Roma, dopo aver lasciato un figlio a Firenze, nato da una relazione giovanile e cresciuto senza di lui. L’apparizione di questo personaggio è la sorpresa dell’ultima parte del romanzo. All’inizio della storia c’è infatti una telefonata misteriosa, qualcuno con cui Giulio parla sottovoce, per non farsi sentire da moglie e suocera, e che chiama affettuosamente “amore”. Il lettore smaliziato pensa subito a un’amante segreta da incontrare nella più completa libertà, come da copione, quando la moglie è in vacanza. E invece ecco comparire il figlio di Giulio, Riccardo, ormai giovanotto. Un figlio tenuto segreto alla suocera, per non esserne ripudiato e soprattutto per non perdere i benefici economici che spettano alla moglie, e di conseguenza anche a lui. Oltre che un calcolo meschino, un rifiuto di crescere, il crogiolarsi fuori tempo massimo in una beata irresponsabilità, che forse è la chiave del protagonista, e che l’umorismo dell’autore giudica con un sorriso. Ma non preoccupiamoci, dopo una giornata passata alla ricerca del pavone, si riscatterà anche lui. 4. Già, ma il pavone? Il pavone svolazza più che volare per la città e si sottrae a ogni tentativo di cattura. Mi piace pensare che sia ancora in giro tra noi e che, nel suo esibizionismo, faccia la ruota a sorpresa a beneficio di qualche perfetto sconosciuto. Come un vero romano il pavone è vanitoso, menefreghista e amante della libertà. Ho scoperto su wikipedia che è originario dell’India e che è stato importato, manco a dirlo dai romani, che lo mangiavano volentieri, e, senza preoccuparsi della contraddizione, lo ritenevano divino e immortale.
|
|
Post n°93 pubblicato il 28 Gennaio 2014 da Jiga0
Quanto dovevo piangere l'ho pianto. Ma poi non c'è banca, amico, discorso, libro, film, cerimonia che possa restituire zii, cugini, la nonna, un padre finalmente normale. Poi foto ingiallite. Chi era Shlomo, e Sandor e Marghit, la cugina Judith è quella bambina bionda?Si capisce o no, che la tragedia è non sentire niente perché non c'è niente da poter ricordare con certezza? Ma colline di scarpe, portafogli, i disegni dei bambini, forbicine per le unghie, persino gambe di legno. Cosa posso sentire, più di quello che ho sentito i giorni dell'infanzia e della giovinezza alla tavola della Pasqua ebraica, quando alla fine della cena irrompeva il racconto della fuga, e non era dall'Egitto? Fughe di notte, soldati nazisti, hail Hitler, juden, scappa babbino. Mio padre e mio fratello sono in fuga nella notte. Mio fratello ha sette anni, è in mezzo a un bosco invernale dell'Appennino, i carri armati tedeschi sferragliano. Padre e figlio attendono in silenzio sotto le braccia degli alberi, la neve gronda sulle loro teste. Basta: non voglio più sentire male, l'istinto comanda di non ricordare i racconti che ho sentito, e di stare bene. Ho un figlio giovane, devo andarci piano a ricordare tutto. Del resto nessuno può testimoniare di cosa accadesse alle persone nude in fila verso le docce. Con testardaggine, ho cercato di fare compagnia ai morti, noti e ignoti, e spesso ho vissuto tra ombre. Da bambino, quando la sera andavo a dormire, correvo nel corridoio per evitare che mi sfiorassero le mani dei Vecchi. Le mani dei Vecchi uscivano dai muri per ghermirmi e trascinarmi nel loro inferno - penso che fosse la traduzione di quello che nessuno mi aveva detto e però sentivo. Non voglio essere invaso dalla Cosa. E' tossica. Ieri pensavo: domani non sentirò niente, né dentro né fuori. Non guarderò mai più la Tv con i ministri e i sindaci che dicono mai più. Io vi scrivo ora, cari amici di Fb, che per un attimo sento il collegamento col vuoto dietro il filo spinato e con le costole secche dei pigiami a righe. Non voglio che anche questo 27 gennaio la mala erba infesti il miocardio, vorrei tenere il mio cuore come un giardino. Desidererei che tutto si sapesse, ma quando ognuno se la sente, questo è il mondo che vorrei. Vorrei che la memoria germogliasse alla sua ora, e che si sapesse quello che continua a succedere tra le generazioni ebraiche, il gas che circola nelle vene dei sogni. Vorrei che sapessero tutto specialmente i ragazzi che hanno meravigliose spalle e possono sopportare la soma di Auschwitz. Vorrei che proprio si provasse inutilmente a capire, che si insistesse, che si battesse la testa nel ricordo del filo spinato e ci si rendesse conto che è inutile, non serve ricordare, ma che l'inutilità è un concime utile. Vorrei che si sentisse in modo disordinato, non il 27 gennaio, ma anche una volta sola, un giorno della vostra vita, cosa è stato fatto a un intero popolo per secoli per culminare nella vita tra le baracche dove ebbe fine la condizione ebraica con dentro quella di tutta l'umanità. Fu lì che il mondo cominciò a finire. Sì, vorrei che ci fosse questa buona educazione: intrecciare Storia e sensibilità - ma già vedo che questa educazione buona non c'è. In molti luoghi il 27 di gennaio si ricorda qualche altra infamia della Storia, stragi, torture, fame, miseria, anche la piaga della calvizie. Pochi anni e già c'è ansia di cambiare il menù che pure era stato fissato: il 27 gennaio ricordare la Shoah. Badate bene, il punto è che se si vuole dare un valore universale alla Shoah, bisogna rispettare la verità, non relativizzarla. Ci vuole equilibrio. Bisognerebbe fare così: entrare nel particolare, lasciare che la macchina fotografica ingrandisca la persona ebraica, la ingrandisca, la ingrandisca, e sparirebbe l'infamia della fascia gialla, e avvicinandoci agli occhi, al sorriso, il sorriso e gli occhi si sgranerebbero e rimarrebbero i pori della pelle, chissà se di un uomo o di una donna o di un bambino che potrebbe essere cinese, russo, polacco, perché in una persona ci sono tutte le persone. E d'altra parte, bisognerà convenire apertamente che la Shoah non è stata una bomba al gas nervino, una strage, una tortura ad Abu Graib, repressione violenta, l'equivalente del bombardamento di Dresda; ma un progetto per attuare lo sterminio dell'animo umano (fu scelto quello ebraico perché questo veniva dalla tradizione religiosa e popolare). In seguito il corpo ebraico, nutrito di bucce di patata, di ciuffi d'erba, fu ridotto a un sacco, un involucro destinato a divenire cenere e passare da un camino, distruggendo le prove della vita e della morte, come se voi non foste mai esistiti, né la vostra famiglia, la vostra città, i vostri ricordi, la vostra musica, le vostre barzellette, i vostri romanzi, la vostra squadra di calcio, il vostro mestiere, il vostro tailleur, il vostro comunismo, la vostra giacca, la vostra cravatta preferita, i vostri pensieri. Come se niente fosse esistito - neanche voi. Dalla mia Montalcino, alzo il calice e brindo alla nostra vita insieme in tutto il mondo.
|
|
Post n°92 pubblicato il 17 Dicembre 2013 da Jiga0
Tag: beccare, dieci euro, divertimento, libellule, racconto breve, romanzi, romanzo, superficie, urlo, volare Le squisitezze dell'appena uscito “La via del pavone, alla disperata ricerca di un pennuto a Roma” A parte tutto, devo rivolgermi i più sentiti ringraziamenti per avere scritto “La via del pavone”. A tali ringraziamenti unisco poi le mie più umili auto-congratulazioni per l’allegria insita nel romanzo. Chissà quando mi tornerà un’allegria simile, approfittatene subito e compratelo. Quello del pavone è un romanzo che vola come nessunaltro romanzo, anche . perché il pavone si libra nell’aria, in definitiva è un uccello e grosso modo vola. Ma c’è un’importante considerazione da aggiungere: ora che il romanzo è stato scritto, sarebbe bene che fosse letto. Come fare perché questo fatto che tutti leggono il mio romanzo si verifichi? Vorrei raggiungere lo stadio di nitidezza interiore dell’inizio, quando vendetti il romanzo alla casa editrice e poi capii che esisteva pagando il telefono, la luce e quasi tutto il gas (per pagare tutto il gas sarebbe stata necessaria una saga). Il mio romanzo è bello e allegro, esiste e voi non lo sapete. E’ appunto in questo che consiste il problema di vendere un libro: i lettori non comprano ogni volume che esce, devono avere un motivo valido per comprarne uno. Come incoraggiamento iniziale a voi lettori, vorrei dire che quando lo scrittore è in forma, comprare un’opera a soli 10 euro è facile. Ma questo potrebbe non essere un incoraggiamento sufficiente: con dieci euro si possono comprare dieci chili di patate che in certi casi sono meglio di un romanzo. Per indurre i lettori all’acquisto servono recensioni, presentazioni nelle librerie, esegesi, columnist che si battono per voi. Ora, a prescindere dai tour nelle librerie, non è mica semplice convogliare l’attenzione di un critico capace su un romanzo, anche se il romanzo fa sorridere, ridere e commuove. Per critico non intendo le persone che hanno un blog e credono che leggere un libro e scriverne sia come ingoiare un gelato. Per parlare de “La via del pavone” servirebbe una persona che sappia cosa sia un romanzo, conosca il problema dello stile, della struttura, dei dialoghi, sappia rintracciare una metafora. Qualcuno che non sia il solito guardone mediatico, uno che fa stalking con quei disgraziati degli scrittori: un esibizionista che apre il cappotto nel parco del web e mostra la propria critica. Serve qualcuno che mastichi ogni giorno il pasto della narrativa. Per parlare de “La via del Pavone” ci vorrebbe uno scrittore, e io dove lo trovo uno scrittore? Un momento: ma io sono uno scrittore. Che stupido a non averci pensato. Se ho scritto “Non mi parte il romanzo, saranno le candele”, “Lo zio coso”, “La scomparsa di Israele”, “Mio figlio mi ha aggiunto su Facebook” e ora “La via del pavone” è perché sono uno scrittore. Dunque, chi meglio di me è in grado di sapere veramente cosa si celi sotto la superficie di un romanzo che poi ho scritto io, cosa esista oltre le increspature gioiose dell’umorismo e il tormento della macchina della realtà, che è sempre rotta e nessuno l’aggiusta. Ma sì, ve ne parlo io. La via del pavone è un romanzo sull’uscita da quella sordità che non permette di sentire ilrespiro lieve degli altri. “La via del pavone” è poi il codice segreto dei fatti, il cifrario della società segreta degli animali, della natura e di molti fenomeni invisibili. La via del pavone è un racconto sulla liberazione dalla solitudine, sul pieno ricongiungimento con la parte più positiva di sé e degli altri. Leggendolo si scopre che in strada passa della piccola gente magnifica, magari dei piccoli giganti, che se ti trovi in difficoltà, si fermano e ti danno una mano. Anche ridendo. Ora, il fatto che io stia parlando bene del mio romanzo dato che è mio, è una volgarità. Qui non si tratta del soddisfacimento del mio ego, anche se il fatto che “La via del pavone” é stato scritto da me e non da un altro, in qualche modo potrebbe influenzare il mio giudizio su un’opera estremamente ben scritta come la mia. Il motivo per cui consiglio il Pavone spericolatamente, è il tema dirompente: sotto le specie di un pavone, la realtà va a visitare un misantropo. Succede dunque che un pavone arrivi a un tratto dentro la bella casa di un architetto di interni, Giulio Campennì. Il pavone giunge al guinzaglio della suocera che gli lascia il volatile in custodia perché deve andare in vacanza con la figlia, la moglie affettuosa di Giulio. E chi può custodire il pavone meglio del genero che quest’estate non ha niente da fare, solo lavorare ed essere grato di vivere nel bellissimo attico romano con vista sulla Piramide e sulla Cristoforo Colombo che lei ha dato alla figlia e a lui, anche se per la verità fu merito del suo povero marito? Più che altro, l’arrivo del pavone a casa dell’architetto di interni Giulio Campennì, un misantropo in titanio e solipsismo, non è una casualità, ma una visitazione quasi sacra. Arriva il pavone al guinzaglio e nell’andito di casa succede che i due principali schiavi della suocera l’umano e il pennuto (il marito è fuggito con la scusa di morire) si guardino negli occhi e niente è più come prima. Poco dopo il pavone salta sul davanzale e fugge dalla finestra, dalla schiavitù della suocera, dalla costrizione dei recinti e dei guinzagli, anche se poi vorrebbe giocare con l’architetto Campennì, magari farlo volare sui tetti. Comunque sia, il pavone fugge e fa fuggire dalla schiavitù. Un altro punto rilevante è questo pennuto proverbialmente meraviglioso che allo stesso tempo è dotato di un canto sgraziato. Come mai accade un fatto così paradossale, che una tale mitologica bellezza sia così sgraziata? E’ come se i doni più belli ricevuti dalla realtà fossero stati rovinati. Il problema è chi mai abbia rovinato il pavone e assieme al pavone anche noi. A ben guardare, il volatile alla disperata ricerca del quale si getta l’architetto Campennì è un liberatore particolare, un Mosè che fa la ruota e ha il becco, che detta leggi eccentriche e francamente è dispettoso. Salta dal davanzale della finestra, sopra il tetto di un tram e si fa inseguire, trascinando il protagonista alla scoperta del mondo che è molto cambiato ma fino a un certo punto. E così, il Pavone, questo curioso protagonista che non parla ma grida, forse pensa ed entra nei nostri sogni notturni, ci spinge fuori dalla solitudine invisibile in cui viviamo e, particolare non da poco, svela l’esistenza di una lingua che appare segreta ma che forse conoscevamo. Come quando nei sogni a un tratto ci troviamo a volare, vediamo che è così semplice, e ci diciamo euforici: “Ma guarda come è facile volare, se lo avessi saputo prima, sai da quanto avrei iniziato a farlo”. E viene fatto di pensare a quanto tempo abbiamo perso a non fare quello per cui siamo nati. C’è dunque questo ancor giovane architetto di interni, un quarantenne che rischia di essere vecchio anzitempo, soffocato da giudizi sul mondo che sono pregiudizi, incarognimenti dai quali non è esente neanche il pavone, che quando l’architetto va a trovare i suoceri, si offende della sua indifferenza e lo becca negli stinchi. Un romanzo di rancori da sbollire e di tenerezza da scoprire. Quando la storia inizia, Campennì ce l’ha con tutta la città esterna. L’esterno urbano gli ripugna. Lo odia e lo incattivisce. L’architetto al mattino si alza e dal terrazzo guarda il mondo col binocolo. Come se fosse su un sommergibile volante, emerge nell’oceano della realtà e osserva da lontano i flussi del traffico verso i Mercati Generali. Ad avere sigillato Campennì in sé stesso, seppellendolo nella venerazione dell’architettura di ìnterni, sono state inconfessate costrizioni, convenzioni, convenienze, e poi segreti. Un segreto personale di cui occhio e croce lui non parla con nessuno. E abbiamo scritto occhio e croce perché l’economia della storia, il parametro del romanzo breve, in pratica un racconto lungo, ci fa intravedere più che vedere il profilo del suo dramma. “La via del pavone” è un racconto intravisto da un tram stipato, dalle convulsioni del traffico, dal bordo di un marciapiede, da una cabina telefonica in disuso, da dentro il flusso della realtà. Il romanzo è un dramma vissuto assurdamente nel realismo dell’assurdo, perché le condizioni di vita sono realisticamente assurde e invece abbiamo la pretesa di viverle come normali - mentre non lo sono. Ed è questo romanzo lievemente comico e lievemente tragico a svelarcelo. Il dramma di Giulio Campennì è qualcosa con cui Campennì viene in contatto impalpabilmente, progressivamente, e saldamente (a proposito, il protagonista de “La via del Pavone” si chiama Giulio Campennì e non Aureliano D’Ancona come annota ancora la celeberrima catena di librerie, lasciandolo girare per internet con due cognomi diversi e due storie identiche: come se un giorno uno di voi scoprisse che c’è uno perfettamente uguale a voi solo che si chiama in un altro modo). Viviamo in una bolla di sordità che copre il suono delle ore ed è costituita da abitudini imprescindibili, le nostre droghe. E non è semplice liberarsi dalla droga, è complicatissimo vedere che siamo drogati e che dovremmo farne a meno. Per farlo servirebbe un atto comico di riparazione, uno sberleffo di dolcezza. Lo saprò, l’ho scritto io.
Alessandro Schwed - “La via del pavone, alla disperata ricerca di un pennuto a Roma” - Mondadori, le libellule - e. 10
|
|
Post n°91 pubblicato il 07 Dicembre 2013 da Jiga0
Antropofagi al collinarea / Il teatro di Schwed e Kaemmerle Recensione di "Insalata con dita" Ve la ricordate quella canzone dei Baustelle dove la voce di Bianconi scandiva: «Amiamo l’Uomo e il suo sapore / I signori e le signore / Il loro eterno roteare/ Come agnello nel kebab»? Ecco, se parliamo dell’ultima brillante pièce nata dalla penna molto caustica di Alessandro Schwed, alias Jiga Melik di Il male e L’eco della carogna, il testo di Antropophagus c’entra tantissimo. In uno spazio per noi completamente sconosciuto, una sorta di Getsemani privato vicino alla chiesetta della piccola frazione di Camugliano, in un’atmosfera bucolica quasi da rappresentazione sacra, abbiamo assistito a uno degli spettacoli più dissacranti in rassegna. Ma il Collinarea è anche questo: scompaginare le aspettative. Insalata con-dita è portata sulla scena da Andrea Kaemmerle (attualmente in forza al Guascone Teatro), unico attore e regista dell’opera. Non sarà inutile anticiparvi sin d’ora che Schwed ha scritto quest’opera pensando proprio alla presenza scenica e alla verve comica di Kaemmerle.
Il risultato è che il tipico umorismo ebraico a cui ci aveva abituato Jiga Melik – spesso ai limiti del cinico – viene “addolcito” da Kaemmerle, che dialoga ampiamente con il pubblico, improvvisa, ricorre a espressioni del vernacolo fiorentino. A farne le spese è il fotografo Vincenzo, fotografo in prima fila, oggetto degli strali di Kaemmerle dall’inizio alla fine. All’inizio dello spettacolo siamo pochi e le zanzare ci divorano; siamo così pochi che Kaemmerle – appena entrato in scena – ci chiama “dodici apostoli con sessanta macchine fotografiche”. Dice che ci ha scelto dopo mesi e mesi di selezioni. Tutto è all’insegna dell’informalità, il pubblico risponde senza timori alle punzecchiature di Kaemmerle. Secondo le intenzioni iniziali del protagonista ci dovrebbe essere una confessione “za za”, diretta, «così ci si leva subito di culo». E invece una serie di fluide digressioni, parentesi su parentesi, scuse non richieste, travestimenti malriusciti, che fanno prender tempo prima dell’outing, un piccolo difettuccio che potrebbe risultare sconvolgente dal punto di vista morale. n questa “macchina della giustificazione” l’inglese è un meccanismo fantastico, perché la parola “outing” in sé allenta la presa drammatica che potrebbe avere la confessione. Un po’ come accade per il “bird-watching”, per il “trekking” e tante altre attività che risultano essere più distinte nella dizione inglese. Provateci voi ad andare in un negozio e dire al commesso: «Scusi, io guardo gli uccelli, che abbigliamento mi consiglia?».
Ma il vero grande motore nella macchina della giustificazione è “la ricerca della felicità”. Ebbene, tutti abbiamo diritto a essere felici, e ognuno può esserlo nel modo e nei tempi che gli sono più opportuni. La pièce di Jiga Melik è molto drastica nei confronti dei quarantenni infelici che si aggirano nella società. Insomma per essere felici si può portare un cane a cacare tutte le sere, oppure decidere di sottrarre una fetta di culo a un cadavere all’obitorio. Ed è questa la scelta del protagonista, concedersi quattro o cinque volte all’anno un po’ di sana antropofagia. Insomma, che male c’è? Tanto i cadaveri se li mangerebbero comunque i vermi. A questo punto, come recita Kaemmerle, non sarebbe meglio mangiarli noi, con il vino giusto e il pane giusto? Le risate sono tante, Kaemmerle è fantastico nella scelta dei tempi comici, ma il ragionamento che lo conduce dalla divagazione all’outing è serratissimo. Anche il tabù più tabù, attraverso un tritacarne di scuse, giustificazioni, argomentazioni, può essere infranto. Lo sanno bene gli ebrei, che conobbero Adolf Eichmann – gerarca nazista accusato di genocidio –, il quale si discolpò con la semplice scusa del dovere burocratico, che solo accidentalmente corrispondeva ad un crimine. “Non c’è niente di male”. E invece il male c’è, perché l’antropofagia di cui parla lo spettacolo non è il cannibalismo che si pratica ritualmente presso tribù selvagge, ma è la scelta quotidiana di mangiarci e lasciarci mangiare dagli altri. “Che male c’è?”, e intanto mandi all’aria un matrimonio per inseguire la carriera. “Ma non c’è niente di male”, e intanto ti lasci sfruttare con contratti a provvigione che ti divorano anima e coscienza. Cannibalismo come lotta sociale, come guerra tra poveri. Facciamo le peggiori azioni e le motiviamo sotto il nome di “ricerca della felicità”. Credere di poter mangiare la coscia dell’amica qui vicino non è assurdo. È normale. È giustificabile. È ciò che siamo diventati. È ciò che ci hanno fatti diventare. Ed esser diventati vegani non ci assolve da tutto questo. Dal punto di vista del sottotesto le potenzialità di Insalata con-dita sono veramente tante. Non abbiamo fatto l’errore di scambiare l’ironia per facile cabaret. No. Perché abbiamo riso tanto, ma abbiamo riso con molte note d’amaro. La degustazione finale con carne bollita (buonissima) e vino ci ha permesso una vicinanza imprevista con Kaemmerle e con il resto del pubblico. Forse per una sera abbiamo mangiato qualcosa che non fosse il fegato d’un collega. Giuseppe F. Pagano
|
|
Post n°89 pubblicato il 05 Novembre 2013 da Jiga0
Dove sono andati e dove non sono andati Alvin Lee e suo fratello Lou Reed (Blog Nuovi Argomenti, novembre 2013) Lou Reed. Qualche mese fa Alvin Lee. Lou, una star perenne; Alvin una delle due chitarre di Woodstock, l’altra si sa, era Hendrix. Con i Ten Years After, Alvin Lee suonò a Woodstock le folate di quel suo prodigioso e dimenticato rock’roll, I’m goin home. Fraseggi rapidissimi, sporchi e ritmati. La voce nasale scandiva: “I’m goin’ home, goin’ home baby, oh goin’ home baby, I’m comin’ and get ya”. Vengo a casa piccola, oh vengo a casa piccola, ti vengo a prendere…”. Si girava, guardava i Ten Years After e ringhiava: one more time, un’altra volta, un altro giro di rock’n’roll ragazzi. Manciate di riff. “Goin’ home now, see my babe…”, i cuori dei settecentomila strizzati dal groove. Erano le 15 di un lunedì di marzo del ’70, quando entrai al cinema Ariston di Firenze, il primo giorno di programmazione di Woodstock, tre giorni di pace, amore e musica. In sala non c’era nessuno a parte il Liscio, uno glabro coi capelli lunghissimi, un gilet, il busto nudo anche d’inverno. Ci vedevamo ai concerti dello Space Electronic, un ex autofficina trasformata in locale per concerti rock, sotto a un paracadute spalancato che copriva il soffitto. Uscii dal cinema all’una di notte. Nove ore per rivedere Alvin che sfrecciava sul rock’n’ roll e Hendrix che suonava l’inno americano, mimando le bombe sul Vietnam. Lou e Alvin sono pezzi di vita che la morte smonta, ragiono mentre faccio la spesa e chiedo quant’è con la faccia mogia – è la mestizia che non molla la presa. Lou e Alvin erano due familiari. Due miei gemelli diversi da me e tra loro. Gemelli fra decine di milioni di gemelli diversi, resi uguali dal rock. Chi suonava e chi ascoltava. Per la verità uno dei due, Lou, lo conosco molto meno di Alvin, il mondo invece conosce molto meno Alvin di Lou. Il fatto è che il rock-blues di quegli anni, hard blues lo chiamavano gli inglesi, è evaporato, e ora, incomprensibilmente, nessuno sa che ci fu quella chitarra rossa velocissima. E d’altra parte, se di Lou Reed ne sapete più voi, c’è il fatto balordo che sono molto triste anche per Lou che conoscevo solamente per Vicious, Take a walk on the wild side, Perfect day. Con Lou ci vedevamo in giro, sì; gli ho sorriso, sì; l’ho canticchiato – ma niente di più del fatto che mi piaceva il modo facile della sua voce che sembra ti dica: senti, facciamo due chiacchiere, e poi ti sputa in faccia una poesia. Mi dispiace Lou, che ci siamo sorrisi da lontano, ma vivevo dall’altra parte del parco, nella zona rock-blues con Alvin, Eric, Jimi Hendrix, Page e Rory Gallagher. Come mai mi dispiaccia tanto per Lou che non conoscevo a fondo, è un mistero, ma è un mistero anche che ci conoscessimo poco e ci capissimo al volo. Di sicuro mi dispiace che il palco del rock stia diventando vuoto. Intendiamoci, il tempo galoppa. Ero quasi bambino quando durante gli assolo di Jimi Hendrix saltellavo nel salotto di casa e guardandomi allo specchio del buffet mimavo di suonare la chitarra con la scopa della mamma. “Poveruomo” diceva mio padre ascoltando Hendrix con le mani prudentemente piantate sui braccioli della poltrona, “come deve soffrire”. Il rock è stata un’immensa benedizione scesa sulla mia vita. Per l’esattezza, avevo quindici anni quando a un tratto, tutto insieme, scoprii che esisteva quel ben di Dio. Era sabato pomeriggio e misi sul piatto Wheels of fire dei Cream, lp dal vivo del ‘67. A un certo punto venne “Spoonfull”, lunga, solenne, densa. Al graffio. Pensai testualmente: “Esisteva tutto questo, e io non lo sapevo”. Il rock-blues rispondeva a ogni mia domanda. Era la pienezza che non esisteva nei Troggs e nei Rolling Stones. Ascoltare i Cream, Alvin Lee, Hendrix era come andare a un concerto di musica per bombardieri. E come è possibile che questo finisca, che ci si debba addirittura separare? Certo il lutto per la morte degli artisti è naturale. Chitarristi, scrittori, pittori, con alcuni di loro ho vissuto come se li avessi conosciuti – perché li avevo conosciuti. E sono stato in lutto anche per artisti morti molto prima che nascessi. A vent’anni tenevo sul muro una foto della poetessa Marina Cvetaeva, e davanti alla foto una candela. Era morta dieci anni prima che nascessi. Leggevogiovinezza, mia rondinella, mia rossa scarpina spaiata, va dagli altri e pensavo ai suoi giorni in ginocchio a lavare i pavimenti di Parigi, alla sua morte ignota, e che non fosse raggiungibile. Rileggevo il Revisore per sentire la voce di Gogol, ed ero triste perché il mio amico Nicolaj, che noia, se n’era andato anche lui. Così per Pavese, Shabtai, Henry Roth di Chiamalo sonno. E l’altro ieri rileggo Marcovaldo e dalla gioia passo allo sconforto perché è venuta la morte e si è ingoiata Calvino. Questo succede con gli artisti: che si stabilisca una vera e dolorosamente ingannevole consanguineità. Tutti gli artisti, di un tempo e di adesso, scardinano la porta del presente, si installano qui da noi ed offrono affinità, fedeltà, gettano luce. Godiamone. Non è vero che sono morti tra i vivi, ma vivi tra i morti. E io alzo il calice ad Alvin e a Lou: One more time. Non era moda – era fuoco. Ancora si appicca.
|
|
Post n°87 pubblicato il 04 Ottobre 2013 da Jiga0
Rapine sulla play Si è detto tante volte che il cinema sta per essere superato dalla Playstation. Ora esce un colossale gioco che è riduttivo non riconoscere come un nuovo tipo di film di animazione, un’avventura dove siamo presenti anche noi, eccome. Firmato da Rockstar Games, è poco dire che arriva, dunque scoppia Gran Theft Auto 5 (Gran rapine in auto). Sono tre i protagonisti, agiti dal quarto che siete voi. Per decine e decine di ore, interpretate: un cinquantenne ancora segretamente in forza all’Fbi (qui si chiama Fib) e dedito alle rapine, un giovane criminale di colore che rivestite facendolo diventare un elegantone, e un freak fuori di testa, eccessivo, pazzamente brutale e assassino, il comico della situazione. Fosse per l’azione dionisiacamente spettacolare, sarebbe un altro colossale action movie del dopo Matrix, con sparatorie, proiettili-grandinata-di-morte e la scia dei bossoli che solcano l’aria. I corpi zampillano come in Tarantino, ormai implicitamente un classico come Dante. E’ l’avventura, ante e post Tarantinum natum. Gli inseguimenti inanellano la megalopoli di Los Angeles che qui si chiama Los Santos, con corse madornali tra highways a sei corsie, scorci urbani, semafori rossi e violati, viadotti, supermercati, fabbriche, hangar, strip club e grattacieli. Più America di così, si muore, e infatti la morte abbonda anche se con gli sberleffi del gioco. Alle calcagna degli inseguiti che sono anche inseguitori, le sirene della polizia, gli spari di mafia, esercito, adescamenti di prostitute, i tossici agli angoli, l’aviazione coi missili intelligenti, i politici che incassano mazzette, e tamponamenti in fila come ciliegie, uno tira l’altro. Le macchine rubate senza sosta sbarbano i guardrail e balzano su improvvisi fondi terrosi, collinari, lunari, tra rotaie della metro e le profondità dell’oceano, finendo in un batiscafo rubato per poi rubare duecento milioni di dollari. Si cappotta in condotti fognari, fiumiciattoli, paludi, e stupisce che nessuno gridi yipyahee-yipyahoo e agiti il lazo come a un rodeo. L’avventura è un cavallo selvaggio, i camion si ribaltano e si ribaltano le auto sui camion. Da un elicottero sfugge al suolo il cassone con il gas nervino che dovrebbe essere posizionato, poi ci si riesce e non è la fine della California. Ma esplosioni a catena, sparatorie con pezzi deviati dell’Fbi e centinaia di malviventi e poliziotti ammazzati come per una guerra civile non ufficiale, durante la quale la gente va al bar, a lavorare, fa sesso e i taxi arrivano in un attimo anche sopra una mulattiera. C’è una sorta di fondo morale: mentre sono inseguiti o corrono o sparano, i protagonisti criminali parlano e viene fuori che vendicano l’ingiustizia subita dall’America. Appunto, Tarantino docet: è uno splatter eccessivo per essere degno di turbamento: il sangue che esce dai corpi si posiziona immobile su giacche e camice, come se fosse unto. Basta entrare in un bar, prendere un caffèino e si torna sani. Se il vostro protagonista muore, molto meglio: nella Playstation morire conviene: c’è tutta la nuova vita da spendere! Si resetta dall’ultimo punto utile, ammaestrati dall’errore commesso (ad esempio, essere inconsapevoli di un’imboscata) e il successo arriva: riescono le rapine in banca, il furto in una grande gioielleria con il gas soporifero immesso nei condotti d’aerazione, l’omicidio tramite cecchino dalla gru di un cantiere, la pistola con silenziatore fredda il capo di una gang mentre entra nella suite del suo albergo tra le guardie del corpo. Stranisce continuamente che non sia un film, ma solo un videogioco. Che succederà tra pochi mesi, quando uscirà la PS4 e definizione e memoria saranno molto maggiori? GTA V è costato a Rockstar Games 250 milioni di dollari. Felicitatevi con loro: il gioco era attesissimo e il primo giorno ha incassato 850 (ottocentocinquanta) milioni. Niente sarà più come prima: il cinema di puro intrattenimento è arcaico, defunto, non ha scuse per esistere. Se c’è da intrattenersi senza pensare, meglio la playstation. Per molti giocatori tra i dieci e i quarantanni, Blade Runner sembra la casa delle bambole. Inutile girare kolossal d’azione, o sedere in platea come nel XIX secolo, lo spettatore è giocatore e il giocatore è spettatore. Un piede è ormai in un nuovo tipo di narrazione, il racconto mobile. Il giocatore-avatar manipola il destino o ne è manipolato, perde e vince, muore e rinasce. Il racconto è morto, oppure è nato un altro racconto tra fiction e reality. Ci sono i dialoghi, uno tsumami di parole, e una cronaca mobile fitta di porte che si aprono, i destini, finché la storia mobile esaurisce le varianti e il gioco è finito. Si ride anche. Non a caso gli americani chiamano i fumetti comics: il videogame presenta legami profondi col vecchio comic magazine di ultravventura. Legami per l’appunto di sangue.
|
|
Post n°86 pubblicato il 24 Settembre 2013 da Jiga0
Come il gatto ma non è il gatto In Maremma gira una pantera. Lo fa nottetempo. Non è che passeggi come un turista a quattro zampe al parco dell’Uccellina, oppure che ne so, faccia un giretto a guardare il tramonto al faro di Castiglione della Pescaia, o nella tarda mattinata si acciambelli addosso a un pattino di salvataggio sul bagnasciuga di Marina di Grosseto. La pantera della Maremma abita nel mistero: non si fa vedere, ma intravedere: guizza nell’ombra. Non passeggia, scivola; non frequenta, si aggira. Non ha famiglia, è un’evasa. Divaga nella macchia mediterranea come se andasse a tentoni per un pianeta sconosciuto: si farà le unghie sugli ulivi secolari, sbuccerà i sugheri. E quando è ora di avere un pasto, non è un’ora certa - la pantera non ha orologio, ha ritmi di appetito, divagazione e caccia – lo stomaco si fa vivo e uccide. E’ questo che preoccupa grandemente, la sua fame. Per esattezza, la quantità della sua fame e se la sua fame comprenda carne umana, o applichi una risoluzione dell’Onu e mangi strettamente i pennuti e i quadrupedi. Mi trovo in Maremma, e so di lei dai giornali e dai tiggì locali. La pantera esiste davvero: è stata fotografata, l’organizzazione della sua cattura si sviluppa di ora in ora, ma ora le notizie su di lei stanno svanendo. Si sapeva che gli uomini della Forestale avessero costruito quattro gabbie, le avessero collocate a Prata, frazione della bella Massa Marittima, e nelle gabbie avessero messo delle esche di carne. Chissà lei dov’è, adesso che la notizia evapora. I felini poi sono abitudinari sino a un certo punto, dopo scatta la personalità, ve lo confermo attraverso l’esperienza con Pepino, il mio gatto. Potrà sembrare paradossale, ma in questi giorni di pantera lui è una sorta di parametro. Un raffronto. Penso: se Pepino fa così, la pantera fa lo stesso moltiplicato trenta. Il gatto Pepino, analizzo scrutandolo da una panchina mentre si fa le unghie su un tiglio, è in tutta evidenza un felino proprio come Baghera (la vox populi ha immediatamente battezzato la pantera, richiamandosi al romanzo di Kipling). Il felino, se grande o se semplice micio, ha consuetudini ferree. Il mio gatto esige di prendere i pasti accanto all’ombrelliera, è lì che mangia i croccantini e niente può apparire inevitabile come la sua abitudine di mangiare in quell’angolo di casa. Invece non è così. Quando un giorno di due inverni fa ha cominciato a scostare inorridito i croccantini al salmone, che secondo me devono essere buonissimi, e a digiunare per giorni, la situazione è divenuta illeggibile. Credevo che stesse diventando anoressico. Rifiutava tutte le nostre offerte, le ali di pollo, la corteccia di groviera e il lattuccio. Come in un racconto biblico, all’alba del settimo giorno mi sono alzato dal giaciglio della mia apprensione e ho controllato la ciotola del gatto: colma, coi croccantini inerti. Ho guardato l’ombrelliera, e ho capito: dopo l’ultima pioggia non avevo rimesso a posto l’ombrellino rosso. Grave inadempienza. Prima di mangiare, il nostro gatto passa a strusciare la testa sul manico piacevolmente zigrinato dell’ombrellino rosso; eseguito il rituale, probabile ringraziamento all’ombrello, inizia a mangiare i croccantini. Forte di questa deduzione psicologica, perchè io gli animali li intuisco, sono corso alla macchina a prendere il grattatore: pregustavo quello che stava per succedere. Pepino avrebbe strusciato la testa sul manico, il suo appetito sarebbe tornato e tutti avrebbero intuito quanto io sappia intuire. Ma quando salgo a salti le scale di casa brandendo trionfale l’ombrellino, una gelida visione dissolve la mia teoria. Sul nostro pianerottolo, alla porta della vicina, Pepino sta mangiando un cospicuo pezzo di pollo lesso. Spunta la vicina e mi fa: “Il vostro gatto ha un appetito! Ieri gli ho fatto il polmone alla veneziana e l’ha rivoluto”. Così come adesso so che il mio gatto mi è ignoto, figuriamoci che succede con una pantera mai vista. Ma che ne sappiamo di lei? Magari viene dalla villa di un collezionista di fiere che si chiama Mario e ha debuttato con le linci. O forse si chiama Alberto, o Enzo, o Gianna, e assembla cuccioli di animali esotici: elefantini, caimanucci, panterelle. Quando crescono, il sordido li molla. Ma io sento che Baghera è profondamente buona e se potesse ascoltare il richiamo della voce di Mario, o eventualmente anche Alberto, Enzo, Gianna, la marcia fantasma in Maremma si fermerebbe. Baghera si calmerebbe, se qualcuno pronunciasse il nome del padrone tiranno che tuttavia ama. Nei dintorni di Prata, un capitano della polizia urlerebbe verso il bosco: “Vieni Baghera, c’è uno: o è Mario, o è Alberto, o Enzo, o Gianna”. Lei sortirebbe lenta dalla selva, magari getterebbe un grido di offeso dispiacere e si farebbe grattare la pancia. Ma come nessuno conosce il nome del suo padrone, allo stesso modo la pantera di Maremma non conosce nessuno nel vasto mondo al di fuori della sua ex villa - la villa poi sarà vuota, il padrone all’estero a comprare un cucciolo di nasica, e la possente Baghera cammina senza sosta per la Maremma: è sola e non vorrebbe. Rigetta la nuova vita, l’emancipazione dello spazio aperto la spaventa. Sta nella selva e non si fa vedere. “Ma chi li conosce - si starà dicendo - questi trenta uomini in verde che sistemano pezzi di agnello crudo dentro alle scatole con le righe che loro chiamano gabbie, quando basterebbe dire scatole con le righe”. La pantera ha contato bene: sono esattamente trenta le persone che le danno la caccia. Si tratta di quelli del Corpo della Forestale, sono loro che le hanno fatto la foto, hanno sistemato le esche, sparso il sangue fresco intorno alle gabbie. Per ora lei non abbocca, si serve al ristorante del bosco. La cosa certa è, sarebbe, che Baghera si aggira nella campagna di Gretaia, dove permangono segni del suo passaggio: rami rotti, unghiate sui tronchi, escrementi. Un sabato mattina l’ha vista un signore che era fuori col cane e se ne intende: per l‘appunto è vissuto sei anni in Africa e la sua descrizione di Baghera concorda con le foto della forestale: “Aveva la coda lunga, gli occhi gialli e le orecchie a punta. Non ho detto niente perché nessuno credeva alla pantera”. E’ chiaro che la zona intorno agli spostamenti felpati di Baghera è blindata: possono transitarvi unicamente i residenti, che piuttosto di convivere con lei avrebbero passato l‘estate al Polo. Ma la Maremma è grande, non si sa dove lei sia, e mentre le notizie affievoliscono come un fuoco morente, galleggio nell’inquietudine. Prendiamo la semplice descrizione della pantera: nera, occhi gialli, orecchi a punta, coda lunga. Il suo identikit mi disorienta. Mutatis mutandis, è il ritratto del mio gatto. Lei grande e lui piccolo, lei mangia un agnello alla volta, lui trenta grammi di croccantini; ma lei è nera e lui è nero, e come se non bastasse entrambi hanno quegli orecchi e gli occhi gialli fosforescenti. E così, quando guardo Pepino, penso che se fossi uno di quei gechi sul muro a cui lui dà la sua caccia crudele, lo vedrei come una pantera, per cui anche se non sono un geco, quando vedo Pepino, è più forte di me, ho un lieve tremore. Capisco come possa sentirsi la vittima di un felino: il fatto di diventare il suo gioco crudele ed entrare in una lunghissima morte. Adesso che di lei non ci sono notizie, la notte faccio solitari turni di guardia. Mi alzo nelle ore del sonno profondo, le tre, le quattro, mi affaccio alla finestra di camera, guardo e a volte il buio pare sospirare. A quell’ora, ho pienamente paura. Mi inquieta immaginare i suoi passi armoniosi, e che dunque la mia morte potrebbe essere armoniosa, anestetizzata dalla forza meravigliosa che si aggira nella pianura perché da qualche parte si sono stufati di lei. Qualcuno è andato col camper fino alla macchia, l’ha lasciata lì come una scatola - e Baghera si aggira stordita. Che se ne può fare di questo esilio chiamato libertà? Mi domando se sia una semplice fatalità che di tanto in tanto, con la ciclicità dei giri di un orologio, le nostre sciatterie si affaccino sul pianeta, la natura liberi le sue forze e noi se ne cada in balia: sia lo tzunami che scortica una centrale atomica di prima generazione, o discendendo a precipizio la scala dei pericoli, una pantera abbandonata che si aggira per la Maremma come in un irriconoscibile giardino, l’uomo appare inadeguato ad amministrare la natura. Non solo non ne sa niente, ma non lo interessa. E’ un’immensa crisi culturale, e la crisi economica è conseguenza della più immane crisi culturale. Qui in Maremma, la pantera in libertà non desta reale timore, ma un poco duraturo interesse mediatico: il passaggio del felino fantasma è uno spettacolo antico, non si può vedere da uno schermo, è uno show è senza orario. I giornali non annunciano la sua programazione: “Ore 17, passeggiata ungulata al Parco dell’Uccellina. Ore 23.30, Baghera è a Grosseto. Azzanna a piazza del Duomo”. Certo, se ne è letto qualche giorno sulle locandine davanti ai giornalai. Accanto al Vernacoliere, c’era quel titolo a caratteri di scatola: AVVISTATA LA PANTERA. La gente passava oltre, sigillata nella bolla delle vacanze. La paura è della Borsa, non di Baghera. E’ la Borsa che fa: ahm, ora ti mangio. A Baghera chi ci pensa. Anche io inizialmente non pensavo alla pantera, ma ora che è scomparsa dai titoli, al mattino sfoglio i giornali e la sera chiudo la porta a doppia mandata. Dicono: non c’è da preoccuparsi. Ma che ne sappiamo di cosa debba preoccuparci di Baghera, o in genere della natura? Ieri c’è stato il terremoto a Gavorrano, tre virgola sei della scala Richter: in due case ce ne siamo accorti, al ristorante accanto no perché la macchina del caffé sibilava. Una scossa leggera, perché tutto è leggero, indolore: siamo sedati. Dicono che una pantera possa fare dieci chilometri al giorno. Ho consultato la guida Michelin: da dove mi trovo a dove in linea teorica si trova lei, ci sono decine di chilometri. Ma che vuol dire? Non è che quando il gigantesco felino si sposta, lascia un messaggio in segreteria: “Sono io, qui ho finito i cervi. Vado ad Alberese”. La pantera gira di notte, nero su nero, magnifico silenzio in magnifico silenzio, pedinata dai versi degli animali sbalorditi da quell’apparizione color carbone. Si ciba di lepri, fagiani, cinghiali, il cui unico nemico erano i cacciatori o i bracconieri, e ora c’è la rapida cosa nera. Certo, la lettura sui giornali dell’attuale dieta di Baghera abbassa la soglia dell’allerta: quando una persona in vacanza legge la lista dei pranzi di Baghera, non pensa alla morte in agguato sulla via di un povero fagiano, ma che col fagiano ci starebbe bene una bottiglia di Morellino di Scansano; e poi che non è giusto che la pantera mangi gratis. Sa cosa dico, Baghera mia, anche se tu fossi vicinissima, macché, sei lontana: filtrata dalla discontinuità delle notizie e dal nuovo istinto onnipotente che ci ha abituato a guardare le guerre, i saccheggi e i terremoti dal salotto di casa. E poi, quando uno è stanco, spenge. Ma la pantera è qui, non se ne va premendo il tasto rosso. Giorni fa, in concomitanza delle apparizioni di lady Baghera, a qualche centinaio di chilometri dalla Maremma, nel capannorese, si è sviluppata un’altra apparizione kiplinghiana: un gigantesco serpente boa. Quando è stato avvistato, anche lui si aggirava, e naturalmente serpeggiava. Anzi, non lui: lei. Una femmina di costrictor, imperator XI. Lunga due metri e ottanta, un esemplare di trenta chili, mica acciughe. L’hanno catturata a mezzanotte, l’ora dei vampiri, delle pantere e degli immani serpenti boa. Il costrictor è stato individuato con un sistema di avvistamento satellitare: era sopra un masso, in mezzo a un torrente asciutto. Ci sono volute due persone specializzate, un erpetologo e una guardia ecozoofila che lavorano in zona, ma non è bastato essere organizzati, pianificare fino al dettaglio. Quando il boa era in gabbia, ha morso entrambi. Era particolarmente selvaggio, non avvezzo alla presenza umana, piovuto chissà come nel capannorese dove i costrictor sono spesso avvistati – per ragioni imperscrutabili, pare che in Toscana, abbondino i collezionisti di animali esotici. In ogni caso, il boa era lento ma si è avvolto rapido al braccio dell’erpetologo e lo ha stretto come se volesse farlo scoppiare. Un bambino sarebbe morto, ha detto. Sempre senza notizie: si vede che la pantera continua a girare. Forse sul cielo di Maremma non gravitano i soldi per collegarsi ai satelliti. Ho telefonato a un amico della Protezione Civile che abita a Grosseto e mi sono procurato un binocolo a infrarossi. La notte mi apposto alla finestra e scruto i boschi. Dove sei? mormoro, nutrito dall’onnipotenza tecnologica della vista notturna. Le foglie degli alberi sono ferme, Baghera non risponde. Magari sta venendo da me. Ho cominciato a usare il binocolo anche al mattino presto, con il fresco, penso, girerà ancora. Stamani, saranno state le sei, ero di vedetta, noto un movimento davanti all’edicola dei giornali. Un’andatura armoniosa viene su per il paese: è un’enorme macchia nera e sta per balzare su un muro. E’ lei, non c’è dubbio. Oddio, grido, la pantera! In casa, non risponde nessuno. Quelli dormono. Che mortorio, penso, poi faccio le corna. “Svegliatevi – ansimo - la pantera!!...Dobbiamo andarcene di qui!”. “Che c’è?”, geme mia moglie. Il braccio di mio figlio, diciassette anni, mi cinge le spalle. “Calma”, sussurra. Mi prende il binocolo di mano e lo punta. Dopo un attimo lo allontana bruscamente dagli occhi. Mi guarda sconcertato: “Babbo - sussurra - hai usato il binocolo alla rovescia!...Quello è Pepino che beve il latte sul terrazzo!”. Essermi sganciato dalla percezione della realtà, è uno scacco, e questo scacco ha vibrato dentro di me tutta la giornata - e alla radio non dicevano niente, in Tv poi figurarsi. A metà pomeriggio non ce la faccio più e torno alla finestra: devo controllare se arriva. Non si scherza su certe cose, che cavolo. All’imbrunire, il cuore mi salta nel petto. Una forma nera familiare risale silenziosa il paese. “Oddio ci siamo - rantolo - Mamma mia se la riconosco! Ecco, lo sapevo…Non dobbiamo assolutamente farci trovare! Presto, chiudete la porta, le finestre, tutto! E non fiatate!...Ma siamo pazzi??!…Forza, prendete le chiavi della macchina e usciamo dalla porta di dietro, ma zitti!…Erano giorni che me lo sentivo a fior di pelle: gli zii”. Mia moglie ammutolisce: “Gli zii?”. Altro che pantera. L’arrivo imprevisto da Torino di zio Marino e la zia Claudia è un segnale di grave pericolo. Farli entrare in casa, significherebbe creare una grave lesione alle vacanze. Zio Marino critica tutto quello che faccio e zia Claudia mangia tutto il pecorino. La decisione è immediata. Serriamo la porta, le finestre, e decidiamo di aspettare: quando poco dopo bussano alla porta e piantati davanti all’ingresso continuano a telefonare ai nostri cellulari, facciamo finta di non esserci. - Ehi, ci siete??...C’è nessuno??!...Aleeeee... Dopo dieci minuti l’assedio è levato, li sentiamo andare via. - Oddio - sussurro - quelli sono peggio di Baghera. Magari tornano. - Pa’ - bisbiglia il ragazzo - ho un’idea: andiamo a dormire a Grilli e torniamo domani pomeriggio. Mia moglie è d’accordo: “Sì, scappiamo”. Ceniamo in silenzio, usciamo dalla porta sul retro e scappiamo a Grilli. Forse ci salviamo. La macchina scende lenta, per prudenza tengo i fari spenti. Metti che passano gli zii e ci vedono. Alla fine della discesa, accendo i fari. “Pericolo cessato”, scherzo. - Frena! - urla mia moglie. Davanti a noi, in mezzo alla strada, si para un enorme gatto nero, non ne ho mai visto uno così. Gli occhi gialli e gli orecchi a punta. Sfila lentamente davanti alla macchina, si ferma e gira la testa verso di noi. Si avvicina felpato al mio sportello, comincia a strofinare la testa contro lo specchietto retrovisore. Ma è un gatto altissimo: sarà trenta volte Pepino. Ci guardiamo. Il motore è al minimo, si sente il fruscio del vento. Sta ronfando. - Frrr. Buona fortuna, Baghera. Scappa anche tu.
|
|
Post n°85 pubblicato il 19 Settembre 2013 da Jiga0
Tag: bene, bene o male, bolero, bolla, galleggiare, inno, ipnosi, male, non morti, sonnolenza, speranza Fanno proprio male a non fare bene e in un certo senso però fanno proprio bene a fare male: E cioè fanno male perché indubbiamente fanno male, ma allo stesso tempo fanno bene perché a un certo punto visto le cose come stanno, e non stanno molto bene, stanno molto male, è inevitabile che si cominci tutti a fare male invece di fare tutti bene dato che chi dovrebbe fare bene poi fa male, mentre chi deve fare male poi continua coerentemente a farlo. E allora è perfettamente chiaro che si cominci a non fare bene e pur tuttavia a fare male, nel senso che è chiaro che fanno male, ma male, a fare male, e niente affatto bene, ma male male a fare male. Se oltretutto ci si domanda chi abbia veramente cominciato, ci si risponde che a fare male invece di fare bene non ha iniziato chi di solito fa il male, ma chi di solito fa il bene, e così chi di solito fa il bene è un bel pezzo che di solito fa il male. E' inevitabile che nei cuori nasca la domanda se sia davvero male fare male quando il primo a fare male è chi dovrebbe fare il bene; e anzi, chi dovrebbe fare bene non fa né il bene, né il bene bene, ma fa direttamente il male con l’aria di chi fa il bene bene, e questo crea disorientamento. Anche se, prevalendo l'obiettività, andrebbe sottolineato che hanno fatto tutti male a fare male, e pur tuttavia, in un certo qual modo, in una qualche misura, da un determinato punto di vista, entro un certo raggio logico, a ben riflettere, dopo accurata indagine, per qualche curiosa ragione, andando a vedere, prendendo spunto chissà dove, in base a non sappiamo cosa, per ragioni sottostimate, fatalmente, e poi anche inesplicabilmente, quasi quasi divinamente, in modo umanamente acefalo e iperuranico, per via di un mistero che ci sovrasta dall’alto e ci solletica dal basso, sorge l’idea incontrollata che poi chi si è trovato a fare male abbia fatto bene a fare male invece di rimanere con le mani in mano. E per capirsi bene sino in fondo, invece di capirsi male, il giudizio è che chi abbia fatto male ha fatto male a fare male, perché indubbiamente ha fatto male, e allo stesso tempo bisognerà convenire che ha anche fatto bene perché a un certo punto visto le cose come stanno, e non stanno molto bene, stanno molto male, è inevitabile che si sia cominciato a fare male invece di fare bene - del resto, chi può dominare la fatalità? Io no di certo. E la domanda che si pone a un certo lìvello è cosa sia il bene, cosa sia il male e sempre a un certo livello anche se il bene e il male non siano la stessa identica cosa quando lo compiono le stesse persone. E si tratta di capire, sempre a un certo livello, se è davvero bene fare bene a un certo livello e anche male fare male a un certo livello, e che cosa sia questo famoso certo livello di cui si parla da un sacco, e se abbia senso compiuto fare il male dato che con il bene non c’entra niente, ma cosa è il niente? Io non lo so. E subentra l’impressione probabilmente fallace, ipnotica, potenzialmente ambigua, ingannatrice, subdolamente avvincente, implicitamente veritiera, sottilmente tenace, capace e rapace, e verace che tanto vale fare tutti direttamente il male e buonanotte. In pratica, si tratta di mettersi pari pari a fare il male o pari pari a fare il bene, o anche di mettersi in pari e fare pari pari sia il bene che il male, se no quelli che vogliono fare il bene non capiscono più nulla - perché ormai stanno facendo tutti il contrario di quello che dovrebbero fare. E cioè chi dovrebbe fare il bene fa il male-bene e chi dovrebbe fare il male fa il bene-male, e un uomo comincia a domandarsi se hanno fatto tutti male a fare male quando avevano iniziato a fare per fare bene. Perché è chiaro cosa accada in una situazione del genere, e lo ripetiamo data la complessità: ci sono quelli che fanno il male invece del bene anche se poi non fanno bene, anzi fanno male, ma male male, e non fanno assolutamente bene perchè indubbiamente fanno male (anche se non è del tutto chiaro che quando facevano male volevano fare bene). Ciò detto, allo stesso tempo, per una fatalità che non sappiamo stimare in quale coordinata della storia morale si trovi, costoro hanno fatto fatalmente bene a fare fatalmente male perché era fatale e a un certo punto bisogna fatalmente prendere una decisione, visto le cose come stanno, e non stanno per niente bene, stanno del tutto male. Perché il male rende bene e il bene meno bene del male. Però meno male che va bene e meno bene che va male.
|
|
Post n°84 pubblicato il 16 Settembre 2013 da Jiga0
Tag: assi, brocchi, centravanti, classifica, corsie, esterni, miseriacane, noia, realtà, serie A, soldi, tifosi Non fanno che pareggiare e rompersi il menisco di Alessandro Schwed Il calciomercato è meraviglioso, purtroppo sta finendo. Ecco cosa succede ovunque, grazie alla potenza onirica della speranza. Ovunque il sogno ruggisce, dalle tifoserie con le squadre destinate alle stelle, a quelle dal quinto posto scendendo fino a metà classifica, dove la speranza è prendere qualcuno con una gamba rotta appena rimessa a posto che ci stia ad abbassarsi lo stipendio, per finire alle società che strappano il prestito dei corridori, portatori della cosiddetta quantità invece dell’inebriante qualità. Ma ovunque, si sogna in modo industriale. In cima alla classifica, grandi giorni a palpitare per l’acquisto di Tevez, Higuain, di agguantare Gomez spalmando l’ingaggio in due lustri, il lungo duello tra Firenze e il Nord, la guerra cruenta per non vendere Jovetic alla Juve e Ljaic a Galliani e poi darlo alla Roma, tiè. Perché il calcio-mercato vero (la compra-vendita del calcio di metà inverno è una parodia, triste solitaria e finale), offre una vita bellissima, degna dell’infanzia, quando i propri eroi compiono le imprese gravemente feriti e sconfiggono da soli una legione nemica. La campagna acquisti si definisce in chat, al telefono, sulla spiaggia. Si riuniscono gli amici, si consulta se stessi, e si elabora: se vendiamo Cavani, col ricavato compriamo un centravanti, se diamo via Jovetic ci compriamo un esterno spagnolo, un interno slavo, il portiere olandese e un mediano basso. Non ci sono limiti per il calcio-mercato interiore. Gli scudetti e le coppe vengono giù come ciliegie dall’albero delle vittorie immaginarie, l’inno della Roma, della Fiorentina, del Napoli detonano nei rispettivi stadi invisibili: nessuno è risparmiato dal trionfo. Il calcio-mercato è la stagione delle soluzioni perfette, senza smentite sino a fine agosto quando comincia lo smorto campionato. L’estate invece, quando gli stadi sono vuoti e i prati ingialliti, durante la caterva delle vittorie nella repubblica della fantasia, i presidenti delle potenziali grandi squadre fanno vivere momenti indimenticabili, le promesse trivellano le teste dei tifosi dove c’è un assetato deserto. Quale speranza è migliore della speranza che offre tutto e si aggiudica tutto? Non c’è fidanzata promessa, Imu promessa, lavoro nuovo fatto balenare anche ipoteticamente, patto con gli elettori, in grado di riprodurre una speranza così, anno dopo anno, puntualmente. Perché le fidanzate, l’Imu, i partiti passano, ma il calcio-mercato, la campagna acquisti irreale è lì ogni estate, pronta e servita, dai tempi di Altafini, Hamrin, Sivori e Maradona fino a Higuain, Tevez e Gomez. A Firenze, in piena estate, con la calura che bolle la città e la spolpa come non accade a nessuna città italiana, quando le pietre del Duomo gemono per un bollore vulcanico, irrompe il nuovo acquisto, Gomez, è lui, è lui, il numero nove che manca dai tempi di Batistuta, detto fatto allo stadio arrivano 30.000 tifosi, pronti a celebrare la più bella coppa, la vittoria del sogno. La pazzia più gioiosa che esista. Ora invece è finita. Arrivano le papere del portiere, la bolletta del gas, i muscoli cotti, il conto del dentista che doveva arrivare a metà settembre. Cominciano le variabili senza controllo: le caviglie slogate a macchinetta, il vento contrario, Higuain che scivola sugli scogli e tocca far causa alla Regione. Ora è finita e non c’è niente di sciatto come l’estate che finisce e il campionato vero e proprio che inizia con i pareggi in casa. Volete mettere con il calcio-mercato?
|
|
Post n°83 pubblicato il 13 Settembre 2013 da Jiga0
Tag: classe dirigente, Convivio, Dante, linguaggio, moda, remixed, social forum, target universale, Tv
Da dopato a spompo di Alessandro Schwed Renzi dilaga. A Bologna esplode con era spompo, a Modena deflagra con io cattivo de che. L’inquilino futuribile di Palazzo Chigi spara il suo neo-gergo sulle feste del Pd. Per ora si esprime in fiorentino e romanesco, ma si appresta a suonare la carica delle primarie con una nuova lingua sia multilocale che socialforum. Dirà bauscia a Pisapia, remixed a Veltroni, poi andrà in Tv da Marzullo e gli dirà bucaiolo. L’obiettivo non è oltrepassare lo straripante 78% di consenso nel Pd: Matteo non può pretendere di piacere anche a Barca, che probabilmente preferirebbe gli dicesse non sono d’accordo, là dove Renzi direbbe sei un magnifico cazzaro. Con la scusa dello scontro per la segreteria, il sindaco sperimenta la nuova comunicazione per le elezioni. “Era Spompo” e “io cattivo de che” illuminano l’Italia come un faro la tempesta. Al largo, Bersani si appresta ad affogare, sono in arrivo cavalloni di mortacci tua. Direte: quelle di Renzi sono solo battute. Allora non vi rendete conto quale rivoluzione sia in corso. Se Dante costruisce la gerarchia estetica tra dialetti e lingua, bolognese, romano, veneziano, e poi la lingua italiana, il fiorentino, suo pronipote Matteo si prepara a ibridare una comunicazione multitematica che sbrana gli avversari a colpi di assorate e di “tu sei completamente download”. Addio al linguaggio gramsciano e al neo-folk di Bersani. Un giorno, “era spompo” sarà citato dai sussidiari digitali come l’”obbedisco” di Garibaldi. Il primo minuto di quella sera bolognese, quando Renzi disse «Bersani alle primarie mi ha fatto un culo così», in pochi si accorsero che era la linea politica rivoluzionaria del prossimo quindicennio e il punto focale era il culo. Ma partiamo pure da “Spompo”: in apparenza fortemente esausto, ma poi guscio vuoto, mela col gigi (Pierluigi). In filigrana, scalciato pure da D’Alema. Mezza calza e non integra calza intera. Cucinato fino alla consunzione della pentola, lesso che barcolla. Inebetito, suonato, groggy, stonato, ito da mo’, dissolto, ko, dead man walking, E ora arriva il romanesco “io cattivo de che?”. Una novità assoluta. Ma ce lo vedete Berlinguer a dire “de che”? Ce ne corre tra il compromesso storico e ‘sti cazzi. Ora la politica va per strada e pesca fiammate linguistiche. Non la rudezza tribale bossiana coi tamburi percossi da tibie, ma una permanente festa della rificolona a Roma, a Modena, su Facebook. Non siamo più tra le arcaiche barzellette aziendali del Cavaliere, l’arrotondato fraseggio retrò da sala-biliardo. Irrompe uno slang tra il Convivio alla rovescia e Roma-Lazio. Il sarcasmo dei rapper nelle sfide di strada: ce l’ho più bello di te - mbé. Mia madre è più sexy di te - che c’è. Solo, invece che a un portoricano, detto a Civati. Del resto, se a iniziare la nuova fase che sbuccia l’avversario come un mandarino, fu Bersani, ora l’ex segretario non può lamentarsi se viene sfidato in Emilia, tra le vigne delle metafore e il visibilio dei grappoli delle scemenze. Fu lui, nelle primarie che lo videro inutilmente vincente, che prese ad andare in giro con le maniche arrotolate, parlando di un tacchino sopra il tetto. Rimanemmo tutti colpiti da quell’enigmatico frasario rurale. Poi non andò bene. Abbiamo non vinto, disse in Tv Camicia Bianca. Sotto le rasoiate linguistiche di Renzi, Pierluigi Bersani si rivela figura mitopoietica della neo-malinconia, derivazione fantascientifica dello psicopompo sul fiume Ade. Se infatti lo psicopompo è la bella figura né divina né umana che traghetta le anime dal mondo dei vivi a quello dei morti, Bersani è la brutta figura di non traghettare un’anima. Uno psico-spompo. Ma che, davero davero?
|
|
Post n°82 pubblicato il 14 Aprile 2013 da Jiga0
Tag: ammazzacaffè, Bersani, giochi di società, granchio, Il Messaggero, Monti, Oxford, Quirinale, tasse, telepatia Se sia meglio il governo di scopo del presidente o quello completamente senza scopo di Monti (Huffington Post, 06-04-13) di Jiga Melik |
|
Post n°81 pubblicato il 20 Marzo 2013 da Jiga0
Tag: bollette, borsellinovuoto, debiti, ebay, guerra, Hitchcock, invocazione, Sc'veick, speranza, tasse
Lettera di protesta a colei che esiste solo dentro di noi (Il Foglio, 14 marzo 2013) di Alessandro Schwed Paura, il tuo cocktail ci sta ubriacando. Ricetta: una parte di realtà mondiale, due parti di irrealtà, e il ghiaccio della sorpresa. Facciamo così, Paura: adesso io approfitto di essere sobrio, mi faccio coraggio e ti scrivo. Non devi montarti la testa, qualcuno pensa a te anche ridendo. C’è chi ricorda per tutta la vita quando vide Psycho, di Hitchcock. Dunque: è il 1960, uno è al cinema. In una cantina su una sedia a dondolo c’è una donna anziana, i capelli bianchi. Non è vera vecchiaia, è la parrucca che si mette il giovane protagonista senza saperlo. Uno schizofrenico. Nel buio dei cinema la gente strilla di terrore. Altri ridono. Perché avere o meno paura, è un fatto del carattere. Ma dimmi: dove abiti, Paura? Forse sulla luna. Lontana da acqua, aria, lontanissima dalla speranza. Nel regno fantascientifico della marmificazione, dove la moglie di Loth ti vide e divenne di sale. Non è scritto cosa fosse esattamente ciò che lei vide prima di cristallizzarsi - per non far sapere che fece in tempo a dire come sei. Ed eccoti di nuovo: qui. Emergi da un’insondabile palude, nerissima, col tuo volto di Paura. Ma come uscire di metafora, se accade adesso che un fantasma si aggiri per l’Italia ed è un’altra metafora? Come distinguere la fantasia torbida dalla disgrazia che potrebbe inverarsi? Come esprimere che la vecchia Paura va intorno col cappotto della nuova, vestita da Equitalia? Ti guardo con prudenza, Paura, discendente del buio. Ti incarni in una persona, poi in un’altra, in una famiglia, contagi una nazione. Mastichi la giornata dei debiti e la rendi una polpetta, ma ti riconosco tra i frammenti: sei tornata da noi. Eri maturata, incubavi. Di recente era anche apparsa la tua sosia, una paura finta che non poteva fare paura. Una paura giocattolo, della lego e da legare, paura baby, vezzo della fine del mondo. Il vaticinio Barbie dei Maya. L’ammoina che dopo avere rotolato nelle ere sul panno seppia delle galassie, il mondo finisse per appuntamento in buca, come una pallina da biliardo. L’idea di morire per una profezia che è uno scoop e mettere all’incasso il thriller della fine, la musica della fine del mondo, i gadget e il rossetto della fine del mondo, i giochi di playstation e i film, i villaggi-vacanza della fine del mondo. Vi dico: la fine del mondo! Mentre la paura vera stronca. Quando sei tu, è buio, siamo nelle tue mani. Si accendono le luci e le mani che ci stringevano al collo erano le nostre. Bugiarda. Commediante. Maniaca seriale. Ora sei a poche centinaia di chilometri, rare immagini greche dal web, silenziate dalla campagna elettorale. C’è una calca, urla sotto a un camion dove distribuiscono arance. La ressa dei poveri. Si spingono, hanno paura di non riempire le borse, le mani, quello che capita. La Paura è che hanno giacche a vento, scarpe da ginnastica e allora sono come noi. Perché non farci vedere, mentre prima era un continuo farete la fine della Grecia? Paura di farci capire. E stai tornando. Ghiacciatrice. Terrorista. Giorni fa Pistorius uccide la fidanzata come in un film di Brian De Palma. Lui androide, lei bellissima - una notizia da paura. Di solito ci visiti in brutti sogni, tra stanze in rovina. Scateni l’istinto di sospendere tutto. Saresti la paura di sempre, solamente che non ti conoscevamo nel dilagare della tua potenza, ma dai racconti sulla guerra dei nostri genitori. E adesso, che tu urli o mormori, noi sussultiamo. Eravamo abituati a pattinare sullo specchio ghiacciato del cinema, ai missili intelligenti visti in Tv, da duemila chilometri. Mica all’evidenza di privazioni che non sopportiamo di chiamare povertà - ma anche se facciamo gli amabili e alla domanda come va? rispondiamo con metafore: “è dura”, “in trincea”, “insomma” - che sono le privazioni se non povertà? Il fantasma del lavoro fa paura, la spending review domestica fa paura, la conta delle monete nel borsellino come i poveri di Dickens, fa paura. Tutte le notti a girarsi nel letto, pronti a impugnare le gocce di camomilla. Ti sento muovere, Paura. Fai cigolare porte, a un tratto scricchiolare mobili, muovi ombre per il gusto immortale di spaventarci. E anche quando la minaccia è vera, è teatro dell’inconscio. Ansimi, ma stai recitando: tu sei agilissima. Rantoli: non hai nulla. Lo speaker del telegiornale legge la notizia, sulla camicia bianca ha un vivace papillon: “…Brescia. Si impicca all’alba piccolo imprenditore”. Intangibile paura, ma soda come i tuoi proiettili cardiaci. Sei in forma. Ci insegui, corroborata dai nostri occhi sbarrati. Quando te ne andrai? Derivi talmente dalla crisi che diciamo crisi, ma potremmo dire paura. E la paura è addentrarsi in un pericolo sconosciuto. Dante: “…Ahi quanto a dir qual era, è cosa dura esta selva selvaggia e aspra e forte che nel pensier rinova la paura!”. E quando il soldato Sc’veik viene arrestato all’osteria per avere detto che c’è una cacca di mosca sul ritratto di Francesco Giuseppe, Hazek sostituisce la paura con una risata. Ma è una breve pausa. C’è stato l’attentato a Sarajevo e sta per iniziare la Prima guerra mondiale. Durante il bombardamento di Genova, mia madre ebbe paura di una cantina dove non voleva andare, ma poi dovette andarci e tornarci, impallidendo per quella cantina più che per le bombe; e la notte dell’alluvione di Firenze, temette di rimanere sigillata con noi in una stanza al secondo piano, sopra a casa nostra invasa dall’Arno, mentre i camion per strada sbatacchiavano fra loro. Se no, Paura, metti vestiti normali e ti intrattieni col terrore domestico. Soffi il tuo vento sui matrimoni perché vadano fuori strada, ci suggerisci che i vicini faranno causa e vinceranno. Fai cadere a un passo la pentola dell’acqua bollente. Ma questo lungo giro che è in corso, è il giro della penuria: è diverso. Entri nelle case senza bussare. Nessuna bomba, annunci di licenziamento, bollette che sono colpi di cannone. Paura di non pagare l’assicurazione della macchina, dell’auto da riparare che giace non riparata accanto al marciapiede. Paura di non fare più viaggi. Di rimanere per sempre dove siamo, più alberi che persone. A casa sua, il meccanico sogna l’officina vuota di vetture da riparare, una è proprio la tua, quella che non puoi portare ad aggiustare e il ponte delle riparazioni è deserto. E tu, Paura, sei un fantasma che ride. La notte, quando si sente il rumore dei pensieri, c’è un frastuono: sei tu invisibile che arrivi con le sincopi. Trascini la catena dei debiti, ti sollazzi a spaventare i debitori che non hanno i soldi per pagare i creditori, e a spaventare i creditori che non hanno i soldi per pagare i propri creditori. La catena sferragliante fa un lungo giro del mondo e si ricongiunge alla medesima catena da cui è partita. Quando le persone deglutiscono, sospirano, parlano da sole, è segno che sei arrivata e fai fremere con mutui insoluti, risse, uno stupro in galera, la sterilità, il terremoto che fa diventare obliquo ciò che è piano, la malattia e l’improcrastinabile morte. Passa la tua ombra lunghissima, e subito un uomo cerca di guardare da un’altra parte. Va tutto bene per distrarsi da te, una scalinata, degli alberi, quello che abbiamo dentro - ma è inutile, il cielo di dentro si è chiuso. Sei la nostra ossessione, attraversi le pareti e piombi in appartamenti dove è accesa una sola luce, per non consumare. Suggerisci pensieri senza sbocco. Un uomo si chiede cosa succederà, e tu, in un orecchio: “Che suonano alla porta e prendono tutto quello che hai”. Vivi appostata davanti alle casse dei supermercati, dove gli sguardi dei clienti adesso sono allertati. Un uomo scruta il display della cassa per vedere se la card contenga ancora qualcosa. Sta provando a pagare. Al bip positivo, deglutisce. E’ salvo. Porterà a casa la spesa. Ma è terreo, lo ha sfiorato la penuria. Non sa di essere notato e mormora “grazie”, lo hai abituato a pensare a voce alta, a comportarsi come se fosse solo. E lì al supermercato, guarda grato il soffitto, perché oltre il soffitto c’è il cielo. Le case sono gelide, particolare di cui non si parla per educazione e la scarsa familiarità col problema di non avere soldi e non sapere come dirlo. E che c’è da vergognarsi, se giorni fa a Napoli non giravano gli autobus perché non c’erano i soldi per pagare la nafta? La vita va avanti camminando di lato. Le pizzerie attendono i clienti, coi pizzaioli bianchi immobili davanti al fuoco acceso. Le librerie sono la luna con dei commessi. Le macellerie espongono tagli ignoti. Su un cartellino, una mano ha scritto: “Carnetta. Tre euro!”. Chiedo che sia la carnetta, e il macellaio: “Tutto”. Non serve Sherlok Holmes per capire che succeda, e che quello che succede a casa vostra succede anche a casa di molti altri. Venduti i gioielli, le stilografiche, le seconde macchine, i francobolli, le collezioni di giocattoli, la pelliccia. Invece la poltrona vibrante massaggiante, acquistata con anni di leasing, non la prende nessuno. E la paura è vederla solitaria, nella casa rimasta spoglia. La caldaia si accende a cena, per non prendere una congestione mentre inizia la digestione, poi di corsa a guardare la Tv con il playd sullo stomaco. Le famiglie siedono in punta a divani che potrebbero essere sequestrati il giorno dopo; nel salotto, i padri meditano in segreto dove nascondere il pianoforte nel caso venissero quelli a pignorare. Si guarda un telefilm, incuneati nella fila dei pullover messi uno sull’altro, ultimo strato la maglia della salute come Alberto Sordi nei vecchi film del ‘900 - il riscaldamento si accende tutto il giorno solamente la domenica, per fare festa con un caldo da milionari, il pollo fritto e un dito neanche di vino. La prima cosa sono le necessità: mettersi a tavola, telefonare, pagare la luce, poi vengono le elezioni. L’essenzialità è sopraggiunta rapida. Diceva Brecht che si ragiona bene a pancia piena. Viene in mente con stralunante attualità il racconto di Bulgakov sull’inverno della rivoluzione. Qualcuno per scaldare la casa brucia i mobili in mezzo all’appartamento, il palazzo va in fiamme e ci si scalda allegri al tepore dell’incendio. Perché tu ci fai deragliare. Ossessioni e stanchi. Bisognerebbe minacciarti, riusciti a bucare con una speranza aguzza. Fare scoppiare te e la tua minaccia di vivere per decenni nel deserto di soldi e lavoro minacciato dagli economisti: le città vuote, abbandonate al selciato. Nelle estati che si rinnovellano, i turisti si aggirano senza italiani intorno, come per un’immensa Pompei brulicante di gente che parla inglese, tedesco e italiano no di certo. La vera popolazione è anziana, vive vergognosa in case di fortuna, anfratti. I figli sono all’estero. La vita come gli ebrei nel deserto con Mosè, solo che qui c’è il deserto senza Mosè. A essere sinceri, a essere crudi, a guardarsi nel fondo, la battaglia decisiva è sconfiggere febbraio, il mese più freddo. Febbraio è la nostra linea del Piave.
Aiuto. Abbiamo perso l’indirizzo della speranza. Diteci dov’è: Non si trova da nessuna parte, non è neanche in qualche fortunatissimo sogno della notte. E quando è che abbiamo smarrito la speranza? Paura e speranza vivono in luoghi indeterminati, ma se c’è da aspettarsi che la paura si nasconda sempre per saltarci addosso, perché la speranza non si mostra mai? La speranza consisteva nello svegliarsi al mattino e avere davanti a sé una bella cosa da fare. E’ lì che abitava, ora chissà dove è andata. Come accade per la paura, anche la speranza è stata appresa dai genitori, che la impararono dai propri genitori, e anche loro l’avevano appresa dai propri genitori in una galleria di apprendimenti della speranza che portano all’inizio del mondo. E la speranza giunge scendendo dai tornanti del nostro sangue. E’ lì che viene dragata ogni giorno, proveniente dalle arterie degli antenati, dopo aver viaggiato nelle condutture dei secoli, lungo le micro-tubazioni del dna, a bordo delle emozioni di avi con la barba incolta che ridevano senza denti. Sulle mappe ataviche della speranza sono tracciate le strade per innamorarsi, le piazze da raggiungere per fare quello per cui siano nati: suonare all’estero, avere una casa col terrazzo, fare il giro del mondo a piedi. Lavorare alla radio, a teatro, in un giornale; avere un cavallino attaccato a un carretto e girare su strade di terra battuta. Però della speranza si sono perse le tracce. Un mistero. Da che potrebbe dipendere? Forse dall’eccessivo preponderare della realtà immateriale su quella materiale, adesso che alle poste chiamano dematerializzate le bollette pagate on line. Forse dipende dalla mutazione per cui si stanno affievolendo i modi degli ultimi ventimila anni e la parola viene inavvertitamente sostituita dalla telepatia. Il figlio piccolo entra all’improvviso, vuol sapere cosa sia “orchestra filarmonica”, e chi ha il tempo di dirlo senza ansia? E può darsi che l’assenza della speranza sia data dalla torsione inferta alle ventiquattro ore diventate come se fossero cinque. Senza fermarsi a tavola e parlare. Senza rallentare. Neanche il tempo di ricordarsi le tappe importanti. Per esempio la lettura ginnasiale di quel racconto di Ovidio degli dei altissimi che chinano la testa per entrare nella capanna di quei due sposi poveri. Percepii che l’umiltà brilla come un gioiello ed è addirittura una qualità sontuosa. C’era tempo, ed ebbi tempo di capire bene che le cose stavano molto meglio di come apparisse. Fu una delle volte che vidi la speranza. Se non è così, le emozioni vanno via senza salutare e rimaniamo sulla porta allibiti, senza sapere se stiamo entrando o uscendo. Allora rimangono le ossa e due pietre. Se il tempo non fosse un meraviglioso labirinto dove sfiorare i misteri e vederli come sono, destinati a brillare lontano, resteresti solo tu, Paura. Senza l’onnipotenza della speranza, la paura è onnipotente, e impercepibile quel vento finissimo. Rimane di rigirarci inutilmente le mani in una stanza vuota, e dire: ah se avessi fatto questo, ah se avessi fatto quello. E la speranza? La speranza è di chi vive in ascolto. Un orecchio a terra lungo la ferrovia, vite come di Apache, a sentire il treno in arrivo, quando all’orizzonte ancora il treno non si vede. E così, un giorno che la guerra è finita da poco, un uomo guida la sua Topolino su una strada di montagna. Ha trentacinque anni, è un Robinson Crusoe scampato alla paura, ha un figlio piccolo e loro si sono salvati. La strada di montagna è spalancata, fa il dentista. Oggi lo hanno pagato con un sacco di farina, lo ha sistemato dietro al suo sedile. A una curva, raffiche di un mitra bucano la carrozzeria. Frena. Esce di macchina, grida “Dio” con un lungo grido. Si affida con tutto sé stesso a delle braccia che non vede. Pensa a tutto. La sua speranza che inizia a quella curva di montagna, si solleva, si alza tra le nubi, vola su una ferrovia, sopra l’Appennino romagnolo, e giunge al mare, oltrepassa le macerie di Genova, altre montagne, il suo Danubio, le ciminiere di Auschwitz, le betulle della pianura russa coi morti di tutti gli eserciti, i contadini che falciano il fieno, sorvola piccole città sconosciute dove bocche che si erano ammutolite hanno ripreso a parlare, delle volte a cantare, si baciano con altre bocche, e anche le gambe abituate a scappare e a marciare, adesso ballano il boogie, e la piccola speranza di uno solo che contiene speranze che sono di tutti, finisce in una curvatura dell’universo e torna ed eccola da lui davanti alla Topaolino, con le braccia alzate. Il mitra si inceppa. Gli spari ammutoliscono. Lo sconosciuto che sparava, forse un bandito, lascia cadere l’arma e fugge nel bosco. Il dentista abbassa le mani. Dopo un po’ va alla macchina, la controlla. Vede che si è salvato per due volte: la prima quando il mitra si è inceppato; la seconda volta è stata la prima, quando passava con la macchina e le pallottole si sono fermate sul sacco di farina dietro al suo sedile. La speranza lo aspettava. E tu Paura, che non si vede ma si sente, non ci sei mai stata.
|
|
Post n°80 pubblicato il 10 Marzo 2013 da Jiga0
di Jiga Melik (Huffington Post 09/03/13) Ho oltrepassato da ben undici anni quello che pudicamente chiamo mezzo secolo, e adesso sto come quando mi morì Jimi Hendrix. Ieri all'alba, mi è morto anche Alvin Lee. Sai, la chitarra rossa dei Ten Years After a Woodstock. Per quanto mi riguarda, il palco di Woodstock è rimasto vuoto. Alvin Lee suonò quel pezzo a folate di rock'roll, fraseggi rapidi, e ritmati, e con la voce nasale ripeteva: "I'm goin' home...going home baby, lock at me, baby, I'm comin' and get you, one more time". Vado a casa...vado a caso piccola, ti vengo a prendere... - si girava, guardava il gruppo, e sotto con la Gibson a riprendere il riff, a manciate: "Dai, un'altra volta", one more time, come quando bisogna riprendere lena e il pezzo ricomincia - cose del rock. Il film del concerto di Woodstock fu un evento imperdibile, mi sembra che uscì l'inverno del '70. Entrai al cinema Ariston di Firenze alle tre del pomeriggio di un lunedì, primo spettacolo, e primo giorno di programmazione. Avevo diciotto anni, i capelli arrivavano fino alle spalle nonostante i divieti di mio padre. Nelle orecchie, avevo i Cream e Hendrix, da ogni mattino a ogni mattino dopo. Venne il film di Woodstock, e fu una benedizione, lì non ero potuto andare. Lo avevo vagheggiato, discusso, adorato ed ero rimasto a Firenze. Era talmente lontano, Woodstock, da essere una mitologia nella mitologia. Lo avevo intravisto in un telegiornale in bianco e nero e nelle foto a colori delle riviste musicali. Ripeto, erano le tre del meriggio, al cinema non c'era nessuno, solo il profumo delle poltrone di velluto. Mi misi a sedere. Non conoscevo i Ten Years After e questo loro Alvin Lee, se non forse dal Melody Maker, la rivista inglese di musica rock e pop che andavo religiosamente a comprare sotto i portici del centro. Insomma, dal punto di vista dell'emozione musicale, andare a vedere Woodstock per me era andare a vedere per la prima volta nella vita Jimi Hendrix in azione, perché allora non c'era YouTube, e così entrai nel cinema vuoto pensando solo a questo, che ero andato per Jimi che suonava il suo inno americano e Purple Haze. E avrei visto la mia nazione, accampata e gioiosa, proprietaria balorda dell'eterna giovinezza. Mi misi a sedere. I Santana, Richie Havens ruggisce Freedom, e Joe Cocker, la voce roca, i movimenti convulsi e irregolari, le braccia fuori schema che sembrano tracciare una scritta obliqua nell'aria. Magnifico, non c'è altro da dire. Poi arrivarono i Ten Years After. E c'è questo qui, capelli lunghi, biondi, un tono inglese pacato. Credo che farò I'm goin home, sussurra. Come se dicesse, va bene, ora faccio merenda. Uno è lì al cinema, è l'inverno del 1970, danno Woodstock, i Ten Years After non li conosce, non lo sa quello che sta per succedere. E mentre accavalla le gambe, parte una tempesta di rock'n'roll da far drizzare i capelli i testa come aculei. La poltroncina rossa al cinema Ariston diventa una sedia elettrica. La chitarra di questo Alvin Lee scarica note a dozzine, rudi, veloci. Guardavo l'orologio, volevo sapere quanto tempo avessi ancora per presenziare a un fatto inesplicabile; e a quanto pareva il tempo proseguiva, l'assolo proseguiva, e Dio come ero fortunato che non avesse mai fine, undici minuti di quella pazzia, sembrava che smettesse, invece ricominciava. Da dove veniva questa energia, da dove veniva? Parlavo da solo nel cinema vuoto, quella chitarra era una centrale elettrica che illuminava il ventesimo secolo. Io proseguivo a trasecolare, la bocca spalancata. Gioia furiosa. Gettavo uno sguardo di lato, il cinema irrealmente vuoto e sullo schermo settecentomila ragazzi coi capelli lunghi facevano una festa finita mesi prima, ma la festa faceva il giro della terra e arrivava sino al cinema Ariston di Firenze, e in sala c'eravamo io e il Magro. E basta. Semmai c'era anche la maschera e avrà chiamato la cassiera: "O Luisa, vieni a vedere, questi sono bischeri spanati". L'unica delusione, il cinema vuoto. Del resto, era il primo spettacolo del lunedì pomeriggio, i normali erano a casa a fare i compiti: gente esangue. Morti, pensavo, siete morti. E così, vi dico, c'eravamo solo io e questo ragazzo coi capelli castani lisci fino a tre quarti della schiena. Lo conoscevo. Era così magro che mi chiedevo se fosse per povertà e perché proprio era magro. Portava sempre il gilet e sotto niente neanche a gennaio. Camminava le braccia di lato, inarcate come molle come quelle dei cowboys che stanno con le mani accanto alla fondina. Apriva la bocca e spuntava un fiorentino sguaiato. Solo che parlava poco. Mi sorrideva perché eravamo della stessa famiglia, e allora che fai, non saluti tuo fratello? E sorridevo. Neanche sapevo come si chiamasse, col sorriso sguincio sempre acceso. Ci vedevamo ai concerti, sotto il paracadute dello Space Electronic, il primo locale underground nato in Italia, una ex officina per riparare le auto. Lì venivano i grandi gruppi americani e inglesi: I Canned Heat, Brian Auger, Rory Gallagher. Lampeggiavano e sparivano. Vite da irregolari, mostrate ad altri irregolari. Poi, uno dei Canned Heat era ispanico e mezzo indio, mi sembra, finì fatto a pezzi e messo in una valigia, e ne parlammo affascinati. Rory Gallagher, altro straordinario chitarrista, era irlandese e suonava con i Taste. A Firenze, cadde dal palco alto dello Space Elettronic durante un assolo furioso. Mai visto qualcuno rimanere così allegro mentre forse muore. Per qualche interminabile istante, dei minuti, rimase sospeso in aria, impiccato al cavo della chitarra senza che nessuno si decidesse ad aiutarlo - rideva con il cavo elettrico intorno al collo e la Fender in mano, eravamo ipnotizzati e nessuno faceva niente. Lo salvò Tony Sidney, grande chitarrista italo-americano, che poi suonò nel Perigeo. E così, al cinema c'eravamo io e il Magro. E quando Alvin Lee finisce l'assolo che lo lancia nella Storia del '900 e se ne va formidabile dal palco, in mezzo al grido felice di settecentomila, in spalla porta un trofeo, quel gigantesco cocomero della campagna di Woodstock. La nazione hippie batte le mani, lui sorride, la giovinezza gli fa scintillare i denti, e lui sa di aver fatto l'impresa, diciamo un orlando furioso con una Gibson rossa fine anni Cinquanta, con sopra il simbolo di facciamo l'amore non la guerra. E sono in piedi nel buio del cinema e mormoro mamma mia, mamma mia, e so di aver partecipato alla Storia anche se qualche mese dopo, e per sicurezza, e per gioia, rimango al cinema fino all'una di notte, e rivedo Woodstock penso quattro volte. Il cinema si popola, si affolla, e ci sono gli applausi, Alvin e Jimi Hendrix, Jimi Hendrix e Alvin. E come certe volte della mia giovinezza, anche lì al cinema Ariston mi agguanta un presentimento di totalità, che io possiedo la vita e la cavalco come niente e so che non è affatto vero e non dura, è una bugia meravigliosa, e nel buio rido e piango e penso che me ne devo ricordare perché invece la vita è breve e queste cose capitano due volte o tre. Ed ecco, l'ho appena fatto. Ho ricordato. E infatti, caro Alvin nato a Nottingham, ma più che altro nato a Woodstock, oggi che sei morto all'alba e lo so stasera, sono triste tutto di un pezzo, come quando mi morì Jimi Hendrix. Sei uscito, e in spalla avevi la nostra giovinezza come un magnifico cocomero fresco. Il sette aprile dovevi suonare con Johnny Winter all'Olympia di Parigi. Sarebbero state scintille. Alzo il bicchiere, alla salute.
|

CAN EXPRESS - VOLUME SCANDALISTICO PER CANI



CERCA IN QUESTO BLOG
IL FRIGO GIA' PIENO
CHI PUÒ SCRIVERE SUL BLOG
I messaggi e i commenti sono moderati dall'autore del blog, verranno verificati e pubblicati a sua discrezione.
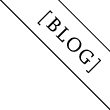



Inviato da: Jiga0
il 20/03/2012 alle 21:32
Inviato da: Jiga0
il 20/03/2012 alle 21:26
Inviato da: Jiga0
il 20/03/2012 alle 21:17
Inviato da: Jiga0
il 08/07/2011 alle 13:51
Inviato da: sergio
il 07/07/2011 alle 14:20