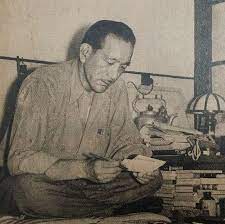Tokio boshoku (Crepuscolo di Tokio) è un film del 1957. Si tratta dell’ultimo film di Ozu in bianco e nero ed effettivamente è come se chiudesse un ciclo. Il film successivo Hingambana (Fiori di equinozio) sarà di fatto un’esplosione di colore e di solarità e la crisi familiare che vi sarà comunque rappresentata assumerà le tinte della commedia e solo in certi momenti incontrerà le sfumature del dramma. Qui invece siamo nel pieno di un dramma che sfocerà in tragedia. I toni sono lenti come sempre ma anche cupi, “crepuscolari” come dice il titolo, girato quasi sempre in interni anche poco illuminati e nelle ore serali o notturne, comunque quando il sole è già in declino. Per di più nella stagione più dura e ingrata: il freddo inverno di Tokio. L’ambientazione ci riserva quindi abbondanti nevicate, cappotti e guanti, cappelli invernali, stufe obbligatoriamente accese in locali fumosi dove la gente si rifugia per consumare un pasto caldo o per giocare d’azzardo.
Al centro di Tokio boshoku c’è la vicenda delle due figlie di Shukichi: Akiko che vive segretamente il dramma di una gravidanza indesiderata frutto di un rapporto con un suo coetaneo che continua a fuggire dalle sue responsabilità e non si fa più trovare da lei. Takako, la figlia maggiore che attraversa una crisi matrimoniale e a causa di ciò si è trasferita per un periodo a casa del padre con la bambina di pochi mesi, lasciando solo il marito. La vicenda delle due sorelle che si intreccia nella prima parte si complicherà ulteriormente nella seconda con la ricomparsa a Tokio della loro madre, scappata di casa con un altro uomo venti anni prima. C’è molto materiale in effetti per costruire un melodramma come si deve. Il tutto sarà però condotto dalla mano del maestro Ozu in modo “smorzato”, trattenuto e messo a distanza.
E’ la figura del padre in realtà a tenere insieme il quadro, a darne struttura e continuità mentre viene dipanato un tessuto familiare che si presenta fin dall’inizio imploso e sbrindellato. Il padre, impersonato come spesso accade nei film di Ozu dall’attore Kishu Ryu, che funge da “attore-feticcio” o alter-ego del regista, raccoglie in sé quanto di meglio ha saputo conservare ed elaborare la famiglia tradizionale a contatto con le nuove istanze di “democratizzazione” e l’ introduzione di principi liberali di marca occidentale. Pare per certi versi che l’intento di Ozu sia quello di offrire questa sintesi alle generazioni successive perché non buttino il bambino con l’acqua sporca.
E’ un padre che viene disegnato dal regista quasi come un simbolo vivente dell’eroicità del quotidiano. Di un saper rimanere al proprio posto senza alcun indietreggiare rispetto a quello che si sta abbattendo sull’istituzione che egli rappresenta. Egli ci ricorda molto il padre del film del 1942 : “Chichi Ariki” (C’era un padre) e di quando alla fine dopo la sua morte e dopo una vita trascorsa a svolgere il proprio compito e “senza mai perdere un giorno di lavoro” il figlio dirà alla moglie “mio padre è stato un uomo straordinario”. Egli mantiene qualcosa, un’ombra, di quell’eroicità condita dei valori del bushido quali la fedeltà, l’abnegazione di sé, lo sprezzo del pericolo e della morte, ma trasferiti in un contesto prosaico e pacifico, dove i nemici non brandiscono spade ne usano archi o frecce ma colpiscono invisibilmente e silenziosamente penetrando negli animi e introducendo disgregazione e confusione. Battaglia silenziosa quindi e tutta interna, interiore e spirituale.
Ozu stesso intervistato riguardo al film si meraviglia che l’attenzione del pubblico e della critica, che peraltro non lo ha sufficientemente apprezzato, si concentrasse soprattutto sul mondo giovanile che vi è rappresentato mentre lui voleva “ritrarre la vita del personaggio interpretato da Ryu (Kishu), un uomo lasciato dalla moglie che cerca di tirare avanti nella vita, insomma un film incentrato su una persona della vecchia generazione” (Yasujiro Ozu, Scritti sul cinema, a cura di Franco Picollo e Hiromi Yagi, Donzelli Editore, pag. 122).
Certo è un padre molto diverso dal marito di Takako, intellettuale sfuggente che fa dotte traduzioni e scrive articoli che parlano di “resistenza alla libertà”. Uomo peraltro dedito all’alcool e “nevrotico”, che non controlla le sue reazioni scomposte sulla bambina, che ai tentativi del suocero di mediare per riportare armonia nel suo matrimonio, latita, minimizza, cambia discorso.
Anche molto diverso dal giovane Ken, altro potenziale padre in fuga, preoccupato per il suo aspetto e la sua faccia smagrita mentre la sua ragazza si dibatte nella più cupa angoscia di fronte ad una scelta in cui lui la lascia totalmente sola.
Padri o mancati padri che rinnegando il proprio ruolo e rinunciando ad esercitarlo costringono il femminile in un angolo e lo obbligano a reagire: o con la disperazione come nel caso di Ken con Akiko o con un’assunzione virile di responsabilità come nel caso del marito di Takako con la moglie. La tendenza centrifuga colpisce tuttavia tutti i membri della famiglia, e le figlie come l’ex moglie ne sono a tutti gli effetti coinvolte e travolte. In tutto ciò appare ancora più eroica la figura di Shukichi.
Ancora qualche parola sul tema della colpa, uno dei temi dell’ultimo ciclo di incontri in biblioteca. In Rashomon di Kurosawa essa è abbracciata come paravento per la propria immagine, anche di fronte a sè stessi. I tre protagonisti se la assumono in pieno ma solo perchè facendo così possono salvare la faccia ed esibire una coerenza che è solo ideale.
Ne Il posto delle fragole di Bergman è un sentimento oscuro, opaco, indifferenziato che assume vari nomi :egoismo, freddezza, insensibilità, falsa generosità. La coscienza di esso si fa strada attraverso i sogni e l’inconscio e questo è il solo presupposto per risvegliarsi da una vita apparente che in realtà è morte e incontrare il proprio desiderio di clemenza, anche negli altri.
In Tokio boshoku la colpa è un bagaglio gravoso di cui si avverte il peso e se ne subisce le conseguenze. Non ci sono sconti nè attenuanti ma si può portare con rassegnata sopportazione e dignità. Su tutto cala un grande silenzio omissivo, non se ne parla per anni, un’aura di segretezza avvolge ogni cosa. C’è come un divieto tacito ad affrontare l’argomento, certo per non doverne soffrire o farne soffrire altri. Finchè non lo si fa costretti dalle situazioni. E’ una colpa che comunque riguarda tutti, nessuno escluso. Occorre comunque imparare dagli errori passati, farne tesoro. E anche saper girare pagina, accettare l’ineluttabile e iniziare a vivere una nuova giornata. Anche se è inverno.