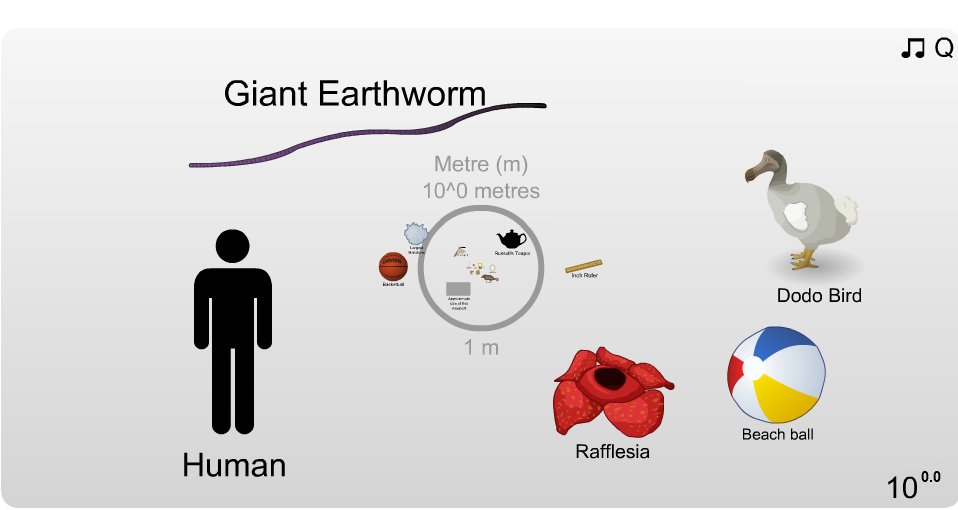|
Creato da m_de_pasquale il 05/10/2009
"il sapere ha potenza sul dolore" (Eschilo) ______________ "Perchè ci hai dato sguardi profondi?" (Goethe)
|
|
"La filosofia guarda da un altro livello cose, problemi, sofferenze, desideri, piaceri. E qui cade la solitudine del filosofo che non gode come gli altri, non soffre come gli altri, perchè non guarda le cose al livello dove le vedono gli altri. Per questo il filosofo è solo e incompreso. Della solitudine ringrazia ogni giorno gli dèi che gli tolgono di torno gli abitatori del tempo; dell'incomprensione si rammarica, non per sé ma per gli altri che non sanno quello che dicono e fanno." (Galimberti)
|
Post n°35 pubblicato il 10 Gennaio 2010 da m_de_pasquale
“Penso che l’illusione racchiuda il mio concetto d’amore … lo avevo idealizzato, mi piaceva tutto di lui … ma poi mi sono accorta che erano tutti castelli in aria…”; “L’illusione rappresenta il modo d’ingannare i sensi con vane speranze, per cui una falsa impressione viene creduta come realtà … si attribuisce consistenza ai propri sogni e alle proprie speranze … l’immaginazione mi libera dal peso della realtà…”. Sono alcune emozioni che un gruppo di ragazzi tra i 16 e i 18 anni hanno evidenziato all’interno di un’attività di consulenza filosofica sull’amore svolta nei mesi scorsi. Sembra che la fantasia faccia della persona amata un qualcosa di unico. Sebbene la psicoanalisi spieghi l’idealizzazione come una regressione – il trasferimento sull’amato del senso di unicità attribuito ai genitori quando si era bambini - essa, nell’amore, gioca un ruolo importante per l’attivazione del desiderio: la fantasia trasfigura la realtà affinché essa abbia un senso per noi. Dice Stendhal: “Ci si compiace di ornare di mille perfezioni la donna del cui amore siamo sicuri […] la nostra mente da qualunque occasione trae la scoperta di nuove perfezioni dell’oggetto amato […] il gaudio aumenta con le perfezioni dell’oggetto amato”. Quando la realtà (l’amato/a) è trasfigurata dall’idealizzazione diventa attraente e perciò seducente. Ma l’idealizzazione collocando tutto il valore nell’altro non ci impoverisce? E se l’altro non ricambia l’idealizzazione nei nostri confronti, non rimaniamo svuotati? A questa trasfigurazione della realtà non è preferibile un sano realismo per proteggerci dalla delusione della scoperta che reale ed ideale non coincidevano? E’ interessante considerare che l’idealizzazione innesca una tensione che fa dell’amore un’esperienza creativa,trasformatrice della realtà. Afferma Gentile: “Amare è volere. Se amiamo ciò che ha pregio e risponde all’ideale è perché quell’ideale non c’è e con l’amore lo vogliamo realizzare [...]. Ora quello che noi vogliamo, appunto perché lo vogliamo, non c’è già al mondo. […] La persona amata è quella ricreata dal nostro amore. È ricreata immediatamente e mediatamente: essa, cioè, è un nuovo essere per noi fin da quando prendiamo ad amarla; ma si fa realmente un essere sempre nuovo, si trasforma continuamente in conseguenza del nostro amore, che agisce su di essa, conformandola a grado a grado sempre più energicamente al nostro ideale. Insomma, l’oggetto dell’amore, qualunque esso sia, non preesiste all’amore, ma è da questo creato”. Ritorna l’enigma dell’amore oscillante tra esperienza del rischio e ricerca della sicurezza: passione (alimentata dall’idealizzazione, stimolante la creatività a reinventare il rapporto con tutti i rischi di ogni avventura) e stabilità (assicurata da un sano realismo che degrada l’idealizzazione). Un’altra tensione è quella tra l’essere se stesso e l’essere altro da sé. Si dice che per non essere estraneo all’altro, chi ama cerca di essere come l’altro lo vuole. Avviene una sorta di immedesimazione che si risolve nell’annullamento di sé nell’altro. Ma a questa maniera il rapporto non si riduce ad un gioco di maschere? Il gioco dell’inganno dell’amore come lo definisce Nietzsche: “Si dimenticano molte cose del proprio passato e le si caccia di proposito dalla mente: cioè si vuole che la nostra immagine, che irraggia dal passato verso di noi, ci inganni, lusinghi la nostra presunzione — noi lavoriamo continuamente all’inganno di noi stessi. E ora credete voi, che tanto parlate e decantate l”obliar se stessi nell’amore”, lo “sciogliersi dell’io nell’altra persona”, che ciò sarebbe qualcosa di sostanzialmente diverso? Dunque si infrange lo specchio, ci si immagina in un’altra persona che si ammira, e si gode poi la nuova immagine del proprio io, anche se la si chiama col nome dell’altra persona — e tutto questo procedimento non sarebbe inganno di sé, non sarebbe egoismo, gente strana! Io penso che coloro che nascondono qualcosa di sé a se stessi e coloro che a se stessi si nascondono come tutto, sono uguali in ciò a coloro che commettono un furto nella camera del tesoro della conoscenza: dal che risulta contro quale reato ci metta in guardia il detto: 'conosci te stesso'”. Che c’entra con l’amore l’allontanarsi da tutto ciò che di sé non piace, assumendo come propria identità quella dell’altro? Il tema qui è “se stessi” più che l’amore perché, ammirando l’identità dell’altro, si sceglie di rimuovere la propria per assumerne un’altra. E quando l’altro ricambia il mio amore, non significa forse che ama il mio “disconoscimento”? Come posso continuare ad idealizzare chi ama il mio disconoscimento? L’altro nel quale mi annullo è “l’altro reale” o la sua idealizzazione? Insomma stiamo parlando di una fusione d’amore o di un incontro mancato dato che ognuno si identifica con l’immagine idealizzata dell’altro? Forse è il caso di rinunciare alla immedesimazione per promuovere la differenza, il riconoscimento delle differenze individuali: solo se si salvaguarda l’identità di ciascuno si favorisce il gioco della seduzione (l’altro vuole condurmi a sé se c’è distanza). Quando c’è distanza diventa difficile la prevaricazione sull’altro per possederlo o la rinuncia di se stessi nell’immedesimazione. (Amore - 4 precedente successivo) |
|
Post n°34 pubblicato il 03 Gennaio 2010 da m_de_pasquale
A capodanno ci scambiamo gli auguri: ma che significa “auguri per il nuovo anno”? Nel Dialogo di un Venditore di almanacchi e di un Passeggere, Leopardi fa dire al Passeggere: “Una vita a caso, e non saperne altro avanti, come non si sa dell’anno nuovo”. Il Passeggere giunge a questa conclusione quando acquisisce il rifiuto del Venditore a rivivere la sua vita così come l’aveva vissuta “con tutti i piaceri e i dispiaceri che avete passati”. Questo perché nella vita sperimentata e che conosciamo con certezza, tutti abbiamo provato più male che bene, e pertanto “ciò vuol dire che se noi ci contentiamo ed anche desideriamo di vivere ancora, ciò non è che per l’ignoranza del futuro”. Perché il senso del nostro presente dovrebbe dipendere da un futuro imprevedibile? Non svalutiamo, così, il nostro presente? Se coltiviamo uno sguardo perduto nell’attesa del futuro è forse perché il nostro presente è così brutto? Siamo figli di un tempo che potremmo definire escatologico, quel tempo inaugurato dalla tradizione giudaico-cristiana secondo cui alla fine di esso si svela ciò che all’inizio era stato annunciato. Da questa idea del tempo nasce la “storia” come tempo fornito di “senso”, che la tradizione giudaico-cristiana prefigura nella redenzione e nella salvezza. E’ la temporalità dell’assoluto futuro che irradia sul tempo dell’uomo i tratti della speranza e dell’attesa del senso ultimo della storia. Questo schema che privilegia il futuro rispetto al passato si è mantenuto anche quando si è affievolito il senso religioso: esso ha continuato a vivere nelle figure secolarizzate della salvezza dove il passato appare come male, la scienza, l’utopia, la rivoluzione come redenzione, il progresso come salvezza. Afferma Galimberti: “Lo schema della storia della salvezza ha perso il suo contenuto ma non la sua forma, e il senso che la storia della salvezza aveva conferito al tempo si è trasferito nella teoria del progresso […] In questo modo un fondo soteriologico sopravvive anche nella più radicale desacralizzazione dell’escatologia religiosa, dove il tema della redenzione viene recuperato e ripresentato nella forma della liberazione”. Nella Gaia scienza di Nietzsche si trova una domanda simile a quella del Passeggere al Venditore di almanacchi, ma la risposta è diversa: “Che faresti se un giorno o una notte un demone si introducesse di soppiatto nella tua solitudine più solitaria e ti dicesse: «Questa vita, quale la stai vivendo adesso e l’hai vissuta, dovrai viverla ancora una volta e ancora innumerevoli volte; e in essa non ci sarà niente di nuovo, ma ogni dolore e ogni piacere e ogni pensiero e ogni sospiro e ogni cosa incredibilmente piccola e grande della tua vita dovrà per te ritornare, e tutto nello stesso ordine e successione - e così pure questo ragno e questo chiaro di luna tra gli alberi, e così anche questo attimo e io stesso. L’eterna clessidra dell’esistenza viene sempre di nuovo capovolta - e tu con essa, granello di polvere!»? […] gli diresti: «Tu sei un dio e mai ho sentito una cosa più divina!»? Se questo pensiero acquistasse potere su di te, avrebbe su di te, quale sei, l’effetto di trasformarti e forse di schiacciarti; la domanda di fronte a tutto e a ogni cosa: «Vuoi tu questo ancora una volta e ancora innumerevoli volte?» graverebbe sul tuo agire come il peso più grande! O quanto dovresti amare te stesso e la vita per non desiderare nient’altro che quest’ultima eterna conferma e suggello?”. Qui ci si muove in un tempo ciclico che riflette il tempo della natura dove ogni cosa non ha una finalità ma semplicemente una fine. Non c’è futuro che non sia la pura e semplice ripresa del passato che il presente ribadisce. Non c’è nulla da attendere se non ciò che deve ritornare. Non più un futuro che dà senso al presente, ma un eterno presente dove passato e futuro si dissolvono. Bisogna avere un amore sovrumano per la vita (la vita della natura dove il dolore e la morte sono momenti di essa e non contrapposti ad essa) per riuscire ad accettare questo tempo, E’ un tempo per spiriti forti: della dottrina dell’eterno ritorno Nietzsche parla solo a se stesso a differenza delle altre di cui parla a tutti (del superuomo) o a pochi (della morte di Dio e della volontà di potenza). Solo a se stesso perché è estremamente difficile non pensare più per cause e per ragioni (trovando un principio, la spiegazione causale ci rassicura; avere una ragione, un fine dà senso al nostro esistere). Forse per capire questo tempo dobbiamo rivolgerci al fanciullo che gioca (il fanciullo cosmico di Eraclito, il fanciullo delle Tre metamorfosi di Nietzsche) che è “oblio” perché vive in ogni istante completamente nel presente, che è “innocenza” perché il suo gioco non ha ragioni a cui ricondursi, non ha scopi da perseguire, è dominato dal caso. “Tutto va, tutto torna indietro; eternamente ruota la ruota dell’essere. Tutto muore, tutto torna a fiorire, eternamente corre l’anno dell’essere. Tutto crolla, tutto viene di nuovo connesso; eternamente l’essere si costruisce la medesima abitazione. Tutto si diparte, tutto torna a salutarsi; eternamente fedele a se stesso rimane l’anello dell’essere. In ogni attimo comincia l’essere; […] Ricurvo è il sentiero dell’eternità”. |
|
Post n°33 pubblicato il 20 Dicembre 2009 da m_de_pasquale
Mentre a Copenhagen le massime autorità mondiali si sono riunite per trovare un accordo sul clima, in tutto il mondo fervono ancora i preparativi per il Natale: addobbi, luci, spostamenti, regali… ma quanto si inquina a Natale? LifeGate, azienda che promuove la eco-cultura, ha calcolato che, nel periodo compreso tra il 25 dicembre e l'Epifania, ogni famiglia italiana consuma in media circa 386 kg di CO2: emissioni generate dagli spostamenti (acquisto regali, visite a parenti ed amici, gite fuori porta), dall'energia elettrica (consumi domestici, luci decorative), dalla produzione di rifiuti (carta da pacco, imballaggi vari), dall'utilizzo di acqua e dal riscaldamento per la maggior presenza in casa. Considerando l'intera popolazione italiana l'impatto ambientale stimato supera i 7,7 milioni di tonnellate di CO2! Il nostro Natale, col suo corredo di pratiche energivore costituenti ormai l’essenza della festa, oltre a costituire una palese dimostrazione di ateismo (ci vuole un po’ di fantasia per scorgere un riferimento religioso tra invasione di luminarie e canzoncine sentimentali, tra gentilezze ostentate ed obbligo al dono … per non dire della chiara contraddizione tra gli sprechi di questi giorni e i tanti Gesù che muoiono per colpa del nostro tenore di vita nel sud del mondo), è in chiaro contrasto con gli obiettivi che si volevano perseguire a Copenhagen: combattere l’innalzamento della temperatura sulla Terra. Esiste un calore “dannoso” che è quello emesso dalle nostre produzioni industriali ed abitudini consumistiche, ed un calore necessario per la vita sulla Terra che è quello del Sole. Afferma il nostro premio nobel Carlo Rubbia che il Sole ha in sé stesso la soluzione del problema che i “grandi” hanno tentato di affrontare a Copenhagen. Immagazzinando la sua energia con una intuizione antica (gli specchi di Archimede) sarebbe possibile risolvere il problema della produzione e del consumo energetico sulla Terra evitando di surriscaldarla utilizzando fonti non rinnovabili (petrolio, gas): “Basti pensare che un ipotetico quadrato di specchi, lungo 200 chilometri per ogni lato, potrebbe produrre tutta l'energia necessaria all'intero pianeta.” Che sogno: abbassamento della temperatura del pianeta, fine delle guerre, combattute, oggi, per il controllo delle fonti energetiche non rinnovabili. Ma il Sole, fin dalle origini della nostra storia, ha avuto a che fare col Natale: la consuetudine di festeggiare la nascita di Gesù il 25 dicembre è recente (a partire dal V secolo), mentre di molto antecedente era la festa del Natale del Sole invincibile (Dies Natalis Solis Invicti) nello stesso giorno. La festa coincideva con i giorni del solstizio d’inverno quando il Sole raggiungeva il minimo della sua forza e la diminuzione della sua luce in cielo costituiva per gli uomini una esperienza tragica che minacciava la stessa vita sulla Terra; bisognava aiutare il Sole ad innalzarsi (questo il senso dei fuochi accesi dagli uomini che con il loro calore e luce dovevano ridare forza al sole indebolito) e ciò avveniva, puntualmente, dopo il solstizio quando, aumentando gradualmente il suo corso in cielo, esso ritornava vitale ed “invincibile” sulle tenebre: il Natale del Sole. Tra le tante testimonianze antiche una delle più interessanti (e che avrà una forte influenza sul cristianesimo) è quella del dio indo-persiano Mitra (rappresentato come colui che inizia il Sole, inginocchiato davanti a lui, con un braccio steso sul suo capo, affinché esso apprenda il suo corso e lo persegua con regolarità e senza sconvolgimenti) partorito da una vergine, soprannominato il “Salvatore” ed anche lui con dodici discepoli. L’alleanza tra Mitra e il Sole garantisce la regolarità del suo ciclo (scomparendo la sera e risorgendo ogni mattina garantisce la continuità della vita sulla Terra) caratterizzato dalla continua distruzione delle singole forme (la morte è un momento della vita) per consentirne la riproduzione di nuove. Afferma Eliade: “il tramonto non è percepito come morte del sole, bensì come una discesa dell’astro nelle regioni inferiori, nel regno dei morti…. Il Sole ha il privilegio di attraversare l’inferno senza subire la modalità della morte… quantunque immortale, il Sole scende ogni notte nel regno dei morti: di conseguenza può condurre gli uomini con sé e, tramontando, farli morire; d’altra parte, può contemporaneamente guidare le anime attraverso le regioni infernali e ricondurle alla luce l’indomani, col giorno”. E’ l’eterno ritorno dove non c’è rimpianto e non c’è attesa perché la temporalità si esprime nella regolarità del ciclo. Se il Natale è per noi anche un ritorno là dove siamo nati (si dice “Natale con i tuoi” … ritorno a casa … ritorno alla nostra origine) per scoprire il significato della nostra nascita, la ciclicità del tempo attestata dalla regolarità del ciclo solare può costituire un paradigma temporale all’interno del quale collocare il nostro natale luminoso dall’oscurità del ventre materno verso l’oscurità della Madre Terra? O questa è una acquisizione troppo forte da sopportare e pertanto è più rassicurante un tempo progressivo, storico, il tempo dell’attesa di un compimento come quello inaugurato dalla nascita di Cristo che vede nella fine il fine (eschaton)? |
|
Post n°32 pubblicato il 16 Dicembre 2009 da m_de_pasquale
Anche se oggi non è molto frequente trovare “credenti” con certezze così salde da giocarsi la propria vita per esse, quelle volte che mi è capitato di dialogare con credenti “convinti”, devo confessare che sono stato sempre pervaso da un irritato stupore nell’osservare che alla fine, nonostante tutte le argomentazioni sollevate, l’interlocutore non nutrisse neppure una minima perplessità sulle sue convinzioni. La sua verità/convinzione non era assolutamente scalfibile. Ripensavo ad alcune affermazioni di Nietzsche: “Le convinzioni sono nemiche della verità, più pericolose delle menzogne … La convinzione è la fede di possedere, in un qualche punto della conoscenza, la verità assoluta … Non è la lotta delle opinioni che ha reso la storia così violenta, ma la lotta della fede nelle opinioni, cioè la lotta delle convinzioni”. Una convinzione è la solidificazione di una posizione – comunque parziale anche se sentita “totale” dal “fedele” – come possono esserlo le costruzioni metafisiche e teologiche, determinazioni concettuali che raccogliendo e precisando in sé ogni possibile senso non tollerano la polivocità di sensi, non consentono diverse interpretazioni. Una posizione univoca è per definizione universale (è questo il significato di cattolicità) perché, non essendoci altri significati a cui rinviare, in essa si esaurisce tutta la verità. Sostiene Jaspers che l’unicità, l’universalità e la cattolicità sono la stessa cosa: “Non solo la chiesa cattolica ha concepito questo pensiero dell’unica verità escludente, perché includente tutto il vero, quando ha fondato con un’altissima costruzione di pensiero il proprio punto di vista… Il pathos della verità unica, accompagnato dall’entusiasmo per l’universalità, per l’unità di tutti gli uomini e di tutta la storia in quell’unica verità, è propria anche della filosofia dell’idealismo tedesco”. La convinzione, quindi, ha a che fare con l’univocità perché definisce un solo significato non tollerandone altri: di qui la sua violenza e prepotenza che si manifesta nella fede di possedere una verità assoluta. Ecco i caratteri della fede religiosa. Se la verità coincide con l’imposizione di un significato escludendone altri (per nostra fortuna, oggi, non ci sono più roghi ed inquisizioni che castigano il rifiuto) l’annuncio del credente ha a che fare con la volontà di verità o piuttosto con la volontà di potenza? Chi ritiene di avere il possesso definitivo della verità non privilegerà il contenuto della sua fede piuttosto che la comunicazione autentica col suo interlocutore? La convinzione del credente, spacciata per verità universale, fondata su un’autorità “trascendente” non rischia di essere poco eloquente per il mondo “immanente”? Non viene, forse, accentuata la separazione col rischio di relegare la “verità” del credente nell’al di là metafisico, nella fantasia mistico-religiosa (trascendenza senza immanenza), o nella pura adesione al dato storico, nella identificazione con le manifestazioni mondane della fede quali strutture come chiese, stato, famiglia ecc. (immanenza senza trascendenza)? L’univocità – che secondo una consolidata convinzione è la condizione della universalità e quindi della verità – è la solidificazione, l’irrigidimento della tensione tra immanenza e trascendenza. L'uomo, invece, ha bisogno di questa tensione per esistere (ek-sistenza = continuo uscire da sé stessi, esperienza della possibilità, della libertà). L’irrigidimento della univocità rischia di relegarci in un al di là fantastico e storicamente non incidente, o in un al di qua oggettivo dove non ci sono “esistenze” ma vite regolate, omologate, conformate. “Tutti vogliono le stesse cose, tutti sono uguali: chi sente in maniera diversa se ne va spontaneamente in manicomio” (Nietzsche). La polivocità, invece, è sorella della trascendenza immanente, del mantenimento della tensione continua tra i due poli (quello della immanenza, della storicità della mia situazione; quello della trascendenza, della possibilità dell’esistenza, dell’uscir fuori) senza la risoluzione dell’uno nell’altro. La vita non è nell’irrigidimento di uno dei due poli, ma nella continua tensione tra i due. Ed una tensione richiede una fede che è sinonimo di rischio e non di certezza. La fede filosofica, a differenza della fede religiosa, sa custodire la polivocità, la tensione oltrepassante; “consapevole di non disporre di una verità universalmente valida [non essendoci univocità non c’è una verità universale] non scomunica, non dichiara eretici i dissenzienti, non accende roghi, non dispone di libri sacri privilegiati rispetto ad altri, perché contenenti la verità assoluta. La fede filosofica sa di essere per via e non scambia la via incerta con la meta definitiva. La fede è filo-sofica perché ama (phìlei), si protende verso la sapienza (sophìa), ma non la possiede” (Galimberti). Si potrebbe concludere ricordando la suggestiva immagine nietzschiana del viandante [non del viaggiatore che comunque ha una meta sicura da raggiungere come ci ricorda ogni chiesa]: “Chi sia giunto anche solo relativamente alla libertà della ragione, sulla terra non può sentirsi altro che un viandante… egli ben vuol guardare, e tenere gli occhi aperti su tutto quel che veramente accade nel mondo; per questo non gli è consentito unire troppo strettamente il suo cuore a nessuna cosa particolare; dev’esserci in lui stesso qualcosa di nomade, che gioisca del mutamento e della provvisorietà”. |
|
Post n°31 pubblicato il 13 Dicembre 2009 da m_de_pasquale
“La Gelosia è una specie di Timore, che si riferisce al Desiderio che abbiamo di conservare il possesso di qualche bene; e non deriva tanto dalla forza delle ragioni, che fanno ritenere di poterlo perdere, quanto dalla grande stima che ne facciamo, che ci spinge ad esaminare anche i più piccoli motivi di sospetto, e a prenderli per ragioni molto importanti”. La definizione di gelosia data da Cartesio nella sua opera Le passioni dell’anima, ci porta a ritenere che questa passione sia frutto, più che del timore ragionevole di perdere un bene, della esagerata considerazione di esso tale da indurci ad ingigantire anche i più piccoli sospetti. In amore la gelosia ha a che fare con l’esclusività: io devo essere l’unico per l’altra/o, devo essere il preferito (ritorna il narcisismo infantile); l’altro/a è un bene di cui solo io devo godere. Per Freud queste caratteristiche rimandano all’amore esclusivo per il genitore del sesso opposto (vedi complesso di Edipo) rivissuto in età adulta ogni volta che si teme di perdere l’amore per la persona da cui si dipende emotivamente: risuona l’eco delle paure di abbandono vissute nell’infanzia, così come infantile è il modo di riviverle se desideriamo uccidere chi ci ha privato dell’esclusività del nostro amore. L’esclusività richiama la fedeltà, anche se si possono manifestare opinioni diverse: per alcuni la fedeltà è sinonimo di possessività (la molteplicità di relazioni sessuali garantisce salute, felcità…), per altri la fedeltà costituisce la condizione per garantire la tranquillità della famiglia consentendo ai suoi membri l’autoaffermazione sociale. Ritorna la tensione, tipica dell’amore, tra passione e desiderio di stabilità. Così come ritorna un’altra tensione quando si considera la diversa percezione della gelosia tra i partner: io posso essere geloso perché questo è segno della mia fedeltà; il mio partner non deve esserlo nei miei confronti perché la sua possessività mi fa mancare l’aria! La gelosia manifesta sempre la sua doppia faccia: l’idea che l’altro possa essermi infedele colpisce la stima di me stesso perché perderei l’unicità nei confronti del mio partner; l’idea, invece, che io possa essergli infedele riaccenderebbe il mio narcisismo infantile e ravviverebbe la fiducia in me stesso dato che sono oggetto di attenzioni da parte di un altro/a. Ma al di là di queste considerazioni è scontata la situazione di malessere in cui verrebbe a trovarsi la persona gelosa che vede alterata la percezione, l’attenzione, la memoria, il pensiero e il comportamento come sostiene la psicologa D’Urso: “la percezione si accentra e si fa minuziosa nei riguardi di tutto ciò che direttamente o indirettamente riguarda la persona amata e i rivali, sia che essi siano reali, potenziali o immaginari. Inoltre aumentano in modo abnorme e selettivo i processi di attenzione, mentre la memoria diventa fortemente selettiva e concentrata su piccoli eventi normalmente trascurati, come l’orario di una telefonata, le incongruenze nei discorsi, un’insolita cura nell’abbigliamento. Il pensiero subisce un vero e proprio stravolgimento nel suo vorticare intorno all’idea del tradimento, fino a sfiorare le soglie del delirio paranoico, dove anche gli eventi più innocenti e insignificanti vengono assunti come prove irrefutabili che la propria gelosia è assolutamente giustificata”. Rabbia, dolore, indignazione accompagnate dalla diminuzione della stima di sé: se il geloso non mette in campo una strategia di controllo di questa passione se la passa proprio male. Cartesio sostiene che la gelosia può essere onesta quando deve conservare un bene molto grande, ma essa è riprovevole (blasmable) in altri casi come quando si scambia il vero amore col possesso: “E si disprezza un uomo geloso di sua moglie, perché è un segno che egli non l’ama in modo giusto, e che ha cattiva opinione di sé o di lei. Sostengo che non l’ama in modo giusto; infatti, se provasse vero Amore per lei, non avrebbe alcuna inclinazione a diffidarne. Ma non è proprio lei che egli ama, è solo il bene che egli immagina consistere nel possederla da solo”. Si ama l’altro/a o il proprio potere sull’altro/a? Sembrerebbe, a dirla con Fromm, che nell’amore si sia trovato un rifugio alla solitudine, si sia formata un’alleanza a due contro il mondo e questo egoismo a due è scambiato per amore. Il mondo è sentito ostile e pauroso e di conseguenza l’amante diventa un riparo da cui non si può prescindere per vivere? Un egoismo che nasce dalla mancanza di amore per sé con conseguente bisogno di possedere l’altro per colmare il proprio vuoto? Ed allora se la gelosia compare quando l’amore si confonde col bisogno di possesso – segno di un amore dipendente che ha bisogno di riempire carenze –, non ci si cura da essa solo separando l’amore dalla possessività? (Amore - 3 precedente successivo) |
|
Post n°30 pubblicato il 08 Dicembre 2009 da m_de_pasquale
“E’ arrivato il prof. Etarcos [chi sarà? leggi al contario… ] che voi chiamate lo strano e che ci sta facendo filosofare da vicino, problematizzando, discutendo, argomentando, preparando mensilmente le tesi contrapposte e argomentate da sostenere uno contro uno in un pubblico dibattito dialogato, appassionato e ragionato su un tema da noi scelto. Certo, questo prof è strano, perché è un filosofo e la scuola è allergica al filosofare, ma è adatta, piuttosto, a somministrare pillole di filosofia. E’ raro che un prof di filosofia sia un filosofo. Ci sono troppi prof di filosofia che fanno i filosofi e c’è qualche raro filosofo che, poveraccio, fa il prof di filosofia per sbarcare il lunario. Ma un filosofo è in rotta di collisione con la scuola, le interrogazioni, i questionari, i tests, i giudizi e gli esami”. E’ una delle battute finali dell’ultimo libro [A killer on the Occident Express – Malatesta Editrice – euro 9] scritto da Francesco Capriglione, strano esemplare (in via di estinzione?) di filosofo locale. L’autore ripercorre, con pungente arguzia e profondità d’analisi, con un linguaggio divertente (diverte perché diverge) il cammino della ragione in occidente tra le lusinghe del potere ed il fascino della libertà: la ragione che per vincere l’angoscia del divenire ha creato stabilità, certezze che ci consentano di sopravvivere: dal to agathon (il Bene) di Platone al Dio cristiano; la ragione dissacrante, smascherante che ha denunciato questi tentativi ingannevoli. La metafisica è stato il prodotto della operazione rassicurante della ragione che insieme al suo surrogato, la religione, ha costituito il puntello del potere. “Filosofi” celebrati dal potere perché organici ad esso e filosofi perseguitati dal potere perché disadattati, disomologati, dissacratori. Come Ipazia, straordinaria figura di filosofa vissuta nel IV secolo d.C., invisa al potere e fatta a brandelli da monaci fanatici su mandato del santo vescovo di Alessandria, Cirillo: “Ipazia è scomparsa. Dove la trascina quella folla impazzita? Nella chiesa se ne scorgono le tracce, lasciate dai brandelli delle sue vesti. I monaci e la plebaglia cristiana fra grida selvagge si scagliano sulla loro vittima. I brandelli dei suoi abiti giacciono dispersi nella navata della chiesa; la trascinano fino ai gradini del pulpito, fino all’altare. Lei sfugge per un attimo ai suoi feroci inseguitori, si alza in piedi e cerca di parlare, ma un’ondata umana la getta a terra, le si precipita di nuovo addosso. Un grido straziante fa tremare la volta. Il grido si muta in un gemito, che si va affievolendo e, infine, si spegne”. Ed allora la filosofia ha a che fare col mondo delle certezze inossidabili della metafisica o piuttosto con la tensione, con la ricerca arrischiante? Fede religiosa basata sulla certezza o fede filosofica fondata sul rischio? E’ più importante la risposta o la domanda? “Bisogna trasformare qualsiasi because in why”. La filosofia è tensione verso un’ulteriorità di senso, è possibilità di accesso ad una logica simbolica oltre una logica disgiuntiva, è il richiamo dell’assenza oltre la presenza. In ciò la forza debole della filosofia di fronte ai prodotti del potere: “Democrazia è tirannide camuffata. Rimembro. Scegliere liberamente i propri padroni significa non eliminare né schiavi né padroni. Nella macchina necrofila del potere dominano solidarietà servili e vincoli osceni di complicità. Al mercato del potere sfilano protettori, prosseneti, mediatori, puttanieri, ruffiani, lenoni, magnacci, battoni, clienti, puttani: la varia umana disumanità di quel servizio pubblico che è la politeia. Questo esercito suicida di servi omicidi trova nella repressione del proprio eros la coltura e l’esaltazione di thanatos. Questa terribile ragnatela lavorata dal potere tesse la farsa del voto: i superprostituti si candidano a protettori, i prostituti ringraziano, i protettori si rallegrano, gli schiavi continuano ad alimentare il regno di thanatos”. Ma l’azione della filosofia si dispiega solo con i prodotti esteriori della potenza separatrice della ragione o anche con quelli interiori come la separazione dalla nostra antica follia? Esiste uno spazio “terapeutico” per la filosofia che faccia i conti con un io separato ma dipendente da un inconscio pulsionale? E se a questa dipendenza si aggiunge quella dal sistema, operante come una grande gabbia in cui viviamo come “liberi” schiavi? Sembrerebbe che nonostante i ripetuti assassinii, ci sia ancora vita per “chi ha per padre il dubbio, per madre l’ignoranza, per moglie l’insicurezza e per figlia l’ironia”! Invito per la presentazione del libro. Le foto della serata. |
|
Post n°29 pubblicato il 02 Dicembre 2009 da m_de_pasquale
Cartesio nelle Meditazioni metafisiche si propone di dimostrare anche la distinzione dell’anima dal corpo: “Meditationum de prima philosophia in quibus Dei existentia & animae a corpore distinctio demonstrantur”. Discutendone in classe, gli studenti sono rimasti affascinati da questa posizione: la piena autonomia del pensiero, nel senso che esso è sostanza (ciò che basta a sé stesso) “ … è il pensiero, la sola cosa che non può essermi tolta … sono una cosa pensante”. Per il nostro filosofo, il pensiero è sinonimo di mente, intelletto, ragione, res cogitans, spirito, io, cogito: insomma di realtà spirituale. E’ sinonimo di anima la cui conoscenza è immediatamente certa dato che essa costituisce la prima realtà ad emergere dalle ceneri del dubbio estremo (posso dubitare di tutto ma non che io stia dubitando, perciò esisto). Ma l’anima può esistere come un principio autosufficiente dal corpo? Costituisce il vero principio nel senso che è all’origine di tutte le manifestazioni spirituali? Non rappresenta, forse, “il colpo di genio del cristianesimo”, come afferma Nietzsche, perché essendo incorruttibile ed immortale ha tolto agli uomini il terrore della morte? L’idea della divisione dal corpo dell’anima e della sua autosufficienza nasce con Platone e costituirà uno dei filoni determinanti dell’antropologia occidentale. Per Platone l’anima nasce per un’esigenza epistemologica: affinché si pervenga ad una verità universale, bisogna prescindere dalla certezza sensibile proveniente dal corpo appunto perché le sensazioni corporee sono instabili, variabili. L’anima (io razionale) è separata dal corpo (a cui, nel mito della biga alata, viene associato il cavallo nero espressione dei suoi appetiti). Questo dualismo antropologico si radicalizza in Cartesio che spezza l’io dell’uomo in corpo e anima. Il corpo da soggetto viene ridotto ad oggetto, relegato nella res extensa, come gli altri oggetti. L’anima è sottratta ad ogni influenza corporea, pensata come puro intelletto nei cui pensieri c’è ogni senso del mondo. Uomini e mondo ricevono senso dalle cogitazioni dell’ego che compongono la nuova scienza. Finisce l’io umano che abita il mondo, che abita un corpo e si afferma un ego cogito, un io decorporeizzato che attraverso le sue funzioni produce oggetti ideali che valgono come norma per l’interpretazione delle cose reali. Il corpo così come è visto dall’ego cogito diventa il corpo oggettivo, un insieme di parti aventi tra loro una relazione meccanica: è il corpo così come lo vede la medicina moderna. Successivamente con la nascita della psichiatria il concetto di anima (psiche, coscienza) si rafforza perché bisognava sopperire a un deficit metodologico e cioè spiegare tutto quello che non si riusciva a spiegare dopo aver ridotto, per le esigenze della scienza, il corpo a pura quantità, a semplice sommatoria di organi. Se torniamo, però, ad una visione originaria scopriamo che nella grecità – prima dell’avvento della filosofia – così come nella tradizione biblica, esiste una concezione unitaria dell’uomo: il corpo non è cosa opposta all’anima. La Bibbia in particolare possiede una visione unitaria dell’uomo a forte accentuazione corporea (non fa mai riferimento all’anima nei termini in cui se ne può parlare sotto l’influsso del pensiero platonico). I termini che ancora oggi usiamo, significativi del dualismo, sono il risultato di un tradimento delle parole originarie usate nella Bibbia: nefes (vita dell’uomo nella sua indigenza) è stato tradotto in greco con psychè e poi in latino con anima; ruah (vento, respiro, potenza di Dio) è stato tradotto in greco con pneuma e poi in latino con spiritus. E’ evidente che le traduzioni hanno accentuato l’idea di un principio (anima) autosufficiente dal corpo che diventerà addirittura immortale. Ed allora come possiamo spiegarci l’anima? Come è nata? Afferma Galimberti: “L’umanità ha sempre chiamato anima la differenza che avvertiva tra sé e gli animali. La parola si è prestata a molti equivoci, ma Nietzsche la sorprende alla sua origine, là dove sorge, in quella incompiutezza che fa dell’uomo l’animale non ancora stabilizzato”. La tesi è la possibilità di rintracciare l’essenza di ciò che chiamiamo anima nella costituzione incompiuta dell’uomo, nella carenza istintuale che lo differenzia dall’animale. L’animale, dotato istintualmente, ha la capacità di adattarsi alla natura e quindi sopravvivere; l’uomo per la sua carenza istintuale deve trasformare la natura in una natura artificiale tale cioè che consenta la sua sopravvivenza. Come afferma Gehlen: “L’uomo vive essenzialmente in una seconda natura, in un mondo da lui stesso trasformato e vòlto al vitale servizio dei suoi bisogni, vive in una natura artificiale”. L’uomo è costretto ad agire per sopravvivere. Nei suoi tentativi di adattamento fa tesoro dei risultati raggiunti che formano il tessuto della memoria: l’interiorità è il riflesso dell’esteriorità. A questi schemi immagazzinati a cui l’uomo farà regolarmente ricorso, darà il nome di anima, ragione, intelletto, spirito. L’anima quindi nasce dall’azione dell’uomo. E’ l’azione che produce la riflessione: l’anima non è originaria. |
|
Post n°28 pubblicato il 28 Novembre 2009 da m_de_pasquale
Come spiegarci la forza d’attrazione che l’altro o l’altra esercitano su di noi? Cosa ci seduce dell’altro/a: ciò che vediamo o ciò che si nasconde? E’ seducente la presenza o l’assenza? La visione del corpo è una delle esperienze più seducenti che esistano e siamo portati a pensare che la visione del corpo nudo sia il massimo dell’erotismo. La nostra società che ha il suo dio nella produzione, ha capito bene come funzione ed infatti usa la seduzione per la produzione: la pubblicità che associa bei corpi a merce da vendere. Ma perché un’abbondanza di corpi nudi o la visione prolungata del corpo nudo a lungo andare diminuisce sempre più il desiderio? Sembrerebbe che quanto più il corpo si riveli tanto più diminuisca la sua capacità seducente, è come se avesse detto tutto e non ci sia niente altro da immaginare. Fine del gioco estetico-erotico. Fine del desiderio. Afferma Baudrillard: “La seduzione non si basa sul desiderio o sull’attrazione: tutto questo è volgare meccanica e fisica carnale, nulla di interessante. Certo, il fascino della seduzione passa attraverso l’attrattiva del sesso. Ma, propriamente, vi passa attraverso, la trascende. Per la seduzione, infatti, il desiderio non è un fine, ma un’ipotetica posta in gioco. Anzi, più precisamente, la posta in gioco è provocare e deludere il desiderio, la cui unica verità è brillare e restare deluso. […] Attraverso lo specchio prismatico della seduzione si perviene ad un altro spazio di rifrazione. Essa consiste non nell’apparenza semplice, non nell’assenza pura, ma nell’eclissi di una presenza. La sua unica strategia è essere là e non essere là, e assicurare così una sorta di ammiccamento intermittente, dispositivo ipnotico che cristallizza l’attenzione al di là di ogni effetto di senso. Qui l’assenza seduce la presenza”. La seduzione dischiude la trascendenza. Nel frammezzo tra visibile ed invisibile io scopro il mio desiderio che coincide col gioco ambiguo della presenza/assenza. Il desiderio è alimentato da un corpo che si intravede (quello che si vede, abbiamo detto, lo spegne): è più erotica una nudità esplicita o una nudità che si intravede dalle vesti? La trasparenza alimenta l’immaginazione rendendo possibile la tensione verso una ulteriorità di senso; è come se si conquistasse la possibilità di superare quella prigionia di significati a cui il corpo è costretto. Ed allora il corpo dell’altro è il fine della seduzione o l’occasione per alimentare il desiderio che significa apertura ad una ulteriorità (= trascendenza)? La seduzione così intesa potrebbe contribuire a rifiutare la settorializzazione del corpo in determinati significati tra cui la sua riduzione a fonte di piacere per l’economia libidica, favorendo, così, l'apertura del gioco della ambivalenza che ci consentirebbe di percepire il corpo nel suo senso originario, recuperandone la natura polisemica, prima di tutti i significati impostigli? Se la demarcazione sessuale con la distinzione del maschile e del femminile è stata un’operazione della Ragione (siamo ambivalenti: nessun essere è relegato “per natura” in un solo sesso) per consentire l’organizzazione sociale, di fronte alla omofobia dilagante, figlia, appunto, della settorializzazione del corpo (corpo maschio e corpo femmina), non potrebbe costituire una cura il recupero della ambivalenza sessuale? Il recupero dell’originario senso ambivalente del corpo prima di ogni principio d’ordine che ha posto la distinzione tra maschio e femmina e nell’evoluzione successiva la prevaricazione del primo sulla seconda? (Amore - 2 precedente successivo) |
|
Post n°27 pubblicato il 25 Novembre 2009 da m_de_pasquale
Se dovessimo descrivere cos’è la felicità analizzando quelle situazioni in cui veniamo a trovarci e che associamo ad essa, potremmo dire che è uno stato di perfetto benessere in cui avvertiamo un sentimento di illimitata espansione che si svolge in una fusione con ciò che ci circonda, uno stato d’animo armonioso caratterizzato da sensazioni di tranquillità, pace. Solo che saremmo tutti d’accordo nel sostenere che questo stato di grazia è temporaneo, accade per brevi periodi. E’ possibile assicurargli continuità? Aristotele nell’Etica Nicomachea sostiene che ogni nostra azione è tesa a perseguire un bene; il bene pratico più alto è la felicità. Solo, continua, non c’è un grande accordo su cosa sia la felicità: “la massa e le persone più volgari giudicano che il bene e la felicità consistono nel piacere (hedoné)”. C’è, in effetti, uno stretto collegamento tra felicità e godimento derivante dal piacere dei sensi, forse perché attraverso questi sperimentiamo quella fusione col mondo di cui parlavamo. Se consideriamo i piaceri del cibo e del sesso, prototipi del piacere in generale, constatiamo che in essi vengono sollecitate le esperienze del gusto e del contatto che sono appunto quelle che ci permettono di giungere meglio ad una identificazione armoniosa con l’oggetto del desiderio. I piaceri del cibo e del sesso sono intensi, veementi, impediscono al soggetto di pensare, ostacolano il suo pensiero in quella capacità che i greci chiamavano phronesis (= intelligenza/prudenza): infatti la nutrizione e la generazione costituiscono quelle funzioni elementari che più ci avvicinano agli animali e quindi distanti da ciò che è proprio dell’uomo, il pensiero. Nei piaceri d’amore non si pensa, quanto più si pensa tanto meno si gode. In particolare nel piacere sessuale sono implicati tutti i sensi: sia quelli della distanza che presiedono alla eccitazione (l’udito – sentire la voce e il respiro del partner - , la vista – guardare il suo corpo, le sue movenze - , l’olfatto – sentire l’odore -), sia quelli del contatto che presiedono alla soddisfazione (il tatto, il gusto). I piaceri della gola – in particolare il bere - abbassano le censure, ingenerano un’ebbrezza tale da sciogliere i sensi e liberare gli affetti, ci si abbandona liberandosi al gioco. Ma afferma Natoli: “I piaceri della mensa – nella specie quelli del bere – e i piaceri d’amore vengono tra loro associati poiché, ordinariamente, danno ebbrezza più di ogni altro piacere. Ora, è a tutti noto che l’ebbrezza abolisce la percezione del limite ed è per questo che persuade gli uomini di felicità”. Ci sentiamo felici perché salta la percezione del limite? Si tratta di godimento o soddisfazione? Il godimento può non implicare la soddisfazione, mentre la soddisfazione non può esistere senza godimento. Allora il piacere deve cercare la soddisfazione – che è appunto altra cosa dal godimento immediato – e la felicità, probabilmente, ha a che fare col buon uso dei piaceri, ma affinché ciò avvenga occorre l’intervento del pensiero che ripristina la distanza rendendo possibile cogliere l’oggetto del desiderio nella sua interezza evitando di ridurlo ad occasione di un godimento puntuale. In altri termini la distanza, ovvero la ricerca della giusta misura, consente di andare oltre l’intensità istantanea del godimento per orientarsi verso la stabilità e la durata nel tempo. Del resto, se pensiamo al principio di costanza di Freud, è più doloroso un piacere intenso e discontinuo che la diluizione dell’intensità nella stabilità. Quindi il gioco è nella dialettica soddisfazione/contenimento del desiderio. Non basta però, occorre anche allargare il campo delle facoltà che intervengono nella produzione del piacere aprendo, così, altre possibilità di soddisfazione con sensazioni analoghe a quelle derivanti dai piaceri dei sensi. Se Leopardi parlando della poesia può dire che essa: “… destando mozioni vivissime, e riempiendo l’animo di idee vaghe e indefinite e vastissime e sublimissime e mal chiare ec., lo riempie quanto più si possa a questo mondo”, significa che non solo i sensi ma anche l’intelletto e la memoria concorrono a produrre soddisfazioni altissime. Un ultimo passo va fatto dopo aver assodato l’importanza della giusta misura e della necessità di guardare ad ampio raggio alla questione del piacere considerando non solo quello proveniente dai sensi. Siamo portati a legare la felicità a qualcosa di esterno a noi da possedere, con cui identificarci. Ma cosa ci attrae: l’oggetto o la sensazione di benessere che proveremo dalla identificazione con esso? Esiste un oggetto in grado di assicurarci stabilmente quello stato di benessere, armonia che contraddistingue la felicità? Dove scoveremo questo oggetto? Potremmo individuarlo in quel compito, proprio dell'uomo, che è la conoscenza di sé, la sola che ci consente di diventare quello che siamo e quindi realizzare la fusione, l’identificazione che ci renderebbe felici? La felicità non coincide, forse, col “diventare ciò che si è” (Nietzsche)? |
|
Post n°26 pubblicato il 21 Novembre 2009 da m_de_pasquale
Sarà che ne possiamo disporre facilmente quanta ne vogliamo (basta aprire o chiudere un rubinetto e non farsi chilometri per prenderne solo qualche litro come accade in Africa), che ne abbiamo tanta da sprecarla (per ogni pipì che facciamo consumiamo per il risciacquo 15 litri d’acqua), che non pensiamo alla necessità vitale che ne abbiamo (senza il petrolio si può vivere, senza acqua no), sarà per tutto questo che trattiamo l’acqua come una cosa a nostra disposizione fino a renderla merce da comprare e vendere? Abbiamo dimenticato che l’acqua è la sostanza primordiale da cui nascono tutte le forme e alle quali tornano come recita l’Enuma Elis (poema mesopotamico della creazione del XIII secolo a.C.): “Quando in alto i cieli non avevano ancora un nome, ed in basso la terra non era chiamata con un nome, e il primordiale Apsu [personificazione delle acque dolci], che li generò, e Mummu, e Tiamat [personificazione delle acque salate], madre di loro tutti, confondevano le loro acque in un solo tutto…” ; abbiamo dimenticato che il Cielo abbraccia la Terra e la feconda con l’acqua della pioggia e che l’acqua, in tanti miti antichi, non solo fa germinare la vita ma è la sostanza medicinale per eccellenza che guarisce, ringiovanisce ed assicura la vita eterna; non facciamo più caso al potente simbolismo del passaggio dalla morte alla vita espresso dalla immersione nelle acque che disintegrando ogni forma e facendo ritornare all’indistinto, rendono possibile una nuova creazione restaurando l’integrità delle origini (il simbolismo cristiano del fonte battesimale in cui il neofita scende – si immerge significando la morte – e poi passando attraverso le acque risale – ritorna ad una nuova vita –): “il destino delle acque è di precedere la creazione e di riassorbirla” (Eliade); abbiamo dimenticato che la filosofia nasce con il pensiero dell’acqua come ci ricorda Aristotele nella Metafisica: “Talete dice che il principio è l’acqua (per questo afferma anche la terra galleggia sull’acqua) desumendo indubbiamente questa sua convinzione dalla costatazione che il nutrimento di tutte le cose è umido, che perfino il caldo si genera dall’umido e vive nell’umido. Ora, ciò da cui tutte le cose si generano è, appunto, il principio di tutto.”; abbiamo dimenticato che per Empedocle, filosofo siciliano del V secolo a. C., l’acqua acquisisce una sacralità tale da essere considerata una dea, Nesti, che “con le sue lacrime distilla il fonte mortale”, radice che, insieme al fuoco (l’energia, il calore di cui abbiamo bisogno), all’aria e alla terra, da origine a tutte le cose; abbiamo dimenticato che Eraclito per raccontare il flusso del divenire e quindi anche l’esperienza del tempo che ci sfugge di mano, maggior cruccio della nostra vita perché ci avvicina alla fine, abbia usato l’acqua: “ A chi scende nello stesso fiume sopraggiungono acque sempre nuove. Non si può discendere due volte nel medesimo fiume e non si può toccare due volte una sostanza mortale nel medesimo stato, ma a causa dell’impetuosità e della velocità del mutamento si disperde e si raccoglie, viene e va. Noi scendiamo e non scendiamo nello stesso fiume, noi stessi siamo e non siamo”. Ebbene, sarà per tutto quanto dimenticato che sembra non suscitare alcuna reazione l’ennesima legge porcata approvata dal Parlamento italiano, il decreto-legge 135/09 che stabilisce all’art. 15 la privatizzazione dell'acqua dando la possibilità ai privati di trattare come una merce il bene fondamentale che ci fa vivere? intervento di Alex Zanotelli contro la privatizzazione dell'acqua |
|
Post n°25 pubblicato il 18 Novembre 2009 da m_de_pasquale
Talvolta accade, durante le lezioni, che gli studenti sollecitino una mia posizione sulla religione: siete credente o ateo? Mentre sul ruolo politico della Chiesa (di buona parte dei vertici di essa e di quegli integralisti che ne fanno parte) manifesto sempre la mia posizione molto critica, sul fatto se sia credente o meno – devo dire la verità – non mi appassiono molto perché si tenta di ingabbiare, semplicisticamente, la questione del sacro nella scelta per uno schieramento o il suo opposto. Ho usato di proposito il termine sacro e non religione ed affini, perché è questa l’esperienza originaria fatta dall’uomo; in effetti il sacro “non implica necessariamente la credenza in Dio, negli dèi o negli spiriti, ma si riferisce a quella esperienza connessa all’idea di essere, significato e verità” (Eliade). Dio si inserisce con ritardo in questa esperienza originaria del sacro. Afferma Galimberti: “Sacro è parola indoeuropea che significa ‘separato’. La sacralità, quindi, non è una condizione spirituale o morale, ma una qualità che inerisce a ciò che ha relazione e contatto con potenze che l’uomo, non potendo dominare, avverte come superiori a sé, e come tali attribuibili a una dimensione, in seguito denominata ‘divina’, pensata dunque come ‘separata’ e ‘altra’ rispetto al mondo umano”. Cosa sono queste potenze che l’uomo avverte come superiori a sé e che poi acquisiranno una dimensione divina? Potrebbero essere gli istinti, le pulsioni subite, patite (di qui il termine passione) dall’io razionale il quale non riesce a collocarle nel suo ordine e perciò legge come 'altro da sé'? Sentite come ‘altro da sè’, è facile che diventino delle proiezioni antropomorfiche dando origine agli dèi? Se così è, il sacro ha a che fare con quello che la psicanalisi chiama il ‘profondo’ (inconscio), con quella follia che ci abita, non la follia intesa come il contrario della ragione, ma la follia originaria, quella che precede ogni distinzione tra la ragione e il suo opposto. Il sacro ha a che fare con quel fondo pre-umano, indifferenziato: “… nelle religioni primitive il sacro è il luogo dove si manifesta la cieca violenza, la sessualità selvaggia, l’entusiasmo fuori misura, il dolore sordo e cieco … al sacro appartengono tutti quei simboli della natura per quel tanto che è estranea alla cultura (istinti, pulsioni, eccessi…)… vi appartengono i mostri, i morti, i demoni…. Il sacro coincide col nucleo di follia che ognuno di noi avverte dentro di sé come non culturalizzabile, non interpretabile… tutto ciò che sfugge alla logica della ragione…” (Galimberti). Se di fronte al numinoso – come afferma Otto – proviamo non solo attrazione (fascinans), ma anche paura (tremendum), tendiamo a tenerci lontano da ciò che ci inquieta. Sembra che ‘religione’ provenga da relegare (recingere): si perimetra l’area del sacro (che ha il suo personale – i sacerdoti -, il suo spazio – il tempio -, i suoi tempi diversi dai tempi profani) in modo da garantire la separazione e regolarne il contatto con gli uomini. Pertanto il sacro ha a che fare con un gioco ambivalente: tenere a distanza per regolare l’accesso. La logica della separazione obbedisce ad una esigenza di difesa: se una cosa è oggettivata, allontanata, può essere controllata. Ma essa è anche distinta da me. Il male viene separato dal bene. Ciò che è separato diventa il male (dal greco dia-ballein = separare): la parola diavolo vi ha familiarità. La distinzione viene ulteriormente accentuata grazie alla relazione di causalità. Se è vero quello che sostiene Nietzsche [“Ricondurre qualcosa di non conosciuto a qualcosa di noto solleva, calma, soddisfa, dà inoltre un senso di potenza … L’impulso di causalità è condizionato e stimolato dal sentimento di paura”], individuando in Dio la causa prima (origine dell’uomo e delle cose), confermiamo la bontà della nostra natura essendo Dio il “Sommo Bene” [per Platone “to agathon”] , e quindi marchiamo ulteriormente la distanza dal ‘male’, dalla dimensione inquietante. Ma conoscere la causa significa anche possibilità di previsione (come ben sa la scienza) e quindi controllo del futuro, vittoria sull’ignoto. Quindi il sacro ha familiarità con quella dimensione che ci appartiene (e che, sentendola minacciosa, ci farebbe comodo pensarla come separata da noi), dimensione della confusione totale, dell’indifferenziato, della follia, del simbolico (sym-ballein = comporre) dove c’è “questo e anche l’altro”, dove c’è – a voler usare una terminologia che è solo successiva alla operazione della ragione – il bene e il male insieme, la gioia e il dolore insieme, la vita e la morte insieme. L’esistenza umana non deve accostarsi troppo al sacro per non esserne dissolta, ma non deve neppure troppo allontanarsene per non perdere gli effetti della sua presenza fecondante “perché – scrive Jung – l’inconscio è la matrix dello spirito umano e delle sue creazioni ed è spesso impossibile dire che cosa è spirito e che cosa è pulsione. L’uno e l’altra sono un impasto insondabile, un vero magma che emerge dalle profondità remotissime del caos originario”. Se il sacro ha a che fare con quel fondo pre-umano che ci abita, quel fondo incomprensibile allo sguardo della ragione che opera in termini di differenze, separazioni, distinzioni, ma accessibile solo al linguaggio indifferenziato (una cosa è questa ed anche l’altra) dei simboli che alimenta mitologie, fantasie, allucinazioni, se il sacro ha abitato questo mondo non costituisce anche per l’uomo contemporaneo una straordinaria opportunità della conoscenza del proprio "sé" profondo? A chi potrà rivolgersi l’uomo contemporaneo per gestire la sua follia se oggi le religioni, nate per tenere a bada il sacro, hanno abdicato alla loro funzione e sono diventate strumento di politica e di potere (si interessano dell’8 per mille, di prendere soldi per le scuole cattoliche, moraleggiano sulla sessualità, …)? |
|
Post n°24 pubblicato il 15 Novembre 2009 da m_de_pasquale
La grande acquisizione di quel processo, avvenuto tra il XVI e XVII secolo, che definiamo rivoluzione scientifica è stata l’elaborazione del nuovo metodo della scienza la cui essenza è l’anticipazione matematica che deve trovare conferma con l’esperimento. E’ nota la dialettica tra le “sensate esperienze” e le “necessarie dimostrazioni” galileiane, straordinaria sintesi di senso e ragione, induzione e deduzione, matematica e fisica. Dopo aver ridotto la natura ai suoi elementi quantitativi (= matematizzazione della natura) viene formulata una ipotesi – una anticipazione – che, affinché possa fregiarsi di caratteri di universalità e necessità, deve essere confermata dall’esperimento. La certezza – ovvero il nostro pensiero (una qualità soggettiva) – viene a coincidere con la verità – ovvero con l’effettivo stato delle cose (una qualità oggettiva): l’ipotesi anticipata corrisponde perfettamente al mondo elaborato dallo sguardo quantitativo. Per Galilei il pensiero coincide con l’essere. E’ solo il caso di precisare che la generalizzazione (la proposizione scientifica universale) è possibile sulla scorta di due presupposti: l'uniformità della natura e la conformità di essa alla struttura matematica impostale dalla ragione (sguardo quantitativo). E' bene sottolineare che questi presupposti sono posti dalla ragione e non dati dall’esperienza. Ma l’azione della ragione scientifica, con le sue generalizzazioni, non si limita solo all’ordinamento del mondo presente, essa guarda anche al futuro con la sua potenzialità previsionale: sa in anticipo cosa accadrà al momento dell'accadimento di determinate condizioni. Così davvero la scienza è potenza come sosteneva Bacone, iscrivibile nella storia della volontà di potenza: “la scienza e la potenza umana in questo coincidono, che l'ignoranza della causa rende vano l'effetto”. La verità scientifica, così intesa, non è più l’uscire dal nascosto (come i greci intendevano col concetto di alétheia), ma è una disposizione dell’io legislatore della natura, essa viene a coincidere con l’oggettività che è di fronte ad una soggettività la quale appunto vuole la cosa davanti a sé nelle modalità che ha anticipato. Il sapere scientifico possiede, così, in anticipo l’oggetto; il possesso è la potenza sull’oggetto. Si pongono, a questo punto, due domande: ma davvero il mondo conosciuto dalla scienza è il mondo che abito? Il mondo conosciuto dalla scienza non si presta, forse, più facilmente ad essere usato ed al limite sfruttato? Ci ricorda Husserl: “Nella matematizzazione geometrica e scientifico-naturale, noi commisuriamo al mondo-della-vita (al mondo che ci è costantemente e realmente dato nella nostra vita concreta che si svolge in esso) nell’aperta infinità di un’esperienza possibile, un ben confezionato abito ideale, quello delle cosiddette verità obiettivamente scientifiche. Il travestimento ideativo fa sì che noi prendiamo per vero essere quello che invece è soltanto un metodo”. Abbiamo scambiato ciò che è solo un metodo per la verità del mondo. Una tecnica previsionale diventa la sola chiave di lettura del mondo che abito facendone perdere tutta la varietà e ricchezza. L’io che abita il mondo non è l’intelletto a cui è sottratta ogni influenza corporea, non è il soggetto oggettivante che utilizza nessi causali per spiegare ciò che gli sta di fronte. E’, invece, l’io che fa esperienza vissuta (erlebnis) del mondo-della-vita (lebenswelt), un mondo soggettivo, corporeo, in cui percepiamo le cose soggettivamente prima di ogni considerazione scientifica, è il ritorno al mondo della doxa che, seppure scalzato, sin dai tempi di Platone, dall’epistème, è l’unico mondo che ha un senso per noi perché è il mondo della nostra esperienza ingenua prima di ogni altra manipolazione. Quando la superstizione scientifica “che nasce dalla falsa coscienza, la quale pensa che la nostra vita sia basata sulla scienza e sia da dirigere con la scienza” (Jaspers) ci induce a credere che l’unico mondo possibile sia quello che, come un oggetto, è alla mercè della mia soggettività e quindi utilizzabile, manipolabile senza più limiti come sta avvenendo nella nostra età della tecnica, si comprende la drammaticità delle domande di Heidegger: “ Siamo forse alla vigilia della più mostruosa trasformazione della Terra intera, e dello spazio temporale a cui essa è legata? Siamo in cammino verso il luogo storico di questo crepuscolo della terra?” |
|
Stamattina in classe si è parlato di mafia. Di fronte alla mia affermazione che per sconfiggere la mafia basterebbe semplicemente non considerare i diritti come favori, i miei studenti mi hanno guardato un po’ straniti. Prima di tutto bisogna essere consapevoli dei propri diritti, secondo esigerne il rispetto: questa pratica consolidando il riconoscimento della mia identità di cittadino (aumentando l’autostima civica), rafforza la sovranità pratica che la Repubblica mi riconosce (art. 1 della Costituzione). Se non sono suddito, non devo chiedere, pietire, implorare favori, devo, invece, esigere il rispetto dei miei diritti. La forza della mafia è nella logica e pratica clientelare – ricalcante l’antica relazione feudale: favore in cambio di obbedienza – che instaura rapporti di soggezione e non di partecipazione. Quindi creare dipendenza è la forza della mafia. La dipendenza – di cui spesso è colpevole una classe di governo che non pone tra le sue priorità i diritti (soprattutto quello al lavoro) che qualificano la funzione civica, ma si disperde in interessi particolaristici tesi a perpetuare il proprio potere – è il volto del consenso: un potere si mantiene in piedi solo se riceve il consenso. La sua forza non gli proviene da sé, ma dal consenso che gli inviano i sottoposti: se il consenso viene ritirato, il potere crolla come un gigante dai piedi d’argilla. Il consenso è la dipendenza che noi manifestiamo quando, inconsapevoli dei nostri diritti, chiediamo il favore. Il consenso si manifesta in tanti modi, uno di questi è il flusso di denaro che si dirige verso il potere: se si blocca questo flusso, il potere crolla. Quanto nostro (si intende anche quello pubblico) denaro percorrendo circuiti tortuosi o abbastanza diretti va a finire nelle tasche delle mafie! Il controllo del denaro è strategico nella lotta alla mafia: non servono eroi per combattere la mafia, ma la determinazione di tutti noi nell’orientare il denaro in canali virtuosi e non mafiosi. Ed allora la lotta alle mafie si gioca indubbiamente sul versante culturale (l’affermazione di una cultura della legalità, del diritto, dei diritti), ma anche sul versante economico (interruzione dei flussi di denaro che entrano nelle casse delle mafie). Per questo motivo una delle priorità di LIBERA [associazioni, nomi e numeri contro le mafie] è l’attuazione della legge 109/96 che prevede il riutilizzo sociale dei beni confiscati alla criminalità organizzata. Nei giorni 12 e 13 dicembre prossimi farà tappa a San Severo la Carovana Antimafia: alcune iniziative si svolgeranno presso l’Art Village. lezione sulla mafia di Paolo Borsellino ad un gruppo di studenti |
|
Post n°22 pubblicato il 10 Novembre 2009 da m_de_pasquale
Nei mesi scorsi ho svolto con due diversi gruppi di studenti, tra i 16 e i 18 anni, un’attività di consulenza filosofica sull’amore. In un esercizio dovevano descrivere le emozioni ricorrenti, i sentimenti provati in relazione all’esperienza amorosa. Tra le emozioni/sentimenti più gettonati: il desiderio e la passione. Riporto – trascrivendo fedelmente – alcuni interventi: “La passione è uno dei pilastri fondamentali dell’amore: se non c’è si cade nella monotonia; è strettamente collegata al desiderio.”; “Il desiderio mi fa provare strane sensazioni come le farfalle allo stomaco: quanto più una persona mi sembra irraggiungibile, più la desidero”; “Il desiderio è strano perché desideriamo qualcosa che molto spesso non possiamo avere, e questa mancanza non fa altro che aumentarlo”; “Il desiderio provoca sbalzi d’umore perché colui che è desiderato non è raggiungibile”; “Il desiderio a volte spinge a fare cose quasi insensate di cui spesso ci si pente; è strano, ma più una persona è irraggiungibile e più la si desidera”; “La passione è una stregoneria da cui non si può fuggire. La passione è il paradosso che vede la ragione scontrarsi col desiderio dell’altro”. Questi ragazzi raccontano – partendo dalla loro esperienza – ciò che Platone aveva già raccontato a proposito della nascita di Eros nel Simposio: “Penìa, nella sua povertà, ebbe l’idea di avere un figlio da Poros [espediente]: così si sdraiò al suo fianco e restò incinta di Eros.”. Eros, continua Platone, possiede gli stessi caratteri dei genitori: povero, rude, senza casa (dalla madre); sempre pronto a tramare inganni, capace di trovare le strade per arrivare dove vuole (dal padre). Quindi Eros, essendo mancante di tutto, desidera, e prova tutti gli espedienti per avere ciò che gli manca: il desiderio è una tensione costante che fino a quando non viene soddisfatta procura sofferenza. Per la fenomenologia, noi (il nostro corpo) abitiamo il mondo, ed in questo abitare viviamo una intenzionalità con l’altro: il desiderio è la manifestazione della intenzionalità (che coincide con l’apertura, e quindi con l’andare oltre il mio corpo = trascendenza). Il turbamento che proviamo quando viene messa in pericolo la propria identità (ogni apertura comporta sempre un abbandono) è la passione. L’esperienza del desiderio ci lacera: voglia di aprirsi, di andare oltre noi stessi (trascendenza) e attaccamento alla sicurezza della casa. Ma se dell’amore abbiamo l’idea di una esperienza di protezione, sicurezza, intimità, che rapporto c'è col desiderio che, invece, parla di rischio, avventura, tensione? Dice Freud: “dove amiamo non proviamo desiderio, e dove lo proviamo non proviamo amore”. Infatti se il desiderio non sa che cosa vuole (è tensione continua), non si lascia governare da una logica e non ha regole (vagabondo come l’Eros platonico), l’amore, invece, che cerca stabilità e sicurezza, tende a spegnere il desiderio. La spiegazione potrebbe essere nel fatto che “L’umanità ha sempre barattato un po’ di felicità per un po’ di sicurezza” come sostiene Freud? Anche la passione gioca con la trascendenza essendo il turbamento provato per la messa in pericolo della propria identità nella sua disponibilità a trascendersi. Afferma Stendhal: “Dubbio ed incertezza tengono desto il desiderio e viva la scintilla della passione che la certezza, invece, uccide”. La passione è sofferenza perché non possiede; essa scompare nel momento in cui possiede: si nutre del “non ancora”, si nutre dell’assenza più che della presenza, essa è, a dirla con Lèvinas “godimento del trascendente”. “Il carattere passionale dell’amore consiste nella dualità insuperabile degli esseri. E’ una relazione con ciò che si sottrae per sempre e che è impossibile tradurre in termini di potere”. Ma allora con il piacere – si pensi al godimento sessuale – sancendo il possesso dell’”oggetto” e quindi l’interruzione della tensione, non si fa forse l’esperienza dello svanire della passione? L’amore torna a rivelarsi come una esperienza enigmatica che viaggia tra protezione ed esposizione, misura ed oltrepassamento di essa, ordine ed eccesso, possesso e libertà, immanenza e trascendenza, amore come modo d’avere ed amore come modo d’essere. Forse Platone ha ragione quando nel Simposio parlando degli esseri che Zeus ha diviso a metà dice: “Queste persone che passano la loro vita gli uni accanto agli altri non saprebbero nemmeno dirti cosa s’aspettano l’uno dall’altro. Non è possibile pensare che si tratti solo delle gioie dell’amore: non possiamo immaginare che l’attrazione sessuale sia la sola ragione della loro felicità e la sola forza che li spinge a vivere fianco a fianco. C’è qualcos’altro: è evidente che l’anima di ciascuno vuole altra cosa che non è capace di dire, e perciò la esprime con vaghi presagi, come divinando da un fondo enigmatico e buio”. Ed allora l’amore è l’esperienza dell’unione simbiotica con l’altro/a? ci innamoriamo del pieno? O piuttosto non ci innamoriamo del vuoto, di quel “fondo enigmatico e buio” verso cui la forza del desiderio (= trascendenza) ci spinge? Quale relazione si gioca veramente nell’amore: quella con l’altro/a o con la parte più profonda del proprio io? (Amore - 1 successivo) |
|
Post n°21 pubblicato il 08 Novembre 2009 da m_de_pasquale
Se uno dicesse che si è recato sulla spiaggia, si è seduto sulla sabbia ed ha cominciato a guardare il mare; poi, guardando il ritmo continuo delle piccole onde sulla battigia, considerava che nessuna onda è uguale a quella precedente e che la loro vita è brevissima (nascono dal niente e ritornano al niente); pensava ancora che pur essendo così effimera la vita delle onde ciò che vi è d’identico in loro (l’acqua) rimane, non perisce, anzi costituisce l’occasione del loro apparire e scomparire. Beh col nostro fare spiccio e pratico, potremmo pensare che un tipo del genere è abbastanza stupido perché al posto di usare l’acqua del mare per farsi un bagno o farsi un bel giro con un acquascooter, perde il suo tempo per qualcosa che non gli serve a niente. In effetti il pensiero che ci è abituale è quello che assegna un significato alle cose (agli enti) sulla scorta della categoria dell’utilità. Non più lo sguardo meravigliato sulle cose, ma la domanda solita: a che serve? Ci sfugge lo sguardo sulla totalità, mentre ci si concentra sulle parti nella misura in cui possiamo servircene: “La foresta è legname, la montagna è cava di pietra, la corrente è forza d’acqua, il vento è vento in poppa” (Heidegger). La categoria di utilità determina il senso di tutto. Il passo, poi, verso l’appropriazione di ciò che è utile (il senso della proprietà!) ed il mezzo attraverso cui ci appropriamo delle cose, cioè il denaro, è breve: il senso ultimo di tutte le cose è nel denaro. Una malattia è all’origine di tutto ciò. Scrive Severino: “Si comincia a scoprire la malattia mortale. Ma chi se ne preoccupa? L’Occidente è una nave che affonda, dove tutti ignorano la falla e lavorano assiduamente per rendere sempre più comoda la navigazione, e dove, quindi, non si vuol discutere che di problemi immediati, e si riconosce un senso ai problemi solo se già si intravedono le specifiche tecniche risolutorie. Ma la vera salute non sopraggiunge forse perché si è capaci di scoprire la vera malattia?”. Questa malattia è l’oblio dell’essere: si distoglie lo sguardo dalla condizione (l’essere) che fa essere le cose (gli enti), per concentrarsi su di esse, riducendole ad oggetti per un soggetto (l’uomo) pronto così a dominarle: inizio della storia del progressivo controllo del mondo da parte dell’uomo grazie agli strumenti che si è dato (la scienza e la tecnica); inizio dell’esercizio della volontà di potenza. Se solo gli enti esistono, l’essere viene considerato come un nulla, un niente: in questa logica è insito l’esito nichilista. Ma se l’essere si annuncia in occasione della manifestazione dell’ente [la sua presenza non esaurendosi nell’ente, instaura un rapporto di trascendenza immanente: è sempre aperto un pensiero che va oltre = metafisica], c’è la possibilità di tornare dal solitamente pensato (ente) al solitamente impensato (essere)? Dove trovare oggi le tracce dell’essere? Per Jaspers c’è stato un periodo nella storia del pensiero occidentale ed orientale (attorno al VI secolo a.C.) in cui il pensiero si è collocato oltre gli enti nell’ascolto problematico del messaggio dell’essere, la cui parola si coglie nell’annuncio del mito oltre la logica codificata dalla ragione. Anassimandro e Lao Tzu appartengono al periodo assiale, così come vi appartengono Eraclito e Parmenide. Questi due filosofi sono stati considerati, dalla tradizione, antagonisti: Eraclito il filosofo del divenire e Parmenide quello dell’essere, movimento contro stabilità. In realtà, sostiene Jaspers, ambedue “pensano in modo diverso ciò che è sempre. L’uno [Parmenide] pensa l’essere nell’identità logica e nella tranquillità trascendente di una perfezione senza cambiamento, l’altro [Eraclito] nella dialettica logica e nella tranquillità trascendente del nòmos immutabile. L’uno coglie il senso dell’essere nell’unità in cui si annienta la contraddizione, l’altro nella contraddizione che si cancella in virtù dell’unità dei contrari.” All’essere di Parmenide corrisponde il lògos di Eraclito: e se il primo pone l’attenzione sulla positività [l’essere è], il secondo sul fatto che senza il negativo non ci sarebbe il positivo [l’unità dei contrari]. Il tutto (= il logos eracliteo e l’essere parmenideo) fa essere le parti (= la molteplicità che si disvela dall'uno) le quali conservano la loro verità se non cadono nella tentazione dell’isolamento (= mantengono l’apertura verso ciò che ha consentito loro di essere), cioè se viene mantenuta quella condizione di trascendenza immanente. Eraclito pensa che una cosa possa definirsi solo nell’opposizione ad un’altra (il giorno è tale in contrapposizione alla notte): “Polemos è padre di tutte le cose, di tutte re”; ma questa opposizione non si risolve nell’annientamento di una cosa a scapito dell’altra: “congiungimenti sono intero e non intero, concorde discorde, armonico disarmonico, e da tutte le cose l’uno e dall’uno tutte le cose. Non comprendono come, pur discordando in se stesso, è concorde: armonia contrastante, come quella dell’arco e della lira. Una e la stessa è la via all’in su e la via all’in giù”; il lògos è, appunto, questa armonia invisibile che accoglie l’unità degli opposti “l’opposto concorde e dai discordi bellissima armonia”. Parmenide concependo l’essere come un intero [“tutt’intero, unico, immobile e senza fine”] ritiene che esso sia quell’unità che ospita la molteplicità; ma purtroppo gli uomini non sanno andare oltre l’apparenza nonostante il consiglio accorato del filosofo [“Ma tu da questa via di ricerca allontana il pensiero / né l’abitudine nata dalle molteplici esperienze ti costringa lungo questa via, / a usar l’occhio che non vede e l’udito che rimbomba di suoni illusori / e la lingua, …”] per cogliere che la verità è nell’unità che comprende tutto. Solo percorrendo la via dell’essere (secondo Parmenide) o guardando l’armonia invisibile (secondo Eraclito) possiamo cogliere la verità, ovvero l’unità del molteplice. Quindi quando il nostro sguardo è dominato dall’apparenza (doxa) ci disperdiamo nella molteplicità, nel pensiero delle parti dimenticando il tutto (cioè l’essere) condizione del loro manifestarsi; e così le parti ( = gli enti) diventano oggetti a disposizione della nostra volontà di potenza, inaugurando, così, la malattia dell’Occidente. Il metodo di guarigione è chiaro. |
|
Post n°20 pubblicato il 05 Novembre 2009 da m_de_pasquale
Grande scalpore sta producendo la sentenza della Corte di Strasburgo sulla questione dell’esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche. Questi i fatti. Nel 2002 due genitori di Abano Terme chiedono al Consiglio d’istituto della scuola frequentata dai loro figli di non esporre il crocifisso sul muro dell’aula scolastica nel rispetto della laicità dello stato e della Scuola pubblica. Il Consiglio d’istituto respinge la richiesta. I genitori ricorrono al TAR contro il Consiglio d’istituto: il Tribunale Amministrativo, pur definendo non infondate le motivazioni dei ricorrenti, rimette la questione alla Corte Costituzionale. La suddetta Corte rispedisce il ricorso al TAR perché non ha competenza nel dichiarare incostituzionale un regolamento: infatti l’esposizione del crocifisso è definita da un regolamento (non una legge) e pertanto non è sottoposto a giudizio di legittimità costituzionale. Il TAR del Veneto respinge, quindi, il ricorso che, successivamente, viene portato dai ricorrenti al Consiglio di Stato il quale, a sua volta, lo respinge perché il crocifisso “esprime valori che delineano la laicità nell’attuale ordinamento dello Stato”. I genitori non si arrendono e ricorrono alla Corte Europea di Strasburgo che ha emanato nei giorni scorsi la discussa sentenza: la presenza dei crocifissi nelle aule scolastiche è "una violazione della libertà dei genitori ad educare i figli secondo le loro convinzioni e della libertà di religione degli alunni". Io continuo a pormi ingenuamente, ma credo con buon senso, la domanda: che c’entra il crocifisso (simbolo religioso) con un’aula scolastica (che non è una chiesa o un luogo di culto) dove si fa e trasmette cultura? Il crocifisso è un simbolo “scandaloso” perché chi pretende di essere Dio appare come un essere umano povero, umile e sofferente. Kierkegaard riflettendo sull’inno contenuto nella Lettera ai Filippesi di Paolo [“ … Rinunziò a tutto; scelse di essere come servo e diventò uomo tra gli uomini … fu ubbidiente sino alla morte, alla morte in croce”] scrive: “Lo scandalo nel senso più stretto, lo scandalo kat’exochén si riferisce all’ Uomo-Dio […] quando lo scandalo è in direzione dell’abbassamento, nel senso che colui che è Dio è quell’uomo umile che soffre come un umile … impotente, il quale, nel momento di passare ai fatti, si mostra assolutamente incapace di tutto”. Nella polemica di questi giorni il crocifisso da scandalo in senso kirkegaardiano, viene brandito come un’arma politica: stride il contrasto tra la debolezza della croce e l’uso arrogante e violento che si fa di essa. Simbolo omologante per la chiesa (di una parte di essa) e i suoi baciapile politici (quelli che alla luce del giorno moraleggiano, e poi di nascosto fottono minorenni e pippano) per controllare meglio masse uniformate, viene presentato come un fattore importante dell’identità di una nazione. Ma si può fondare un’identità collettiva (ammesso che sia possibile oggi) su una tradizione religiosa che nella pratica degli italiani spesso è solo una formalità che ha perso il carattere scandaloso, di contraddizione, di paradossalità che evidenziava Kierkegaard? Più che di identità, non si dovrebbe parlare di senso di appartenenza che rende stabile una società, il quale è rafforzato dall’aumento della solidarietà? La solidarietà non si acquisisce quando esiste un impegno concorde nel garantire a tutti i suoi membri libertà ed uguaglianza, rimuovendo tutti gli ostacoli per i quali tanti cittadini non sono uguali e liberi come recita l’art. 3 della nostra Costituzione? Scrive Stefano Benni: “Quanti cristi inchiodati a una sedia o a un letto la gente scavalca, per inchinarsi a un cristo di legno. Quanti sacrifici dimenticati, per ricordarne uno. Se mi facessero entrare in una chiesa, griderei: smettete di guardare quell’altare vuoto. Adoratevi l’un l’altro”. Pertanto ha prodotto più danni alla solidarietà - sociale, politica, economica - l’approvazione dello scudo fiscale che quella che potrà produrre l’eventuale rimozione dei crocifissi! Ed allora si comprende che la posta in gioco – mai dichiarata - che infiamma l’anima di tanti prelati e politici non è tanto l’identità (cristiana) di un popolo, ma il mantenimento del potere di una certa chiesa sulla società italiana: che miseria quando si pensa ai temi che impone la riflessione sul dolore e la morte insite nel simbolo del crocifisso! Il crocifisso nella tradizione cristiana sintetizza la funzione del dolore nell’economia della salvezza: il dolore è la conseguenza di una colpa originaria che chiede riparazione, ma esso concorre, anche, alla redenzione e alla salvezza spostata in un’altra vita. Nietzsche chiude Ecce homo con una frase sibillina “Dioniso contro il crocifisso…” non nel senso di opporre la gioia al dolore, ma nel senso di opporre la vita [Dioniso] – che riconosce la necessità del dolore e della morte come suoi momenti - ad una vita [crocifisso] che, rifiutando il dolore e la morte, aspira ad una da cui è bandita la morte. Scrive Nietzsche: “Dioniso contro il “crocefisso”: eccovi l’antitesi. Non è una differenza in base al martirio – solo essa ha un altro senso. La vita stessa, la sua eterna fecondità e il suo eterno ritorno determinano la sofferenza, la distruzione, il bisogno di annientamento. Nell’altro caso il dolore, 'il crocefisso in quanto innocente' valgono come obiezione contro questa vita, come formula della sua condanna. Si indovina che il problema è quello del senso del dolore: del senso cristiano o del senso tragico”. Si scontra il senso tragico del dolore col senso cristiano. Per la tradizione greca il dolore è costitutivo della esistenza; e questa circolarità della vita con la morte è colta dalla coscienza tragica. Ed allora il problema non è quello della contrapposizione tra vita e morte [la nostra vita individuale che vorrebbe essere eterna, ma è segnata dalla precarietà della morte], ma tra vita della natura (che per vivere esige la morte delle singole esistenze) e vita della singola esistenza (che per vivere deve allontanare la morte). Se una riflessione sul crocifisso ci porta a tali pensieri sul dolore, la morte, la vita, non gli si rende un cattivo servizio se viene brandito come un’arma per mantenere il controllo sociale? |
|
Post n°19 pubblicato il 03 Novembre 2009 da m_de_pasquale
Con lo slogan “Una risorsa riciclata…una risorsa guadagnata”, inizia in questi giorni a San Severo la raccolta dei rifiuti “porta a porta”. Domani sera alle ore 19 ci sarà, presso casa Eirene, un incontro per presentare l’iniziativa. Il problema dei rifiuti non è altro che l’espressione dell’anomalia caratterizzante il nostro sistema economico. Un sistema che ha invertito i mezzi con i fini perché il consumo è esercitato come mezzo di produzione: non si producono più beni per consumarli, ma si consumano per produrne sempre di più. All’aumento dei consumi corrisponde l’aumento dei rifiuti. E’ necessario creare sempre più bisogni (e qui la pubblicità svolge egregiamente la sua funzione nel far sentire come necessari bisogni che a dirla con Epicuro non sono né naturali, né necessari); consumare, consumare, consumare per non interrompere la catena produttiva ed anche perché il progresso tecnico rende obsoleti, in tempi sempre più brevi, i prodotti. La centralità del consumo rivela il tratto nichilistico che caratterizza la società della tecnica: la distruttività costituisce l’imperativo funzionale dell’apparato tecnico; il mondo viene continuamente cambiato, diventa subito vecchio ed è da buttar via. Questa mentalità dell’”usa e getta” ci è ormai entrata nelle ossa e non ci accorgiamo della sua pericolosità. Dice Anders: “L’umanità che tratta il mondo come un mondo da buttar via, tratta anche se stessa come un’umanità da buttar via”. Se le cose esistono solo per essere consumate e, laddove resistono, per essere sostituite con altri prodotti (vedi la funzione diabolica della moda), allora esse perdono la loro consistenza ed il mondo diventa evanescente e con il mondo la nostra identità, poiché la nostra identità ha bisogno di ancorarsi a dei punti di stabilità. L’individuo perde i suoi punti di riferimento, i luoghi di ancoraggio della sua identità, perde la continuità della sua vita psichica. Pertanto qui non stiamo parlando solo di separare la carta dalla plastica, ma stiamo parlando della permanenza della nostra umanità. Paul Connett - professore di Chimica alla St Lawrence University, Canton, NY – sostiene che la nostra società ha un approccio sbagliato al problema dei rifiuti perché lo identifica con la costruzione di inceneritori e discariche e non si pone il problema di ridurre i consumi. La domanda che oggi dobbiamo porci non è quella di come liberarci dai rifiuti in modo efficace e col minimo danno, ma come stiamo trattando le risorse che vanno esaurendosi in modo da non privare le generazioni future della loro fruizione. Insomma l’attenzione deve essere spostata dai rifiuti al consumo che li produce. Oltretutto l’ottica abituale con cui si affronta la questione rifiuti – pensando di risolverla costruendo inceneritori - è antieconomica e dannosa per la salute e l’ambiente (si pensi alla diossina, ad altre emissioni tossiche in atmosfera come la nanoparticelle): l’inceneritore di Brescia è costato 300 milioni di euro ed ha creato 80 posti di lavoro; nella Nuova Scozia (Canada) il 50% dei rifiuti sottratti alle discariche in 5 anni ha creato 1000 posti di lavoro e 2000 nelle industrie che usano i materiali separati! Ed allora la parola d’ordine è Rifiuti 0. L’obiettivo non sarebbe utopico se ci fosse una responsabilità industriale (investire in una produzione sostenibile e pulita) ed una intelligente e lungimirante leadership politica (merce rara in Italia). Ma poiché su questi due fattori si può fare poco affidamento, non resta che contare sul terzo fattore: la responsabilità della comunità. L’imperativo che le è affidato è quello di ridurre il più possibile la frazione residua (cioè il rifiuto che va in discarica o viene incenerito) aumentando il rifiuto che può essere riciclato (quello, appunto, raccolto porta a porta) attraverso due abitudini: la riduzione e il riutilizzo. Allora se ciò che è in gioco è il permanere della nostra umanità in una società dominata da un sistema il cui fine è solo la funzionalità dello stesso, ridurre, riusare e riciclare diventano le vie per opporci al destino nichilistico della società tecnica. The Story of Stuff di Annie Leonard (in tre parti) Zero Waste di Paul Connett |
|
Post n°17 pubblicato il 01 Novembre 2009 da m_de_pasquale
La Regione Puglia ha emanato un bando pubblico per favorire l’insediamento dei giovani in agricoltura. Al di là di una espressione equivoca (“miglioramento della competitività delle imprese agricole pugliesi”), sono interessanti gli obiettivi dell’azione perché si intende “consolidare il tessuto socio-economico nelle zone rurali” ed “incoraggiare il miglioramento delle capacità professionali dei giovani agricoltori, anche al fine di orientarli verso lo sviluppo di nuovi sbocchi per le produzioni agricole”. Ma quale rapporto con la terra si auspica per questi giovani? La logica competitiva non ha a che fare con lo sfruttamento che ottimizza i risultati e perciò si è competitivi? O la competizione deve giocarsi su un diverso rapporto con la terra? Terra da dominare o terra da abitare? Per i greci antichi la natura costituiva un limite insuperabile a cui l’azione umana doveva piegarsi come alla suprema legge: l’uomo non può dominare la natura, ma solo svelare ciò che è in lei. La concezione greca della verità è intesa come svelamento (aletheia) della natura (physis) dalla cui contemplazione nascono le conoscenze che regolano l’agire dell’uomo. Da questo orizzonte cosmologico del pensiero greco, si passa ad uno antropo-teologico della concezione giudaico-cristiana: la natura è il prodotto della volontà creatrice di Dio che la consegna all’uomo. Affidando la natura all’uomo, viene anche deciso il suo destino. C’è scritto nella Bibbia: “l’uomo domini sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo, sugli animali domestici, su tutte le fiere della terra”. Un destino di dominio che oggi si risolve nello sfruttamento della natura: le cose non sono più considerate per quello che sono, ma per quello a cui servono; e l’uso che l’uomo ha sempre fatto delle cose per garantirsi l'autosussistenza, diventa usura, logoramento della terra. Scrive Heidegger: “ La legge nascosta della terra la mantiene nella moderata misuratezza del nascere e del perire di tutte le cose entro i limiti della loro possibilità, che ognuna di esse segue e che tuttavia nessuno conosce. La betulla non oltrepassa mai la sua possibilità. Il popolo delle api abita dentro all’ambito della sua possibilità. Solo la volontà, che si organizza, con la tecnica, in ogni direzione, fa violenza alla terra e la trascina nell’esaustione, nell’usura e nelle trasformazioni dell’artificiale. Essa obbliga la terra ad andare oltre il cerchio della possibilità che questa ha naturalmente sviluppato, verso ciò che non è più il suo possibile, e quindi è l’impossibile.” Al primato della natura è subentrato il primato del mercato: i beni sono prodotti dalla natura non per il soddisfacimento dei bisogni, ma per la produzione di denaro grazie allo scambio di essi secondo le leggi del mercato (Marx direbbe non più valori d’uso, ma valori di scambio). E’ il dominio della cosa sull’uomo, ovvero del “materialismo” (ed ironia della sorte, Marx che ha denunciato tutto ciò, viene tacciato di essere un materialista!). Per curare la nostra volontà di potenza che ha ridotto la terra ad un fondo a nostra disposizione sfruttabile oltre ogni limite, ci farebbe bene un bagno rigeneratore nel pensiero delle origini, dove la natura è la Grande Madre [l’associazione madre/terra insiste sulla forza generatrice della terra e sulla sua funzione protettiva]. Ritornare a quell’idea di sacralità associata all’agricoltura, considerata non semplicemente una tecnica, ma - essendo in relazione con la vita presente nei semi, nei solchi, nella pioggia - anzitutto un rituale compiuto sul corpo della Terra-Madre che mette in moto le forze sacre della vegetazione. Afferma Mircea Eliade: “ Quel che l’uomo ha veduto nei cereali, quel che ha imparato da questo contatto, quel che ha inteso dall’esempio dei semi che perdono la loro forma sotto terra, tutto questo rappresentò la lezione decisiva. L’agricoltura ha rivelato all’uomo l’unità fondamentale della vita organica; tanto l’analogia donna-campo-atto generatore-semina, come le più importanti sintesi mentali uscirono da questa rivelazione: la vita ritmica, la morte intesa come regressione. Queste sintesi mentali sono state essenziali per l’evoluzione dell’umanità e furono possibili solo dopo la scoperta dell’agricoltura. Appunto nella mistica agraria preistorica sta una delle radici principali dell’ottimismo soteriologico: precisamente come il seme nascosto nella terra, il morto può sperare in un ritorno alla vita sotto nuova forma. Ma la visione malinconica, talvolta scettica, della vita ha parimenti origine dalla contemplazione del mondo vegetale: l’uomo è simile al fiore dei campi…”. |
|
Post n°16 pubblicato il 29 Ottobre 2009 da m_de_pasquale
L’attuale crisi economica ha fatto schizzare il debito italiano alle stelle: ogni cittadino italiano (bambini compresi) ha sul groppone un debito di 29.000 euro. Il debito pubblico viaggerà attorno al 118% del P.I.L. (= Prodotto Interno Lordo cioè il valore complessivo dei beni e servizi prodotti in un anno misurante la ricchezza del Paese) nel 2010. Occorrerebbero – si dice – programmi di stimolo economico volti ad aumentare la spesa pubblica per rilanciare l’economia: ma se non ci sono risorse come si fa ad aumentare la spesa pubblica? Si dice che il riavvio dell’economia deve passare attraverso il rilancio delle imprese: ma se esse sono sottoposte alla concorrenza straniera (al di fuori dell’Italia e all’interno) come faranno ad intercettare la debole domanda esistente? Si sostiene che l’Italia dovrebbe investire in ricerca ed innovazione: negli altri stati europei, nonostante il periodo di crisi, si continua ad investire sulla scuola e sulla formazione, da noi si fanno i “tagli” nella scuola! Si dice che l’Italia dovrebbe avere uno sguardo lungimirante e decidersi ad operare riforme strutturali: al contrario naviga a vista affrontando le emergenze che assorbono le poche disponibilità finanziarie! In questa situazione, i gestori del credito (le banche) non si espongono per sostenere quelle piccole imprese che avrebbero bisogno di denaro come l’ossigeno: al contrario fanno i loro giochi finanziari col denaro dei risparmiatori! Cos’hanno in comune le ricette su esposte (peraltro non o mal applicate in Italia) per uscire dalla crisi? Tutte condividono un paradigma di riferimento: l’aumento del PIL [che calcola il valore monetario delle merci scambiate] è la condizione per uscire dalla crisi. Il PIL aumenta quando aumentano i consumi: acquistando beni e servizi, il denaro si muove contribuendo a far crescere il PIL. Pertanto, secondo questo paradigma, il benessere di uno stato è direttamente proporzionale alla movimentazione mercantile delle merci. Ma per star bene, abbiamo bisogno di merci o di beni? Ricordo che il bene (finalizzato al soddisfacimento dei bisogni esistenziali) non passando necessariamente attraverso la intermediazione mercantile, non viene computato nel PIL e quindi non contribuisce a farlo crescere. L’egemonia del PIL corrisponde alla dittatura della produzione (stimolata dall’obbligo di consumare): è la riproposizione del meccanismo consumo/produzione per perpetuare il sistema economico. Se è così assistiamo ad una inversione di fini: non più il soddisfacimento dei bisogni esistenziali, ma il mantenimento del sistema economico! Si chiede Maurizio Pallante: “Vive felicemente chi si propone di avere sempre maggiori quantità di merci, anche se non sono beni, e spende tutta la vita per questo obbiettivo? Non vive più felicemente chi rifiuta le merci che non sono beni e sceglie i beni di cui ha bisogno in base alla loro qualità e utilità effettiva, lavorando di meno per dedicare più tempo ai suoi affetti? Vive felicemente chi vive in una società che si propone di produrre sempre maggiori quantità di merci, anche se non sono beni, e sacrifica a questo obiettivo la qualità dell’aria, delle acque e dei suoli? Non vive più felicemente chi vive in una società che antepone il bene della qualità ambientale alla crescita della produzione di merci che non sono beni?” Il PIL si fonda sul mito della crescita, ma preoccupanti segnali ci invitano a rivedere questo mito: il progressivo esaurirsi delle fonti fossili d’energia, le guerre per averne il controllo, l’innalzamento della temperatura terrestre, i mutamenti climatici, lo scioglimento dei ghiacciai, la crescita dei rifiuti, le devastazioni e l’inquinamento ambientale. E’ sempre più urgente definire nuovi parametri per le attività economiche e produttive, elaborare un’altra cultura, un altro sapere: adottare come nuovo paradigma il B.I.L. (= Benessere Interno Lordo). Per capire la portata rivoluzionaria del nuovo paradigma fai l’esercizio proposto: |
- sitografia generale
- video storici
- video dal 1900 ad oggi
- storia antica
- storia medievale
- storia moderna
- storia del novecento
- tutti i documenti cattolici
- dizionario di storia antica e medievale
- dizionario di storia moderna e contemporanea
- dizionario di storiografia
- dizionario di economia
- dizionario del cittadino
- storia di san severo
Tag
Area personale
Menu
CAMPI FILOSOFICI
2012: il sacro, tremendum e fascinans
2011: l'altra faccia del potere
2010: inseguendo la felicità
2009: l'equivoco dell'amore
mail: m_de_pasquale@libero.it
un'altra informazione?
- report
- presa diretta
- servizio pubblico
- anno zero
- w l'italia
- current tv online
- c'era una volta
- iene
- doc 3
- il fatto quotidiano
- lettera43
- cadoinpiedi
- il post
- linkiesta
- agoravox
- giornalettismo
- articolo 21
- liberainformazione
- la voce
- carta
- peace reporter
- nigrizia
- narcomafie
- altreconomia
- arcoiris tv
- wikileaks
- paolo barnard
- tzetze
- YouReporter
- i segreti della casta