Schwed RaccontaSu e giù per la tastiera |
C'ERA UNA VOLTA MONTALCINO

JIGA MELIK E IL SIG. SCHWED
Jiga Melik è l'alter ego intermittente dello scrittore Alessandro Schwed. Il signor Melik nasce nel 1978 nella prima e provvisoria redazione del Male, un ex odoroso caseificio in via dei Magazzini Generali a Roma. Essendo un falso sembiante di Alessandro Schwed, Jiga Melik si specializza con grande naturalezza nella produzione di falsi e scritti di fatti verosimili. A ciò vanno aggiunti happening con Donato Sannini, come la consegna dei 16 Comandamenti sul Monte dei Cocci; la fondazione dell'Spa, Socialista partito aristocratico o Società per azioni, e la formidabile trombatura dello Spa, felicemente non ammesso alle regionali Lazio 1981; alcuni spettacoli nel teatro Off romano, tra cui "Chi ha paura di Jiga Melik?", con Donato Sannini e "Cinque piccoli musical" con le musiche di Arturo Annecchino; la partecipazione autoriale a programmi radio e Tv, tra cui la serie satirica "Teste di Gomma" a Tmc. Dopo vari anni di collaborazione coi Quotidiani Locali del Gruppo Espresso, Jiga Melik finalmente torna a casa, al Male di Vauro e Vincino. Il signor Schwed non si ritiene in alcun modo responsabile delle particolari iniziative del signor Melik.
MIO FIGLIO MI HA AGGIUNTO SU FACEBOOK - ROMANZO


LA SCOMPARSA DI ISRAELE - ROMANZO
LINK DOVE VIVO
- Fahrenheit
- Il Tizio della Sera
- romanzo LO ZIO COSO
- La Scomparsa di Israele
- Corriere della Sera
- Critica letteraria
- libri su libri
- i suoni della memoria
- IBS
- settimanale L'AZIONE p. 7
- Il Piccolo - recensione teatrale "Alla ricerca dello zio Coso"
- Il Messaggero Veneto - Giornata della Memoria Intervista ad Alessandro Schwed
- anobii
- libero di leggere
- articolo sul Foglio
- roma
- IL MALE
- il Male su facebook
AREA PERSONALE
TAG
MENU
I MIEI BLOG AMICI
|
Post n°51 pubblicato il 15 Ottobre 2012 da Jiga0
Basta con la guerra tra Israele e Palestina, basta con tutte le guerre di Alessandro Schwed
Quel preavviso israeliano all’Iran è come un vento forte che annuncia un cambio di stagione, poi si attenua, poi sta in silenzio, pronto a mordere. Un’altra guerra si è messa in coda alle guerre della Storia. Il Mediterraneo che si infiamma, altro che Atlantide. Che avvenga-non avvenga l’attacco israeliano ai siti nucleari iraniani, due popoli attendono, dimenticano, di nuovo attendono. Nelle case di Teheran e Tel Aviv chiamano al telefono i parenti nel mondo, parlano di quello che potrebbe succedere. O non parlano con nessuno e la notte sognano la guerra: da qualche parte la paura deve finire. Un’immane pazzia. Il conflitto tra Israele e il mondo arabo, di cui l’Iran non è parte etnica ma religiosa, è così permanente da essere eterno nell’agenda politica mondiale. Una guerra di guerre, lunga sessantaquattro anni, il cui inizio nel ’900 è visibile in filmati in bianco e nero. Il fatto era, ed è rimasto, che l’esistenza di Israele era un’offesa, Israele non doveva esistere. Poi Israele ha continuato a esistere, ha capitalizzato le guerre vinte prima contrattando la restituzione dei Territori senza riuscirci, e da vari anni, con questa destra in carica, assorbendo in modo implicito, poi sempre più esplicito, i Territori. Netanyahu pare ingoiarli, evitando di contrattare la restituzione, come se fosse un non udente di un governo di non udenti. I Territori contengono la massa crescente dei coloni, un sempre più consistente serbatoio elettorale con cui fare i conti del consenso e degli affari edilizi, della costruzione delle infrastrutture. C’è la onnipresente pervasività fisica, economica, mediatica degli insediamenti israeliani, basta guardare la carta geografica; c’è il macigno della non restituzione dei Territori; la scomparsa dei tavoli della pace; il fine evidente di far prevalere lo status quo; il prender piede, con le ultime ondate dell’Alyà, di nuove stratificazioni etniche e sociali, la degenerazione dell’idea sionista in una cultura pionieristica che ricorda sempre di più la storia del Far West o, peggio, il cinema Hollywoodiano sul Far West e la dissoluzione delle terre indiane. Una semiguerra all’Iran, ma anche un’azione militare ostile nel suo territorio, sarebbe la pietra tombale su qualsiasi accordo futuro per i Territori. Un tale accordo non interessa questo governo di Israele che detiene nei Territori una parte importante del proprio serbatoio elettorale, e che in nome dei propri interessi politici e finanziari, non solo non è interessato alla pace, ma forse le è contrario. Dato che le ragioni di questa ostilità (una terra da restituire, l’aspirazione a uno stato palestinese) sono proprio le ragioni che se rimosse con i sacrifici dolorosi propri di una pace, danneggerebbero irreparabilmente gli interessi politici e finanziari del governo e del suo elettorato. Perché così si fa la pace con un nemico: rintracciando le vere ragioni dell’ostilità, contrattandole con l’offerta di terra e compensazioni che facciano arretrare quell’ostilità, in cambio dell’accettazione di alcuni punti, per esempio il riconoscimento dello stato d’Israele; mentre con minacce e azioni apertamente ostili come un blitz nei siti nucleari iraniani si ottengono subito il logoramento e la rottura di un qualsiasi tenue filo di dialogo. A fronte della mancata volontà israeliana di pace ricercata a ogni costo (magari con sacrifici dolorosi come la restituzione di Gerusalemme est e di Hebron), e anzi si preferisce minacciare l’Iran, si rispecchia in modo uguale e contrario la politica estera, o imperiale dell’Iran. La quale si offre come una ripetizione di quello che faceva la vecchia Urss nella regione, posto che il vero interesse del Cremlino nell’area era di mantenere l’instabilità. Era il tempo in cui, in modo sottile, non veniva realmente sostenuta la causa palestinese, la nascita di uno stato, ma come accade oggi con l’Iran si armeggiava ad apprestare turbolenze, a fare delle aspirazioni palestinesi un’arma di pressione nell’area più delicata del mondo. Dunque, la questione palestinese usata come rubinetto da aprire e chiudere: un’arma contrattuale. La chiave per altre mire e altre trattative. Ora che la politica estera è stata sostituita dalle intraprese militari portate in giro per il mondo dalle coalizioni occidentali, e la pace-guerra è familiare agli occhi della nostra opinione pubblica, il conflitto israelo- palestinese è paradigmatico quanto al significato universale della parola “guerra”. La lunghissima guerra tra Israele e Palestina illustra come un conflitto possa avere utilità istantanea e alla lunga l’inutilità della peggior beffa. Con la sua guerra di guerre vinte, Israele è riuscito a resistere, mai ad avere vita normale; dall’altro lato, attraversando come impunemente le sconfitte, i palestinesi hanno alimentato il sogno di una Palestina che sorge addirittura al posto di Israele, ma non hanno posto una sola pietra per la nascita dello stato palestinese. E così, se consideriamo la guerra tra Palestina e Israele dal 1948, la vita dei due popoli è paragonabile a quella di una persona di 64 anni che ha vissuto l’intera vita chiusa in casa, al buio, senza avere mai visto il sole. E a me pare che oggi, profondamente, la vita quotidiana di Israele e Palestina ponga la questione filosofica del senso della guerra, la sua incompatibilità col sentire del nostro tempo. Né vinta veramente né persa per davvero, può una guerra continuata al posto della vita essere una forma ufficiosa di società, con la gente che va al lavoro, alla partita, a ballare, e a un tratto parte per Gaza o il Libano? O vive confezionando ordigni, scavando tunnel, sempre un passamontagna sul volto? A Gaza, i ragazzi giocano con la PlayStation, fanno la mitologica parte di Messi, ma fra poco potrebbe partire una fatwa anche sui Blaugrana che hanno ospitato Shalit a una partita col Real Madrid, e così morirà anche questo innocente sogno infantile. Può una guerra eterna seminare il futuro? E può il sistema delle guerre portate dalle coalizioni come esportazione della pace, divenire un baluardo di civiltà e democrazia? Le vite di Israele e della Palestina dicono di no, che servirebbe l’ordine della pace. Mentre gli esiti della pace armata sono i quaranta morti al giorno in Iraq, l’irriducibilità talebana (con cui già i sovietici fecero i conti), gli attuali oltre duemila morti della coalizione occidentale, il permanere di al Qaida la cui effettiva esistenza appare insondabile, e raggela. La dottrina dell’esportazione della democrazia con la guerra ha fallito e le strade di Baghdad snocciolano morti, del resto come può una pioggia di missili sulle vie della tua città averti educato alla democrazia? Noi che abbiamo visto in tv l’attuarsi dell’ordine attraverso la miniserie dei bombardamenti in diretta, in Iraq, Kosovo, Afghanistan, Libia, abbiamo constatato de visu che la guerra “intelligente” fa crollare le mura dei bunker ma rende monchi e orbi come la guerra antica. La guerra rimane sempre la stessa: un cannibale. Israele potrebbe scegliere, malauguratamente, di agire se nell’imminenza delle presidenziali Obama mostrasse incertezze, a seconda dell’andamento della campagna elettorale; oppure se i repubblicani a un tratto fossero così forti da dettare un ritorno alla dottrina Bush. Certo, non si può attaccare l’Iran per un dibattito televisivo andato male a Obama. Per ora la realtà è che la Casa Bianca dice di avere una visione del nucleare iraniano affine a Israele, ma una diversa valutazione sulla tempistica di Teheran. Seconda cosa, il mondo è attraversato da una crisi economica come metafisica, la sua lunghezza non si piega e non si spiega: una crisi che è come una guerra mondiale invisibile, e sia l’America che il mondo non possono permettersi due contemporanee, fatali guerre mondiali. A fronte del flemmatico palleggio della Casa Bianca che smorza il preavviso israeliano di guerra, il ballon d’essai di Netanyahu torna nel campo di Israele, prigioniero storico della filosofia della guerra preventiva, e trova lo stato ebraico saldato alla propria immobilità, fatta di un sostanziale disinteresse a una pace che non sia la dissoluzione geografico-politica di una possibile patria di Quelli. Solo i popoli di Israele e Palestina sanno quanto sia insensato il sistema della guerra. Per Israele la guerra è la struttura emotiva dei giorni: gli ebrei israeliani sono usciti dalla Seconda guerra mondiale e dalla Shoah, e sono stati fluidamente ingoiati da una guerra fatta di guerre successive: come se la vita possa costituirsi solamente di guerra, e nella migliore delle ipotesi bisogna essere pronti al suo scatenarsi. In Israele è un dato naturale che ci sia la guerra, o che sia dietro l’angolo, e anzi è pericolosamente sospetto il contrario: una pace lunga significa che Quelli si stanno organizzando. Solo chi vive così da generazioni, sa, consciamente o meno, che a una guerra lunga generazioni corrisponde la depressione, la vita sui nervi e altri passi sul viale dell’angoscia. Con la guerra, nelle famiglie israeliane, hanno fatto i conti uno o molti; e nel vicinato, sul pianerottolo, c’è sempre un vicino, un conoscente che è diventato pazzo per aver perso la famiglia nella Shoah e un figlio in guerra. E così, l’Israele moderno è paradigmatico di come la guerra abbia un’utilità istantanea e un’inutilità assoluta. Il susseguirsi delle guerre vinte, nel peggiore dei casi almeno non perse, ha sviluppato l’odio crescente dei vinti e la stanchezza di quei disgraziati dei vincitori. Questo governo Netanyahu dei preavvisi di guerra esercita un’assenza di ricerca della pace, un’estraneità totale all’azione di ascoltare il prossimo, che è condizione esistenziale di non vita. Non è un caso che l’ultimo eroe di Israele non sia Rabin, che aveva stretto la mano ad Arafat ed è stato assassinato, ma il corpo dimenticato di Sharon: un né vivo né morto che certo non torna a vivere e che misteriosamente non riesce a riposare in pace – metafora inquieta della vita impossibile israeliana. Israele amplia gli insediamenti, costruisce case e infrastrutture: è come se cullasse la tensione. Sta smarrendo la normalità. E’ una vita in stato ebraico di assedio. E in modo paradossale, questo rassegnarsi alla vita come guerra, assomiglia alla sopravvivenza quotidiana del tempo mentale e fisico della Shoah. Quanto vale per la guerra eterna tra Israele e il mondo arabo, Israele e l’Iran, vale per le reiterate guerre occidentali nel Golfo, nel Kosovo, in Afghanistan, Libia. Per quanto tale modo di operare venga chiamato peace keeping, contingenti di pace, guerra umanitaria, quando volano gli aerei e cadono le bombe, i contingenti non sono di pace. Guerre con “costi umani”, si dice, per non dire morirete a chi sta per morire; guerre con obiettivi limitati, si dice, che colpiranno “solo” le infrastrutture, come se strade, ponti, fabbriche, stazioni ferroviarie siano parentesi della vita. Guerre in tv, come se quell’essere di Baghdad nelle tv di tutto il mondo, la città di Aladino che si immergeva in una fantasmagorica luce verde, rendesse plausibile la pioggia dei missili da crociera Tomahawk sparati dal Golfo, come se la crociera dei tubetti di ferro fosse una capatina in città. “Sono stati sparati 130 missili da crociera” avverte quieto dal teleschermo lo speaker, opzione sorridente della guerra nella vita di famiglia. Uno torna a casa: cara, che è successo oggi? Niente, centotrenta missili da crociera, centrati otto target, e fuoco amico a Kabul – ma nulla, non erano italiani. All’inizio, le guerre in Kosovo-Afghanistan- Iraq volano alte tra le nubi dello spettacolo televisivo, poi piombano in basso e colpiscono davvero. La guerra corre, ci sono le dichiarazioni dei rappresentanti dei governi. Si presentano ai microfoni in eleganti abiti civili, come se non fossero loro a mandare gli aerei dato che hanno la cravatta. Ci sono quelle dichiarazioni: nessuno ce l’ha coi popoli colpiti, la guerra è contro il regime e i suoi capi. Va da sé che non sono perforati solo i bunker del regime e le ville al mare dei capi: saltano in aria le normali piazze con le normali panchine, le case con i letti e i comodini e se va bene le scuole bruciano con dentro solo i meravigliosi disegni dei figli. Ma le belle strade che legano i quartieri si riempiono dei crepacci delle bombe, diventano strade inutili, e anche se le trasmissioni televisive funzionano ancora e la sera danno un film, la normalità ormai è scappata dalla finestra e nessuno sa dove sia andata. La pietà, quella subentra quando finalmente le macerie sono inquadrate dal basso assieme ai corpi immobili; e risulta veramente strano che oltre alla guerra preventiva non possa esserci la pietà preventiva, ma solo la sterile pietà successiva. Un permanente Vietnam. Un set cine-bombardante che elimina dittatori e rende profughi i popoli. Le case dissolte, le auto carcasse, le popolazioni fuggite, le vie deserte, le tendopoli piene, l’acqua finita, i padri scomparsi – la guerra è stata vinta. Da chi? Guerra per una pozza d’acqua, come nell’inizio mitopoietico di “2001, Odissea nello spazio” di Kubrick. Lì, poniamo quattrocentomila anni fa, viene ucciso il membro di un gruppo di ominidi ancora privi di parola. Ringhiano, sbuffano, sono dotati di un’andatura incerta. Quando giungono alla pozza, litigano con altri ominidi per il suo possesso: il fatto è che lì si beve. Converrebbe avere la pozza e bere al posto degli altri. Tra gli ominidi c’è una discussione stilisticamente brutale. Le urla sono sempre più forti e ha luogo la prima uccisione della storia. Non originata da una lite individuale, ma come sottende il racconto biblico di Caino e Abele un omicidio- guerra per una contesa tra due gruppi identici ma socialmente diversi. Uno è stanziale e vive presso la pozza, l’altro è un gruppo che arriva da chissà dove per andare chissà dove e adesso ha sete. Per invidia, balordaggine, la prevalenza di un istinto insopprimibile, scoppia la prima guerra umana. Alla pozza di Kubrik, la scoperta di come risolvere il contenzioso e bere solo gli uni e assolutamente nessuno degli altri, avviene per caso: un ominide tira su da terra l’osso di un animale spolpato, reso bianco dal sole, e lo brandisce. Per un’intuizione fatale, colpisce la testa a un contendente, che cade affievolito sul terreno. Urlava, ora però è in silenzio, misteriosamente inerte. Tra gli ominidi si diffonde la vertigine: è stata tolta la vita. I compagni del morto fuggono, gli altri giubilano: la morte può essere data, c’è questo potere! In segno di trionfo, lo strumento che ha ucciso un uomo per la prima volta della Storia, l’osso di una preda uccisa e mangiata, viene tirato in cielo. L’osso volteggia in alto, più in alto ancora, cinematograficamente diviene una stazione spaziale orbitante – il tempo è passato in un soffio: l’ominide è un uomo. Fa l’astronauta, comunica a distanze immense. Si nutre in modo funzionale alla vita spaziale, strizza dei tubetti e ingoia sintesi cremose di uova, verdure, carni. Galleggia in assenza di gravità, cammina saltellando su pianeti dove non c’è ossigeno. Ora che non è più il 2001 del film, ma il nostro 2012, sappiamo che dopo avere orbitato nelle stazioni spaziali, l’uomo ha ucciso e uccide come alla pozza dell’acqua. Fa ancora la schifosa guerra. La storia umana passa da un omicidio: tutte le scoperte e le acquisizioni della volontà ne sono intossicate. E in modo appena visibile, un filo sottile che attraversa la lunga stanza della Storia, tutto inizia da un colpo in testa, inferto mediante l’osso di un animale ucciso per nutrirsi – versare sangue, uccidere apparenta con la violenza, la rende una delle cose ordinarie di oggi e di domani. Genesi è l’allegoria di un trauma: rompere l’armonia tra le creature, fu altamente tossico: dalla morte è venuta la morte. Perché la questione della guerra è la questione del Male: è metafisica, muove lo spirito. Ora però, la moderna questione della guerra è che la guerra in tv non seduce più. Non possiamo fantasticare più sulla guerra romantica, i commilitoni, l’avventura. In tv, la guerra fa schifo. Mica è un film, non c’è ritmo. C’è gente in fila per l’acqua, i bambini stano zitti, a un angolo c’è un cadavere. La guerra non è in sintonia con la nostra sensibilità, con gli occhi dei figli a tavola – non è ricevibile. La guerra della giustizia strappa i corpi, lascia odio, è comunque guerra. Certo, talora la guerra è stata utile: se a liberare l’Europa non ci fossero stati gli americani e l’Armata rossa, chissà cosa sarebbe oggi il mondo. Ma siamo nella post Storia, c’è l’attesa di vita, le palestre, il culto del corpo, i viaggi, gli amici dei social network da Milano a Giava: la guerra non è comprensibile, razionalizzabile, assimilabile. Perché ritenere che la guerra risolva, se non è affatto così? Che il dolore fisico non ci sia, quando si vede bene che c’è? Possiamo pensare che se quattrocentomila anni fa non ci fosse stata la lesione dell’armonia universale, versare sangue di altre creature per riempire se stessi di cibo e di possesso; se non avesse prevalso l’impulso di versare sangue come una cosa naturale per nutrirci, una cosa sopportabile, come infatti sopportiamo la convivenza degli occhi miti del bue con la fetta di carne sul nostro piatto. Se tutto questo non fosse mai successo, se non avesse prevalso mors tua vita mea, la Storia sarebbe stata un’altra. Allora non ci sarebbero stati Auschwitz né Hiroshima. Invece, c’è più di una guerra a generazione. Alla fine abbiamo visto due Gheddafi, quello assalito e sparato, e quello ricomposto in un interno. Di quello assalito si dice che siano stati i francesi ad assalirlo, ma ad assalire è stata la solita guerra. Il secondo Gheddafi è quello di qualche giorno dopo, ricomposto forse in una capanna. Era come se stesse dormendo. Estraneo alla guerra che aveva appena finito di rimbombare, appariva parte intrinseca di una pace sconosciuta sia al lui di prima che a noi di ora. Affacciato al confine di quel mondo col nostro, il suo corpo pacato domandava: “C’era bisogno di tutto questo?”.
Il Foglio, 9 ottobre 2012 |
|
Post n°50 pubblicato il 13 Ottobre 2012 da Jiga0
di Alessandro Schwed E’ un peccato che il giorno dopo la notizia sia evaporata. La notte di Ferragosto una signora che soggiornava in un agriturismo dalle parti di Tarquinia ha denunciato alla polizia una cicala che friniva senza sosta, posizionata sul pino di fronte alla finestra di camera sua. Intollerabile per la sua stanchezza, per la sua mente – per un’ignoranza stordita i cui confini sono ignoti. E’ probabile che la donna fosse andata in agriturismo alla ricerca della natura, o di quello che lei riteneva essere la natura. Non era preparata al canto delle cicale, ma a un’oasi insonorizzata. Denaturata. Le sarebbe stato più semplice sopportare il ciclico passaggio della metropolitana sotto l’impiantito, come a casa sua; vedere alla tv Pino Scotto, quello simpatico del rock che ha perso il controllo e ormai dice solo vaffanculo; addormentarsi al suono dei vicini del piano di sopra che si scannano. Ma non convivere col canto di una cicala, lì, in piena campagna. Non essere in balìa di un insetto che non può neanche essere regolato. Le dispiace venire su in camera mia e spegnere quella cicala? Mi spiace signora, ma la direzione non risponde degli insetti sulle pareti esterne dell’agriturismo. Ah sìì?? Guardi che se non abbassate immediatamente il volume di quell’insetto, chiamo i carabinieri e domattina alle sei faccio arrestare anche il gallo! |
|
Post n°46 pubblicato il 29 Maggio 2012 da Jiga0
La destra di Sarkozy e Berlusconi si inabissa. Dove c’erano loro, ora c’è un invitante buco nero. Da quell’antimateria erompono Marine Le Pen e il nazismo greco. Adesso anche in Italia sta maturando qualcosa. Tutto è iniziato sere fa, quando un grido terribile ha squarciato la via Nomentana: “A li mortacci!...Ve possino caricavve! …Mo ve fo vedé io, ve fo!...”. Al sentire quelle grida bestiali, la gente si è emozionata: è corsa in strada, si è affacciata alla finestra, si è tappata in casa. Il pensiero è stato unanime: o stanno girando il seguito del Marchese del Grillo, o stanno pestando i calli di Nanda, la barbona di Porta Pia. Niente di tutto questo. Al balcone, le mani sui fianchi, illuminata dalla luna, è apparsa una donna coperta di farina che gridava come una lupa. Era l’onorevole Alessandra Mussolini. Quel che è successo è semplice, dopo l’exploit elettorale dell’estrema destra di Marine Le Pen e dei nazisti greci, mentre preparava il calzone alla Ciano, Ale ha avuto uno scatto d’orgoglio. E’ corsa al balcone e ha arringato i sette colli: “Ao’!...Aprite bene le recchie! Er vento sta a cambià!...Se vince quella slavata della fija di Le Pen, vuoi che non trionfi la nipote de nonno mio?!...Dico, qui c’è la nipote di Benito Mussolini!...E ho detto Mussolini, mica ho detto cotica!”. Non cadiamo dalle nuvole, dopo il crollo della destra moderata, ce lo dovevamo aspettare. La nipote del Duce è già al lavoro. A una prima occhiata, la sua idea appare drammaticamente vincente. Con un’audace innovazione che ricorda la retromarcia, invece di proporre passi in avanti verso un futuro totalmente buio, lancia Il Programma dei 100.000 Passi Indietro. Che tra l’altro recita: “Insieme! Indietro! Incontro a un passato luminoso!”. Sarà il partito della nostalgia che ti strappa le lacrime dagli occhi, e se non sei d’accordo ti strappa direttamente gli occhi. Ancora non è stato deciso il nome della nuova formazione. Ci sono due ipotesi. Alessandra propone “Alba Patata”. Alba, perché alla Mussolini è venuta l’idea di fare qualcosa che in qualche modo ricordasse vagamente la Grecia; patata perché la patata è stata molto importante nella sua vita. O se no, la base spinge molto per l’enfasi sentimentale di una sigla come CCBNC, “Calci in Culo e Botte Ne li Cojoni”. Ma andiamo a vedere quali sono le idee di fondo. E subito ci viene da piangere. Il punto di forza del programma è senz’altro il ripristino della Tv in bianco e nero e il ritorno a un solo canale, seguito dal comma: “Migliorare la razza, bonificare le racchie”; comunque non è indifferente neanche l’idea di incrementare il consumo del gelato al pistacchio. Un bella botta alla crisi viene dalla proposta di tornare subito alla lira e allo stipendio canterino delle mille lire al mese. Altri punti-chiave sono gli incentivi familiari per l’acquisto della brillantina, in concomitanza all’introduzione della sospirata pena di morte. E poi: l’orologio a cucù, la macchina da scrivere, il ritorno a un numero base di trentacinque milioni di italiani e rendere obbligatorio il casco coloniale. E ancora: che gli uomini facciano gli uomini, le donne le donne, e i recchioni i recchioni. Sabato gnocchi, giovedì trippa e martedì purga. Fin qui, le idee base su cui sta fermentando la nuova destra. Va detto che i punti principali sono emersi a un summit familiare tenuto da Alessandra Mussolini, con la madre Maria e la zia Sofia Scicolone. Le tre donne, riunitesi davanti a una spianatoia, con farina zero zero e matterello, tra la realizzazione di una pizza Napoli e una pastiera, non si sono ancora accordate sulla proposta della signora Loren di rendere obbligatorio in tutta Italia l’uso della maschera di cera. Il Male, 18 maggio 2012 |
|
Post n°44 pubblicato il 06 Maggio 2012 da Jiga0
Esce in Italia "Becchi e pervertiti", saggio di Freud del 1938 sul primo Disney |
|
Post n°42 pubblicato il 06 Maggio 2012 da Jiga0
Tragedie a vuoto |
|
Post n°40 pubblicato il 30 Aprile 2012 da Jiga0
Il Fatto 25.4.12
NB Faccio cortesemente presente a Furio Colombo che Jiga Melik (Alessandro Schwed) non è israeliano, ma italiano. |
|
Per conoscere il lato umano della compagine governativa, iniziamo un ciclo di interviste con i ministri professori. Il primo incontro è con Paola Severino, ministro della giustizia. In una famosa intervista dove le facevano notare che nella denuncia dei redditi di 7 milioni di euro si è dimenticata della villa da 10 milioni sull'Appia, il ministro ha risposto serenamente "Essere ricca non mi imbarazza affatto". Diciamo subito che a noi non interessano le insinuazioni realistiche secondo cui avrebbe evaso pur essendo la più ricca del governo. Vogliamo solamente far aprire il ministro e tirarne fuori la donna che vi è sigillata. La incontriamo al prestigioso ristorante Doria Pallavicini, il nove forchette dove ci ha invitato. Paola è già a tavola. "Eccolo! - esclama, umettandosi la bocca col tovagliolo - Sono arrivata un minuto prima, così mi avvantaggio". Indossa un giro di mezzo chilo di perle. "...E' mio ospite naturalmente. Si serva pure dei miei avanzi". Mi inchino e spiluzzico, tanto paga la Micragnosa. Prendo posto al grande tavolo circolare. "Magari possiamo cominciare l'intervista..." "Faccio scarpetta e sono tutta sua". "Allora, ha dichiarato che essere ricca non la imbarazza affatto" "E' vero. Perché l'opulenza è segno di ricchezza e la ricchezza di opulenza. Per esempio tra me e lei c'è un baratro". Ride a garganella, mostrandomi la maionese coi capperi che copre la sua lingua come un tappeto. Fa stappare un Roederer Crystal Rose. ""Lo sente il fruscio?". "Si, le cose, le bollicine lì..." - sono brillo e a stomaco vuoto. "Lo vede il baratro?...". "Veramente, vedo doppio". "Appunto, tra noi c'è la Fossa delle Marianne. Se io dico 'fruscio', mi riferisco a come frusciano i bigliettoni che mi costerà questa bottiglia, lei invece sogna bollicine". Ora che è fradicia, lo chiedo: "Ministro, posso osare una domanda estremamente intima?". Il ministro ride. Getta la testa indietro, i capelli volano compatti nell'aria e si riposano sulla nuca con un sonoro clac "Osi!!", ride, mordendo la collana di perle a 45 giri. "Paoletta, abbiamo capito cosa non la imbarazza, invece che cosa è che la imbarazza?". "Oddio...ma mi vergogno!..." La incoraggio. Si schernisce. "Faccia conto di essere sola e spogliarsi di tutto". "Guardi - fa inghiottendo una raffica di bianchi - ho spesso un incubo, una cosa densa...sono a letto...". Ah ecco, ci siamo...a letto. Poi?". "Sto dormendo, sogno. Sono completamente alla mercè: come nuda. "Come 'come nuda'? Senza tutti i vestiti?" No, peggio...peggio...". "Senza pelle?". "Peggio". "Senza ossa?" "Magari!...Sono dal parrucchiere. Eraldo mi ha appena fatto il carré. Vado a pagare. Lui mi fa: 380 perché è lei. Apro il portafoglio, non ho le carte di credito. Ho solo gli spiccioli: 170 euro. Capisce??". "Certo - deglutisco - 170 euri! Che cialtronata". "....Lo può dire...La stanza mi gira intorno con tutto Eraldo. Devo ancora fare colazione con mia figlia al Passetto, ritirare una comodino del '500 e pagare i pioppi giganti. Che ci faccio con 170 euro, la zingara? Bisogna che torni subito a casa. Devo controllare al pc se sono ancora ricca o sono diventata una di voi altri. Capisce che schifo?". Faccio segno di sì. Il ministro tossisce e mi sputa in fronte un nocciolo di ciliegia. "Ahi", mi lamento. "Stia zitto...nel sogno sono costretta a prendere la metro. Entro a piazzale Flaminio, con tutti gli estranei. Il vagone è pieno, devo rimanere in piedi. Un bambino si attacca al mio soprabito. Vomito... vomito...Dalla bocca mi esce un gatto". Il ministro sbianca, barcolla. Si alza in fretta. Portano il conto: 870 euro. Il ministro fruga nella borsetta. "Non è possibile - cinguetta - ho lasciato il portafogli a casa. Ci pensa lei?". Esce. Un momento: questo è l'incubo del ministro. Che c'entro io? |
|
Post n°38 pubblicato il 13 Aprile 2012 da Jiga0
|
|
Post n°37 pubblicato il 27 Marzo 2012 da Jiga0
Viaggiando su un treno diretto in Ungheria per far visita a uno zio miticamente scampato alle persecuzioni naziste, Melik apprende che la Seconda guerra mondiale non c’è mai stata. Glielo spiega il dottor Oscar, un veterinario che prende posto di fronte a lui nello scompartimento, sedendosi sul sedile che viaggia in direzione contraria al senso di marcia del treno. È proprio da qui che si dipartono i due binari opposti e paralleli che legano le vicende narrate. Quello antistorico del veterinario nazista che procede a ritroso cancellando e ricomponendo la realtà e quello dei ricordi del protagonista ebreo, che si protende tra passato e presente avanzando per accumulo di memorie familiari vivide, eppure indefinite. Quando il treno è ormai già entrato nella campagna ungherese, Melik riceve una bastonata sulla testa. E a questo punto, oltre alle verità storiche anche i vocaboli per raccontarle scompaiono dalla sua mente confusa. |
|
Post n°36 pubblicato il 27 Marzo 2012 da Jiga0
Ore e minuti rognosi di giornate rognosissime |
|
Post n°35 pubblicato il 27 Marzo 2012 da Jiga0
Giga Melik |
|
La cerimonia funebre per il piu' famoso re gorilla ci ricorda che l'anello mancante è nel giardino della Natura
E' di poco tempo fa un insolito comunicato dell'ufficio del turismo e dei parchi nazionali del Ruanda che annunciava la morte di un gorilla chiamato Titus. Il tono era di protocollare costernazione, come se fosse venuto a mancare un capo di stato molto popolare. In effetti era così. Titus era il re dei gorilla. Nato trentacinque anni fa con un fisico gracile per poi divenire un esemplare di duecento chili, con il suo dorso argentato e quella mole di dominatore era assurto a celebrità mondiale come protagonista di un film con Segourney Weaver. Questo primate che ha avuto più figli di ogni altro primate censito, poi è fatalmente morto per il dispiacere causato da un figlio che gli stava portando via l'ultima moglie, in una scena quotidiana che lui seguiva nascosto tra gli alberi e umiliato. Titus era stato molto amato dal popolo dei gorilla. Nel 1983, durante la sanguinosa guerra civile in Ruanda, aveva condotto il suo clan in salvo, lontano dai massacri. Dopo quindici anni di eccezionale stabilità per un regno di primati, il trono fu rovesciato da uno dei figli, forse lo stesso che lo ha fatto morire di infarto. Titus dal dorso d'argento accettò di buon grado di non essere più re, rimase nella tribù la quale continuò ad essergli devota, il che significa che ogni giorno gli hanno portato il cibo nella tana o sugli alberi. Ma la cosa più importante che lo riguarda, è accaduta dopo la morte. I membri della famiglia, mogli, figli, nipoti, sono arrivati sul luogo dove giaceva il corpo, si sono messi a rispettosa distanza e hanno fatto la guardia, impedendo agli esseri umani di avvicinarsi alle spoglie. Poi, alcuni di loro lo hanno lavato. Nel corso della riunione, il figlio maggiore, quello che gli ha causato l'infarto, ha alzato la testa e ha lanciato grida prolungate e cupe, e così hanno fatto gli altri familiari. La quale cosa assieme a tutte le altre assomiglia a un che di luttuoso. Abbiamo la libertà di immaginare che i lamenti dei gorilla abbiano chiesto a cielo, aria, alla foresta, agli spiriti della Natura-Dio, dove fosse finito re Schiena d'Argento, che li aveva tanto protetti e che prima era sempre vivo. Anche se presso i primati esiste una cerimonia di solenne rispetto e tristezza così simile a delle esequie di stato, non è una prova che gli uomini vengano dalle scimmie; di certo, si percepisce nei gorilla la consapevolezza della morte e che la morte esige rispetto e un congedo - il punto è quanto possa estendersi la memoria di Titus nei primati: a questa generazione e basta, o prosegue? Siamo propensi a credere che si fermi in questa generazione. Ma si percepisce un'antica epoca comune di uomini e gorilla, un patrimonio su cui è calato un oblio violento; una cancellazione ascrivibile al tempo infinito trascorso, e magari a un trauma collettivo. E se i gorilla fossero errori di costruzione genetica, se la selezione naturale avesse bloccato i rapporti fra uomini e primati, essendo i primati una specie dalla crescita bloccata per mancanza di una memoria che oltrepassi la singola generazione? Una specie senza mai un futuro? Se fra le due comunità ci furono rapporti e poi gli uomini decisero di porre fine all'unione, magari per la nascita di creature mostruose, non lo sappiamo per una rimozione o per un deficit di memoria che la scienza oggi non sa colmare. Solo i miti ricordano quello di cui un tempo ci si ricordava; ma i miti non hanno voluto costruire memoria su tale punto che assomiglia a un giallo dai risvolti agghiaccianti. Di oggettivo, rimane l'aspetto meravigliosamente equivoco della natura. In ogni caso, dopo le "esequie" di Titus mi sono messo a pensare agli animali, che sempre ci danno notizie, ci rinviano a qualcosa. Mi sono messo a pensare come uno che stia fermo e a un tratto riceve una spinta, e così, volente o nolente, si muove - traballando, ma si muove. Potrebbe esserci stato un tempo in cui uomini, scimmie, cavalli, anatre, lupi, ma tutte le bestie di cielo terra e mare erano fluidamente una società; prima che si frantumasse l'unità della vita, e che i mitologici primi uomo e donna, Adamo ed Eva, aprissero gli occhi e si vedessero reciprocamente nella cosiddetta nudità; deve esserci stata una fratellanza con gli animali, prima che l'uomo si accorgesse della tremenda povertà della sua condizione. Durante l'infanzia del mondo, allegoricamente descritta in Genesi, noi e gli animali ci capivamo: sapevamo chi fosse il Re generatore e con il serpente discutemmo anche di politica. Questo accadeva prima che noi, e loro, cacciati tutti per un terribile errore umano, scoprissimo la fame, la sete, il dolore, e peggio ancora, la morte. E così, prima che la necessità sviluppasse la conoscenza come violenta discontinuità con l'armonia, noi e gli animali ci frequentavamo. Oggi, consideriamo gli animali singolarmente: il cavallo mentre tira la carrozzella con sopra i turisti che ridono; il cane che corre nel parco e quasi ride riportando il bastoncino al padrone; al telegiornale, la balena arenata sulla spiaggia. Eppure, per quanto nelle nostre città noi li si incontri solo uno alla volta ed essi vivano in esilio dalla natura e separati tra loro, gli animali riescono a mantenere una sorta di unità politica dentro di noi. Sono depositari dell'idea di istinto. Portano impresso lo stile iniziale. Lasciano intravedere che tra noi e loro corre qualcosa come tra i membri di una nazione. Davanti a noi, ora, gli animali domestici sono come sonnambuli; assumono inerti le conseguenze dell'esilio dalla natura; subiscono le nostre abitudini e il nostro ego. Dormono in attesa che torniamo a casa; davanti al frigorifero, miagolano e chiedono il latte che possono avere solo tramite noi, invece di andarsi a procurare una lucertola come i loro avi. Gli animali selvatici poi sono remoti, dall'altra parte del mondo. Corrono su un altopiano; volteggiano su cime di montagne innevate; scivolano sul fondo degli oceani e molti non sono mai stati visti. Se no, smembrati e cucinati sono parte irriconoscibile di un bue, di un suino, di un pollo, di un gran pesce esotico, di popolare tonno - animali come cibo. Animali in mezzo alla natura, come improvviso pasto di bellezza; simboli di Giuseppe il sognatore e di Giovanni l'apocalittico; inchiodati alla parete, teste o corpi di una collezione imbalsamata. Notizia del mondo primordiale dai graffiti di una grotta; depositi di vertebre per lo studioso e per il pubblico di un museo. Imbambolata proiezione psichica: "Lulù, pappagallino di mamma!". Oggetto di delirante conversazione in treno: "Guardi, gli animali son meglio dei cristiani!". Intontita osservazione davanti al televisore: "Quel delfino sembra parli!". Poi gatti, cani, delfini non parleranno mai - ma sogniamo il tempo in cui lo facevano, sogniamo che lo facessero - ci servono per sognare. Nel simbolismo cinese, dove sono presenti gli animali selvatici e non i domestici, la tigre ha una luce che splende sulla testa e ha potere di comprendere se un uomo è buono. Più sommessamente, vedo che il mio gatto torna subito a casa quando lo penso - è telepate. D'accordo, siamo uniti: ma a quale fine? Ora che abbiamo classificato tutti gli animali, dal primate al mollusco, che trapiantiamo il cervello ai topi, ricacciamo nel buio impressioni che forse sono suggerimenti. Dice Filone l'alessandrino che quando gli animali furono nominati da Adamo, ricevettero il nome come segno di singole passioni umane, le quali sono paragonabili ad animali selvaggi, e vanno domate. E allora, quando l'uomo conosce ogni parte di sé, è ricco, e quando non la conosce, è debole. Ora che non conosciamo gli animali come ad esempio li conoscono i contadini, in modo familiare; che è svanita la sapienza dei bestiari e gli animali non fanno da specchio con il loro carattere, non c'è da meravigliarsi se non sappiamo che compiti abbiamo nel posto chiamato mondo. Guardiamo un gorilla: ride e piange, e chissà se davvero ride e davvero piange; lava un morto, o sembra che lavi un morto? E per quale motivo non dovrebbe avere il sentimento di lavarlo, per non perdere il nostro primato spirituale? Il nostro primato è dunque così miserabile da essere messo in discussione dal fatto che i gorilla piangono come noi, o c'è un lato della vita che è senza fine, scivola in avanti e non riusciamo a sfiorarne la comprensione? In ogni caso, gli animali sono degli incompresi. Noi li abbiamo. Li collezioniamo. Non li conosciamo. Finiti nelle nostre mani, non sono più veri cani, veri gatti, veri canarini. Sono ombre. Camminiamo con loro, stiamo in groppa a loro, giochiamo con loro, parliamo a loro, ma ci rivolgiamo a prigionieri. Creature ignare di avere perso il proprio regno - come noi? Chissà che succederebbe, a scoprire gli animali. Ah - scoprire gli animali.
Ventanni fa lasciai la città e con mia moglie andammo a vivere in una valle di fronte al monte Amiata, nei boschi e in mezzo alla natura. Entrammo in un altro ordine di vita. C'erano templi naturali fatti di ulivi, fichi selvatici, giganteschi e improvvisi arcobaleni che andavano da una parte all'altra della valle, funghi e fiori e giacimenti di insalata selvatica e legna fine con cui avviare il fuoco. Poi affiorarono gli animali. La notte, da sotto le finestre di un vecchio tentennante podere nel cuore del bosco, pervenivano borbottii, un raspare alla porta che poteva essere turbinare di foglie secche. Al mattino, nei praticelli intorno casa c'erano tracce di rami rotti che il giorno prima erano interi, un minuscolo sterco, e il cibo che avevamo dimenticato su un piatto era sparito; e un giorno, un sasso che pareva un sasso appoggiato alla porta di casa si mosse ed era un porcospino: era lui che veniva a prendere il cibo che avevamo iniziato a lasciare ogni sera a un amico sconosciuto e fedele. A notte, venivamo con la macchina e incontravamo file di cinghiali che attraversavano pazienti la strada bianca; ci fermavamo e contavamo i piccoli cinghiali dietro la madre e una volta ne contammo tredici. Una sera, sulla cassetta della posta, davanti ai fari, turbinò il biancore di un gufo reale, come neve in volo nella notte. E c'erano daini che guardavano da lontano come se non guardassero, in tralice, e avevano la groppa già piegata per scappare; e aquile che calavano dagli altipiani e scendevano fino a radere la campagna e forse a scrutare che facessimo dietro quelle finestre. I due giovani cani che avevamo tornavano felici da lontano, nei fianchi avevano i morsi fondi dei cinghiali e non uggiolavano - potenza della libertà. Quando uno dei cani morì, fu per lo sparo di un cacciatore.
Ero ragazzo. Avevo un cane, si chiamava Vaniglia. Era una femmina di restone, bionda; anzi: gialla. Come accade spesso tra padrone e cane, mi somigliava. Veniva alla redazione del giornale dove lavoravo; si accucciava sotto al mio tavolo, e alla riunione di redazione sotto quello dei grafici. Il giornale era satirico e misi il nome del cane sul tamburino. In seguito, Vaniglia entrò anche nella sigla di un varietà televisivo. Ma ecco che successe la prima volta che la portai al mare. Non aveva neanche un anno. Si mise a riva, davanti alle onde - sotto i minuti spruzzi bianchi. Osservava le acque con rispetto. Il tempo passava, e composto e in silenzio, quel cane non smetteva di farsi uno col vento e col mare, come se a un tratto avesse visto casa e ci fosse finito dentro. Quello lì davanti al mare era il vero cane, non quello della sigla Tv. Ma continuai a non conoscerlo. Quando il cane fu vecchio, andai a vivere in campagna e lo lasciai libero di andare e venire. Senza collare, senza tavoli sotto i quali stare, fu incontrollabile, ridivenne animale: razziò un pollaio, era una piccola fiera. Sparì. Credevo fosse morta. La rividi da lontano, dopo un anno: era su un crinale, correva alla testa di un branco di cani randagi, di quelli persi dai cacciatori. La chiamai: fu come se non sentisse. Corse avanti ancora. Era parte della natura. Non la vidi più.
In Genesi 1-21, il testo dice: "...Dio creò i grandi mostri del mare e tutto quello che vive e guizza nelle acque. E Dio vide che era bello". Il passo è abissale. Come può un grande mostro essere bello, anzi, giudicato bello? Eppure è vero, dato che risuona in noi. La bellezza animale dei mostri strega lo sguardo. Una piovra che vortica in una giostra di spuma, lo sguardo vitreo del pescecane sopra l'abisso dentato e un colpo di pinna che taglia l'oceano come fosse burro. In questo v'è energia e allegria, una visceralità della vita che toglie il fiato. Nel quadro del Tintoretto, "La creazione degli animali" un Dio canuto e gagliardo come un ragazzo temperamentoso, cammina nell'aria dato che è Dio. Lo vediamo di profilo, proiettato in avanti in un gioco di cui è entusiasta. Fiancheggiato da cielo e mare, il Padre-Ragazzo dell'Universo è colto nel grandioso gesto creatore degli animali. Uccelli e pesci appaiono già lanciati nell'aria, in volo come schiere di frecce. Alle spalle del Dio dell'entusiasmo e dell'energia, in mezzo a poche fronde, premono il muso di un cavallo, di un cane e altri volatili ancora, tutti impazienti di partecipare al mondo nuovo di zecca. E' di questa immane famiglia che ci viene raccontato, dove il padre degli uomini è più di conduttore e guida, più di pastore: è padre generativo di ogni specie.
Sul sito internet del parco nazionale del Ruanda c'è una foto scattata sulla tomba di Titus, subito dopo la sepoltura. Si vede una lunga linea di persone. Sono gli inservienti del parco, in tute da lavoro blu oppure verdi. Una quarantina di persone di colore, e un bianco. Le loro espressioni sono meste e solenni, degne di un'occasione storica e di una giornata da ricordare. Sono gli amici di Titus ritratti accanto alla tomba del re che pesava duecento chili, che era morto a 35 anni, aveva regnato su un piccolo popolo che alla morte aveva lavato le spoglie e montato la guardia al suo corpo gigantesco. Sopra la tomba c'è un cartello con scritto "Titus riposi in pace. Nato il 24 agosto 1974. Morto il 14 settembre 2009". Se i fumetti sopra le persone esistessero anche nella vita, sopra le teste di tutte queste persone intorno alla tomba di Titus ci sarebbe un grandissimo fumetto con scritto il pensiero di tutti i presenti: "Che re era Titus, il nostro amico" e alla fine, un punto esclamativo. E proprio adesso penso che l'anello mancante che i darviniani cercano, è l'anello spezzato dalla fine dell'armonia; che uomini, gorilla e animali erano fratelli, e gli uomini responsabili dell'intera natura - giardinieri. Poi la responsabilità fu lasciata cadere. Da quel momento tutto fu diverso. La foto intorno alla tomba di Titus illustra il mondo come era. Come era l'unione della natura. Ogni tanto si riesce a vedere tutto questo, stando di vedetta in mezzo alla nebbia.
ALESSANDRO SCHWED IL FOGLIO, 19 OTTOBRE 2009
|
|
Post n°33 pubblicato il 20 Marzo 2012 da Jiga0
|
|
Post n°32 pubblicato il 20 Marzo 2012 da Jiga0
|
|
Post n°31 pubblicato il 20 Marzo 2012 da Jiga0
La corte internazionale ha deciso: la Germania non paga i danni per le stragi naziste in Italia L'Aia ha deciso: non saranno pagati i danni per l'eccidio nazista dei 203 italiani uccisi a Civitella, Cornia e San Pancrazio. La sentenza scaturisce da una cultura giuridica per la quale ora c'è la pace con la Germania e per i discendenti il danno maggiore è di acquistare dei wurstel tedeschi fabbricati in Cina. L'assunto è che la guerra c'era quando c'era la guerra, ora c'è la pace e il diritto internazionale ha perdonato la Germania. Ormai le sofferenze sono finite: prevale l'idea che non si possa far causa a uno stato come se fosse una persona. Io posso fare causa al signore che abita al piano di sopra perché alle tre di notte si mette a camminare sulla mia testa, ma uno stato mica può mettersi a camminare sulla mia testa. Sarebbe l'apocalisse internazionale del disturbo notturno. A parte che una persona non è uno stato. Si è mai sentito che uno finisce le uova, va sul pianerottolo e le chiede alla Germania? Il secondo assunto che si aggira nelle stanze dell'alta corte è che ci sono 400 casi italiani di eccidi delle SS: vogliamo istruire 400 cause e scoprire che la strage è una condizione di vita normale quando c'è la guerra? In altre parole, ora che c'è la pace è un reato avere ragione e farlo presente alla Germania. Infine, anche volendo, i riscontri non sono possibili perché i testimoni principali sono morti subito. A quanto pare, chi fosse in lite con la Germania per fatti negativi avvenuti in Italia tra il '42 e il '45, deve rivolgersi ad Adolf Hitler. Era lui il titolare. Non dovrebbe essere difficile rintracciarlo: dall'Aprile del '45 non ha più lasciato Berlino. Se proprio non fosse possibile controinterrogarlo, le pretese cadono automaticamente: la legge dell'Aia mica è una ciofeca. Del resto, le richieste italiane sono valutate come derivazione di una cultura popolana: chiacchiere, pettegolezzi di taglialegna, segatura. "Mi ricordo, mi ricordo...". Eh no: tante cose si ricordano, e poi in via dei Ricordi non abita mai nessuno. Cosa c'è agli atti? Scaffali con fotografie, lettere di innamorati, voci che rimbombano nella testa. Niente di concreto. Erano in battaglia? No, erano in chiesa e i soldati si misero i grembiali mimetici. E in questo bisogna riconoscere che dopo la fucilazione i tedeschi erano pulitissimi e gli italiani erano sudici come al solito. Dice: ma non è giusto, ci sono pacchi di testimonianze. E allora? All'Aia coi dattiloscritti ammazzano le mosche e con la varechina del diritto internazionale sterilizzano la Storia. Bisognerà pur arrendersi: di fronte alla nebbia dei ricordi, ora c'è la pace e il nazismo va in prescrizione. La Seconda guerra mondiale diventa un gigantesco "si dice". La guerra c'era prima, se c'era. Ora c'è la pace. Dicono: "Le vite delle nostre famiglie sono rovinate: la notte sogniamo le SS che portano via mio padre". "Su, sentiamo: chi sogna queste SS, lei o questo suo padre?". "Io. Mio padre l'hanno ammazzato le SS". "Allora non millanti, non spagnoleggi, non suborni: torni con una delega di suo padre con la richiesta di rimborso per essere stato ammazzato". "Ma vostro onore!...". "Senta, intanto si soffi il naso che mi sporca lo scranno. E ragioni! Se suo padre viene tamponato da un camion, l'assicurazione chi rifonde lei o suo padre?". "Mio padre". "Visto! Lei che c'entra?". "Ma qui c'è una famiglia devastata, mia madre vedova, nessuno che lavorava...ci hanno portato via la casa". "Lo vede: si riduce tutto a una questione di soldi. Avido, si vergogni: un po' di rispetto per suo padre. Avanti il prossimo...". "Eccomi, vostro onore. In famiglia, soffriamo tutti di depressione". "Bene. Siete pazzi. Poi?". "Sono entrati in casa, hanno preso il mio fratellino di tre mesi, l'hanno tirato in aria e gli hanno sparato come a un piccione". "Eh, per un piccione". "...Io non ho detto piccione, ho detto 'come a un piccione". "Senti, matusalemme, tra dieci minuti ho l'autobus. Non rompermi le palle: siamo all'Aia, mica a casa di Mao". E' questa la pace. Non possiamo rovinare la pace ai tedeschi, sono appena riusciti a far dimenticare la guerra alla corte dell'Aia. Le cose andrebbero riconsiderate a mente fredda, davanti a una botte di gin. 203 italiani vengono accompagnati in una chiesa e mitragliati finché non ce n'è più bisogno. E' così che va la guerra quando si invade un paese estero: bisogna farsi rispettare perché c'è la guerra. E' durante la pace che è sufficiente farsi rispettare in Borsa. Comunque, i tedeschi sono puliti: si misero dei grembiali. Jiga Melik |
|
Post n°26 pubblicato il 05 Luglio 2011 da Jiga0
Allora la vita era questa Vasco smette. Dice che ha sessantanni, dice che non ce la fa più: non ha l'età per una vita da rocker - quella spericolata. Cantare, viaggiare, fare giorno, il rombo del furgone, gli alberghi. Il corpo del rocker è stanco. Il suo congedo è stato da rocker: ruvido, reale. Era stanco, l'ha fatto sapere. Non mi posso immaginare un cantante italiano famoso e amato come lui, che riempie gli stadi come lui, che fa come lui e spara dritto in faccia alla stampa di essersi stancato del tran tran. A lui invece è venuto di dirlo, lo ha fatto all'improvviso: questa burrasca non la regge, ed è chiaro che non se l'aspettava. Vasco è frastornato. Lo capisco. In effetti, per noi, per la generazione della giovinezza al potere e il potere alla giovinezza, non era previsto che la giovinezza se ne andasse. Dovevamo scintillare e basta, al massimo uno poteva spezzarsi in due, ma non provare seccature come il fatto di non reggere il ritmo, lo stress, la ripetizione. E in particolare, quanto alla scomparsa della giovinezza, quarantanni fa non era prevedibile perché da giovani nessuno si mette a pensare che poi la giovinezza ti pianta in asso. A sedici anni, e anche a trenta c'è il presente, così grande che non si vede la fine. E tutte le altre cose, il futuro, le tradizioni, le responsabilità, i doveri, la previdenza, la pazienza e la coerenza sono il recinto degli adulti - e la giovinezza è brada. Chi avesse detto tra i miei amici rocker, ribelli, militanti, beatnik, "ma poi che faremo da vecchi", sarebbe stato classificato come un caso disperato di umore nero. Il fatto che la giovinezza passi e un giorno si è vecchi così come a un tratto certi giorni comincia a piovere, era una litania che apparteneva alle prediche materne così come l'incombere della vecchiaia e la vecchiaia appartenevano agli anziani sconosciuti per strada e a quelli noti a casa, ai genitori e ai loro amici funebri che per le feste regalavano un servizio da té, alle foto nell'album di famiglia con una zia che aveva vissuto lucida fino a novantasette anni, ma gli ultimi venti era stata costretta a letto e sarebbe stato molto meglio che se ne fosse andata a settantanni. In questa nostra generazione nessuno progettava di vivere con prudenza e nessuno guardava il padre o la madre per fare un ragionevole calcolo su quando avrebbe iniziato a invecchiare e con quale malattia ereditaria addosso. Quando abbiamo iniziato a essere rocker e beatnik, avevamo negli occhi Hendrix che bruciava la sua chitarra al festival di Montreaux e la giovinezza appariva un presente sconfinato e inattaccabile dalle forze nemiche. L'età adulta era fascista, la vecchiaia reazionaria e meno male che c'eravamo noi. Nel rock poi uno è contagiato dal virus micidiale della giovinezza: il corpo è una molla il cui fine è tendersi e scoprire quando si spezza, le esagerazioni sono la norma e la norma un'esagerazione. Il rocker non pensa al dopo: il rocker è cicala, non formica. Dice Gregory Corso: "...beat è qualunque uomo che rompa il sentiero stabilito per seguire il sentiero destinato", e i rocker seguono il sentiero destinato: suonano. Seconda cosa, i rocker non pensano, la loro attività è catturare brividi. Terza cosa, se uno nella vita suona il rock, non è un professionista, ma un rocker. E non è finita: per un rocker non è immaginabile diventare come gli altri, e poi non è immaginabile diventare: un rocker è un rocker; inoltre, i rocker non hanno scelta: devono suonare. Se non hanno successo, pazienza, i rocker non vivono in funzione del successo, loro possono sopravvivere anche tutta la vita, ma la via è segnata, ed è che la notte il rocker canta, tira allo spasimo le corde della chitarra e poi fa un rapido inchino. L'inverno, se non è famoso, il rocker resta in silenzio; se è famoso, gira i teatri. D'estate, a seconda della fama, canta su palco grande o medio, oppure su uno piccolo nell'angolo di una piazza, e mentre canta la gente al bar beve il caffè, parla al telefonino e qui e lì scappa un applauso. Perché se no, nella vita, che avrebbe dovuto fare Vasco: l'urbanista, il bidello, il chirurgo? Vasco ha seguito il suo univoco destino beat e adesso il corpo del rocker è stanco. Magari non si aspettava che a un tratto la maggior parte del tempo gli si sarebbe presentato alle spalle; e noi non ci aspettavamo di arrivare al paradosso di essere non dico dei vecchi, e neanche gente malridotta, ma sostanzialmente delle persone non giovani con la necessità di dormire mezz'ora dopo pranzo - e questa è una cosa che alla nostra generazione non doveva essere fatta. Non che noi ci credessimo giovani divinità del canto roco, venute in Terra a rockblues mostrare. A far vedere come è bella una canzone svogliata e sguaiata, oppure come fosse "Spoonfull", versione 1967, quando a Londra scrivevano sui muri "Clapton is God". Ma la nostra generazione non si aspettava, e ancora non si aspetta di invecchiare: non perché qualcuno si ritenga immune dalla mortalità, dalle ordinarie malattie e da questa cosa dei reumatismi. Ma tale è stato il nostro culto del presente, da non vedere che il tempo stesse passando - e la nostra è stata una vita estremamente distratta: non guardando che succedesse al nostro involucro, il cosiddetto corpo. E a forza di dare del tu a degli sconosciuti incontrati a un concerto di Frank Zappa e The Mothers of Invention, come se questa affinità estetica potesse riempire il cosmo; a forza di prendere le cose così come vengono, a non interessarsi al rinnovo della patente, alla visita di leva, al ritiro del diploma di maturità, a cambiare città e a un tratto cambiare di nuovo città, e di città in città svegliarsi senza sapere dove abitiamo - abbiamo dimenticato di segnare i numeri di telefono dei vecchi amici e di guardare il calendario. I vecchi amici e il calendario hanno una funzione quotidiana: ricordano bene l'anno di nascita, le medie, le ripetizioni di matematica, il concerto dei Rollino Stones a Roma nel 1969 - e il corpo del rocker è stanco. Porterà via dalla scena quel modo di Vasco di tenere le mani davanti al corpo, il modo di uno che brancola nel buio ed è proprio lì che trova idee e versi, nel buio - come il minatore il diamante nella tenebra della miniera. Il rocker-minatore vive nel buio, mica di giorno: di luce c'è la luce del palco, artificiale e sparata, l'energia viene dalle chitarre, dai microfoni, il distorsore, e il concerto è una vibrante centrale umano-elettrica. Il rocker vive sul palco, non a casa. Nella vetrina spalancata degli stadi, nel gigantesco morso del pubblico. Il rocker abita allo stadio. Vasco, il cappellino in testa, arriva allo stadio e comincia a vivere la sua vita rocker, e gli stadi si somigliano tutti e sono la stessa casa, e alla fine un uomo non ne può più. I cancelli di ferro sbattono, il camion dell'amplificazione entra, dietro il furgone con la band. Vasco, il cappellino in testa, scende dal furgone, scende di macchina, forse da una moto e avrà gli occhiali da sole, si sarà alzato da poco: io queste cose me le immagino, sono quelle dei Led Zeppelin ai ventitre anni o giù di lì di Jimmy Page alla Royal Albert Hall, dei Rolling vecchi bucanieri incartapecoriti a Parigi, nel film di Scorzese, dei Blind Faith a Hide Park nel 1968, e poi dei Queen a Wembley, di Hendrix all'isola di White - tutti con sgargianti pantaloni a campana. E così Vasco Rossi entra allo stadio e avrà l'andatura da rocker: i rocker si riconoscono perché camminano come cowboy, ti aspetteresti che abbiano un lazo, lo lancino tra la gente e peschino qualcuno. Vasco lancia i versi delle canzoni e afferra la gente per la punta del cuore. Clac. Però, dopo quarantanni negli stadi, alla fine il corpo del rocker è stanco: nel pomeriggio il sound-check, la sera torni allo stadio, suoni e sei spremuto. Prima di un concerto davanti a quarantamila persone, dal corpo del rocker vanno via cinque anni. Non c'è una dissipazione simile. A un'ora dall'inizio del concerto, entri allo stadio e la paura ti tiene le zampe sul collo. La paura è una carogna meravigliosa. Chi non ha paura, non può essere un rocker. Il rocker deve suonare col ventre pieno di paura. Ti immagino, Vasco, prima del concerto. Arrivi allo stadio, cammini nei corridoi con gli altri della band, e nei corridoi tutti sorridono a Vasco - l'artista da vicino. Aspettano qualcosa da te, un miracolo. Sei Babbo Natale rock'n'roll, sezione Italia. Aspettano un miracolo quelli del botteghino, gli inservienti che vanno sulle gradinate a vendere gelati, i raccattapalle, gli uscieri, i magazzinieri e tutti i loro amici entrati di straforo. Sei nel corridoio che cammini e cammini, fuori la folla urla: Vasco, Vasco. Punti il camerino, secondo me sai già dove ti hanno messo. Poi dico che ti siedi e che pensi alla scaletta. Il chitarrista accorderà la Gipson, uno della band riderà più forte degli altri, è quello che ha paura, il più giovane. Mi immagino un tale che non c'entra con lo staff, un saputello con le mani in tasca, racconta una barzelletta a voce altissima - come si fa a raccontare una barzelletta a voce altissima? - il saputello ride a voce altissima come se si facesse un male cane e ora dovessero portarlo all'ospedale. Poi penso che vengono a chiamarti: Vasco, cominciamo, sei pronto? Tutto a posto, ragazzi. Prima di uscire e cantare, farai un pensierino alla donna, a Dio, a mamma, alla tua famiglia, alle tue famiglie, a tutti i tuoi amici o a un amico che non c'è più, al posto dove sei nato, e a bere un sorso buono. Ok, cominciamo. Apri la porta e sei di nuovo in corridoio. Cammini rapido verso l'uscita sul campo di calcio; quelli della band camminano rapidi con te. Nessuno parla, sorrisi tirati. Il clamore del pubblico aumenta, sali le scale che portano al campo, d'estate l'erba è sciupata. Odore di quest'erba, e anche di un'altra erba, una folata. Lo stadio è nel buio, fa parte dello show. Vicino all'uscita degli spogliatoi c'è una folla di fotografi, di gente che non capisci chi sia, uno ti stringe la mano e dice sono il sindaco, i poliziotti hanno il cane lupo che tira forte e ci sono i flash dei fotografi: Vasco sorridi, Vasco guarda qui. Vasco, Vasco. Una pioggia di pacche sulle spalle: sei anestetizzato, ridi. Qualcuno ti ricorda di entrare sul palco dalla scaletta dietro. Nel buio, le luci sono a posto, quando arrivi al microfono, lo sai, si accende l'inferno e si comincia. Ok? Ok. Le assi del palco, le torri degli amplificatori. Ci siamo: il cuore rulla. Sulle gradinate una ragazzina urla: eccolo!...E gli altri: Vasco, Vasco. I flash dei telefonini, i flash dei fotografi, un flash di quando eri bambino. Sei all'asta del microfono, prendi un respiro, vai. Il pedale della batteria batte sulla cassa, e uno, e due, sul palco si accendono milioni di luci, e ci sei solo tu: Vasco, Vasco. Il rock era bellissimo, ma ora non ce la faccio più. Basta. Basta sound-check, basta spogliatoi, basta corridoi, basta neon, basta camion, basta pacche sulle spalle e gente che ride urlando: il corpo del rocker è stanco. La giovinezza che non c'è più, è una prigione. Una vita in alberghi, autogrill, cercando fra stadi e autostrade un angolo a misura, un posto dove dire in confidenza a sé stesso: "Vasco, allora, come va?". Ci sono sessanta stagioni, il corpo del rocker è stanco. E' difficile che ci sia di nuovo un mondo come quello del rock: per carità, la notorietà è la stessa infezione in tutti gli show: i corridoi e le pacche sulle spalle, ma il mondo del rock è diverso. Nomade. Esoterico. Trasandato alla gran perfezione. Si trattava di concentrarsi, andare sul palco e coprire la folla di brividi. Stabilire un contatto con la gente come se la gente là sotto fosse la tua famiglia, e lo sa fare uno ogni cento milioni di persone. E se c'è modo di vedere che cosa sia la giovinezza, a che punto sia, quanto duri, è il rock. Il rock chiede il tuo coraggio, non basta essere bravi. Il rock è un brivido, il resto sono canzoni. Ma la vita prima e dopo il palco, logora. I ristoranti dove sogni un uovo al tegamino, e sono le tre di notte, la cucina è chiusa e c'è solo salsa tartara. Stancano le promiscuità e quel fatto che la gente ti dia del tu, e il cellulare che squilla, le interviste, gli impresari, gli agenti, il segretario, i ristoratori che corrono al tuo tavolo stropicciando il grembiale, i cuochi, un altro cameriere che porge un foglietto per l'autografo a suo figlio, e tutti che fanno l'occhiolino. Resisti a questo, resisti a tutto, ma non si può fiammeggiare tutta la vita, e il corpo del rocker è stanco. Hendrix riposa in pace nei suoi dvd, lo stesso fanno Janis e Jim Morrison. Steve Ray è caduto giovane come Patroclo, aveva fretta di andare a casa, era salito da solo sull'elicottero di Clapton. Gli altri, quelli che non sono morti, suonano e sono famosi, ma alla fine devono passare al blues, diventano meditativi - il corpo del rocker è stanco. Gli artisti morti giovani hanno avuto fortuna, si sente dire, e la loro fortuna sarebbe che morendo sono rimasti giovani. Chi ha continuato a essere vivo, a cantare, è solo uno normale: infatti è rimasto vivo. Hendrix e Mozart sono morti giovani e poveri e ancora ne parlano, dice qualcuno. Nel rock, se non sei morto da giovane in una vasca da bagno, da giovane in una piscina o sopra un water la siringa nel braccio, o fatto a pezzi e messo in una valigia come Alan Wilson dei Canned Hit (quelli di "On the road again"), se non capitano tali cupe vicende, ci vuole qualcosa in più per diventare un mito. Per esempio è successo a Beethoven. Beethoven era Beethoven, che discorsi, ma aveva toccato il cuore a tutti, e quando alla fine della vita diresse la Nona in un teatro di Vienna, ormai non sentiva più niente. Era sordo. La diresse aiutandosi con un sistema di cornetti acustici, pare che percepisse un ronzio ritmato e che un'assistente gli girasse le pagine dello spartito. Quando la musica finì, a Beethoven fu fatto cenno di girarsi verso il pubblico - si girò. Dai palchi e dalla platea fu sventolato un muro di fazzoletti bianchi. Nel teatro si sentiva il rumore che fanno le vele quando ci sono i colpi di vento. Questo è da leggenda rock. Ma per sopravvivere senza preoccuparsi dei colleghi leggendari morti, si deve essere giovani, incoscienti: suonare e cantare perché non c'è niente di meglio. Invece, anche se non l'avresti mai detto, a un certo punto il corpo del rocker si è fatto stanco. Mentre la gioventù è spensieratezza, parità con con qualsiasi cantante sconosciuto e con qualsiasi star. La giovinezza è l'unico comunismo realizzato senza danni. Per questo le canzoni di Vasco venivano bene, la voce non si curava di quello che la voce lasciava dietro - o così pareva a tutti. Un giorno deve essere successo qualcosa, forse a un certo punto conta cosa lasci in una giornata, e così è arrivato l'annuncio: il mio corpo di rocker è stanco. Proprio così, Vasco, non si può esser giovani per sempre come credevamo. O meglio: si può, solo che mentre dentro senti la giovinezza di sempre, la sensibilità di sempre, e il modo di dire le cose è quello di quando dicevi "allora ragazzi, che si fa stasera, andiamo al cine?", poi non è affatto così. Mentre ti continui a sentire il solito te stesso di sempre, parli agli altri e hai ventanni come loro, la verità è che quelli non ne hanno sessanta come te, non sono i tuoi coetanei, loro sono nuovi di zecca. Tutti quei ragazzi potrebbero essere tuoi figli, tuoi nipoti, e a volte si rivolgono a te con deferenza, e la deferenza non va bene - sarebbero mai arrivati alla deferenza con Hendrix? Non lo sapremo mai. C'è un film dove si vede Hendrix che suona tenendo la chitarra dietro la schiena, poi la fa girare intorno al corpo, la porta alle labbra e la suona con i denti. Davanti a lui, sotto il palco, un ragazzo lo guarda con la bocca spalancata, immobile come fosse di gesso. Vasco dice che non se la sente di continuare. Penso che succeda lo stesso ai comici: si può essere comedians per tutta la vita, Jerry Lewis per cinquantanni di seguito? "Ooooh, ragaaaaaazzi...che beeeeeeeello". Non si può essere clown per sempre. Anche a Chaplin è successo. Da vecchio faceva un film, bello, bellissimo, struggente, e ogni volta sembrava dicesse educatamente addio. Il comico da vecchio diventa una maschera tragica. Il rocker è come il comedian, chiuso nella prigione dello show - il rocker deve guizzare, o dare l'impressione di farlo. Di sicuro, ora che Vasco smette, non ci sarà più una parte del primo rock. Nel rock c'era una libertà potente, vera e falsa, quella vera molto vera e quella falsa molto falsa - erano belle tutte e due. La libertà del rock è appariscente e tagliente, e chi non l'ha vista, chi non ci si è tagliato, non può sapere quanto mancherà. Gli amplificatori friggevano sempre, domani Vasco li spenge. Curioso che si invecchi, allora la vita era questa.
Alessandro Schwed
Il Foglio 5 Luglio 2011
|
|
Post n°25 pubblicato il 27 Giugno 2011 da Jiga0
Brividi I nuovi ragazzi del mondo, quelli che vanno dai quattordici ai quaranta, sono tristi. E' morto Ryann Dunn. Chi di voi sapesse chi era, andrebbe censito come rara specie vivente; oppure è il contrario: si avvia ad essere specie da proteggere chi ignora la profusione degli eroi mediatici, nomi di qualche anno, destinati a essere sostituiti da altri nomi: più immagini che persone; più pixel che carne e ossa. Così, senza che noi adulti del Novecento lo sapessimo, ci è morto Ryan Dunn. Aveva fatto qualche film in Tv, una pellicola al cinema, ma era un eroe di MTV, uno stuntman eccentrico. Intanto, era fra i protagonisti dello show televisivo di avventure spericolate "Jackass", più o meno "Idioti", ma andrebbe bene anche il più stradaiolo "Bischeri". Ryan era di un cosmo che in Italia va in onda sulla parabola, un successo televisivo dell'altra parte del mondo. Si era fatto conoscere per acrobazie poi divenute mitiche: spaccare le piccole vetture dei campi da golf, volare dai tetti, o eseguire preziosismi discutibili, come quando inserì nel proprio retto una macchinina-giocattolo. Ryann radunava pubblico a qualsiasi costo con le sue imprese da locanda di bucanieri, goliardate da brivido. Non un eroe come nella classicità, quando gli eroi erano Achille ed Ettore e le loro gesta oltre a essere cantate da Omero, o nelle veglie invernali di regge che alla fine erano spelonche, venivano dipinte intorno al giro di un'anfora - le anfore erano i media di una volta. Ryann era un eroe della Tv giovanile americana e planetaria, un esuberante alter ego di milioni di adolescenti, avatar di ognuno come alla playstation ogni giorno. Quando cinquantanni fa Mario Riva cadde dal palco dell'Arena di Verona e morì, la mia emozione di ragazzo non fu la stessa: non fui triste, ma sconcertato che la morte potesse entrare nella vita con questa facilità trasandata. Dunn era una star del mondo degli stuntmen, un solista delle esagerazioni roboanti, cugine del wrestling e di ogni eccesso spettacolare, ma molto più pericolose. I brividi e la morte affascinano il pubblico giovanile che oscilla tra documentari sul nazismo travestiti da Storia e gente che si lancia dal grattacielo con la macchina. E appunto che sia morto Dunn, l'ho appreso da mio figlio adolescente - che non so come faccia ad avere tempo a sapere tutto, mentre suona la chitarra, guarda film, gioca a playstation, amministra i dibattiti del circolo culturale del social forum, e poi ogni tanto dorme. Ryann Dunn era come Bear, ex marine delle forze speciali inglesi, protagonista di decine di puntate televisive che sono le sopravvivenze nei deserti e nelle foreste di tutto il mondo, in crepacci dove si fa lasciare con l'operatore televisivo che lo riprende mentre lui sopravvive mangiando talpe, accendendo sterpi bagnati, depurando l'orina e bevendola. Solo che Bear, per fortuna, è vivo - anche se ora, dopo due stagioni di devozioni a voce alta mio figlio e i suoi amici stanno lasciandoselo alle spalle. Ryann era come Andrew Zimmern, l'anchorman viaggiatore di Bizarre Foods, documentario di cucina a dir poco esotica, ma esotica è poco e cucina è troppo. Andrew entra in un villaggio dell'Uganda, si fa invitare a pranzo dagli aborigeni e banchetta con il loro piatto speciale, le termiti al vapore. Un eroe dell'assaggio. E' che gli eroi del mondo di ora sono volatili, potrebbero morire di indigestione, di lavanda gastrica, di puzzola indigesta. Se no, lasciano la vita volando fuori strada con la macchina per via di una bevuta di birra. Non maledetti, ma incauti; eroi di questo lungo tempo di inconcludenza quotidiana e benessere inavvertito che neanche la crisi economica sta riuscendo a scuotere - eroi postmoderni che ormai non sono il nulla e non sono più postmoderni: ormai il flusso di immagini è permanente. Elude l'arcaica differenza tra il giorno e la notte, trasforma il tempo in una parentesi. Nell'indecifrabile adolescenza sempre più lunga e ludica, dove i quattordicenni giocano a playstation giochi di uomini trenta, quarantenni, i Ragazzi-Sempre-Ragazzi si affezionano a dei clown della morte che rischiano la vita in modo buffo. Tutto questo, oltre che discendere dalla tradizione che lo spettacolo americano ha mutuato dal cinema e consiste di inseguimenti, salti nel vuoto e nel fuoco (che infatti in gergo tecnico sono chiamati gag come i numeri comici), tutto questo, dicevo, potrebbe provenire dall'antico, eterno mondo delle scommesse anglosassoni, dai giorni piovosi passati al pub e al whisky, puntando mezza sterlina su quante uova sode un uomo possa mangiare in tre minuti. Ryann era ubriaco e andava a centosessanta. E' morto come un ragazzo qualsiasi.
Alessandro Schwed Il Foglio, 25 giugno 2011
|
|
Post n°24 pubblicato il 29 Aprile 2011 da Jiga0
Tag: dramma, Elias Canetti, fiaba, Golem, Jakov Lind, leggerezza, Nazismo, Patrie, umanesimo, yiddish
IL NIPOTE DI SC'VEIC Come dall'interno di una botola teatrale che è la Seconda guerra mondiale, sbuca il sergente della Wermacht Gauthier Bachmann. golem di un'umanità immersa nel nazismo. Dopo il massacro del suo reggimento, svanito in pochi minuti sul campo di battaglia, Bachmann è stordito, o forse lo è sempre stato. In ogni caso, viene dichiarato inabile, tara fisica e morale che non accetta. Al contrario, vuol dimostrare che sa eliminare benissimo gli esseri umani e obbedire a un ordin
Alessandro Schwed Il Foglio, Aprile 2011
|
|
Post n°23 pubblicato il 29 Aprile 2011 da Jiga0
Cinturino torna dalla guerra
Eccomi in treno che torno a casa. A un tratto la guerra è finita e io guardo l'Ucraina dal finestrino...Lo vedi, il treno è pieno di ragazzi italiani. Torniamo. Ero prigioniero...sono finito in Russia... Appoggio la testa allo schienale...ancora non mi abituo alla libertà. Una ventata dai binari, un treno di gente che canta. Scommetto che la mamma è in carrozzella davanti all'uscio. Vedo il cartello con la scritta: Italia. Sul treno gridano: l'Italia! Grido anch'io. Ecco, guarda: Bolzano. Sul marciapiede c'è una folla che urla, ma che succede? sono donne, gridano ciao, battono le mani, c'è anche una bandiera, ragazze, mamme coi bambini in braccio, bambine coi fiori, donne coi capelli bianchi, la guerra è finita, il suono dell'italiano è dolce. Quella ha gli occhi come la mamma nella foto da fidanzata, una ragazza regala una pentola di patate, c'è il latte, il pane fresco, una frittata. Mi affaccio al finestrino, mi danno qualcosa, bevo vino e neanche lo so, mi piego fuori, una ragazza mi abbraccia, è bella, rido con le lacrime, ciao Bolzano, non ti dimentico per tutta la vita. Non è finita, Piacenza, Reggio, alle stazioni le donne, i fiori, il ragù, una festa lunga come l'Italia, sono un ragazzo italiano che torna a Montalcino. E' il 2 di luglio e adesso arrivo. A Siena c'è il Palio. A Montalcino la corriera si ferma alla tornata della piazza. Davanti alla fiaschetteria incontro lo zio Bruno: fa una faccia. A casa si apre la porta, per prima vedo la mamma.
Poi senti. Dopo una decina di gior ni sono andato a lavorare alla fornace. Siamo liberi, dissi, si comincia un'altra vita.
Alessandro Schwed 2005 - Le voci di Montalcino
|
|
Post n°22 pubblicato il 18 Febbraio 2011 da Jiga0
Tag: alessandro schwed, America, amore, deportazione, ebrei, fred wander, fuga, mare, marsiglia, persone, presagio, vicoli
HOTEL A STELLA GIALLA 1942.Vigilia dell'invasione tedesca in Francia. Una folla di ebrei si accalca all'Hotel Baalbek di Marsiglia, città-ultima spiaggia qualora si abbia il denaro per imbarcarsi in direzione dell'America; per gli altri, città-trappola dove sognare di salvarsi. In albergo, il tumulto delle stazioni: si arriva, si parte. Ci si separa: da amici occasionali; dai bar del porto; dalla società malavitosa che compra e vende; dagli ultimi giorni di normalità. Una sera c'è Edith Piaf, piantata sul palco all'Odeon, canta con la voce metallica in spregio alla morte. Protagonista è un ventenne in fuga, sventato, povero. Vorrebbe fuggire in America. Incontra Katia, bella e inquieta ragazza ebrea, segretamente partigiana. Lei lo porta al Baalbek, rifugio dove vivere la parvenza di una vita. Il padre di Katia, un vecchio sarto, gli fa subito una bella giacca di lino. I due giovani si innamorano, ma non se lo dicono. Si sono incontrati in una vita senza futuro, si guardano e basta. Il ragazzo scopre gli ebrei: operai, medici, insegnanti, lo scemo del vilaggio. Al Baalbek ci si organizza: con trecento dollari puoi scappare ad Algeri, nella stiva di una nave. In viaggio passano l'acqua potabile, niente più. Nel viavai di improvvise partenze, i poveri rimangono e ricevono regali dai ricchi che invece partono - e allora i poveri si rallegrano amaramente. La polizia fa retate nel foyer. Il proprietario protegge, ma forse è della polizia. Ai commissariati le celle sono cantine, le prostitute si pettinano, cantano: incontro dantesco con un'umanità marginale e immensa. Il Baalbek è una tendopoli a più piani. Le porte delle stanze sono aperte, la gente è addossata sulle scale, guarda dalle ringhiere ed è guardata. Le donne cucinano zuppe di cavoli, il cui odore ricorda la normalità, e gettano sguardi nelle stanze altrui. Le partenze sono quelle di chi ha comprato un visto, le notizie dalla realtà sono quelle di un piroscafo carico di ebrei, affondato dai tedeschi: non basta l'oro per rimanere vivi. Chi parte, lascia tutto nelle soffitte dell'albergo. Qui, fino a dopo la guerra, sosteranno valige, pacchi. Come in una vacanza insensata, nel foyer dell'albergo la gente discute di economia, di che cosa faranno i tedeschi. Molti non credono possibile che il mondo lasci fare i nazisti, fatale discussione ebraica. In mancanza di informazione libera, le notizie vengono desunte: quali eventi internazionali avranno fatto lievitare drasticamente il costo di pasta, margarina e pesce essiccato? Scorrono i caratteri degli inquilini, l'amore tra i due ragazzi, la gelosia fanciullesca di lui, la giovinezza inesperta di lei, nonostante i fucili nascosti sotto il letto. Poi Katia svanisce: si dice che fosse sul piroscafo per la Martinica affondato dai tedeschi, ma ancora dopo la guerra non si sa se Katia sia viva. Prima della deportazione, il ragazzo ha tempo per un amore, questo vissuto, per Lily, la moglie di un amico che poi tornerà dal marito. I vecchi coniugi Stern partono per la Spagna: valicheranno le montagne con dei passatori. Spediscono in altre città i propri libri, gli oggetti, i vestiti. Regalano le proprie cose agli amici dell'albergo. Un mattino li trovano distesi sul letto della loro piccola camera. Si sono tolti la vita. Era questa la loro partenza. "Avremmo dovuto fuggire per tempo, ma dove?", domanda il ragazzo a un amico del Baalbek, una notte che marciano al freddo, ormai prigionieri dei nazisti. Il grande personaggio è l'albergo. "...mobili pieni di fessure che diffondevano un odore acidulo, come in tutti gli alberghi a poco prezzo: avevano assorbito tutto, tutto, quei mobili e quelle pareti, come spugne avevano assorbito il dolore degli uomini e il loro fallimento". Gran libro. Alessandro Schwed
Il Foglio ,18 febbraio 2011
|

CAN EXPRESS - VOLUME SCANDALISTICO PER CANI



CERCA IN QUESTO BLOG
IL FRIGO GIA' PIENO
CHI PUò SCRIVERE SUL BLOG
I messaggi e i commenti sono moderati dall'autore del blog, verranno verificati e pubblicati a sua discrezione.
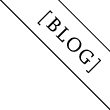


.jpg)








Inviato da: Jiga0
il 20/03/2012 alle 21:32
Inviato da: Jiga0
il 20/03/2012 alle 21:26
Inviato da: Jiga0
il 20/03/2012 alle 21:17
Inviato da: Jiga0
il 08/07/2011 alle 13:51
Inviato da: sergio
il 07/07/2011 alle 14:20