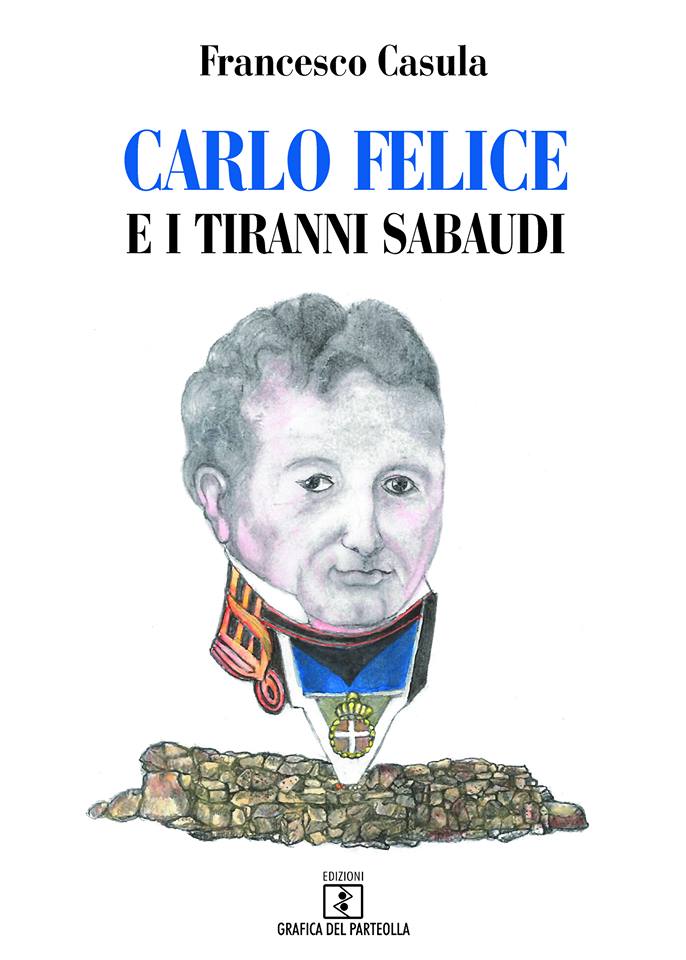Alessandro Barbero e lo sciocchezzaio sul Medioevo sardo.
di Francesco Casula
Alessandro Barbero, come una star televisiva o cinematografica o canora, spopola nei Media. Fan devoti, osannanti e plaudenti, lo venerano. Come il 10 maggio scorso, nel Salone del libro a Torino, quando centinaia e centinaia di uomini e donne, lo accolgono sul palco, con un vocio tonitruante, con urla e berci, da veri e propri tifosi da stadio.
Ho l’impressione, a prescindere da quello che racconta e sostiene, come storico intendo. Capita così che dopo aver più volte ribadito che “non conosce la storia sarda”, sulla stessa pontifica discetta giudica, impancandosi a vero e proprio maestro e distribuendoci vere e proprie perle (leggi fole), come quella secondo cui nel Medioevo sardo (ovvero dei regni giudicali) “la lingua del potere era il greco”! Possibile che anche a uno “non specialista sulla storia sarda” (parole sue!), non venga in mente che la lingua del potere per eccellenza nei Giudicati, è quella usata nella Carta De Logu, una delle più illustri e importanti Costituzioni nell’intero Medio Evo europeo?
Mi son domandato da dove può aver desunto e tratto tal scempiaggine. Forse dal fatto che nel regno giudicale di Càlari la lingua sarda veniva scritta anche in grafia greco-bizantina? Ma allora il nostro confonde la lingua con la grafia! Ricordo peraltro, che la grafia greca viene utilizzata, solo nel regno giudicale di Cagliari e, pochissime volte. In due pergamene, scritte comunque nella variante sardo-campidanese: la prima è del 1089: “contiene una donazione di terre servi aggregati rurali, vigne e “salti” da parte del re Costantino I” (1). La seconda, dei primi 20 anni del secolo XII “contiene la certificazione da parte del re giudicale di Cagliari Torchitorio de Gunale di una serie di negozi effettuali da tale Gostantini Frau” (2).
La seconda perla che ci ha distribuito il Barbero, è ancora più “preziosa”: riguarda il “colonialismo”. Nella sua furia iconoclasta, tendente a liquidare “pregiudizi e infatuazioni” (ha usato proprio queste locuzioni) sul Medioevo sardo, come sulla storia sarda in generale (aggiungo io,) nega che il colonialismo abbia caratterizzato l’Isola.
In questo pregiudizio e infatuazione sarebbe caduto anche un grande storico come Jonh Day: per il quale la Sardegna era un laboratorio di storia coloniale. Una delle più antiche e costanti colonie del mondo.
Per Barbero niente affatto. E fa un esempio. Con la presenza di Pisa e Genova la Sardegna non fu per niente colonizzata. Anzi. Esse portarono in Sardegna imprese capitali ricchezze commerci: creando la potenza dei Giudicati.
Ma va? Un po’ limitato e miope lo sguardo storico del Barbero, con qualche simpatia nordista e savoiarda (è quello che nega lo sterminio dei Meridionali con Garibaldi e soci e i campi di concentramento dei tiranni sabaudi, ad iniziare da Fenestrelle).
Se avesse allungato lo sguardo avrebbe visto e capito i risultati della funesta presenza dei Pisani e Genovesi nei Giudicati (quello arborense escluso) in cui apporterebbero, a parere dello storico piemontese, “magnifiche e progressive sorti”! Ovvero la loro morte e scomparsa!
Ma ecco la storia che Barbero dovrebbe studiare, prima di pontificare e raccontare balle: tutta la prima parte del secolo XIII assiste a una lenta agonia della Sardegna giudicale che si conclude con lo smembramento dei Giudicati di Cagliari (1258) e di Torres (1259) mentre quello di Gallura, caduto sotto la signoria dei Visconti, languirà per qualche decennio e morirà nel 1288. Resisterà solo il Giudicato d’Arborea: che intelligentemente e opportunamente, non si lascerà blandire dai portatori di benessere, civiltà e ricchezza venienti dal mare!
Fu infatti esiziale per la stabilità dei Giudicati, il fatale contatto con l’Europa comunale e feudale e insieme l’aver consentito da parte dei Giudici e Maiorales, che i signorotti stranieri che vi si erano stabiliti, imparentandosi con le famiglie senatoriali, vi ottenessero vasti possedimenti, edificando castelli e dotandosi di proprie milizie.
Nel disgregamento dei Governi giudicali, esautorati i Giudici e divisi i maiorali, essi – gli stranieri, segnatamente Pisa e Genova – poterono raccoglierne l’eredità e impadronirsi di buona parte dell’Isola.
Nel breve giro di pochi decenni, troviamo stabiliti nel Logudoro i Doria e i Malaspina; in Cagliari i Massa e i Donoratico; in Gallura i Visconti. Furono essi, portando in Sardegna la turbolenza feudale, le rivalità comunali e la spregiudicatezza politica che distrussero i Giudicati. Essi infatti riuscirono a insinuarsi nelle famiglie maiorali, imparentandosi, ottenendo vasti possedimenti e perciò stesso ponendosi nella condizione di candidati al governo giudicale: in Cagliari nel 1188 con Massa (Benedetta Massa) e i Visconti in Gallura (1207), quando alla morte di Barisone di Gallura, erede è la figlia Elena di Lacon che sposerà Lamberto Visconti dando così origine, alla dinastia pisana dei Visconti. Il loro figlio Ubaldo Visconti diventerà infatti Giudice di Gallura.
Di un Giudice dei Visconti parlerà Dante nella Divina Commedia (Canto VIII del Purgatorio): si tratta di Ugolino Visconti, noto come Nino ((Pisa, 1265 circa – Gallura, agosto 1296), suo amico, immortalato e ricordato come “giudice Nin gentil”.
I Visconti aspireranno anche al Giudicato di Cagliari, che peraltro si troverà alla mercé anche di altri contendenti, come Genova: che però fu sconfitta. Contribuirono alla sua disfatta Pisa, il Giudicato d’Arborea, il Giudice di Gallura, Gherardo e Ugolino dei Donoratico.
Così il Giudicato di Cagliari fu diviso in tre parti: 1/3 andò ai Giudici di Arborea; 1/3 ai Giudici di Gallura e 1/3 ai Donoratico.
Dopo Cagliari seguirà la crisi del Giudicato di Torres (a causa dei conflitti fra famiglie dei maiorales di Pisa e Genova e il Papato) e di quello di Gallura con le rivalità fra i Lacon e gli Spanu.
Il potere giudicale, a Cagliari, Sassari e Gallura, con la presenza preponderante di Pisa e Genova, diventa solo nominale e così quei Giudicati, perdono di fatto, la loro indipendenza.
Così, a Cagliari nel 1257 un esercito pisano, assedia ed espugna, distruggendola la capitale, Santa Igia e nuova capitale, diventerà Castrum Caralis, edificato su una collina adiacente. Sulle mura già poderose del Castello i Pisani erigeranno tre splendide e temibili Torri: dell’Elefante, di San Pancrazio e del Leone (costruita nel 1322), erroneamente chiamata dell’Aquila, che non fu mai completata.
Qualche anno più tardi nel 1259 cadrà il Giudicato di Torres (o del Logudoro), in parte assegnato come feudo a famiglie genovesi (Doria), in parte annesso al Giudicato di Arborea.
Dopo qualche decennio nel 1296 scomparirà anche il Giudicato di Gallura, occupato dai Pisani.
Note bibliografiche
1. F. Cesare Casula, La scrittura in Sardegna, dal nuragico ad oggi, Carlo Delfino editore, Cagliari 2017, pagina 62.
2. Ibidem, pagina 66.