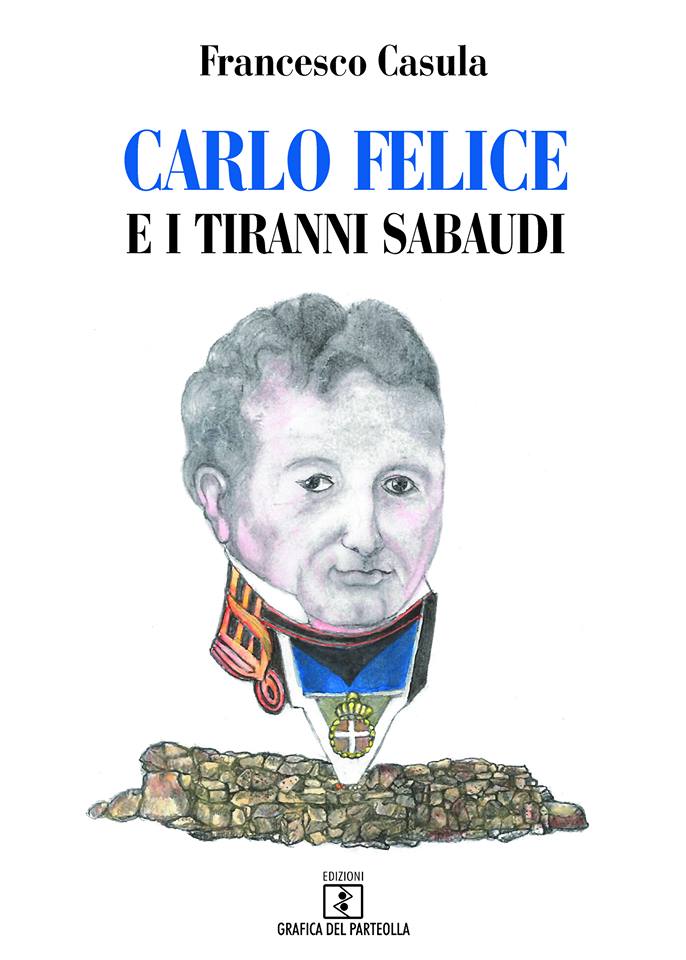L’ammazzamento del viceré Camarasa: un episodio della storia sarda più famoso che conosciuto.
di Francesco Casula
Durante la loro esistenza (dal 1355 al 1718/20) vi furono tentativi ricorrenti degli Stamenti di rivendicare e di assumere più ampi poteri. Come in tutta Europa del resto, i Parlamenti lottavano contro i re/principi che invece tentavano di instaurare il loro potere assoluto.
L’episodio di maggiore frizione e conflitto fra il Parlamento sardo e il sovrano spagnolo avvenne nel 1655, quando gli Stamenti posero al sovrano una condizione secca: noi approviamo il donativo quando e se voi approvate le nostre richieste.
Fino ad allora il Parlamento che si riuniva ogni dieci anni, aveva posto il problema delle richieste ma slegate dall’approvazione del donativo. Ora invece è intransigente: senza l’accoglimento di ben 25 richieste, il donativo non verrà approvato.
Protagonisti di quel Parlamento sono l’arcivescovo di Cagliari (che era anche capo della Chiesa sarda) e soprattutto il marchese di Laconi don Agustin de Castelvì, «prima voce » dello stamento militare, che viene inviato a Madrid per spiegare (e convincere) il re in relazione alle richieste del Parlamento.Contrariamente all’uso dell’invio di un rappresentante per ogni stamento, don Agustin fu mandato lui solo a capo della delegazione, a riprova della fiducia che l’intero Parlamento, finalmente unito, salvo un gruppo nettamente minoritario, riponeva in lui.
Rimarrà per un anno a Madrid: resistendo a ricatti, minacce e lusinghe. Tentò anche forti mediazioni, riducendo le richieste da 25 a 5: una di queste non era altro che l’habeas corpus, cioè il principio secondo il quale nessuno può essere imprigionato senza il mandato di un giudice e sulla base di un reato definito; l’altra, molto più rilevante ai fini economici e sociali delle classi privilegiate che il Marchese di Laconi , rappresentava, era quella della riserva ai residenti in Sardegna di tutte le cariche, civili, religiose e militari.
Il Governo di Madrid, naturalmente, respinse le richieste, non solo per una questione di merito ma di principio: non poteva accettare la tesi dello scambio (donativo per approvazione richieste) perché in qualche modo avrebbe significato mettere in una situazione di parità il regno di Sardegna con quello di Spagna.
Di più: al suo ritorno in Sardegna agli inizi del 1668 il viceré Emanuel Gomez de los Cobos marchese di Camarasa, destituì il marchese di Laconi e il 24 maggio sciolse il Parlamento stesso. Circa un mese dopo, nella notte fra il 20 e il 21 giugno il marchese di Laconi fu ucciso. Il delitto, fu fatto ricadere sulla corte viceregia. E comunque un mese dopo fu assassinato anche il viceré Camarasa. Furono accusati la moglie e il suo amante, Salvatore Aymeric, cadetto dei conti di Villamar.
Uno scontro fra il viceré, il suo autoritarismo e il parlamento? E in particolare con il Marchese di Laconi, invero un po’ ribelle e bandolero ma caduto per la difesa degli interessi dei naturales sardi, di tutti indistintamente? Addirittura «redemptor y restaurador de la Patria»? «Padre del Pueblo» o «amparador de los pobres», espressioni che risultano da alcuni documenti dei giorni seguenti il delitto? Questo è il don Agustín che si vuole accreditare presso l’opinione pubblica. In realtà si tratta di un conflitto fra gli interessi delle classi privilegiate sarde e il Governo di Madrid che non vuole rinunciare minimamente al centralismo del suo potere e del suo dominio.
In altre parole, comunque: ”Non è certo possibile ricondurre questi episodi a un consapevole progetto di affermazione autonomistica e ‘nazionale’ dell’isola nei confronti della Spagna, ma essi sono comunque il segno di una monarchia non più vincente sul teatro politico e militare europeo in piena decadenza economica e civile, e che non ha più argomenti sufficienti per far accettare senza reazione le sue pretese centralistiche. E non può più offrire alle aspirazioni di affermazione delle élites, e forse dell’intera società sarda, un orizzonte di adeguato appagamento”*.
*A. Brigaglia A.Mastino G.G. Ortu, Storia della Sardegna 3, Editori Laterza, Roma-Bari 2002, pagina 31.