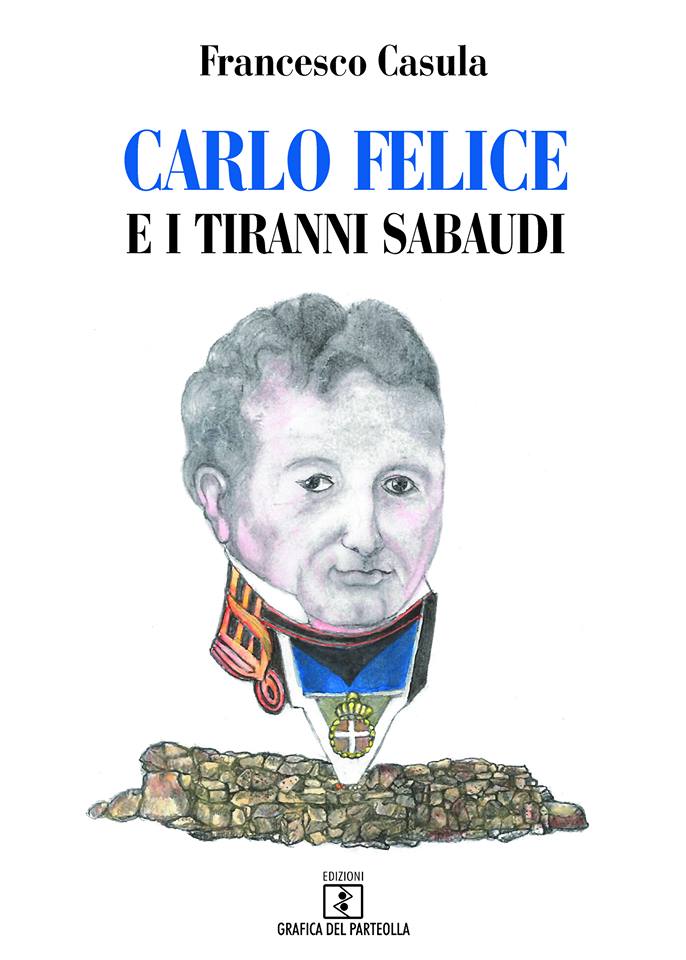MONTANARU E SA LIMBA SARDA
di Francesco Casula
Montanaru impreat sa limba de sa mama in cada si siat manera e cun balentia manna. Est pro more de sa limba sarda, chi issu podet arribare a iscriere poesias mannas e galanas. In sa poesia sua si nuscat frischesa e sincheresa: “Un popolo senza dialetto – iscriet – se potesse esistere bisognerebbe immaginarlo vecchio, compassato, retorico, accademico, freddo e burbero: privo delle tenerezze dell’infanzia, senza le gioie dell’adolescenza e l’esuberanza della gioventù. E come questi tre stati dell’età umana vengono a completare l’uomo, così i processi linguistici del dialetto rendono fresca, semplice, immaginosa una lingua: servono a svariarne lo spirito, agitarne le movenze, a renderla insomma viva e interessante, semplice e piana” (1).
E cuncruiat: “Nessun progresso potrà significare la scomparsa del nostro patrimonio dialettale perché ciò che è intimità della nostra natura rimarrà sardo nel bene e nel male” (2).
Su poeta de Desulo, peroe, in sa limba non biet ebia una funtzione literaria e poetica, ma puru una funtzione tzivile, de educatzione, de imparu pro sa vida. In su Diariu suo iscriet gosi: “…il diffondere l’uso della lingua sarda in tutte le scuole di ogni ordine e grado non è per gli educatori sardi soltanto una necessità psicologica alla quale nessuno può sottrarsi, ma è il solo modo di essere Sardi, di essere cioè quello che veramente siamo per conservare e difendere la personalità del nostro popolo. E se tutti fossimo in questa disposizione di idee e di propositi ci faremmo rispettare più di quanto non ci rispettino” (3).
E galu: “Spetta a noi maestri in primo luogo di richiamare gli scolari alla conoscenza del mondo che li circonda usando la lingua materna” (4).
Diat essere – comente podet cumprendere cada unu de nois – chi cada mastru de iscola imbetzes de cundennare sa limba e sa curtura de su logu de sos dischentes, a issos los depet zunzullare a connoschere e istudiare e imparare cun su limbazzu issoro, una manera de essere, de fàghere, de cumprendere, ebia gai si trasmitit a beru sa curtura de su logu, in iscola. Oe, totus sos istudiosos: linguistas e glotologos, e totus sos scientziaos sotziales: psicologos e pedagogistas, antropologos e psicanalistas e peri psichiatras, sunt cuncordos a pessare, narrere e iscriere de s’importu mannu de sa limba sutzada cun su late de sa mama. Su chi narant est chi pro creschere bene su pizinnu, pro aere elasticidade e impreare comente tocat s’intelligentzia, a imparare duas limbas li fàghet bene e l’agiudat puru a creschere mengius.
Est in sos primos tres annos de vida chi su pilocheddu cumintzat a aere s’abecedariu in conca, e puru si a s’incuminzu de s’iscola sas allegas, sa gramatica, sas maneras de narrere parent amisturadas, sa conca sua est giai traballende pro assentare totu, una limba (su sardu) e s’atera (s’italianu). Nos ant semper narau chi su sardu limitaiat s’italianu e imbetzes est a s’imbesse. Una limba cando la sues e la faghes tua dae minore, t’imparat unu muntone de cosas. T’imparat a biere su mundu in una certa manera, t’imparat a assentare sos pessamentos, t’imparat a ti guvernare a sa sola dandedi unu sensu mannu de responsabilidade, ca est una cosa tua, ca l’as intesa e impreada dae minore. Gasi si podet badiare a in antis e cumprendere totu su chi tenes cara cara, cun curiosidade e gana de imparare.
S’americanu Joshua Aaron Fishman, istudiosu mannu de sotziu-linguistica lu narat craramente, su “bilinguismu” no est de curregere, ne una cosa chi ti faghet trambucare, ma una manera bona de imparare chi t’agiudat in sas intragnas de sa vida e cunfruntande-di cun sos ateros. Limba e curtura de su logu de una pessone sunt medios e trastes de liberatzione, de autonomia, pro ti podere guvernare a sa sola, de indipendentzia, serbint a s’isvilupu de una pessone e mescamente de sos giovanos pro ite sa base abarrat su naturale issoro, partit “dal mondo che li circonda”: pro la narrere a sa manera de Montanaru. Sa limba imparada in domo e in ziru dae minore, serbit pro irmanigare sas cumpetentzias de comunicatzione, de sinziminzos, e de cunfrontu cun s’ateru e li serbit puru pro imparare ateras limbas.
Li serbit a essere cussiente de s’identidade sua, de l’intendere balente, de l’impreare, de non timere cumpetitziones ma de si cufrontare a barbovia cun atere, sena mancantzias. Li serbit pro fagher sua s’esperientzia de s’iscola e de sa vida, imparende e boghende a campu sas raighinas suas. Sa limba, s’istoria, sa curtura de su logu serbit a sos pitzinnos pro aere sigurantzia in issos matessi, pro apretziare s’ambiente in ue istant, pro connoschere sos balores de su logu issoro, primu intra totus s’istare paris, s’amistade e sa tratamenta, balores o maneras de faghere de sa tzivilitade sarda chi sunt balentes meda. Pro los agiudare a brusiare s’idea malavida de su “sardu” comente pessone limitada, comente curpa o neghe, pro los agiudare a no si brigungiare prus de essere sardos, ma l’imparare chi est unu balore mannu, comente essere albanesos, marochinos, o palestinesos. Sos pitzinnos oe sunt male chistionados, non tenent ne manera, ne allegas assentadas pro comunicare, imparant allegas malas o gergo, – comente aiat jai naradu Gramsci, prus de chent’annos faghet, su 26 de Marztu de su 1926, in una litera indiritzada a Teresina, sa sorre prus pitica: ” […]Poi, l’italiano, che voi gli insegnerete, sarà una lingua povera, monca, fatta solo di quelle poche frasi e parole delle vostre conversazioni con lui, puramente infantile; egli non avrà contatto con l’ambiente generale e finirà con l’apprendere due gerghi e nessuna lingua: un gergo italiano per la conversazione ufficiale con voi e un gergo sardo, appreso a pezzi e bocconi, per parlare con gli altri bambini e con la gente che incontra per la strada o in piazza. Ti raccomando proprio di cuore, di non commettere un tale errore, e di lasciare che i tuoi bambini succhino tutto il sardismo che vogliono e si sviluppino spontaneamente nell’ambiente naturale in cui sono nati: ciò non sarà un impaccio per il loro avvenire: tutt’altro[…] (5).
Note bibliografiche
1. Montanaru, L’Unione Sarda del 16 Luglio 1933.
2. Ibidem.
3. Antioco Casula, Montanaru, Poesie scelte, Testo, traduzione e note a cura di Giovannino Porcu, op. cit. pag. 35.
4. Antioco Casula, Montanaru, Poesie scelte, op. cit. pag.35
5. Ibidem.