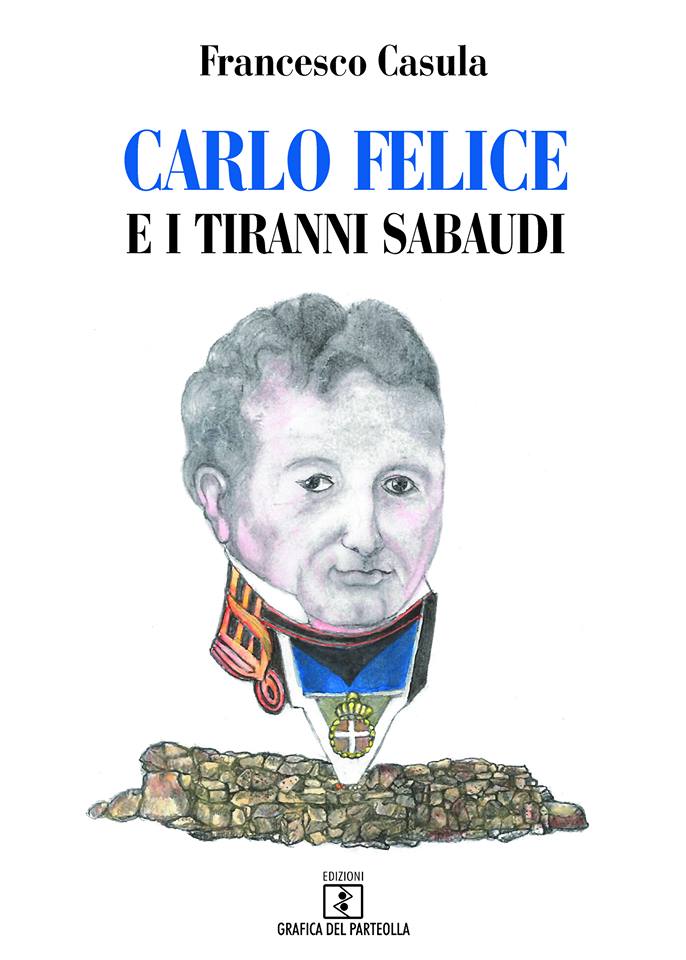SA DIE DE SA SARDIGNA
di Francesco Casula
Per ricordare La cacciata dei Piemontesi è nata ”Sa Die, giornata del popolo sardo” – ma io preferisco chiamarla “Festa nazionale dei Sardi” – con la legge n.44 del 14 Settembre 1993.
Con essa la Regione Autonoma della Sardegna ha voluto istituire una giornata del popolo sardo, da celebrarsi il 28 Aprile di ogni anno, in ricordo – dicevo – dell’insurrezione popolare del 28 Aprile del 1794, ovvero dei “Vespri sardi” che portarono all’espulsione da Cagliari e dall’Isola dei piemontesi e di altri forestieri (nizzardi e savoiardi) ligi alla corte sabauda ed espressione del potere e dell’arroganza, compreso lo stesso inviso Viceré Balbiano.
Quanti?
Alcuni storici (Girolamo Sotgiu) dicono 514; altri (Luciano Carta) 600-620. Pochi?
Moltissimi, se si pensa che Cagliari alla fine del ‘700-inizio ‘800 contava 20 mila abitanti e dunque vi era un “burocrate” piemontese per meno di 40 cagliaritani!
-Precedenti, cause motivazioni della “Rivolta”
1. Tentativo francese di occupare e conquistare la Sardegna.
I Francesi sbarcano e occupano l’Isola di San Pietro l’8 Gennaio del 1793 e pochi mesi dopo Sant’Antioco. Il 23 Gennaio la flotta, comandata dal Truguet getta le ancore nella rada di Cagliari bombardandola: il 27-28 Gennaio i Francesi sbarcano nel Margine Rosso di Quartu sant’Elena e il 14 Febbraio sottopongono a un fuoco infernale le posizioni tenute dal barone Saint Amour.
Parallelamente alla spedizione del Truguet, un altro attacco vede Napoleone Bonaparte comandante dell’artiglieria con il grado di tenente colonnello. Grazie soprattutto al valore del maddalenino Domenico Millelire e del tempiese Cesare Zonza, l’attacco fu respinto. Anche Sant’Antioco e San Pietro saranno liberati tra il 20 e il 25 Marzo, per l’intervento di una flotta spagnola. Così, sconfitti al fronte Nord come al Sud, i Francesi sono costretti al ritiro.
Perché i francesi tentano di conquistare la Sardegna?
Motivazioni ideologiche (ovvero chiacchiere): esportare la rivoluzione e con essa i principidell’89: Liberté, Égalité, Fraternité.
I motivi veri:
a. ”approvvigionare con i suoi grani e il suo bestiame l’esercito e impinguare le casse dello stato che la guerra e la rivoluzione avevano ormai svuotato” (Girolamo Sotgiu);
b. “l’avere un rifugio nei porti di Sardegna nel caso di guerra marittima, era stimato utilissimo”(Carlo Botta).
Evidentemente i francesi ritenevano inevitabile la guerra con l’Inghilterra – come di fatto avverrà – e dunque vogliono dotarsi di una bella base militare ad hoc.
Chi difenderà la Sardegna, respingendo i francesi?
Non l’esercito regolare dei re sabaudi ma i miliziani, i volontari sardi, sostenuti e finanziati dagli Stamenti: ovvero da nobili e clero ostili ai rivoluzionari francesi che consideravano demoni mangiapreti ma anche da democratici come Angioy o il Marchese di Flumini.
Hanno fatto bene i sardi a difendere la Sardegna?
E’ una questione storiografica aperta: il problema è però chiarire che i sardi più che difendere il regno dei sabaudi difendono la loro terra.
2. I Sardi vincitori presentano “il conto” al re Vittorio Amedeo III.
I Sardi – cito lo storico Natale Sanna – “dopo secoli di inerzia e di supina quiescenza ridiventano finalmente consapevoli del proprio valore e la classe dirigente fiera della sua forza e dei risultati ottenuti, credette giunto il momento di chiedere al re il riconoscimento dei propri diritti, tanto più che a Torino, mentre si concedevano in abbondanza promozioni e onori ai Piemontesi, si ignorava quasi completamente l’elemento sardo, distintosi nel Sulcis e nel Cagliaritano”.
Infatti – ricorda Girolamo Sotgiu – “seguendo le indicazioni del viceré Balbiano, le onorificenze militari accordate dal Ministro della guerra furono tutte concesse, con evidente ingiustizia, alle truppe regolari che avevano dato così misera prova di sé… e alla Sardegna che aveva conservato alla dinastia il regno concesse ben povera cosa: 24 doti di 60 scudi da distribuire ogni anno per sorteggio tra le zitelle povere e l’istituzione di 4 posti gratuiti nel Collegio dei nobili di Cagliari…”.
E altre simili modeste concessioni. Di qui la decisione del Parlamento sardo – composto dagli Stamenti: quello militare (o feudale), quelle ecclesiastico e quello reale (formato dai rappresentanti delle città) – riunito nel Marzo-Aprile 1793, di inviare un’ambasceria a Torino per presentare al sovrano 5 precise richieste, le famose “5 domande”:
-il ripristino della convocazione decennale del Parlamento, interrotta dal 1699;
-la conferma di tutte le leggi, consuetudini e privilegi, anche di quelli caduti in disuso o soppressi pian piano dai Savoia nonostante il trattato di Londra;
-la concessione ai “nazionali” sardi di tutte le cariche, ad eccezione di quella vicereale e di alcuni vescovadi;
-la creazione di un Consiglio di Stato, come organo da consultare in tutti gli affari, che prima dipendevano dall’arbitrio del solo segretario;
-la creazione in Torino di un Ministero distinto, per gli Affari della Sardegna.
Si trattava, come ognuno può vedere, di richieste tutt’altro che rivoluzionarie: non mettevano in discussione l’anacronistico assetto sociale né le feudali strutture economiche, anzi, in qualche modo, tendevano a cristallizzarle. Esse miravano però a un obiettivo che si scontrava frontalmente con la politica sabauda: volevano ottenere una più ampia autonomia, sottraendo il regno alla completa soggezione piemontese, per affidare l’amministrazione agli stessi Sardi. La risposta di Vittorio Amedeo III non solo fu negativa su tutto il fronte delle domande ma fu persino umiliante per i 6 membri della delegazione sarda (Aymerich di Laconi e il canonico Sisternes per lo stamento ecclesiastico; gli avvocati Sircana e Ramasso per lo stamento reale; Girolamo Pitzolo e Domenico Simon per lo stamento militare, ).
Il Pitzolo, scelto dalla delegazione per illustrare le richieste, non fu neppure ricevuto dal sovrano né ascoltato dalla Commissione incaricata di esaminare il documento… non solo: il Ministro Graneri neppure si curò di comunicare alla delegazione ancora a Torino, la decisione negativa del re, trasmettendola direttamente al vice re a Cagliari.
3. La rivolta cagliaritana e la cacciata dei piemontesi
Ecco come lo storico sardo da Girolamo Sotgiu descrive il fatto:
“E fu così che il 28 Aprile 1794, come narrano le cronache «si videro i soldati del reggimento svizzero Smith vestiti in parata». La cosa passò inosservata perché si pensò che si trattasse di esercitazioni militari. Ma “sull’ora del mezzogiorno furono rinforzati i corpi di guardia a tutte le porte, tanto del Castello, come della Marina », e questo fatto cominciò a susci¬tare qualche preoccupazione fino a quando «sull’un’ora all’incirca, quando la maggior parte del popolo è ritirata a casa e a pranzo, fu spedito un numeroso picchetto di soldati comandato da un Capitano Tenente e tamburo battente con due Aiutanti ed il Maggiore della piazza» ad arrestare Vincenzo Cabras.
«Avvo¬cato dei più accreditati e ben imparentato nel sobborgo di Stam¬pace»2, , nonché il genero avv. Bernardo Pintor e il fratello Efisio Luigi Pintor, che poté sfuggire alla cattura perché assente.
I due arrestati furono condotti alla torre di S. Pancrazio e furono subito chiuse tutte le porte, mentre già il popolo si radunava tumultuando.
L’arresto di uomini noti anche per la partecipazione attiva alla vita pubblica apparve subito quello che probabilmente doveva essere: l’inizio, cioè, di una rappresaglia più massiccia.
Da qui l’accorrere tumultuoso di centinaia, migliaia di persone, (almeno 2 mila, il 10% dell’intera popolazione cagliaritana) l’assalto alle porte, che furono bruciate o divelte, l’irruzione nei corpi di guardia, il disarmo dei soldati, la conquista del bastione e delle batterie dei cannoni. Tutto questo nel rione di Stampace, dove si erano verificati gli arresti. All’insorgere di Stampace seguì in rapida successione la sollevazione dei borghi di Villanova e della Marina.
La folla, superata la resistenza dei soldati, aprì le porte che tenevano divisi i sobborghi l’uno dall’altro che la massa del popolo unita poté rivolgersi alle porte del Castello.
Negli scontri rimasero uccisi alcuni popolani e alcuni soldati. L’assalto al Castello, dove il viceré voleva organizzare una più efficace resistenza, avvenne subito dopo. Bruciata la porta, lunghe scale appoggiate alle muraglie, «facendo scala delle loro spalle l’uno sopra l’altro», i dimostranti riuscirono a entrare nei locali dove erano ammassate le truppe a difesa del viceré e del suo quartier generale.
Così, il 7 maggio 1794, 514 (secondo Girolamo Sotgiu) o 600-620 (secondo Luciano Carta) tra piemontesi savoiardi e niz¬zardi furono costretti ad abbandonare l’isola, e, «divulgata per tutto il Regno l’espulsione da Cagliari dei Piemontesi, fu univer¬sale l’approvazione»; ad Alghero fu fatta la stessa cosa e, dopo qualche resistenza, anche Sassari seguì l’esempio della capitale. Né mancò, nel giorno drammatico dello scommiato da Ca¬gliari, anche il grande gesto da tramandare alla storia: «La piazza che dalla porta di Villanova mette nel Castello era ingom¬bra di popolani della classe più umile. Erano carrettaj, facchini, beccai, ortolani ed altri di simil fatta, gente poco ausata a squisi¬tezza di tratti», quando la piazza fu attraversata dai carri che «scendevano dal Castello nel quale aveano avuto stanza i mag¬giori ministri», trasportando «al porto le loro masserizie con quelle del viceré». All’apparire di tanta «abbondanza di car¬riaggi», si levò un solo grido:
Ecco le ricchezze sarde trasformate in ricchezza straniera: non giungeano qui con tanto peso di bagagli o con questa dovizia di guarnimenti: assottigliati ci veniano e scarsi quelli che oggi si dipar¬tono con fortuna così voluminosa. Buoni noi e peggio che buoni, se lasciamo che abbiano il bando con questi stranieri anche le robe che erano nostre.
E il passare dalle parole ai fatti sarebbe stato inevitabile, se un beccaio, Francesco Leccis, sentita nell’animo l’indegnità del tratto, sale sopra una panca, e brandendo in mano il coltellaccio del suo mestiere quale scettro d’araldo, ferma¬tevi, grida a quei furiosi:
quale viltà per voi, quale onta a tutti noi! Non si dirà più che la Sardegna ha bandito gli stranieri per insofferenza di dominio, si dirà che si è sollevata per ingordigia di preda. La Nazione volea cacciarli e voi li spogliate? Ed esortati i carrettieri a muoversi, «la folla si bipartiva, e le voci erano chete, e l’onore di quella critica giornata era salvata da un beccaio»9.
Meno aulicamente del Manno, il padre Napoli racconta la stessa cosa:
Lasciateli andare – sembra che il Leccis abbia detto – che i sardi benché poveri non han bisogno della M… dei Piemontesi, parole che colpirono in modo lo spirito di quelle plebaglie, che subito risposero nel loro linguaggio: aicci narras tui? chi si fassada, cioè: così dici tu? che si faccia .