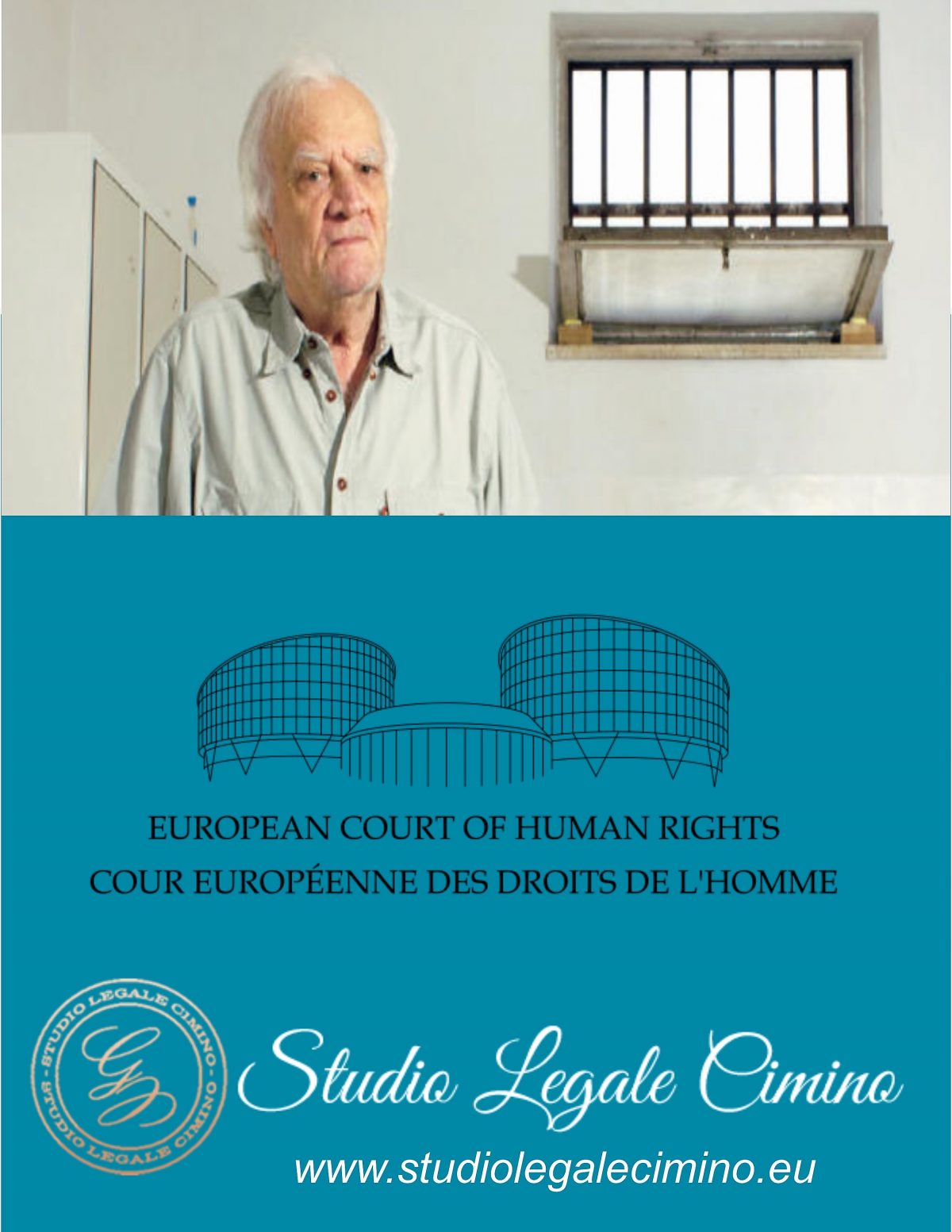“L’ITALIA PAESE DI SANTI, POETI E AVVOCATI”: IL PAPA PREFERISCE CONFONDERE I RUOLI
L’intervento del Sommo Pontefice al corso “Matrimonio e Famiglia” tenutosi in San Giovanni in Laterano e conclusosi solo alcuni giorni fa con parole pesanti verso gli Avvocati apostrofati come “approfittatori e speculatori” della lite coniugale, non può che suscitare qualche riflessione.
Com’è noto, Papa Bergoglio con le due Lettere “Mitis Iudex Dominus Iesus” e “Mitis et misericors Iesus” ha riformato i processi di nullità del matrimonio canonico sia per il rito latino che per quello orientale: sono state quindi introdotte procedure più snelle e, soprattutto, è stata contemplata la gratuità della procedura, salvo una “giusta e dignitosa” retribuzione degli operai del Tribunale.
D’altro canto, sul piano deontologico, l’art. 49, § 2, delle Normare Romanae Rotae Tribunalis prescrive infatti che “procuratorum advocatorumque emolumenta non alia admittantur, quam quae sunt probata”. In sostanza, è vietato al patrono di percepire, o anche solo pattuire, compensi esagerati per la propria opera professionale.
Ma nel corso dell’intervento alla Basilica di San Giovanni, il Papa si è spinto oltre, invitando gli Avvocati all’ascolto dei coniugi e soprattutto, ad ammonire i coniugi in crisi dall’affidarsi ad Avvocati che “in queste situazioni di crisi pensano solo al guadagno che possono trarre” e quindi il monito “Bisogna difendere le coppie dalle mani di alcuni avvocati!”
Il diritto di famiglia costituisce senz’altro un settore particolare, che porta l’avvocato ad occuparsi di situazioni delicate nelle quali vengono coinvolti, in misura maggiore rispetto ad altre fattispecie, gli equilibri e le situazioni personali dei soggetti interessati, costretti a vivere situazioni di profonda sofferenza e disagio. In molti casi, peraltro, le vicende vedono il coinvolgimento dei minori, la cui tutela e il cui interesse assumono importanza prioritaria ed esigono l’adozione di particolari cautele.
Si ritiene pertanto che, soprattutto nel diritto di famiglia, l’avvocato non debba limitarsi al rispetto delle regole procedurali a difesa del proprio assistito, ma debba “valutare le conseguenze” del proprio operato, nel senso che occorre “chiedersi cosa accada se agiamo in un determinato modo ovvero se non compiamo determinate azioni e nei confronti di chi si producano tali conseguenze (A. MARIANI MARINI Deontologia e responsabilità sociale: l’avvocato del minore).
D’altro canto, il nuovo Codice deontologico forense, approvato dal Consiglio Nazionale Forense nella seduta del 31.01.2014, contiene alcune disposizioni che riguardano in maniera specifica il comportamento dell’avvocato in materia familiare e minorile, prevedendo ad esempio (art. 68, co. 4) il divieto assoluto, senza limiti temporali, per l’avvocato che abbia assistito congiuntamente i coniugi, di assistere un coniuge o un convivente della coppia in controversie successive tra i medesimi.
Se questa è la normativa – sia nell’ambito del diritto canonico che in quello statutario – cui l’Avvocato DEVE attenersi (prevedendo anche la sanzione della sospensione dall’esercizio professionale), davvero non si comprende come il Papa abbia potuto invocare la difesa delle coppie da “alcuni avvocati”, appellandosi ora agli obblighi di tipo etico-sociale, ora alla gratuità dell’impegno professionale, forse dimenticando che attraverso l’istituto del gratuito patrocinio, la difesa tecnica viene assicurata anche ai soggetti economicamente disagiati.
Né d’altronde, in nome dell’obbligo di lealtà e correttezza verso il cliente, si può dare ingresso a forme di coercizione della volontà, dissuadendo dalla separazione coppie in crisi che troppo spesso assurgono alle prime pagine della cronaca nera intrafamiliare.
E allora, come membro e parte attiva dell’Ordine degli Avvocati di Roma, dico SI all’apertura verso la famiglia come centro di affetti; SI al rispetto della responsabilità genitoriale ma favorire una serena separazione è sicuramente obbligo dell’avvocato che abbia percepito, nel dispiegarsi della crisi coniugale, il pericolo di un acuirsi delle tensioni.
Difendere il significato di Famiglia ad ogni costo; dissuadere separazioni che possono assurgere a tragedie, non solo non è compito dell’Avvocato (e forse più opportunamente del Ministro del culto che dovrebbe conoscere, attraverso la confessione, l’animo profondo dei fedeli) ma è contrario al principio di lealtà e verità, il tentativo di sopraffazione della volontà altrui e, anzi, l’Avvocato, attraverso gli strumenti raccolti dall’esperienza, ben può e deve favorire un pacifico sgretolarsi del nucleo familiare, sempre tutelando gli interessi degli eventuali soggetti minorenni coinvolti, laddove intravveda il rischio di condotte violente e di maltrattamenti ai danni delle persone più deboli.
La società di oggi è purtroppo caratterizzata sempre più pesantemente dallo sgretolarsi del valore FAMIGLIA: i casi di femminicidio, di pedofilia (e la Chiesa ne conosce non pochi…!!), di stalking sono sempre più numerosi e allora, preoccuparsi di quanto costi una consulenza, piuttosto che affidarsi alla preghiera in Dio, sembra invece tradire il monito di Sant’Agostino ne “Il discorso del Signore sulla Montagna”: Non perché voglio un regalo, ma perché ritengo necessario il merito.
Il cliente non chiede l’offerta dell’Avvocato ma il suo merito.
@Produzione Riservata
Studio Legale Gelsomina Cimino
Papa e Avvocati