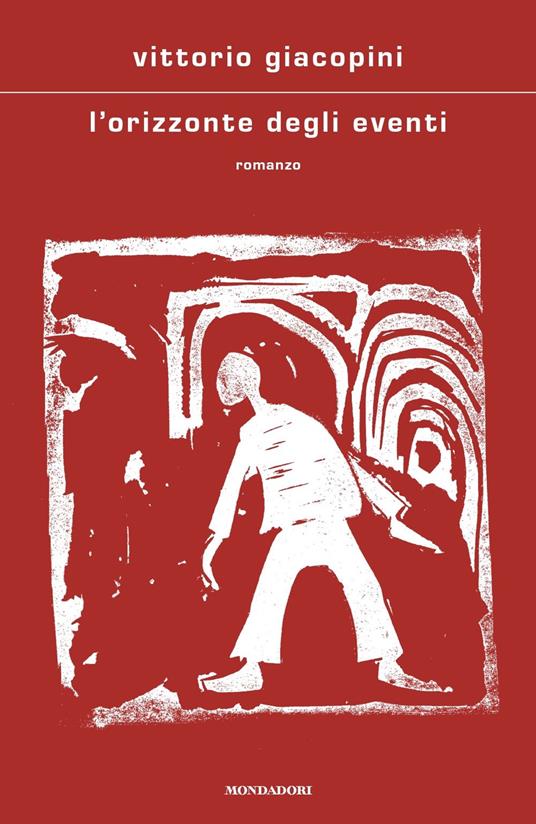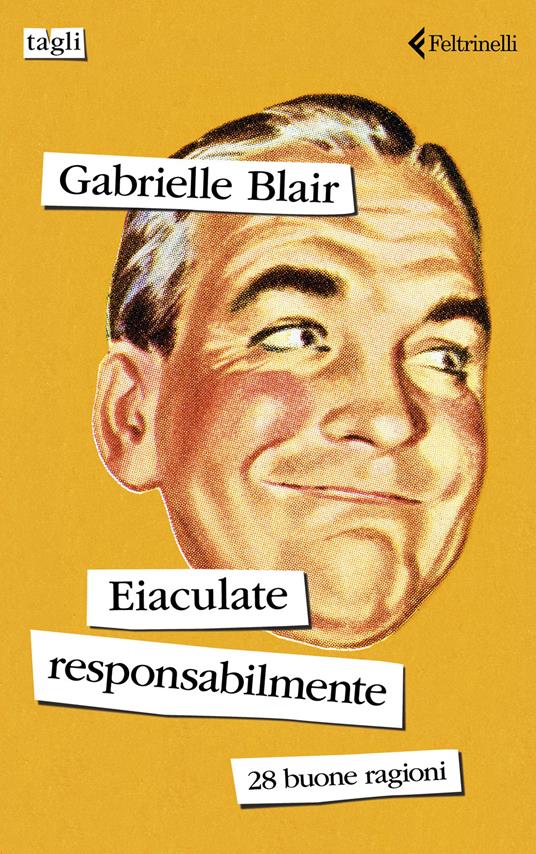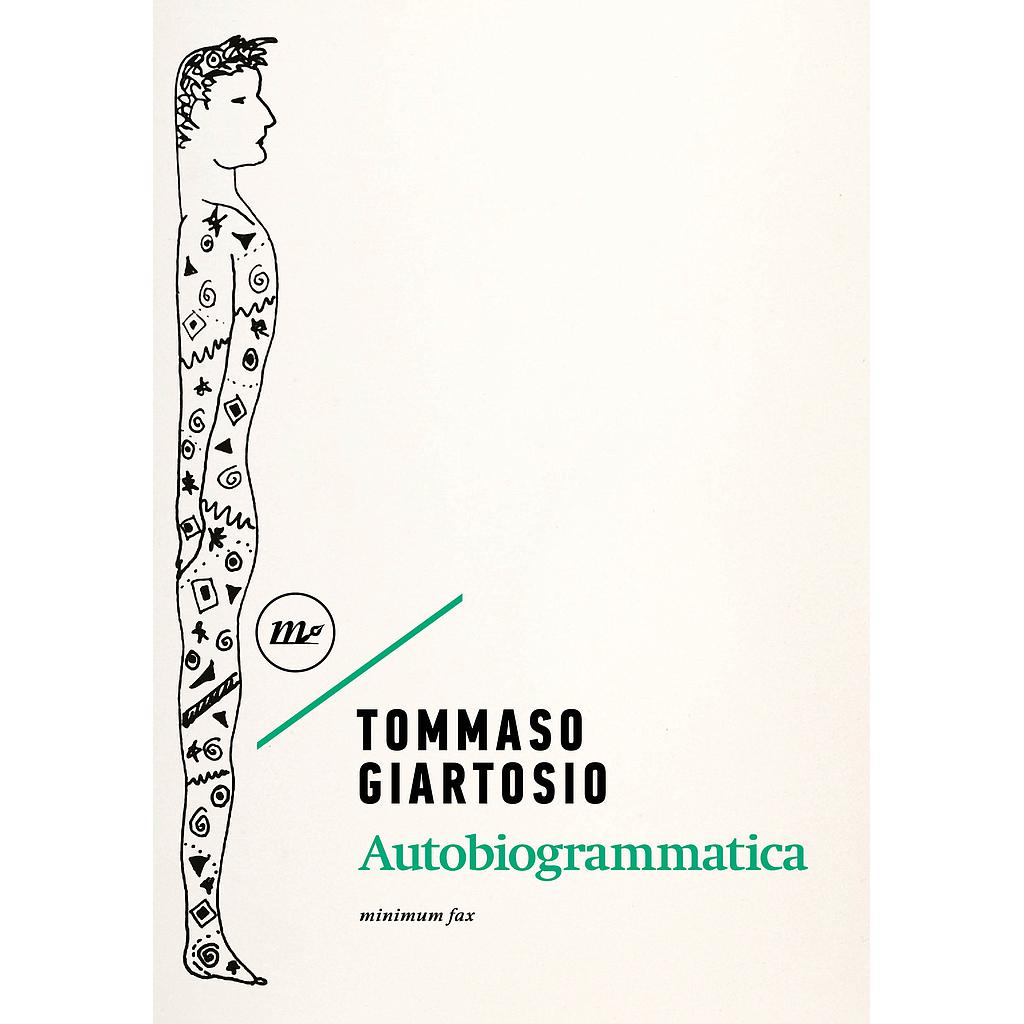Prima o poi la vita ci mette alla prova con esperienze così grevi che, dopo averle date in pasto a parenti e amici, le tramutiamo in prequel e sequel dei giorni obliqui e devastanti. Torneremo poi in solitudine al passato, giacché il Tempo avrà reso chiaro che la condivisione del dolore non allevia la pena né aiuta a farla scivolare come in una sorta di sogno. Gli scrittori più versati rendono il dolore distillandolo in quadri narrativi di forte emotività a cui viene spontaneo affidarsi quando sarà più pressante l’urgenza di dialogare con una voce che rifugge l’inconsistenza del dire. Ne sia un esempio questa pagina di Giartosio nella quale lo scrittore richiama il periodo in cui, in relazione alla malattia della madre, si misura con la sospensione temporale che divide la vita dalla morte. E si provi a non sobbalzare se è già stata messa agli atti l’esperienza di ritrovare se stessi dopo essere sopravvissuti alla morte di una persona amata.
“Oggi mia madre è morta. Oggi scrivo questa frase, che può essere vera solo oggi. Rende preziosa questa giornata, l’ultima in cui è stata viva.
[…]
Di giorno vado a trovarla. Dopo il Covid e la polmonite batterica e i tre mesi in ospedale, si alza in piedi sempre meno. Il suo corpo è un plateau. Lei che ama l’Africa lo chiama il mio corpo negroide. È sempre stato qualcosa di energico e morbido e fresco, profumato come un lombrico. Ora si è disteso come certi fiori senza gambo che si rilasciano sulle loro foglie, i petali già staccati ma ancora tutti in posizione. Conserva l’apparenza della forza: le mani hanno una presa coriacea, ma in realtà faticano a stringere le posate […] Quando devo accompagnarla in bagno o dal dottore vedo per la prima volta nella mia vita il seno acciambellato sulla cassa toracica, il pube spelato che ricorda certe miti cucuzze di studiosi. Indovino l’utero prolassato, le ossa iliache come palchi di alce. Non posso trattenermi dal pensare che ho abitato questo luogo dove ora strisciano gli elettrodi e zampetta il fonendoscopio. È come visitare la propria aula delle elementari invasa dai rampicanti. Sento in me questa freddezza imposta, la paura di sentire tutto ciò che c’è da sentire, e mi prende un pudore vicario, un po’ ipocrita. La aiuto a rivestirsi”.
Tommaso Giartosio, Autobiogrammatica
In alto: Sari Soininen, Transcendent Country of the Mind
Restando in tema, l’inarrivabile Marcel Proust:
(…) da parecchio lontano, appena superato San Giorgio Maggiore, scorgevo quell’ogiva che m’aveva veduto, e lo slancio dei suoi archi spezzati aggiungeva al suo sorriso di benvenuto la distinzione d’uno sguardo più elevato e quasi incompreso. E poiché dietro quei balaustri di marmo di vari colori la mamma leggeva aspettandomi, il viso raccolto in una veletta di tulle d’un bianco non meno straziante di quello dei suoi capelli per me che sentivo come mia madre l’avesse, nascondendo le lacrime, aggiunta al suo cappello di paglia non tanto per apparire “elegante” alle persone dell’albergo, quanto per sembrare a me meno in lutto, meno triste, quasi consolata della morte della nonna; poiché, non avendomi riconosciuto subito, non appena la chiamavo dalla gondola mandava verso di me, dal fondo del cuore, il suo amore che s’arrestava solo dove non c’era più materia per sorreggerlo, alla superficie del suo sguardo appassionato che cercava di avvicinare il più possibile a me, di innalzare, sporgendo le labbra, in un sorriso che sembrava baciarmi, entro la cornice e sotto il baldacchino del più discreto sorriso dell’ogiva illuminata dal sole di mezzogiorno: a causa di tutto ciò quella finestra ha preso nella mia memoria la dolcezza della cose che assieme a noi, contemporaneamente a noi, ebbero la loro parte in una certa ora, che suonava identica per noi e per loro; e per quante e quanto splendide siano le forme racchiuse fra le sue colonne, quella finestra illustre conserva per me l’aspetto intimo d’un uomo di genio con il quale si sia trascorso un mese nello stesso luogo di villeggiatura e che abbia contratto per noi una qualche amicizia, e se da allora, ogni volta che vedo il calco di quella finestra in un museo, sono costretto a trattenere le lacrime, è semplicemente perché essa mi dice la cosa che più d’ogni altra può commuovermi: “Me la ricordo molto bene, vostra madre”.