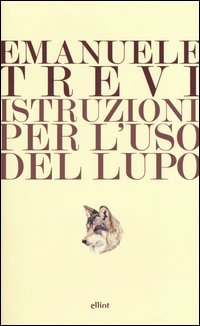È questo il Trevi che mi piace, lo stesso di Sogni e favole, scoperto qualche anno fa e subito entrato a far parte dei libri che è bello rileggere di tanto in tanto. Alcuni ritengono che Trevi sia bravo a parlare di morti. Non è così. È che a volte le ciambelle gli riescono col buco e altre no.
Nel saggio Istruzioni per l’uso del lupo compone un disegno affabulatorio del ragionar di critica, riparandolo sotto un mantello di malinconia lucida e leggera. Grazie Emanuele per la tua generosità. Ma non andare più in tv a fare marchette. Non ti si addice e non lo sai fare.
“Caro Marco,
si può recensire un tramonto? Questa sera di dicembre, affilata dalla tramontana, ha appena finito di eseguire una sua geniale serie di variazioni sui temi del rosso-porpora e del lilla. Apparentemente, nessuno qui intorno sembrerebbe essersi meritato un tale principesco dispendio di bellezza. Perlomeno, di fronte a questi virtuosismi dell’apparenza, io mi sento un poco abusivo. Il mio sentimento della Natura è quello di una persona che viaggi in autobus senza biglietto: piacere di un trasporto rapido e indolore, ineffabile attesa del castigo.
Adesso, mentre la penna iniziava ad arare il foglio, nel conclusivo drappeggio delle tenebre è a Venere – invernale e indisturbata, ignara del suo nome – che tocca il suo quarto d’ora di celebrità, una solenne iscrizione negli Annali dell’Armonia. Una volta ho letto una splendida, consolatoria etimologia del nome Venere nel De natura deorum di Cicerone: «Venus, quia venit ad omnia», «giunge a tutte le cose». Ma tutti i doni fanno parte di un’economia dell’enigma e del segreto. Ho iniziato questa sera a pensare a un lavoro umano, quello della critica letteraria. Parlare di un lavoro vuol dire, fin dal primissimo moto del pensiero, comprendere il tempo umano come segnato dalla frattura di una vocazione. Ho il sospetto che questa vocazione abbia a che fare con Venere, nell’evidenza della sua luce che giunge a tutte le cose, ma anche nell’angoscia che germina dalla qualità opaca di ogni dono, dalla fuga di significato che sta dentro ogni accadimento della felicità.
Prendendo in mano la penna, ho guardato il cielo – il tramonto e la stella – e ho pensato a un uomo giusto, a un individuo puramente ipotetico, capace di accogliere in sé l’apparenza di questa sera, di subirne l’urto assieme alla seduzione. Quest’uomo sa bene che ogni figura della bellezza sarebbe mutila se non contenesse in una sua piega la zona ombrosa dell’inespresso. È una cosa detta molto bene da Walter Benjamin nel suo saggio sulle Affinità elettive di Goethe, quando scrive che «solo il bello, e nulla fuori di esso, può essere essenziale velando e restando velato» e dunque «nel segreto è il fondamento divino della bellezza». Io credo che la critica sia – alla radice – un modo di amare le cose della vita facendo leva su questa reticenza, su questa provvidenziale avarizia che non consente mai al significato di rompere l’ultimo sigillo rivelandosi nella sua pienezza. È proprio la straordinaria omertà della bellezza (quel suo guardare ostinatamente, come il Cristo flagellato del Caravaggio, un punto estraneo alla vicenda, fuori del quadro) la materia prima dello sforzo del critico. Sulla sua testa, il tramonto e la stella brillano come i vessilli, disperati e sorridenti, di un lutto e di una speranza.
Adesso mi sono ricordato di una cosa importante che ho visto al cinema, in un film di Ken Loach che si intitola Riff-Raff: il protagonista va al funerale della madre. Tutti i parenti sono raccolti su una collinetta del cimitero, pronti ad aprire l’urna e spargere le ceneri al vento. Ma accade un incidente. Quando si apre l’urna, le ceneri si rovesciano su di tutti, fratelli e amici, che ne vengono accecati e impolverati. Con quello che si vede al cinema, uno può fare quello che desidera. Spesso non se ne fa nulla. Però, a me capita di ricordare questa scena quando penso alla critica e al suo rapporto con la bellezza. Perché mi sembra evidente che sia meglio venire accecati da una cosa grande, che vedere molto distintamente tante cose meschine. Essere accecati significa anche rinunciare alla piccola consolazione dei propri ricordi, della propria psicologia, dei propri gusti, e disporsi ai fatti estremi della vita in tutta la loro violenza, che è mancanza di una razionalità apparente.
Temo che il nostro modo di pensare la vita sia troppo anestetico, e questa parola mi cade dalla penna molto a proposito, perché indica due cose: fuga dal dolore e fuga dalla bellezza. Secondo me questo è un problema politico, anzi il problema politico. Noi siamo nati dentro l’Europa (quest’idea diplomatico-letteraria tenuta assieme dal latino, dalla retorica e dalla crudeltà reciproca) e moriremo che l’Europa non ci sarà più.
Il guaio non è una civiltà che va in cenere, ma il fatto che rischiamo di non saperne fondare un’altra. Abbiamo troppa paura del dolore e troppa fiducia nel buon senso. Troppe stampelle. Una vera civiltà dovrebbe essere il luogo dove tutto ciò che è più debole viene accolto e protetto. Noi dovremmo essere venuti al mondo per dividere il pane con i più poveri, far giocare i bambini e dare una cuccia agli animali. La nostra vita non passerebbe invano se avessimo un’idea poetica della politica. E invece, non lasciamo mai che la poesia sfondi gli steccati dentro i quali abbiamo circoscritto arbitrariamente la nostra vita. Questo accade a causa della nostra invincibile paura delle cose estreme, che ci induce a pensare i gesti di una giornata come eventi che è meglio tenere separati fra loro. La musica è lontana dal lavoro e il lavoro è lontano dall’amore che a sua volta è lontano dalla letteratura. E tutto ciò che di bello e di grande ci cade sulla testa marcisce perché, semplicemente, non trova il suo luogo. Ci crediamo furbi, perché spingiamo via le ceneri nella direzione “giusta” del vento, via da noi.
E invece, il più furbo era proprio il primo dei tre porcellini. Ricordi? Quello che costruiva la sua casa con la paglia. Perché il lupo, in un modo o nell’altro, deve arrivare. Si spreca una vita a immaginarselo, questo lupo, e a fare delle case solidissime. Mentre, con la sua paglia, quel genio del primo porcellino voleva esprimere la sua semplice verità: che senza il lupo, senza la sua splendida giustizia, non vale nemmeno la pena di esistere.
Sarebbe ipocrita dire che il lupo non è così brutto come lo si dipinge. Anzi, è molto peggio. Il lupo è la verità della vita di un uomo, e la verità della vita di un uomo sta in ciò che più teme. Io non ho perso di vista, caro Marco, la critica letteraria. Ma il lupo non ha mai perso di vista me, in compenso. E se fossi così cretino da pensare ancora che la critica letteraria non sia, in fin dei conti, una questione di lupi, allora non saprei nemmeno cosa scriverti.
La vita è troppo breve per fare delle polemiche. Però, quel nostro sistema di non pensare a ogni giorno come a una totalità indivisibile di bellezza, dolore, segreto, è proprio nella critica letteraria che si rivela nel suo aspetto ridicolo. Perché un critico, di solito, crede di poter ricorrere ad altro: a un linguaggio più o meno impersonale, più o meno elegante, che dovrebbe trovarsi fuori di tutto. Un punto archimedico per sollevare il mondo dei libri, una specie di eterna domenica ermeneutica. O anche, purtroppo, quel paese dei balocchi dove si diventa tranquillamente asini, per semplice inerzia.
Questo linguaggio è stato variamente analizzato. Preso in blocco, appare come una fungaia sterminata di ipotesi e giudizi sulla letteratura. Una proliferazione mostruosa, così è apparsa a uno dei migliori, George Steiner, in Vere presenze, uno dei pochi libri di critica che faccia sospettare un carattere umano autentico nascosto fra le pagine. Il problema fondamentale di questo linguaggio, comunque, è nel suo carattere assolutamente fittizio. Sta tutto fuori dall’esistenza di chi lo adopera; finge di ignorare che qualcuno, un essere umano, lo adoperi. Perché un essere umano è la somma della sua paura e del suo lupo. Quello che fa veramente, il suo lavoro, è capire come ci si comporta con il lupo. Se nel lupo ci siano solo fame e denti, oppure se nel fatto di essere sbranati ci sia pure, dietro a tutto, il tesoro di una saggezza e di una redenzione. Ed è questo il luogo mentale della letteratura che nel suo insieme è una straordinaria Istruzione per l’uso del lupo, alla quale molti uomini e donne hanno contribuito da che mondo è mondo. Da quando, dunque, il primo cavernicolo ha provato quel sentimento complesso, divino e mortificante, che noi oggi chiamiamo, con espressione comodamente sintetica, angoscia. Ogni volta che un uomo ha pensato «adesso quella cosa lì mi annienta», stava già facendo letteratura, senza saperlo, come il famoso prosatore di Molière. Stava facendo qualcosa, insomma, che nasce dall’incontro fra la scoperta di essere minacciati e la necessità di continuare, ad ogni modo, a respirare. Di fronte alla paura, l’uomo dà al suo mondo una disposizione nuova, di carattere sempre vagamente rituale. La perfetta attenzione che ne deriva, donata a ogni suo gesto, è già di per sé l’origine di ogni tecnica espressiva. Se la meta di tutto questo fosse l’autoconservazione, o, peggio ancora, il perpetuarsi del proprio miserabile nome nella memoria degli altri, si tratterebbe di un’operazione di contrabbando, faticosa quanto inutile. No, non è questo. Un rito è un’innocenza reale opposta alla vergogna della morte, la trasformazione di uno spazio umano in uno spazio di dignità. Questo conta. L’identità e la morte hanno il loro tempo limitato per misurarsi, e non c’è nulla da fare, vince sempre la più forte. È l’intervallo prima della catastrofe che va salvaguardato. Per quanto ne sappiamo, la nostra vita è tutta lì. Il lottatore di judo si inchina di fronte al tappeto, prima di salirci sopra. Puoi riconoscere un buon maestro dalla sua premura per questa inezia. Perché nessuno di noi decide chi vince e chi perde, il nostro compito è tenere il tappeto pulito, disposto a ogni avvento. Il mondo è fragile ma dentro il tempo magico della cerimonia c’è una sua verità.
Adesso, io mi rendo conto che le cose che ti scrivo possono anche suonare irragionevoli o contorte. Però sono convinto che non si può tirare fuori la letteratura da uno scenario di questo tipo e scrivere di un romanzo che è “ben riuscito”, o “accattivante”, o “melenso” o “inconcludente” e poi mettersi l’anima in pace. L’anima, tra l’altro, non dovrebbe mai stare in pace. Non è fatta per questo. Loro sostengono delle banalità: la critica “informa” il pubblico, lo “orienta” fra i libri. Noi, in realtà, non abbiamo bisogno di tutte queste informazioni. Ci piacerebbe qualche notizia attendibile sul lupo. È un lupo universale? A ciascuno il suo? Ha un sesso? Quando arriva? Quando se ne va? La letteratura, temo che sia proprio questo: un immaginosa lupologia. Eppure, nelle pagine dei giornali, delle riviste dedicate alla letteratura, dei libri dei critici ce ne sono orme sempre più rare.
Sembra che i libri non abbiano nulla a che fare con il dolore, con il fatto elementare che noi tutti facciamo esperienza delle cose a partire dal nostro smarrimento. Gran parte della critica, dalla recensione più ignara di congiuntivi al più impervio saggio filologico, sembra solidale nel pensare alla letteratura come a un gigantesco mulino che macina altri mulini, dentro un tempo astratto e glaciale, nel quale l’unica vicenda è quella delle possibili combinazioni di artifici. Se il mio unico problema è capire quanto un romanzo è migliore o peggiore di altri romanzi, o quanti altri sonetti nasconde nella sua filigrana un sonetto, io, di fatto, sto esiliando quel romanzo e quel sonetto nel regno della morte. So perfettamente che molti uomini raffinati e bene intenzionati hanno creduto e continuato a credere a questa infamia di un sistema di segni autoregolato come un flipper, dove tutto è menzogna e tutto è verità. Però io mi chiedo come sia possibile pensare che una cosa che accade nel mondo possa stare così, separata dal mondo. Solo il diavolo separa ciò che era unito: e questa e la sua più grande menzogna. Tutto muore quando sta fuori dalla terra, filo di lana strappato al disegno del tappeto. Un critico dovrebbe portare in dono i Nuovi versi alla Lina di Saba a un uomo abbandonato, e non per consolarlo, ma perché possa intuire che il lavoro durissimo che ci tocca in sorte è fare di un destino una figura musicale. Dovrebbe sbattere in faccia gli ultimi canti dell’Odissea ai fascisti che odiano l’immigrato, e non per educarli, ma perché possano sospettare che è gradito agli dèi solo chi sa accogliere il viandante sconosciuto, ascoltare il suo racconto, mentre per gli altri ci sarà solo la freccia impassibile di Ulisse. La nostra anima è questo: intuire e sospettare. La possibilità perenne di un’apertura. Ciò che avviene nella letteratura è il miracolo di un inchino reciproco, di uno sfiorarsi di labbra, tra l’anima e il mondo. Dentro questo incontro, come i conigli e le colombe e i foulards nel cappello del prestigiatore, ci sono tutti i sentimenti possibili: lo sgomento dell’Islandese di Leopardi di fronte alla macchina universale della sofferenza, la nostalgia di Omero e Proust per un tempo degli eroi che solo il respiro del verso e della frase potranno restituire al silenzio del presente, la pace conquistata da Tolstoj nei bivacchi della guerra… Il mondo non ha, forse, una sua direzione ma è vasto e imprevedibile tanto quanto noi, nella scrittura, ci ostiniamo a pensarlo”.
Emanuele Trevi, Istruzioni per l’uso del lupo