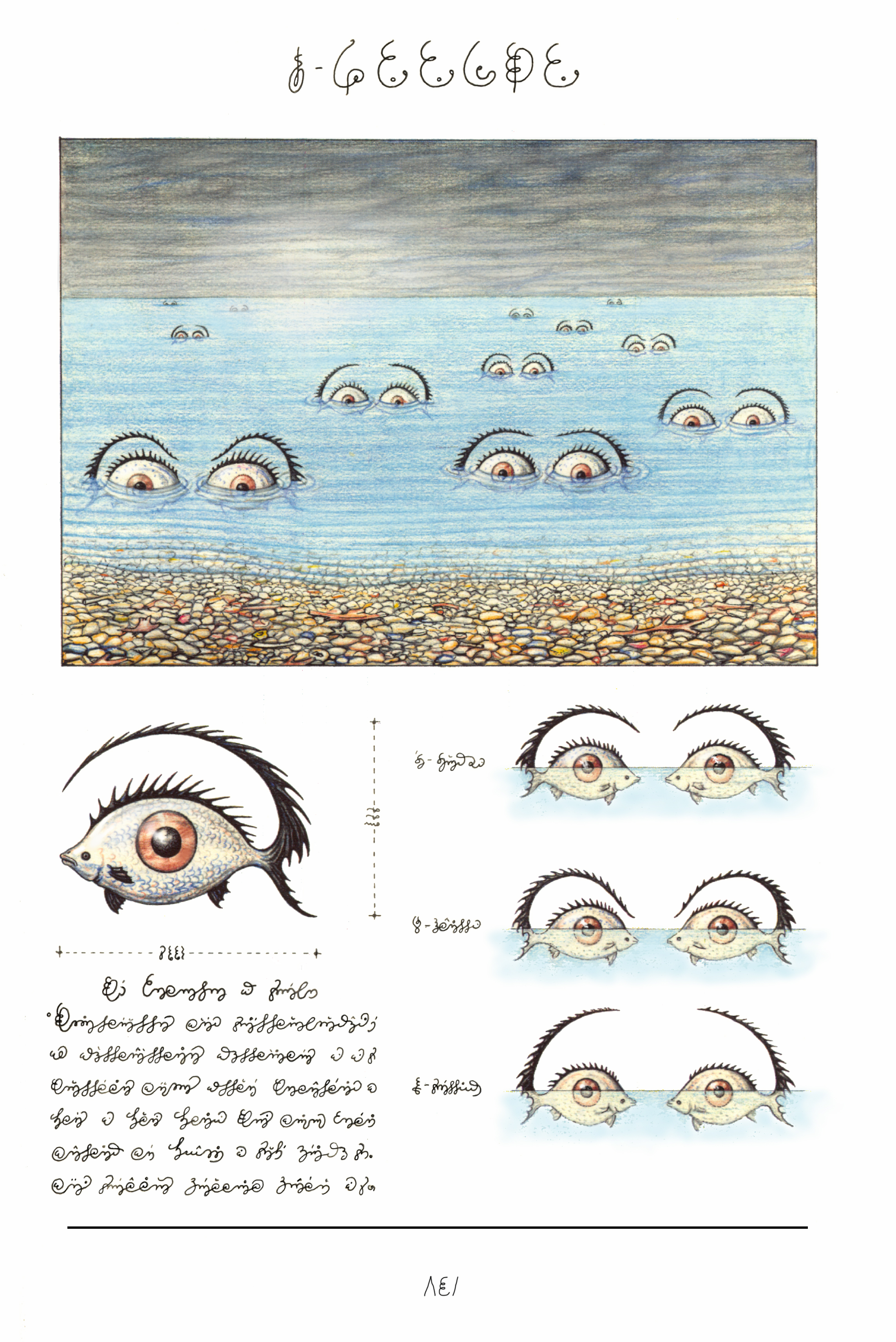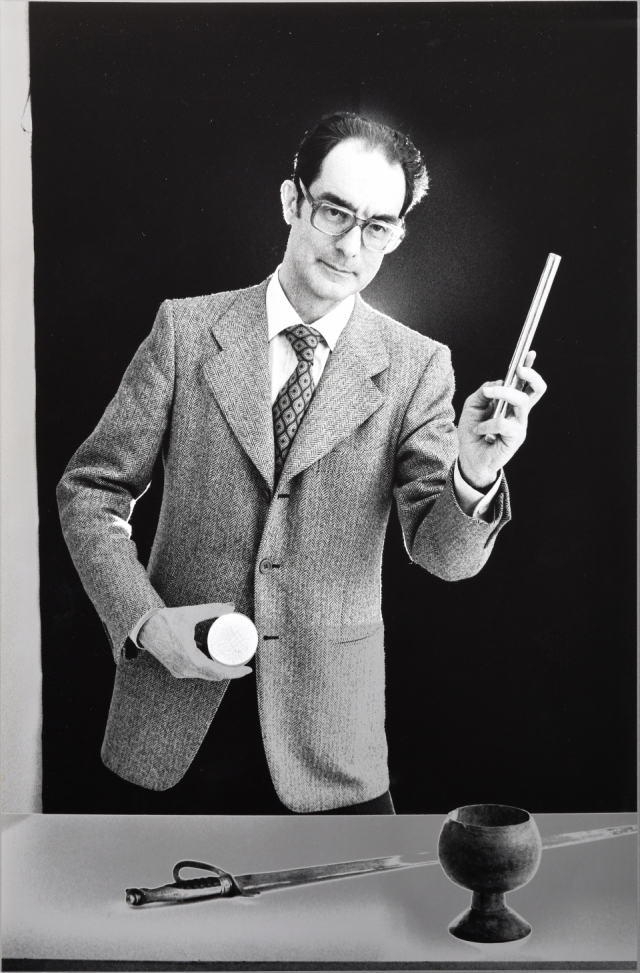“Anche se un’intera industria campa dicendovi il contrario, le gioie della mezza età sono davvero poche. L’unico vantaggio, a mio modo di vedere, è che se ti va bene acquisisci una stanza per gli ospiti. C’è chi se la ritrova in automatico quando i figli se ne vanno, mentre altri, come me, finiscono per cercare una casa più grande. “Seguitemi” dico ora. La camera in cui accompagno i miei ospiti non è riordinata in fretta per accoglierli. Non funge anche da ufficio o da stanza degli hobby, ma esiste a un unico e solo scopo. Dentro ci ho messo un letto vero, anziché un divano letto, e appoggiato a una parete, come negli alberghi, c’è un portavaligie. Il pezzo forte, però, è il bagno privato.
“Se alla vasca preferisci la doccia posso metterti di sopra, nella seconda stanza per gli ospiti” dico. “Il portavaligie c’è anche lì.” Quando sento queste parole uscire dalla mia bocca, affiancata da due solchi tipo burattino, provo un brivido di anziana soddisfazione. È vero, ho i capelli grigi e sempre più radi. Ho la guarnizione del pene che perde, e continuo a gocciolare urina ben dopo essermi richiuso la cerniera dei pantaloni. Però ho due stanze per gli ospiti.
La conseguenza è che, se vivi in Europa, quelle due stanze di ospiti ne attirano un bel po’. C’è chi spende una fortuna per il volo dagli Stati Uniti, e quando arriva è così povero e stanco che dormirebbe anche in macchina, se gliela offrissimo. Un tempo abitavamo in Normandia, in campagna, e gli ospiti venivano sistemati nella mansarda, che fungeva anche da studio per Hugh e puzzava di colori a olio e topi in decomposizione. Aveva il soffitto di legno ma non il riscaldamento, per cui faceva sempre o troppo freddo o troppo caldo. In quella casa c’era un solo bagno, incastrato tra la cucina e la nostra camera da letto. Poiché agli ospiti era negata la privacy che a volte serve in gabinetto, due volte al giorno prendevo Hugh e ci avviavamo verso la porta, gridando con la massima normalità: “Noi usciamo per venti minuti esatti. Serve niente dal marciapiede?”.
da Calypso
“Cari Amici e Familiari,
quando leggerete questa lettera io sarò già morta. Voi starete presenziando alla cerimonia e sarete seduti in silenzio, con in mano un bel fermacarte, un regalo che proviene direttamente da quella collezione che in vita era stata il mio orgoglio e la mia gioia. Vi rigirerete il fermacarte fra le mani e guarderete attentamente l’oggetto incastonato nel vetro, una rosa o uno scorpione, e fra le lacrime vi chiederete: “Che cos’è la morte?”. Io a quel punto la risposta a questo interrogativo la conoscerò, ma non sarò in grado di fornirvi i dettagli. So solo che un giorno vi incontrerò di nuovo nei verdi pascoli del Paradiso e sarò felice di abbracciarvi tutti, a parte Randy Sykes e Annette Kelper, e di farmi raccontare le ultime novità. Quando quel momento arriverà probabilmente non avrò molta voglia di vedere nemmeno mia madre, ma ahimè: arriva per tutti il momento in cui dobbiamo attraversare quell’ultimo vecchio ponte.
Se le mie indicazioni sono state seguite come ho chiesto (vedi busta n. 1), questa lettera vi sarà letta dal pulpito della Chiesa del Buon Pastore di Cristo dalla mia migliore amica Eileen Mickey (ciao, Eileen), che indosserà l’abito a maniche lunghe griffato Lisa Montino che mi stava così bene. (Eileen, io spero tanto che tu abbia perso un po’ di chili oppure che l’abbia fatto allargare sui fianchi, altrimenti ci soffocherai, lì dentro. Inoltre ricordati di farlo lavare a secco. So che tu e la tua famiglia volete sempre risparmiare, ma ti prego: non dare retta a quelli che dicono che Woolite fa miracoli. Mandalo in tintoria!)
La maggior parte di voi si sta probabilmente chiedendo perché l’ho fatto. Vi ripetete in continuazione: “Cosa può aver spinto Trish Moody a un gesto simile?”.
Sussurrate: “Perché, Signore? Perché hai preso con Te Trish Moody? Trish era un raggio di sole, sempre impegnata ad aiutare gli altri, sempre così allegra e vivace e piena d’amore. Così carina, poi. Sveglia, dolce e carinissima”.
Probabilmente scuotete il capo pensando che c’è un mucchio di gente molto peggiore di Trish Moody. Per esempio c’è quella sottospecie di uomo del suo ex fidanzato, Randy Sykes. Il ragazzo che, dopo che Trish gli ha accidentalmente tirato sotto il cane facendo retromarcia con la macchina, l’ha pestata come un tamburo. Pestata con le parole, d’accordo, ma è come se l’avesse presa a pugni. L’ha colpita ripetutamente con insulti ed espressioni quali “opportunista”, “gelosa”, “infantile” e altre che non oso riprodurre per iscritto. La morte del cane è stata un tragico incidente, ma forse nella sfortuna anche un bene, visto e considerato che Randy tendeva a trascorrere davvero troppo tempo con lui. Quel cane rischiava di diventare come lui, viziato e ribelle. Inoltre, avendo un pedigree lunghissimo, era comunque destinato a soffrire in futuro dei ben noti problemi all’anca.
E quale fu la risposta della mamma di Trish quando la sua bambina, dopo la rottura con Randy, corse da lei con il cuore a pezzi bisognosa di amore e comprensione? «Se stai cercando comprensione guarda sul vocabolario, fra “catarro” e “condiloma”.»
Può darsi che mia madre possa reggere battute del genere. Io no di certo”.
da Ciclopi
“Ho preso la bici e sono andato al lago delle barchette di Central Park, dove ho preso un gelato per poi sedermi a leggere su una panchina. Ho acceso una sigaretta, e me la stavo gustando quando la donna seduta tre metri e mezzo più in là, sull’estremità opposta della panchina, ha cominciato ad agitarsi le mani davanti alla faccia. Ho pensato che volesse scacciare una vespa.
Lei invece, continuando a dimenare le mani, mi fa: «Scusi, le spiace se stabiliamo che questa è una panchina per non fumatori?».
Davanti a una frase del genere io non so nemmeno da che parte cominciare a rispondere. «Le spiace se stabiliamo che questa è una panchina per non fumatori?» Stabiliamo un bel niente. I nostri voti si annullano a vicenda. Quello che voleva dire era: “Le spiace se lo stabilisco io che questa è una panchina per non fumatori?”.
Capirei se fossimo stati su un ascensore o rinchiusi insieme nel bagagliaio di una macchina, ma lì eravamo all’aria aperta. Chi si credeva di essere? La donna aveva un paio di sandali, che sono sempre indizio sicuro di guai. Sembravano il genere di calzature che poteva aver indossato Mosè mentre scalpellava le sue regole sulle tavole di pietra. Guardai i sandali, poi le braccia che si agitavano, e infine spensi la sigaretta. Facendo finta che non ci fosse alcun problema, mi misi a fissare le pagine del mio libro, odiando lei e Mosè. Tutti e due.
Il problema, con i non fumatori aggressivi, è che quando ti impediscono di fumare sentono di farti un favore. Sembrano convinti che un giorno, guardandoti indietro, li ringrazierai per quei quindici preziosi secondi di vita che ti hanno regalato. Non vogliono capire che per te sono solo quindici secondi in più per odiarli e meditare vendetta”.
da Diario di un fumatore