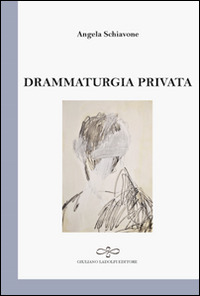Di seguito ripropongo in versione integrale l’intervista all’attore Niko Mucci pubblicata su comunicaresenzafrontiere
Niko tu non sei napoletano…
No,ho origini abruzzesi e pugliesi. Ma, a parte qualche breve periodo della mia infanzia, ho vissuto tutta la mia vita a Portici. Per sbaglio sono nato in Piemonte.
Ti senti napoletano adottivo o napoletano a tutti gli effetti?
Mi sento un napoletano adottivo nella misura in cui mi ritengo un meridionale: di Napoli percepisco pregi e difetti. L’avere più origini e l’aver soggiornato in diversi luoghi del meridione d’Italia ha fatto sì che la mia formazione culturale fosse napoletana. Non dimentichiamo che a Napoli fu istituita la prima università italiana, e che Napoli e le sue province per secoli sono state, e lo sono tuttora, un’attrattiva per quanti in Europa e nel mondo, nel corso dei secoli, volendo formarsi culturalmente, inserivano la città partenopea nei propri viaggi di formazione. A Napoli e nelle sue province hanno visto la luce tanti uomini e donne che hanno condizionato e condizionano tuttora la cultura mondiale.
Uno di questi è sicuramente Gianbattista Basile di cui ti sei divertito a trasporre in teatro le favole del Pentamerone.
Questo è un progetto che iniziò a maturare quando ero ancora giovane. Caso ha voluto che successivamente, in età matura, mi incontrassi con un discendete di Basile, il regista Domenico Basile, il quale ha tradotto dal napoletano antico, non da quello moderno che noi oggi conosciamo, le cinque favole del Pentamerone e insieme ne abbiamo fatto delle rappresentazioni teatrali in strada a Giugliano, paese natio di Basile. In precedenza già mi ero cimentato con Basile. Per la precisione lavorando con Renato Carpentieri con il quale in ben due occasioni abbiamo portato in scena le favole di Basile. Questo mi ha imposto di studiare il napoletano, non solo da autori moderni, ma da autori del passato come appunto Basile.
So che sei appassionato della letteratura latino/americana. E definisci la cultura napoletana antecedente il terremoto dell’ottanta molto affine a quel tipo di cultura sudamericana. Puoi spiegare questa sottile caratterizzazione?
Prima di tutto penso che sia chiaro a chiunque abbia a vissuto Napoli, sia culturalmente che praticamente, che la città dopo il terremoto è cambiata a livello di impostazione culturale e politica; così come è cambiato il rapporto che la città aveva con la politica e con i propri sentimenti. Ritengo che dopo il terremoto la città sia diventata più cinica, più distaccata da tutta una serie di cose che, seppure facessero parte di un’oleografia, erano insite nel napoletano. Mentre dopo sono diventate solo cartolina. Viceversa un’attenzione non cinica verso i sentimenti, a mio avviso, è rimasta nella cultura di lingua spagnola, sudamericana in particolare. C’è una generazione di scrittori sudamericani moderni che, senza smarrire la classica verve surrealista che caratterizza da sempre quel tipo di letteratura, affrontano in maniera molto incisiva tematiche realistiche. Uno è De La Parra – uno psichiatra – di cui metterò in scena un testo; un altro è Jorge Accame di cui ho già proposto “Avana”, un lavoro molto bello che in Italia non era mai stato rappresentato. Entrambi mantengono un sottofondo di poesia a fronte di un cinismo realistico che possiamo ritrovare in Moscato e in altri autori napoletani, dando vita a una sorta di teatro della crudeltà alla napoletana.
Tu svolgi la tua attività teatrale in un cosiddetto teatro di frontiera perché situato in una zona periferica e “particolare” della città
Il TAN di Piscinola, ai confini con Scampia, Miano, Chiano; comuni dove non c’è un cinema, un teatro, non c’è nulla perché la gente possa divagarsi senza doversi spostare.
Pregi e difetti del lavorare in una zona di frontiera
Prima di tutto, lasciami dire che è bellissimo! Per quanto riguarda i difetti, una sorta di provincialismo da parte di alcuni abitanti di quelle zone che preferiscono spostarsi a Napoli, malgrado noi facciamo molte attività come quelle che si svolgono in città. Provincialismo che io ho già testato a Portici: noi facevamo una proposta e la gente invece preferiva spostarsi a Napoli per vedere o fare le stesse cose da noi proposte.
Non pensi che, più che provincialismo, possa trattarsi di una sorta di precauzione, nel senso che l’idea di dover andare in un luogo deputato “pericoloso” incida sulle scelte delle persone?
Questo sicuramente: tante volte, ai miei inviti a vederci a vedere al TAN, mi sento rispondere, “ma non è pericoloso?”. La mia risposta è sempre la stessa: ci vado da venticinque anni e non mi è mai successo niente! Purtroppo è difficile sradicare un luogo comune dall’anima della gente. Questo è l’aspetto critico dello stare in periferia. Il grosso pregio invece è che in quella zona esiste un associazionismo spinto e un interesse per fare le cose al fine di dire “noi non siamo la camorra, noi non siamo lo spaccio. Noi siamo gente che vuole vivere la cultura”.
Qual è stata la risposta del pubblico a questo vostro impegno?
All’inizio ottima: eravamo seguiti da un nutrito pubblico tanto da arrivare ad avere per una stagione teatrale circa cento abbonati che è tanto per un piccolo teatro come il nostro. Abbiamo creato una rete con altri teatri e un pulmino che porta la gente da Napoli centro fino a noi e poi la riaccompagna in città. Ma soprattutto abbiamo riscontrato un interesse e una voglia di fare da parte degli abitanti del posto che ci fanno venire la voglia di continuare. Considera che io vado da Portici a Piscinola, il nostro direttore artistico viene da Fuorigrotta. Malgrado le distanze, ci spostiamo con gioia perché in quel territorio c’è fermento culturale per dimostrare di essere la parte buona di Napoli!
Passiamo per un attimo alla tua passione per la poesia, come nasce?
Quando da ragazzo suonavo, avevo la tendenza a fare il cantautore quindi mi scrivevo i testi delle canzoni e molti li mettevo da parte. Molti anni dopo, lavorando in teatro, una sera che eravamo in tournée, nell’attesa che la compagnia che ci ospitava finisse le prove, cominciai a improvvisare dei versi e la cosa mi divertì molto. Visto che poi le persone a cui li feci leggere si divertirono a loro volta, cominciai a scrivere con continuità. Inoltre la scrittura mi è stata di grande aiuto nei momenti di depressione derivanti dallo stare lontano per lungo tempo dalla famiglia a causa del lavoro. Quando poi le iniziai a pubblicare su Facebook, più di un amico mi chiese perché non le raccogliessi in un libro. E così nacque la prima raccolta di poesie, ATTORI A BABORDO, tutte scritte in tournée. Avevo come punto di riferimento Isa Danieli con la quale lavoravo: un giorno, mentre eravamo in pausa, prese una mia poesia, la lesse e disse “ a mme ‘e rime nun me piaceno, ma chesta poesia è bella”. A quel punto mi sentii incoraggiato e decisi di pubblicare.
Anche la tua seconda raccolta di poesie ha un titolo che richiama il mare, NAVIGARE E’ TARDI, ci spieghi perché questo legame con il mare e la navigazione?
Ho sempre accostato la compagnia di teatro all’equipaggio di una nave, obbligato per tutto il viaggio a stare insieme, decidendo se accoltellarsi o collaborare per portare la nave in porto. E poi mi porto dentro il monologo iniziale di Ismaele in Moby Dick che termina dicendo, “il mare, dove ciascuno come uno specchio ritrova se stesso.”
Tua moglie è l’attrice Nunzia Schiano, il vostro è un rapporto in cui prevale l’intesa o il conflitto?, ovviamente mi riferisco alla vostra attività teatrale.
Per un lungo periodo siamo andati di amore e d’accordo su tante cose. Negli ultimi tempi qualche conflitto nasce rispetto alle valutazioni sui giovani attori: io sono più possibilista, lei invece è molto rigida. Le nostre discussioni vertono sulla misurabilità del concetto di talento, ossia se il talento si può misurare o no: io dico che esistono vari gradi di talento; lei invece sostiene che il talento o c’è o non c’è! E su questo ci facciamo delle battaglie ideologiche che mi sono divertito a traslare in un testo teatrale: l’anno scorso ho proposto a mia moglie un copione in cui io e lei eravamo una specie di aspettando Godot, due ex attori settantenni che su una spiaggia rivedono il loro percorso. Mi ha risposto,”non lo farò mai, sono contraria all’autoanalisi in teatro”.
Ultima domanda, tuo figlio ha anche lui intrapreso l’attività nel modo dello spettacolo, seppure da regista cinematografico. Il suo cortometraggio ‘Corduroy’ è tra i finalisti per la categoria al Festival del cinema di Roma: come padre sei orgoglioso, preoccupato o cosa?
Di mio figlio sono molto orgoglioso per il percorso che ha fatto: come me ha iniziato a suonare; quindi si è interessato di cinema; si è laureato al DAMS; ha fatto dei master. Tuttavia vorrebbe fare lo sceneggiatore. Ma quello che mi ha reso particolarmente orgoglioso è il modo con cui ha gestito la compagnia durante i tre giorni di riprese. Secondo me ha fatto un solo errore: nel cortometraggio Nunzia interpreta il ruolo di protagonista; un giorno le disse, “mamma devi metterti qua”, anziché chiamarla Nunzia. Per il resto ha gestito in maniera egregia una compagnia composta da persone più esperte di lui; ascoltando e portando avanti il suo progetto, mediandolo con l’aiuto degli altri. Non è cosa da tutti.
Niko progetti per il futuro?
L’uscita del terzo libro di poesie che si chiama BAIONETTE LE PAROLE, in cui sono racchiuse tutta una serie di poesie che scrissi quando fui costretto in ospedale in seguito all’incidente per cui ho rischiato la vita e che mi ha limitato nei movimenti. Ma che mi ha anche obbligato a una profonda riflessione su me stesso per capire come avrei dovuto rivedere la mia vita, a valutarla in modo diverso. Per quanto concerne il teatro, sono costretto a passare più tempo dietro le quinte, lavorando come regista,che non a stare sul palco come attore. Ma ti assicuro che ciò non sminuisce affatto la mia passione per il teatro. È solo un inversione di ruolo, per alcuni aspetti anche più affascinante della recitazione stessa. Seppure il contatto che hai con in pubblico quando sei in scena è tutta un’altra emozione.
Fatti una domanda e datti una risposta.
Quali pensi siano i punti finali del tuo percorso?… Citando Flaiano, speriamo che la morte ci trovi ancora in vita!
Poco prima di pubblicare l’intervista, apprendiamo che l’attrice Nunzia Schiano, al Festival del Cinema di Roma, ha vinto il primo premio come attrice protagonista nel cortometraggio “Corduroy” girato dal regista Francesco Mucci.
A Niko, Nunzia e Francesco i complimenti della redazione di Comunicare Senza Frontiere.