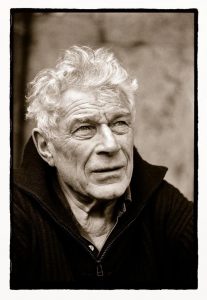Nei giorni di Pasqua vi consiglio un fioretto civile e sentimentale: andate a ritrovare un paesino del vostro passato. Fate visita a quel piccolo, vecchio, parente delle vostre origini; tutti abbiamo un piccolo paese nel cuore, nativo o adottivo, o sfiorato solo in un giorno d’infanzia o di gioventù. Portatevi come compagno di viaggio un libro di Franco Arminio, poeta e paesologo, come lui si definisce. O paesofilo, direi. Un geopoeta, che non è un poeta geometra ma un poeta della terra, dei luoghi, dei piccoli comuni. “Vorrei essere ricordato con una sola frase, l’uomo che amava i paesi”, dice Arminio, nativo a Bisaccia, nell’Irpinia d’Oriente.
Vi parlerò dei paesi con le parole sue, tratte dai suoi libri. Tornate al vostro paese, esorta il poeta, non c’è luogo più vasto. Cominciate la migrazione al contrario, anche se non è conveniente. Avete una casa vuota che vi aspetta; lì se ne sono andati tutti, specialmente chi è rimasto. Una volta, dice il poeta, i paesi erano fatti dei vivi e dei morti. Chi moriva veniva evocato in continuazione. Oggi seppelliamo assai presto anche la memoria. Eppure il paese è una fabbrica dove si producono sentimenti, attese tradite, indifferenze inusuali, presenze mute, sostegni di cui neppure ti accorgi. Avere un paese significa avere più mondo.
Per fare comunità ci vuole un luogo. Il luogo ha una poetica, oltre che un paesaggio. Ci vuole una tensione intellettuale e sentimentale insieme, avverte il poeta. La poesia ha il compito di legarci di più alla Terra, ci radica nella vita. Poesia per fare comunità, per dare coraggio al bene, per ingentilire il mondo più che biasimarlo. La poesia è di chi sta al mondo per cantarlo. Amore per l’essere e la realtà, aggiungo io, realismo fisico e metafisico. Il consiglio del poeta è portare la poesia ovunque, in ogni contesto, scolastico, istituzionale, civile. Il nero dell’Italia di oggi, dice bene il poeta, non è il fascismo ma la depressione. C’è gente che finisce la giornata prima di cominciarla. La depressione non è avversata perché non dà fastidio, è remissiva, al più nuoce a se stessi. Ma la scontentezza fa danni, dice il poeta (lo scrissi anch’io in un saggio dedicato agli Scontenti). Si parla tanto di narrazione ma nessuno sa narrare niente; e ci si ammala anche per questo, c’è come un ristagno delle emozioni. Occorre riprendere la cura dello sguardo, la passione di vedere il mondo; e piantare la vostra inquietudine in mezzo al salotto, e ovunque.
Il poeta rivolge il messaggio ai ragazzi di paese e dice loro: prendetevi le albe, non solo il far tardi, contestate con durezza i ladri del vostro futuro, siete la prua del mondo, davanti a voi non c’è nessuno. Ma ricordatevi, aggiungerei io, di quanti c’erano e ci sono dietro di voi, fate pace con la storia, le eredità, le radici, la memoria.
Un paese, avverte il poeta, per sua natura fa resistenza al nuovo, è conservatore. Ma i paesani d’oggi sono inzuppati di sfiducia, sono rami senza radici…Bisogna arieggiare i paesi, agitare le acque, ci vuole una comunità ruscello più che una comunità pozzanghera. Riabitare i paesi non è questione di soldi, dice il poeta. I soldi servono a farli più brutti, mentre per riabitare i paesi servono piccoli miracoli, una nuova religione dei luoghi; la questione non è economica ma teologica. Siate inattuali.
Il poeta vede ovunque l’impronta del sacro, il sacro minore, che si annida tra gli uomini, la terra, gli animali, le cose, i gesti. E scrive un libro dove la prima parola di ogni poesia è Sacro. Sacra è la poesia, ma solo quando è ladra, quando ruba un poco di miseria al mondo. Sacro era mio padre, dice il poeta, che non amava andarsene a dormire, gli era caro il sonno sul tavolino. Prosegue il poeta, abbiamo bisogno di contadini, di poeti, di gente che sa fare il pane, che ama gli alberi e riconosce il vento. Ogni albero è un pensatore, uno storico locale. E invece da troppi anni non arriva un anno nuovo, il mondo è simbolicamente morto.
Poi torni dalla poesia alla realtà e vedi che vanno via tutti dai piccoli comuni; chi resta è vecchio, sordo, disabile, rassegnato o eroico, fedele ad oltranza all’abitudine di un’origine e di mondo ereditato. I provinciali al quadrato, anzi alla terza potenza, per quelli che abitano nei paesini del sud, vivono quest’assedio; ogni giorno si arrende qualcuno e si consegna alla città. Nessuno si cura di loro, non c’è un Corriere dei piccoli che li racconti e li rappresenti, se non un poeta disarmato. Tanti sono i disagi, gli abbandoni, le lunghe noie, di chi vive nei paesini. Eppure nei piccoli comuni conosci più persone che nelle grandi città: nel paesino ti fermi a parlare con cento persone e ne saluti mille, nella metropoli ti fermi a parlare con sei persone e ne saluti venti. Vedi meno folle ma incontri più persone. Il paesano ha più mondo, più vita, più natura. Il paesano non va in farmacia, in caserma, in salumeria, in chiesa ma va dal farmacista, dal brigadiere, dal salumiere, dal parroco. Figure al singolare, non intercambiabili; di tutti sai vita, morte e miracoli. Forse perché sono piccoli comuni fanno più comunella; perché, non so ancora per quanto, sono comunità. Il piccolo comune è come un giardino d’infanzia, anche se abitato da vecchi, lo dovremmo tutelare come un bambino, con premura e tenerezza. Dovremmo aiutarlo ad attraversare la strada della modernità ed estendere ai piccoli comuni la legge a tutela dei minori. Col poeta riconosciamo la letizia senza scampo di vivere sotto la luce del sole; specialmente in un paese piccolo, inerme, ricco della sua piccola immensità.