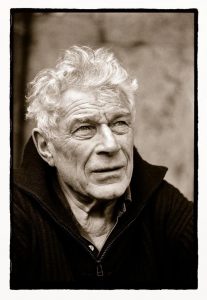Nella stessa settimana di mezza estate, un luglio di cinque anni fa, il Sud, l’editoria italiana e la letteratura popolare persero due grandi pop-writer e due figure pubbliche con grande seguito: Andrea Camilleri e Luciano De Crescenzo. Entrambi hanno reso più accattivante il sud, i suoi linguaggi, il suo modo di vivere e di pensare, la Sicilia di Camilleri e la Napoli di De Crescenzo. La sorte ha dato a Camilleri il privilegio di vivere una lucida e riverita vecchiaia, ha recitato per vent’anni il ruolo di Grande Vecchio e di Oracolo Siculo della Tv e delle Lettere. Invece ha dato a De Crescenzo un ventennio di declino e di ritiro dalle scene pubbliche per ragioni di salute. Ricordo vent’anni fa a una cena De Crescenzo si presentò esibendo un biglietto preventivo di scuse perché non riconosceva i volti delle persone, anche a lui note o addirittura amiche. I primi tempi si pensò a una spiritosa trovata dello scrittore, che conoscendo molte persone non ricordava i loro nomi e dunque era un modo gentile e simpatico per scusarsi in partenza della distrazione e non passare per superbo e scostante. In realtà soffriva di prosoagnosia, una malattia seria.
Entrambi sono stati scrittori assai popolari, e l’uno deve molto alla traduzione televisiva dei suoi romanzi, l’altro al cinema e alla partecipazione attiva nella simpatica scuola meridionale di Renzo Arbore. De Crescenzo si tenne sempre lontano dalla politica e dalle ideologie, si definì monarchico, indole di destra ma votante a sinistra, un po’ ateo e un po’ cristiano, ma preferì non mischiarsi nelle vicende della politica. Camilleri invece da anni ormai aveva assunto il ruolo di testimonial della sinistra, si era schierato apertamente in modo radicale, con qualche nostalgia del comunismo e un’antipatia viscerale che tracimava nell’odio verso Berlusconi ieri e verso Salvini di recente, fino alla famosa dichiarazione del vomito. Ma per giudicare un autore si deve avere l’onestà intellettuale e lo spirito critico di distinguere le sue posizioni politiche dalla sua prosa e dall’impronta che lascia nella letteratura. A questo criterio ci sforziamo di attenerci, ma l’aperto schierarsi di Camilleri gli è valso da morto una glorificazione veramente esagerata. Mentre De Crescenzo ha avuto un trattamento sottotono. Eppure De Crescenzo, oltre a riabilitare con arguzia il sud, aveva avuto il merito non secondario di aver reso simpatica e popolare la filosofia a tanti, e soprattutto la filosofia antica. Aveva reso famigliare la figura di Socrate, i presocratici, lo Zarathustra nietzschiano, stabilendo un ponte con la Magna Grecia. I professori di filosofia trattavano con sussiego De Crescenzo, come se fosse un abusivo del pensiero e un profanatore della filosofia: ma lui non ha trascinato in basso la filosofia, ha innalzato il lettore comune facendogli scoprire e amare la saggezza dei filosofi. Lui è stato un campione amabile di filosofia pop. Quanti accademici contemporanei hanno allontanato i lettori dalla filosofia, coi loro linguaggi involuti che nascondevano scarsa originalità e più scarso acume. Allontanavano la gente senza avvicinarsi alle vette del pensiero. Meglio De Crescenzo a questo punto…
Dal canto suo Camilleri è stato uno scrittore di talento, ha inventato un suo linguaggio gustoso e simil-siciliano, ha scalato le classifiche librarie quanto e più di De Crescenzo, anche perché la narrativa tira più della saggistica, le sue opere sono state tradotte in tutto il mondo, aiutato dal successo televisivo di Montalbano che è una delle fiction più vendute nel mondo. Ma i necrologi agiografici, gli infiniti servizi dedicati dai tg, i paragoni con Pirandello e Verga, e perfino con i classici, non gli hanno reso un buon servizio. Quando muore un personaggio pubblico bisogna rispettare la memoria e difenderlo dai suoi detrattori come dai suoi esagerati incensatori. Camilleri intrigava con le sue trame, sapeva gigioneggiare in video e sul palco, col suo tono da cassandra sicula e l’aura istrionica del vegliardo, assumendo un ruolo ironico-profetico. Grande affabulatore. Sul piano civile, sbandierava l’antifascismo, seppure molto postumo, ieri antiberlusconiano, poi antisalviniano. Una polizza per farsi incensare, come era già avvenuto in vita, e come è avvenuto in morte. Era uno scrittore bravo, un giallista e un autore di polizieschi di successo, non un Gigante, non il Grande Scrittore che entra nella storia della grande letteratura. Non esagerate, Camilleri rimane nella bestselleria corrente e nella personaggeria di scena del nostro tempo. Non rendetelo ridicolo, paragonandolo a Pirandello e Verga e pure a Sciascia. E’ come se negli anni trenta avessero paragonato Guido da Verona e Pitigrilli, autori di successo e di talento, a D’Annunzio e Pirandello. Via, abbiate senso della misura e delle proporzioni. Non mettetegli pennacchi e aureole, abbiate rispetto di un morto; lo scrissi allora sui social e oltre a una marea di consensi ricevetti insulti isterici dai suoi fan, che sono spesso lettori di un solo autore, non hanno termini di confronto, e credono che leggere Omero o Camilleri, Proust o Saviano sia la stessa cosa. La mia polemica non era rivolta contro Camilleri ma contro chi lo usa per scopi politici e lo innalza a tal punto da rendergli un cattivo servizio. Sappiate distinguere il successo dalla gloria, il cantastorie dalla storia, il “colore” dal pensiero. Pirandello descrisse a teatro la condizione dell’uomo contemporaneo, la perdita delle verità, l’avvento del relativismo; Camilleri seppe intrattenere, piacevolmente, migliaia di lettori e milioni di spettatori. Sono due cose diverse. Camilleri non è Pirandello, e De Crescenzo non è Benedetto Croce. Lo dico per difendere la verità e la memoria di ambedue, De Crescenzo e Camilleri.
Marcello Veneziani