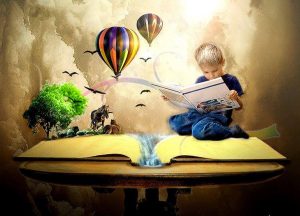Ci sono quadri che nascondono le loro storie meglio di altri.
Questo, per esempio:

Il dipinto, ora al Louvre, è datato alla metà del Seicento e attribuito al pittore olandese Samuel Hoogstratten (1627-1678, contemporaneo di Vermeer e specialista in effetti prospettici.
Il titolo, con cui è noto, è “Les pantoufles, le ciabatte“.
In un nitido interno domestico- un soggetto che, all’epoca andava di gran moda- una prospettiva rigorosa di soglie e stipiti di porte aperte, inquadra un’infilata di stanze, divise da un corridoio. Il senso di profondità è accentuato dalle mattonelle a losanghe del pavimento e dal gioco di luce e ombra.
Tutto sembra quieto e tranquillo. In realtà, se lo si guarda bene, si scopre che la calma è solo apparente. Si avverte, da subito, con un po’ di disagio, che, nel dipinto, manca qualcosa: manca qualsiasi figura umana. Un’assenza che si nota, tanto più che siamo abituati a vedere, nei quadri dell’epoca- in Vermeer soprattutto- ambienti abitati da giovani donne riflessive, domestiche indaffarate, o gruppi intenti alla musica o alla conversazione. E, poi, abbiamo l’impressione precisa che qualcuno, da quelle stanze, ci sia appena passato. Ma chi? Per scoprirlo non resta che varcare la cornice ed “entrare” nel quadro alla ricerca di indizi.
Subito, un dettaglio salta agli occhi: le ciabatte, talmente evidenti da dare il titolo al quadro.

Senza dubbio non sono lì a caso: sono illuminate, quasi fosse un proiettore, dalla luce del sole che entra a fiotti nella stanza e disposte proprio al centro della composizione. In un interno, così immacolato, quelle ciabatte, un po’ consunte, abbandonate per terra, con negligenza, nel bel mezzo del corridoio, sono un elemento stonato. Ed ecco che quello che, all’inizio, poteva parere una puro esercizio prospettico sembra, all’improvviso, animarsi. Non ci resta che ripercorrere, di nuovo, quegli ambienti silenziosi e osservare, uno a uno, tutti i dettagli.

Scopriamo, allora, che la scopa non è stata ben riposta, ma lasciata, in bella vista, appoggiato su una parete. Il mazzo di chiavi, ha l’aria di essere stato appena infilato nella serratura della porta e poi dimenticato. Se entriamo nel salotto, vediamo che, sul tavolo, c’è un libro chiuso e una candela, posta di traverso sul candeliere, che sembra sia stata spenta in tutta fretta. Allora qualcuno, qui, c’è stato davvero! Ma perché tanta negligenza e tanta precipitazione? E dove sarà la padrona di casa? Perché di una donna si tratta, a giudicare dagli oggetti tipici di occupazioni domestiche prettamente femminili. Se proseguiamo nell’indagine, scopriamo che proprio l’autore, Samuel Hoogstratten, un primo indizio ce lo aveva fornito, niente di meno che nel suo “Trattato sulla pittura”, dove aveva scritto: “i quadri migliori sono quelli che hanno un significato istruttivo”.
Vorrà dire che, anche in questo dipinto, un significato c’è. Vale la pena cercarlo. Rientriamo nel quadro e, questa volta, lasciamo che sia il pittore a guidarci. In effetti, se prestiamo attenzione, vediamo che quello che attira subito lo sguardo è il quadro, appeso alla parete di fondo del salotto, che spicca, con evidenza, sul bianco del muro. Non cerchiamo oltre: la chiave è là.
Il quadro raffigurato non è affatto di fantasia, ma è la copia, con qualche variante, dell”Ammonizione paterna” di Gerard Ter Borch. La tela di Ter Borch, all’epoca, era notissima: ne erano state fatte numerose copie e stampe da esporre, bene in vista, nelle più dignitose case olandesi. Nel dipinto un padre, indicando con fare minaccioso un’alcova rossa, simbolo evidente di peccato, ammonisce la figlia contro il vizio e la dissolutezza, a cui può condurre l’amore carnale. Era il soggetto giusto da porre, come monito, sotto gli occhi delle giovani perbene. Ecco dove ci voleva portare il pittore!

Nessun elemento del dipinto era casuale. Facendo parlare solo gli oggetti fuori posto, l’artista ha costruito un piccolo racconto morale –o immorale- perfettamente comprensibile dai suoi contemporanei: una donna, nella fretta di precipitarsi a un incontro galante, si scorda le chiavi sulla porta, abbandona le scopa appoggiata al muro e si toglie le ciabatte proprio in mezzo al corridoio. Spegne anche la candela, alla cui luce stava forse leggendo. E ora, fuori dal nostro campo visivo, in un’altra stanza, si dedica a un’illegittima attività amorosa. Presa dalla passione, ha scordato le sue più elementari incombenze: una condotta, all’epoca, davvero riprovevole. Preferire le vane gioie d’amore alle sagge occupazioni domestiche non era degno di una donna onesta.
Quella che il pittore ha abilmente suggerito, col suo gioco di indizi, è una sottile lezione di comportamento, destinata a qualche casalinga inquieta, a rischio di cadere in tentazione. Nessun mistero, dunque, tanto che, a questo punto, potremmo pure proseguire il racconto con un pizzico di pepe e di dettagli piccanti. Meglio di no! Ora che tutto è chiarito, la cosa migliore da fare è uscire in silenzio dal quadro, senza dimenticare di chiudere, con discrezione, la porta d’ingresso.