Avete presente le soffitte delle antiche dimore? Sono labirinti di vecchie cose deposte spesso alla rinfusa: memorie del tempo che passa, relitti della moda che cambia. Nonostante tutto, hanno sempre esercitato su di me un fascino potentissimo: persino il velo di polvere che si posa sulla superficie dei mobili, dei quadri, degli specchi fioriti di macchie mi sembra che abbia un buon odore. Un odore nobile, a modo suo: quello della Storia.
Capirete dunque l’eccitazione che mi colse il giorno in cui, all’improvviso, mi fu chiesto qualcosa che altri avrebbero preso per una rogna da allontanare, e io invece giudicavo un privilegio: decidere cosa fare dei beni appartenuti alla prozia Alvisa.
La prozia Alvisa, sorella di mia nonna, era morta alla veneranda età di 110 anni; un vero record persino in una famiglia come la nostra in cui le donne, vuoi per un dono genetico vuoi per il temperamento guerresco che scorre nel sangue, arrivano facilmente a superare la soglia dei novanta.
Come ogni ragazza di buona famiglia del suo tempo, Alvisa era stata educata in vista del matrimonio, della devozione al marito e alla famiglia. All’età di cinque anni – questo era l’uso di allora – la premurosa mamma aveva iniziato a mettere da parte gli oggetti che avrebbero dovuto formare il suo corredo da sposa. Il quale giaceva ancora intatto dentro una robusta cassa di quercia nella soffitta che dovevo esplorare, non sfiorato dalle ingiurie del tempo e anche da quelle umane: Alvisa infatti, dimostrando un’indole fiera piuttosto insolita per le donne dell’epoca, aveva elegantemente trovato il modo di rimanere nubile fino alla morte. Insegnante di pianoforte, si era sempre mantenuta da sé mantenendo in tal modo anche la propria indipendenza fisica ed emotiva.
Quel corredo da sposa di una ragazza benestante degli anni Venti mi intrigava più di ogni altro oggetto presente nella soffitta; chiesi dunque a mia sorella il favore di esplorarlo con me, e di condividerlo, anche, lasciando tutto il resto in eredità alle nostre cugine.
Che emozione, aprendo quella cassa! La prima sensazione che ne ricevemmo fu olfattiva, il particolare profumo che emanava: naftalina, immancabile antidoto contro le tarme, mista però a resine naturali usate probabilmente per preservare il legno dai tarli.
Dentro, un paradiso di tessuti differenti, alcuni dei quali addirittura lavorati su antichi telai domestici che ci immaginavamo percorsi da instancabili mani femminili. Pizzi, trine, delicati ricami a intaglio provenienti da una sapienza ancestrale… Dodici di tutto, era la regola nelle famiglie abbienti. Lenzuola, tovaglie, asciugamani di lino per il bagno e di cotone robusto per gli usi di cucina, e poi gli indispensabili pannolini per i tragici giorni del mestruo, che le donne fermavano alle mutande usando grosse spille da balia. Come dovevano essere scomodi…
La cosa che più ci colpì, anzi non è esagerato dire che ci lasciò attonite, fu però un’altra. Un corredo completo, ovvero dodici capi, di una lunga camicia da notte in lino spesso, con splendide smerlature sui polsi e lungo lo scollo. Bellissimo indumento, se non fosse stato per una particolarità che ci avrebbe fatto lambiccare il cervello: al centro della parte anteriore, più o meno quella porzione di camicia che doveva correre dall’ombelico a metà coscia, si apriva una lunga asola. Sì, esatto: un’asola tale e quale quella che si usa per i bottoni, solo che in questo caso bottoni non c’erano. Passammo almeno un quarto d’ora a considerare quell’anomalia, fin quando ci apparve evidente la verità: erano camicie da notte concepite per le partorienti, munite perciò di una grande asola centrale che avrebbe facilitato le manovre dell’ostetrica nel momento di sgravarsi.
Ci sembrò un’autentica rarità, così pensammo di visitare il negozio di un antiquario delle nostre zone, ansiose non certo di vendere la cara reliquia di famiglia, ma almeno di conoscerne l’esatto valore.
Spiegammo all’antiquario la dinamica del ritrovamento e le nostre congetture al riguardo. Si fece una bella risata alla faccia del nostro candore.
“Ma quale camicia da parto!”, ci disse. “E mi fa specie che certe cose io le debba sentire proprio da due donne…”.
“Perché le sembra assurdo?”, chiese mia sorella.
L’antiquario ci gettò un’occhiata di sbieco.
“Siete giovani, e da come parlate mi rendo conto che non avete ancora figli. Il giorno in cui partorirete, vi renderete conto che nessuna ostetrica è in grado di eseguire le manovre del parto disponendo di uno spazio ridotto come quello che passa dentro l’asola di quelle camicie”.
Ci sentimmo due povere sceme.
“Ma allora, scusi”, chiesi io, “a cosa diamine serve quell’asola lì? Mica per andare in bagno senza prendere freddo in inverno… l’apertura in tal caso dovrebbe trovarsi nella parte posteriore della camicia”.
La mia considerazione scatenò un’altra risata dell’antiquario.
“No, no”, rispose dopo essersi ricomposto, “Lei ha ragione almeno su un fatto: quell’asola serviva per far passare qualcosa. Qualcosa di più piccolo, tuttavia, rispetto alle mani di un’ostetrica o al corpo di un neonato”.
“E cosa?”, ebbe l’ingenuità di chiedere mia sorella.
L’antiquario arrossì. Giuro. Arrossì davvero, anche se la situazione gli sembrava estremamente spassosa.
“Dovete sapere, ragazze care, che la vostra prozia visse in un’epoca molto lontana dal nostro tempo. Non è solo una differenza data dai cellulari, da internet, dalla televisione… A livello morale, per esempio, negli anni Venti esisteva un codice rigidissimo. Oggi può sembrare grottesco, ma allora era la norma condivisa da chiunque”.
“Che norma?”, feci io.
L’antiquario si schiarì la gola. Dalla sua espressione, capimmo che intendeva prenderla molto alla larga.
“Prima del Concilio Vaticano Secondo, che avvenne nel 1968, era d’obbligo che una puerpera non uscisse di casa in quanto considerata impura per aver trasmesso al figlio neonato il peccato originale. Il peccato della carne e del sangue. E quando il bambino veniva liberato da questa macchia morale con il battesimo, anche la madre doveva mettersi in ginocchio per ricevere dal prete una speciale benedizione liberatoria, una forma di esorcismo”.
Aguzzammo le orecchie. Quella specie di lectio magistralis ci intrigava, non vedevamo l’ora che il nostro saccente antiquario arrivasse a spiegare il mistero della camicia con l’asola davanti.
“Se la morale cattolica considerava peccato mettere alla luce un figlio, ovvero dargli la vita, immaginate come poteva giudicare l’atto naturale con cui quella vita era stata concepita nove mesi prima?”.
La domanda ci lasciò di sasso. Per alcuni istanti rimanemmo attonite e in silenzio, nessuna di noi due osava dare voce al pensiero apparso nelle nostre menti come un fulmine a ciel sereno.
Mia sorella si riscosse prima di me.
“Dunque…”, esitò… “perciò quella camicia da notte serviva… Per il sesso?”.
L’antiquario ridacchiò.
“Sesso… Anche questa è una parola troppo moderna. Implica la libertà mentale di pensare che l’atto fisico tra maschio e femmina abbia un valore di per sé, una sua dignità autonoma…”.
“Insomma!”, sbottai io, “ci siamo capiti su cosa esattamente doveva passare dentro quell’asola, oppure no?”.
“Certo”, rispose lui, “ma non avete afferrato per niente il concetto di base. Non si trattava di sesso, ma di obbedienza”.
“Obbedienza?”
“Assolutamente sì. Ottemperare al sacro dovere di procreare per dare continuità al mondo e alla Chiesa. Tant’è vero che quel particolare tipo di camicia ha un nome per così dire liturgico. Si chiama giubidomine, derivato dal latino iubet Dominus, ovvero “Dio lo ordina”. Mi spiego?”.
Si era spiegato benissimo, in realtà; solo che noi stentavamo a crederci.
“Dunque le donne andavano a letto con quella camicia che le copriva dal collo ai piedi – dissi incredula – e i mariti…”.
L’antiquario fece il gesto di stringersi nelle spalle.
“Ragazze mie, quelli erano i tempi. Quella era la mentalità. Per la donna la faccenda doveva rappresentare più che altro un atto di sottomissione, un obbedire devoto ai doveri familiari, al marito, alla severa disciplina religiosa sul matrimonio. Ma per gli uomini non era poi tanto meglio, almeno psicologicamente. I preti consigliavano in confessione di toccare le proprie mogli il meno possibile, anche durante l’atto coniugale. Provare piacere era una colpa, persino nel matrimonio. Tant’è vero che prosperavano i bordelli, a quel tempo. Così gli uomini potevano togliersi liberamente certi sfizi”.
Mia sorella, attivista in una onlus per i diritti delle donne nel mondo, prese letteralmente fuoco.
“I maschi!”, tuonò. “E le donne, allora? Solo subire, solo obbedire!?”.
La cruda realtà era sotto i nostri occhi, e il sapiente antiquario non poteva proprio farci niente. Ricordavamo entrambe che quella strana parola, “giubidomine”, era usata nel dialetto delle nostre zone per indicare una gonna troppo lunga, un cappotto troppo largo, qualcosa che insomma infagotta la figura femminile in modo da nascondere le forme e annichilire il sex appeal. Un termine dispregiativo. Credevamo però che fosse solo una parola inventata… Invece no. Indicava un preciso capo di vestiario con una struttura sua. Con un’identità definita, anche se atroce. E la funzione di cimitero per qualunque afflato passionale nella coppia. Era doloroso immaginare quegli amplessi asettici consumati tra i due corpi attraverso lo schermo di lino di quella camicia… Un contatto arido e freddo. Rasposo, per giunta: le tele del tempo non erano tanto morbide al tatto.
Quanti matrimoni erano stati condannati a quella tristezza, inariditi dal senso di colpa, annegati nella fretta di fare prima che si può, per togliersi dalla coscienza l’adempimento del dovere… E le fiamme della passione? E i gesti del prendere piacere e darlo, attraverso i quali passa l’oro inestimabile della tenerezza? Tutto perduto. Tutto negato dal castigo del “giubidomine”.
Uscimmo dal negozio dell’antiquario scure in volto. Per diversi minuti nessuna di noi due parlò all’altra. Covavamo in cuore lo stesso malumore.
“Io le faccio a pezzi!”, sbraitò mia sorella.
La proposta mi ripugnava, dopotutto.
“Perché non le diamo in beneficenza?”, proposi.
Lei accettò la proposta, benché di malavoglia. L’idea di ridurre a brandelli quella specie di galera tessile, quel cimelio di una discriminazione mutilante e odiosa la seduceva molto. Accettò per farmi contenta, e anche perché in questo modo qualcun altro avrebbe tratto un beneficio da ciò che era stato fabbricato appositamente per ledere e danneggiare.
Portammo così le dodici camicie da don Tonino, il parroco attempato che si occupava di raccogliere abiti usati per la Caritas. Era un vecchietto arzillo, per i suoi ottantacinque anni, e ancora nel pieno delle facoltà mentali. Dopo averci ringraziate, osservò le camicie con istanti di perplessità. Che subito lasciarono spazio a una faccia divertita.
“Il “giubidomine”!”, esclamò ridendo. “Dove li avete trovati?”.
“Nel corredo di una nostra prozia morta a centodieci anni”, borbottò mia sorella.
“Ne avevo sentito parlare da ragazzino, e poi anche in seminario. Giuro però che è la prima volta che li vedo dal vivo!”.
Mi sorella s’indignò. In quel momento il vecchio parroco le appariva come il guardiano di quella morale cattolica schiacciante che aveva lasciato dietro di sé un’interminabile scia di lacrime e insoddisfazione.
“Lei non prova disagio nel guardare queste camicie, don Tonino? Non crede che la Chiesa dovrebbe chiedere scusa per le umiliazioni che ha inflitto alle donne durante quasi duemila anni?”.
Il prete sembrava spiazzato.
“Sì!”, rincarò lei sempre più appassionata, “la negazione del diritto al piacere fisico. L’imposizione del rapporto sessuale come un obbligo nei confronti del marito, addirittura fatto assurgere a precetto religioso!”.
“Non capisco…”, balbettò il poverello.
Mi sentii in dovere di mediare nella situazione imbarazzante che si era creata.
“Ci scusi, don Tonino. Abbiamo scoperto a cosa serviva quell’asola nelle camicie e ci siamo rimaste male, ecco tutto. Sarà d’accordo con noi che la morale cattolica dei decenni passati era troppo rigida. Diciamo pure disumana, sotto certi aspetti… Mi pare assurdo negare il diritto al piacere fisico persino nella coppia regolarmente sposata. Persino laddove il matrimonio era stato benedetto dal sacramento”.
“Sono precetti del diritto canonico”, obiettò lui con mitezza.
“D’accordo, reverendo, ma tutto questo non è accettabile. Non è giusto”.
“Certo che non è giusto”, fece il prete. “Ogni ragazza che si sposava aveva almeno una camicia di quel tipo nel suo corredo. Sapeva di dover mettere quell’indumento ogni volta che andava a letto. Era un dovere importante, perciò lo compiva. Tanti matrimoni sono stati felici anche così”.
“Felici?”, tuonò mia sorella. “Col giubidomine addosso?!”.
“Ma no”, rispose don Tonino. “Una volta entrata nel letto, se lo toglieva”.
L’autrice
Storica del Medioevo, Barbara Frale è nota nel mondo per le sue ricerche sui Templari ed è autrice di monografie e romanzi di successo, oltre che consulente storica della serie tv Rai I Medici. Masters of Florence. Dopo i bestseller I sotterranei di Notre-Dame e Cospirazione Medici – per citarne alcuni – si è dedicata a un romanzo che indaga sulla figura di uno dei più grandi artisti di tutti i tempi: Leonardo da Vinci. Il mistero di un genio, edito Newton Compton, 12 euro.







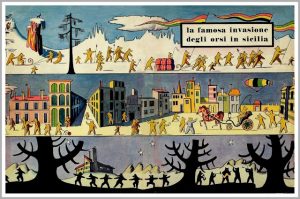
 “Scendiamo al piano. Meglio combattere con gli uomini che morire di fame quassù”, dicevano gli orsi più animosi. E al loro re, Leonzio, diciamo la verità, l’idea non dispiacque: sarebbe stata una buona occasione per cercare il suo figlioletto. I pericoli, se tutto il popolo fosse sceso in massa, sarebbero stati ben minori. Gli uomini ci avrebbero pensato su due volte prima di affrontare un esercito simile.
“Scendiamo al piano. Meglio combattere con gli uomini che morire di fame quassù”, dicevano gli orsi più animosi. E al loro re, Leonzio, diciamo la verità, l’idea non dispiacque: sarebbe stata una buona occasione per cercare il suo figlioletto. I pericoli, se tutto il popolo fosse sceso in massa, sarebbero stati ben minori. Gli uomini ci avrebbero pensato su due volte prima di affrontare un esercito simile.

