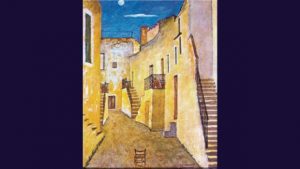La famiglia scelta. È l’espressione chiave per adottare una nuova, radicale sostituzione. Basta con la famiglia “costretta”, ossia la famiglia naturale, con i suoi legami di sangue e i suoi vincoli determinati dall’essere padri, madri, figli, fratelli “biologici”. Invece la famiglia scelta è per definizione una famiglia volontaria, adottiva, collettiva, libertaria ed egualitaria in cui vivono sotto lo stesso tetto persone varie, e animali annessi, indipendentemente dal genere e l’orientamento sessuale. In una parola, la famiglia queer.
Il mito di fondazione della famiglia queer è associato a Michela Murgia, la scrittrice che prima di morire decise di rendere pubblica e solenne la sua famiglia scelta, ibrida e allargata. Come tutti i miti di fondazione, la morte della fondatrice ha dato “sacralità” simbolica a questa visione pur dissacratoria della famiglia naturale e tradizionale. Al di là della vicenda terrena della scrittrice sarda, alcuni giornali, circoli intellettuali, cenacoli si stanno impegnando a trasformare quell’esempio di famiglia queer in modello di riferimento alternativo rispetto alla famiglia coatta traducendola in battaglia politica e civile per rivendicare la libertà d’amare e di scegliere (Elly Schlein sarà con loro).
Cos’è una famiglia queer? “Una famiglia ibrida fondata sullo ius voluntatis, sul diritto della volontà” spiegava la Murgia. E i suoi discepoli, da Michela Andreozzi a Marcello Fois, spiegano che la famiglia scelta è struttura variabile oltre che volontaria, e comprende animali, svariate sorelle, papà e mamma elettivi (si scelgono i padri e le madri con votazioni, si procede per acclamazione, si va a rotazione?). E ciascuno specifica come si faceva da bambini quale ruolo assume nel gioco di ruolo che sostituisce la famiglia naturale. Io faccio il papà, io la figlia…Ribadendo che il sangue non c’entra nulla, e la famiglia tradizionale non ha mai funzionato bene, ma ora non funziona più.
Sarebbe facile giocare sull’ironia, ma prendiamo sul serio quel che viene detto e rispettiamo le scelte altrui, fino a quando non pretendono di essere alternative e sostitutive rispetto a quelle che costituiscono la realtà naturale e l’esperienza di vita su cui si fondano la società tramite le famiglie e la loro riproduzione. Dunque, cos’è quella società allargata di conviventi con libera e mutante sessualità? E’ una libera e provvisoria associazione, ma non chiamiamola famiglia. Qual è il legame che insorge tra loro? E’ l’amicizia, non si può paragonare all’amore famigliare. Arrivo a dire che se l’alternativa è l’isolamento, il solipsismo, ovvero la solitudine non come scelta ma come perdita del mondo e depressione, ben vengano questi club allargati, affettivi prima che sessuali, piuttosto che definirle con linguaggio camorristico “nuove famiglie organizzate”.
I problemi sorgono quando queste reti amicali si configurano come la famiglia del futuro, con la pretesa di sostituire i legami famigliari. E quando si pretende di cancellare, degradare, svalutare tutto quel che proviene dalla natura, dal sangue, dall’ereditarietà, dai legami del destino, rispetto a quelli fondati sulla volontà. Che è soggettiva e quindi conflittuale rispetto ad altre volontà soggettive; che è mutevole e quindi non può garantire costanza e sicurezza degli affetti come invece quelli tra genitori e figli, o tra fratelli. Che non è riproduttiva, perché le associazioni di tipo omosessuale non possono riprodursi se non usando terzi (uteri in affitto, fecondazioni artificiali, compravendita di corpi, semi, ovaie, neonati, ecc.).
Torno a dire che nessuno vuol negare la libertà di quelle scelte, ma non sono sostitutive rispetto alle vecchie, scassate, controverse, contestate famiglie naturali. E le fratellanze senza padri e madri, di solito degenerano in fratricidi; se non ti riconosci nella comune origine, se non ti riconosci in un padre e una madre comuni, alla fine, passato il periodo dell’abbraccio generale, insorgono le divergenze, le priorità, le egemonie. Ogni volontà, alla fine, è volontà di potenza, di dominio. Se non personale, ideologica, di un modello, di una struttura, di un collettivo.
La famiglia, si sa, sta male già per conto suo; l’atomismo e l’egocentrismo, il narcisismo e la fluidità, i desideri infiniti e le pretese la mettono a dura prova. Spesso i matrimoni saltano, e il vero rapporto indissolubile, alla fine, è di tipo verticale: è quello tra genitori e figli, che non si può disdire o revocare, come invece può accadere nel rapporto di coppia. Non idealizziamo la famiglia “tradizionale”, cogliamone tutti i limiti, i difetti, le contraddizioni con una società troppo aperta e troppo individualista per poter reggere l’urto a livello famigliare. Però, provate a pensare “senza”, provate cioè a liquidarla, a ritenervi solo figli del vostro tempo e delle vostre scelte, anziché figli della storia e della famiglia. Provate a perdere quell’asse di riferimento, necessario anche quando lo confutate; provate a negare quell’alveo d’origine, quel luogo d’infanzia e di formazione, quel rifugio, quel bisogno originario, primario, di sicurezza; dove i legami sono autentici proprio perché biologici, naturali, precedenti la nostra stessa volontà; veri e istintivi. Perché noi non nasciamo come una tabula rasa su cui decidiamo tutto; noi nasciamo eredi biologici, con legami naturali affettivi (gli stessi che vi commuovono quando parlate dei cuccioli di Amarena, l’orsa abbattuta in Abruzzo). Quel che precede la nostra libertà e la nostra volontà si chiama natura, identità, origine, destino. Perché dovremmo disprezzare, rigettare, spezzare tutto questo? Non siamo autocreati e tutto ciò che costruiamo non lo costruiamo dal nulla ma sempre da realtà preesistenti. Create pure le vostre case arcobaleno e le vostre reti amicali; ma sappiate che non sostituiscono la famiglia da cui provenite e quella costruita accoppiando e procreando. Sono due piani diversi. E bisogna saper distinguere, e rispettare, la sfera dei legami naturali da quelli elettivi. Noi siamo quel che siamo e diventiamo quel che siamo; non nasciamo dalla nostra volontà e dai nostri desideri. Siamo creature, possiamo essere creativi, ma non siamo creatori.
Marcello Veneziani