Ed ora guardiamo questa città nuova (Neapolis) durante la dominazione romana.
Il paradiso terrestre, che si apre allo sguardo di chi, fin dai tempi più remoti, appena doppiate le bocche di Capri, penetra nel golfo di Napoli e approda, dal mare, sulle coste, quel paradiso di bellezza e di fecondità, che meritò alla Campania l’attributo di felix, non formò mai la felicità e la ricchezza dei napoletani, ma, anzi, fu causa della loro infelicità e della loro povertà. Quelle terre non appartennero mai ad essi, ma a spietati invasori e dominatori, che, attratti dalla pingue preda, se ne impossessarono con la frode e con la forza, costringendo gli abitanti dei luoghi alla servitù e alla miseria. Né i dominatori si appagarono di ciò; ma i napoletani, ridotti allo stremo della povertà, furono ancora da essi crudelmente offesi e spremuti, spinti a combattere per altrui interessi, sempre opposti ai propri, ostacolati in ogni tentativo di elevazione morale e spirituale. E’ questo il motivo vero per cui l’animo del napoletano è scettico di fronte alle avventure e teme che ogni novità piuttosto che giovargli, debba peggiorare la sua condizione. Scetticismo, dunque, che – come dicevamo – non è congenito al carattere dei napoletani, ma è il triste frutto delle dure esperienze, cui la storia li ha sottoposti, in ogni epoca.
I Romani, buttatisi presto sulla bella preda della Campania, di cui fecero l’oasi preferita per le loro villeggiature, i loro ozi e i loro piaceri, dopo essersi estesi fino alle falde del Vesuvio, cominciarono a guardare con inquieta gelosia alla città di Neapolis che si sviluppava al centro dell’arco del golfo, in ottima posizione strategica. I Romani erano turbati dal fatto che la città subisse l’influenza dei forti Sanniti, coi quali avevano più di un conto da regolare. Meditavano, secondo la loro prassi del massimo risultato col minimo sforzo, sul modo migliore per attrarla nella loro orbita: la guerra aperta o il sottile gioco diplomatico. Prevalse il partito della guerra che vide i Romani vittoriosi. Da quell’anno Napoli visse sempre all’ombra di Roma, a cui fu fedelissima. Conservò un’autonomia apparente, regolata dal foedus neapolitanum, che ne rispettò i riti, gli usi, i costumi e la lingua greca, che continuò ad esser quella degli atti ufficiali. E anche quando, nel 90 av. Cr., per effetto della lex Julia, Napoli, città alleata, divenne municipio, non fu trattata con l’inflessibile durezza con cui i romani erano soliti trattare tutti gli altri municipi. Continuò ad esservi tollerata la cultura greca, le monete continuarono a portare l’incisione della testa di Pallade, vi si celebrarono ancora i ludi lampadici in onore di Par-tenope, istituiti dallo stratega ateniese Diotimo. Quella di conservare una parvenza di libertà ai popoli soggetti, ai quali effettivamente la toglievano, era arte somma dei romani. Ma, in realtà, i gravami della dipendenza da Roma si facevano sentire assai forti sulla vita dei napoletani: essi dovevan fornire un pesante tributo di navi e di marinai per le guerre navali; e se questo, come acutamente nota Gino Doria, giovò, in un certo senso, ai napoletani stessi, che ne trassero buone esperienze marinaresche da essi sfruttate con vantaggio nelle guerre successive, è pur vero che noc-que al loro traffico marittimo mercantile. Il passivo della dominazione romana si ripercosse assai gravemente anche sul morale dei napoletani. Tolse loro il senso virile della libertà, senza cui non vi è dignità; ne fiaccò lo spirito combattivo, poiché si sentivano protetti per la loro incolumità dalla potenza romana (come avvenne contro Pirro, nel 280 av. Cr., e contro Annibale nella seconda guerra punica); e si dedicarono ai facili e non sempre onesti guadagni dell’industria dei forestieri, che affluivano continuamente nella città.
Durante l’epoca romana, inoltre, in Napoli, come in tutte le città viventi sul lusso e sui piaceri voluttuari dei dominatori, erano sorte una infinità di industrie, di commerci, di mestieri al servizio di quel lusso e di quei piaceri. Le antiche epigrafi ci danno notizie delle corporazioni napoletane del lavoro, tra le quali particolarmente forte era quella degli architetti e degli edili, che lavoravano per quei ricchi romani che si venivan costruendo le loro sontuose ville e terme e teatri lungo tutto l’arco del golfo, tra Capo Misene, Baia, Pozzuoli, Lucrino, Posillipo, e, via via, fino a Pompei, ad Ercolano, a Stabia. Ville ed edifici, venuti alla luce negli scavi, meravigliano anche noi moderni per la loro arte e per i conforti che offrivano. Accanto agli architetti, fiorirono, necessariamente, le arti sussidiarie: marmorarii, fabbri, lignarii, ferrarii, aurarii, lanisti, istruttori e allenatori di gladiatori, saponarii e unguentarii, tutti riuniti in corporazioni. Sicché quando, con la cessazione dei facili lucri della dominazione romana, i napoletani doveron provvedere a nuove fonti di guadagno, poteron riprendere quei mestieri, in cui si erano allora specializzati. E la vita corporativa valse a formare in loro il senso dei diritti e dei doveri dei lavoratori. A Napoli, nel VI secolo, si ebbero le prime lotte sindacali quando i saponari insorsero contro i soprusi del magistrato imperiale palatino Giovanni, invocando ad arbitro della loro vertenza nientemeno che l’intervento di Papa Gregorio Magno.
Verso la fine dell’Impero, Napoli aveva oltrepassato di molto i 30.000 abitanti e si era dilatata fino a San Sebastiano e a Santa Maria La Nova, da una parte, e dall’altra, oltre San Nicola dei Caserti. E, fin da quel tempo, ebbe le acque del Serino e del Bolla.
Simbolicamente, l’Impero, che aveva dominato e romanizzato la città, già disgregato dalle invasioni barbariche, agonizzò a Napoli nella persona dell’ultimo imperatore, che – per tragica ironia del destino – portò insieme congiunti i nomi del grande fondatore dell’Urbe e quello del grande fondatore dell’Impero: Romolo Augusto. Egli si spense, infatti, nel 476 d. Cr., nella villa di Lucullo, ov’era tenuto prigioniero da Odoacre.
A proposito della denominazione di Castel dell’Ovo, molte e leggendarie sono le versioni che se ne danno. La più probabile e realistica è che essa derivi dalla forma ovoidale della sua pianta. Molto diffusa è, poi, la leggenda dell’uovo di Virgilio, il grande poeta, che era considerato – non sappiamo bene perché, forse per equivoco ingenerato dal nome della madre, che si chiamava Magia – un po’ mago anche lui. Il poeta, dunque, avrebbe messo un uovo in una gabbia e lo avrebbe collocato in un angolo remoto del castello. Naturalmente, era un uovo incantato, che, fin quando fosse rimasto integro, avrebbe garantito la incolumità dell’edificio. Ettore Imparato, nella sua «Piccola Storia di Napoli», afferma di aver sentito da un tedesco che la denominazione, più probabilmente, era da rapportarsi al fatto che l’intonaco del castello fosse stato impastato con bianco d’uovo, per renderlo più resistente. Ipotesi strana, in verità!
Per quanto attiene alla sua storia, vi era, in antico, una dipendenza della sontuosa villa di Lucullo, il quale, per costruirsela, fece tagliare il monte Echia, all’altezza dell’attuale via Ghiaia, creando un canale, e, sull’isolotto di Megaride, innalzò il famoso castello, ricco di marmi, di statue, scintillante di ori, con diverse sale da pranzo, pareti con diversi colori, a ognuno dei quali corrispondeva un « menu » diverso, secondo la importanza degli ospiti che riceveva. Bastava che dicesse ai suoi cuochi: «Oggi si pranza nella sala rosa, o verde, o azzurra», e quelli capivano che tipo di cena dovevano approntare.
Lo stesso Imparato afferma che, fino a qualche decennio fa, nelle acque intorno al Castello si rinvenivano ancora pezzi d’argento e d’oro.
In seguito, vi sorse la chiesa basiliana del Salvatore. I normanni lo trasformarono in rocca, ampliata successivamente dagli Svevi e dagli Angioini. La forma attuale di fortino circolare l’assume nel 1961. Nell’interno sono ancora visibili tracce della villa romana del cenobio basiliano e dei rifacimenti trecenteschi.

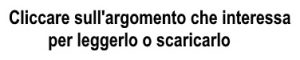

Di questo lungo periodo della civiltà greco-romana, Napoli conserva molti avanzi archeologici, il più cospicuo dei quali è da considerarsi, senza dubbio, il corpo originario di Neapolis, che si può ancor oggi, senza troppo sforzo ricostruire mentalmente, nonostante le brutte sovrapposizioni edilizie e le trasformazioni avvenute nel corso dei secoli. E’ ancora possibile individuare i tre decumani paralleli, e i cardini ad essi corrispondenti in senso perpendicolare, seguendo via Tribunali, corrispondente al decumano centrale, la piazzetta di San Gaetano, la Chiesa di San Paolo, dove due colonne corinzie scanalate rappresentano le vestigia del tempio dei Dioscuri, che occupava il sito dell’attuale basilica cristiana, la chiesa di San Lorenzo, e, più in là, gli archi dell’Anticaglia, appartenenti alle terme e al teatro coperto (l’Odeon). Tutto l’insieme costituisce un grandioso complesso monumentale, che suggerisce alla fantasia del visitatore un’immagine suggestiva di ciò che fu, un tempo, il Corpus di Neapolis.
Avanzi delle mura di Neapolis, di costruzione greca, consistenti in grossi blocchi rettangolari di granito, racchiusi, purtroppo, in una cancellata, si possono osservare nella piazzetta dell’attuale cinemateatro Splendore, dove si trova l’ospedale Ascalesi, allo sbocco di via Forcella, e in Piazza Bellini, tra San Sebastiano e via Costantinopoli.
Dette mura solide ed imponenti, di cui non si conosce l’esatto perimetro, dovevano però estendersi da Foria a Costantinopoli, a San Domenico Maggiore, fino all’attuale Corso Umberto e prolungarsi sino a Forcella e ai Tribunali, includendo anche nella loro cerchia Santa Maria La Nova.
I moderni archeologi danno per sicuro che l’attuale via Forcella e i vicoli circostanti e quelli che sboccano in essa, corrispondono esattamente al primitivo tracciato greco.
Notevoli, per il tipico carattere architettonico degli acquedotti romani, sono pure le arcate superstiti in mattoni rossi, dette, perciò « Ponti rossi » di un’antica conduttura d’acqua romana.
Ma, più che nella città, dove il sovrapporsi tumultuoso e violento di dominazione a dominazione si accaniva a distruggere e a cancellare fin le ultime tracce di quanto il dominatore precedente aveva costruito di buono, le tracce gloriose e stupende della civilizzazione greco-romana s’impongono all’ammirazione del mondo nelle dissepolte e redivive città di Pompei, di Ercolano, di Stabia, di Cuma, di Baia, di Pozzuoli, di Miseno e nei tesori archeologici, raccolti nel Museo Nazionale, fondato da Carlo III di Borbone. Opere di scultura, di pittura, d’architettura, opere di ingegneria idraulica, di cui non si sa se più ammirare l’ardimento del genio che le ha create o la imponenza della mole, la solidità delle strutture che sfidano il tempo, o la raffinata eleganza e la suprema grazia che le ravviva. Il mondo classico rivive soprattutto a Napoli, città solare, nello spirito dei suoi abitanti e nel loro culto della bellezza.
Insieme coi monumenti della classicità greco-romana, mentre il paganesimo si va lentamente spegnendo, a Napoli si ritrova anche la prima fioritura della monumentalità del cristianesimo, di cui sono antichissimo documento le catacombe di San Gennaro, che forano le colline a settentrione della città. Esse, risalenti al II secolo, contengono sepolture di martiri in stile primitivo, vestigia di altari, di cattedre episcopali, di fonti battesimali, di epigrafi e presentano un quadro eminentemente suggestivo ed emotivo, non solo per chi ha fede nella vita misteriosa, difficile ed eroica dei primi cristiani.
Generalmente trascurate dal turismo, che preferisce le aure vivificanti del mare e dei colli di Napoli, le catacombe napoletane meritano, proprio per il loro valore artistico e per ciò che rappresentano della vita sotterranea dei primi cristiani, di essere ricordate con particolare insistenza. Esse si trovano sotto le pendici di Capodimonte e penetrano, coi loro misteriosi cunicoli, nel masso tufaceo, dalle Fontanelle alla Sanità e dai Miracoli a Miradois.
La più importante (quella che qui ci limitiamo a descrivere invitando i lettori a scoprire le altre da sé) è la catacomba di San Gennaro, che risale al II secolo d. Cr.. In essa, benché in parte guaste dal tempo e dall’incuria, si ammirano molte e belle pitture paleocristiane. In origine, era una tomba gentilizia, che, man mano ingranditasi, divenne il cimitero della chiesa cristiana napoletana. Vi furono sepolti S. Agrippina, e, nel V secolo, il martire S. Gennaro. Quando, nel IX secolo, il principe di Benevento, Sicone, rapì il corpo del Santo, la catacomba perdette importanza, finché nel secolo XIII fu abbandonata e devastata. Consta di due piani: quello inferiore è costituito dalla Basilica cimiteriale di San Gennaro, con in fondo l’altare, e, dietro di esso la cattedra episcopale. A destra dell’altare, si vedono due arcosolii con pitture del IX secolo, raffiguranti vescovi napoletani; nella cripta, avanzi di mosaici e di affreschi sulle pareti.
Le catacombe — a giudizio di Ferdinando Gregorovius — sono gli unici monumenti del tempo antico posseduti da Napoli, che, insieme con la strana grotta di Posillipo, conservino, quasi intatta, la loro struttura antichissima. I due monumenti sono ambedue sotterranei: ed è questa, forse, la causa per cui hanno meno sofferto della manomissione degli uomini.
