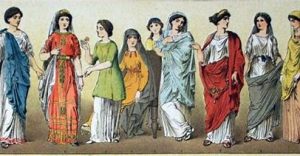Considerando la qualità degli ingredienti e il fatto che sia la biacca che il carbonato di piombo sono altamente tossici, particolare peraltro già noto alle Romane, è comprensibile nutrire forti dubbi sui risultati di tali rimedi estetici e condividere l’opinione dei poeti e commediografi latini, che non lesinano velenose e sarcastiche critiche a tali costosissime pratiche femminili.
“Riccioli, trucco, belletto, cerone e denti hai comprato. Con la stessa spesa compravi una faccia nuova”, commenta Lucilio sin dal II secolo a.C., ben poco cavallerescamente, nel XVI libro delle sue Satire.
Marziale non è meno caustico: “Ovunque tu passi, fai pensare che Cosmo (ndr Cosmo era il più noto profumiere contemporaneo a Marziale) stia traslocando e che essenze profumate escano a profusione da un flacone agitato. Non mi va, Gellia, che tu prenda gusto a queste sciocchezze straniere. Lo sai che il mio cane potrebbe essere così profumato!” (Epigrammata, 3,559).
Ovidio non pare più conciliante anche se è prodigo di consigli.
“Ma che l’amante non vi colga mai con i vasetti delle vostre creme. L’arte che vi fa belle sia segreta. Chi non vi schiferebbe nel vedervi la feccia cosparsa per tutto il viso, quando vi scorre e sgocciola pesante tra i due tiepidi seni? E che fetore l’esipo (ndr, tipo di lanolina) emana, rozza spremitura del vello immondo di un caprone, fetido anche se viene da Atene! E non vi approvo quando v’applicate in pubblico misture di midollo di cerva o vi fregate davanti a tutti i denti. Queste cure fanno belle ma son brutte a vedersi. Spesso ciò che ci piace, piace quando è fatto, mentre si fa dispiace.” (Ars amatoria, 209-218).
Per nulla scoraggiate da simili, dissacranti commenti, le donne romane continuarono a imbellettarsi, marcando le sopracciglia con antimonio polverizzato (stibium) o con il nerofumo ( fuligio) e colorando le palpebre con ombretti verdi se ottenuti dalla malachite e azzurri se derivati dall’azzurrite.
Dal gelso, dal fuco (un’alga di colore rossastro), da estratti animali e vegetali e da sostanze minerali (soprattutto cinabro, gesso rosso e minio, anche quest’ultimo tossico) venivano poi ricavati i rossetti per le labbra.
Anche i denti erano oggetto di cura, grazie ai dentifrici preparati con polvere di pomice, mastice di Chio, soda e bicarbonato di sodio. Per l’alito esistevano poi “miracolose” pasticche: “Per non olezzare pesantemente delle bevute del giorno prima, Fescennia, trangugi smodatamente pastiglie di Cosmo…che dire, giacché l’alito pestifero mescolato alle pastiglie puzza ancora di più e il duplice odore del fiato si spande più lontano!” (Marziale).
L’arte della preparazione dei belletti era affidata alle cosmetae (schiave appositamente addestrate per quello specifico compito) che, di volta in volta, al momento dell’uso, scioglievano i vari ingredienti con la saliva in piccoli contenitori, aiutandosi con una specifica serie di spatolette, cucchiaini e miscelatori ad anello in legno, osso, avorio, ambra, vetro o metallo.
Le maschere di bellezza per prevenire l’invecchiamento della pelle o per curarne le imperfezioni (efelidi, desquamazioni, macchie) erano poi altrettanto diffuse. Potevano essere a base vegetale e ricavate da lenticchie, miele, orzo, lupini, finocchio con aggiunta di essenze di rosa e mirra oppure ottenute da composti organici ( corna caduche di cervi, escrementi di alcione, topo e coccodrillo, placenta, midollo, genitali, fiele, urina di vitelli, mucche, tori, asini) mescolati a olio, grasso di oca, succo di basilico o semi d’origano, biancospino, zolfo, miele o aceto.
Particolare attenzione doveva poi essere riservata alle modalità di applicazione. Le maschere ottenute con l’urina d’asino, ad esempio, pare fossero efficaci solo se utilizzate al momento in cui sorgeva la costellazione del Cane.
I profumi meritano una particolare menzione. Troviamo una stupenda testimonianza del loro intero processo di produzione, ad opera di paffuti amorini, nell’affresco della casa dei Vettii di Pompei.Non essendo ancora conosciuto il processo di distillazione, introdotto dagli Arabi solo nel IX secolo d.c., le essenze erano ottenute per spremitura e macerazione. La base oleosa (tecnicamente chiamata onfacio) era costituita da olio di olive verdi o da succo di uva acerba (agresto) e in essa venivano fatte macerare sostanze profumate insieme a coloranti. Ci sono anche giunti i nomi di alcuni profumi.
Il Rhodium era l’essenza derivata dai petali di rosa, prodotta soprattutto a Palestrina, Capua e Napoli; l’Illirium e il Susinum erano ottenuti con varie specie di gigli pompeiani, il Mirtum-laurum dal lauro e dal mirto, il Melinon dalle mele cotogne, lo Iasminum dal gelsomino. Dall’Egitto proveniva il Metopium, tra i cui ingredienti figurava anche il costosissimo “Balsamo di Giudea”.
In età imperiale Alessandria era il maggior centro di smistamento delle spezie e delle erbe aromatiche che da qui venivano inviate a Roma e, soprattutto, a Preneste, Napoli e Capua, dove si trovavano i massimi produttori di essenze ma anche i più abili contraffattori (!!!!) dei più famosi profumi dell’epoca.
Le essenze raggiungevano prezzi proibitivi già dal I secolo d.c., quando una libbra di profumo costava anche più di 400 denari. Uno scandaloso spreco, a detta di Plinio, poiché simili ricchezze venivano dissipate “pro fumo”, senza alcun effetto se non quello di appagare il piacere altrui, dato che “chi è profumato non si accorge di esserlo”.
Seguendo letteralmente le indicazioni di Plinio e di Dioscoride è stato possibile ricreare le antiche fragranze, scoprendo che i gusti dei nostri vanitosi antenati propendevano per aromi intensi e dolciastri, forse più adatti a coprire gli olezzi delle fogne e delle stalle, oltre all’odore pungente e acre del sangue delle fiere uccise negli anfiteatri durante gli spettacoli.
Dei profumi non si faceva però solo un uso personale.
Era costume diffuso, infatti, profumare arditamente anche gli ambienti domestici. Esempio altisonante per regalità e sfarzo è la Domus Aurea di Nerone in cui “il soffitto dei saloni per i banchetti era a tasselli di avorio mobili e perforati, in modo da poter spargere fiori e profumi sui convitati.” (Svetonio, Neronis Vita, 31)Tali pratiche non erano comunque prive di inconvenienti. Pare infatti che, ad un banchetto offerto da Nerone, uno sfortunato commensale sia morto asfissiato dagli effluvi di ingentissime quantità di acque profumate con petali di rosa lasciate cadere sugli invitati.
L’imperatore Eliogabalo, invece, aveva fatto disporre una pioggerella di acque profumate e violette dal soffitto, ma precipitarono sui suoi ospiti anche i vasi di terracotta che le contenevano.
L’imbarazzante incidente pare abbia fatto sbellicare Marziale: “Un buon profumo hai dato ai commensali, è vero, ma cibo niente. E’ da ridere essere profumati e affamati. Digiuni e ben unti, Fabullo, sono i defunti.” (Epigramma, 3,12).
Ancora, a detta di Plutarco, Cesare avrebbe mangiato asparagi conditi per errore con un unguento aromatico anziché con un volgare ma certamente più salutare olio da cucina.
Non sono noti eventuali effetti collaterali che Cesare abbia sofferto a causa dell’incauto pasto ma il suo rapporto con i profumi e, più in generale, con la femminile arte cosmetica intesa nel senso del termine greco “kallopizestai” (millantare!), doveva essere piuttosto tribolato.
E’ infatti noto che la divina Cleopatra era una esperta conoscitrice delle più antiche arti della cosmesi, (a lei si deve un intero trattato sull’arte del trucco), tanto che alla fattoria con annessa “officina aromataria” scoperta sulle sponde del Mar Morto nella regione dell’Idumea, in riva ad un lago, 30 chilometri a sud dell’Oasi di En Ghedi è stato dato il nome di “laboratorio cosmetico di Cleopatra”.La zona, 400 metri sotto il livello del mare, è una delle più profonde depressioni terrestri e, a causa della forte evaporazione, la concentrazione dei sali era altissima. L’officina, appartenuta a Erode il Grande, era composta da nove ambienti, di cui uno adibito a sala d’attesa per i clienti e arredato con panche in pietra. Interessantissimi, per l’eccezionale stato di conservazione, i ritrovamenti del sito, due vasche per la macerazione, altrettanti mulini rotanti per la triturazione dei vegetali, due forni e un focolare per riscaldare gli oli nella preparazione dei profumi, oltre a diversi residui di essenze e belletti.
Nell’officina veniva anche prodotto ciò che Plinio indica come “asphalite”, fango conosciuto anche con il nome di pece nera di Giudea, estratto dal petrolio e usato per curare la psoriasi, oltre ai famosi sali del Mar Morto, utilizzati sia come medicamento che belletto, tuttora usati in cosmesi.
R. Petrucci