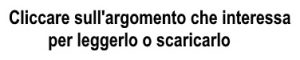Napoli nel Cinquecento…
Con la prima metà del secolo XVI, comincia ad affermarsi, a Napoli, anche nel campo delle arti figurative, l’opera di artisti locali, che, progressivamente si liberano dall’influenza di pittori e scultori romani, toscani e lombardi. Primo, fra tutti, il pittore Andrea Sabatini (Andrea da Salerno), che rivela nei dipinti una robusta grazia raffaelliana; e gli scultori Giovanni Mariliano, (Giovanni da Noia) Gerolamo Santacroce, Annibale Caccavello, i due D’Auria. Segue una nuova predominanza di artisti stranieri: Giorgio Vasari, Leonardo da Pistoia, Marco Pino da Siena, pittori; e Michelangelo Naccarino e Pietro Bernini, scultori. Solo sul finire del secolo, si ha una ripresa artistica napoletana, con caratteri di continuità e di originalità, specie in pittura. Quanto all’architettura, essa rimane vincolata a moduli di altre regioni italiane, e, anche quando il barocco napoletano assumerà una fisionomia propria, risentirà ancora dell’influsso del bergamasco Cosimo Fanzago, che lasciò a Napoli parecchie sue pregevoli opere.
Anche la musica napoletana ebbe, nel ‘500, i primi indirizzi di scuola locale, nel Conservatorio di S. Maria di Loreto e in quello dei Poveri di Gesù Cristo, istituito, nel 1589, dal frate francescano Marcello Fossataro.
Anche la città si allargò, per la crescita della popolazione, salita, ormai, ad oltre 262.000 anime, come risulta da un censimento del 1547. Fu necessaria, quindi, una nuova cerchia di mura, che, iniziata nel 1583 fu terminata nel 1587, per opera del viceré don Pedro de Toledo. La cinta andava da Porta S. Gennaro a S. Maria di Costantinopoli, per via Bellini e l’attuale Piazza Dante, lungo la collina dove ora c’è l’ospedale della Trinità, il Corso, donde proseguiva per S. Lucia a monte e S. Maria Apparente, scendendo, poi, a S. Caterina a Ghiaia (Porta di S. Spirito), salendo a Pizzofalcone e, di là, ridiscendendo verso S. Lucia a Castelnuovo. Il capolavoro di don Pedro fu, però, via Toledo, aperta nel 1536, una delle più celebri e belle vie del mondo, che, tuttora, costituisce il centro più vitale e la gloria dei napoletani. Lo stesso viceré provvide ad altre strade di collegamento, come l’Infrascata, del 1560, che portava all’Arenella e ad Antignano, allora villaggi, donde, attraverso amene campagne, si raggiungeva Sant’Elmo, che fu restaurato tra il 1537 e il 1549. Don Pedro sistemò, inoltre, la viabilità del borgo di Ghiaia, dal palazzo Cellammare fino al Largo Ferrantina, dov’era la villa di Alfonso II d’Aragona, che, per un certo periodo, i viceré scelsero come loro residenza. Dal borgo, si proseguiva verso la chiesa di Piedigrotta, sorta su un antico tempio e rifatta nel ‘500, intorno alla quale si celebrava ancora la più folcloristica di tutte le feste napoletane e si andava fino a Mergellina, ov’è la casa del Sannazaro, che fece costruire la chiesetta di Santa Maria del Parto – denominazione che ci fa ricordare il suo « De Partu Virginis » – in cui si trova la tomba del poeta.
Alcuni borghi rimasero fuori le mura, come i Vergini, borgo Avvocata, S. Antonio abate e Loreto.
…nel Seicento…
Nel Seicento molte e originali furono le opere di architettura sorte in Napoli soprattutto per la genialità del Fanzago di cui ancora oggi ammiriamo S. Teresa a Ghiaia, S. Ferdinando, S. Maria degli Angeli alle Croci, S. Maria Egiziaca, la Certosa di S. Martino.
Ma più che l’architettura, fiorì la pittura. E’ noto che, nella Napoli sei-centesca, gli influssi della potente arte pittorica di Michelangelo Merisi da Caravaggio, creatore del luminismo italiano, si fecero sentire su tutti gli artisti dell’epoca. Non passivamente, però. Soprattutto i pittori maggiori, Battistello Caracciolo, Bernardo Cavallino, Mattia Preti, — che dipinse i famosi pannelli della peste del 1656 per le porte della città — pur attingendo spunti e motivi alla grande arte caravaggesca, seppero infondere toni, movenze, espressioni nuove alle loro figurazioni; e così pure Massimo Stanzione, il Fracanzano, Salvator Rosa, che, interpretando il naturalismo e il colorismo congeniti ai napotani, precorsero quella transizione dalla pittura del ‘600 a quella del 700, che si attua con Luca Giordano e con Francesco Solimena.
Nella seconda metà del Seicento, nasce anche la musica nel senso tutto napoletano di quest’arte. Si smette con le imitazioni veneziane e fiorentine; e il teatro di San Bartolomeo, costruito nel 1620, a gara con quello del Palazzo reale, diviene, a partire dal 1651, sotto il viceré d’Onate, il tempio del dramma musicale napoletano, ove si rappresentano le prime opere di Francesco Provenzale e di Alessandro Scarlatti, iniziatori e precursori del nostro Ottocento musicale. I conservatori della città preparano le nuove generazioni di musici e di cantanti; e, insieme con essi, sorgono schiere di ballerini, di mimi, di scenografi, di vestiaristi, di attrezzisti, che, a poco a poco, acquistano fama di bravura in tutta Italia e all’Estero.
Insieme con le arti, si afferma a Napoli la nuova cultura. La vita del pensiero, che si era precedentemente assopita, si riaccende alla luce viva della filosofia di Cartesio e dell’illuminismo di Hobbes, che relega in soffitta l’ari-stotelismo e il tomismo, e da inizio a quello che possiamo chiamare il nuovo corso della verità e della ricerca scientifica, con una serie di uomini geniali, quali Tomaso Cornelio, il Valletta, Leonardo di Capua, l’Ausilio ai quali spetta il vanto di avere spianato la via a Giovanbattista Vico. Né, per la verità storica, il nuovo pensiero fu imbavagliato dal regime viceregnale spagnuo-lo: quantunque i sovrani di Spagna si atteggiassero a strenui difensori del cattolicesimo e si fregiassero con orgoglio del titolo di re cattolici, pure, sotto sotto, si guardavano sempre in cagnesco col potere ecclesiastico, per via delle questioni giurisdizionali, di cui erano gelosissimi. Contro il nuovo pensiero intervenivano solo se sconfinasse in propaganda eversiva politica: per il resto, lasciavano correre.
Non progredirono molto, nel ‘600, le scienze giuridiche e neppure gli studi storiografici, sebbene questi fossero stati avviati, per opera del Capaccio e del Summonte, del Capecelatro e del Parrino, che fornirono molto materiale a Pietro Giannone. Ma avvio notevole ebbero le scienze economiche, per opera del cosentino Antonio Serra, il quale meditando sulla miseria delle popolazioni meridionali, ne intuì per primo le cause e ne propose i rimedi, dando inizio agli studi per la soluzione di quella questione del Mezzogiorno, che, come la tela di Penelope, non arriva mai a un compimento definitivo. Trattato da visionario e cacciato in galera dal conte di Ossuna, il Serra è stato pienamente riabilitato dal giudizio della storia. Le cose del mondo vanno spesso così. Il Leopardi amaramente cantò: « Virtù, viva sprezziam, lodiamo, estinta ».
Napoli generosa ha intitolato ad Antonio Serra l’istituto statale di economia e commercio.
Ed eccoci alla poesia. Il Seicento napoletano è il secolo di Giovanbattista Marino: poeta, senza dubbio dotatissimo di estro e di senso dell’armonia, di immaginazione anche troppo viva e di virtuosismo coloristico, gran conoscitore della lingua, ma privo di potenza creativa e di quel freno d’arte, che gli avrebbe risparmiato la ridondante gonfiezza e vacuità, che i critici gli rimproverano e che spesso ha causato la messa in evidenza più dei difetti che dei pregi della sua poesia, collocata in pessima luce dai suoi stolidi imitatori: i marinisti. Ma, dal flagello di costoro, la poesia napoletana si redense subito, accostandosi alla vena popolare, con le fiabe del « Pentamerone » e con le « Muse napoletane », di Giovambattista Basile, che si diffusero e piacquero in tutta Italia e in altri paesi d’Europa; e, se pure in grado minore, con la Vaiasseide e il « Micco Spadaro » di Giuseppe Cesare Cortese e con gli scritti di altri poeti dialettali meno importanti, i quali descrivono tanto realisticamente la vita quotidiana del popolino napoletano da farcene un quadro assai più chiaro che non tanti libri di storia. Naturalmente, si scrissero anche opere da buttare al macero, di ogni specie, giustamente sepolte senza infamia e senza lode, perché nessuno le lesse, tranne i loro autori.
Intanto, però, lo stato della città precipitava sempre più nel disastro economico. Nel 1648. finanche soldati spagnuoli, detti, forse per questo, bisogni, chiedevano l’elemosina « con gravità spagnuola » come si esprime, umoristicamente, il cronista. Sommosse, specie di donne, si verificarono al Lavinaio, per il diminuito peso della palata. L’inflazione monetaria e la falsa monetazione causarono lo svilimento della moneta; e i torbidi civili e l’insicurezza sociale ad opera del banditismo (divenuto tanto potente che il capo-brigante abate Cesare Riccardi osò imporre patti al viceré per non chiudere completamente le vie, di cui era padrone, al vettovagliamento) gettarono la città nella situazione più disperata. Vi si aggiunsero le calamità di due terremoti, 1688 e 1692, che fecero vittime e rovine nelle province e in città, dove crollarono la cupola del Gesù Nuovo e la parte rimanente del portico del Tempio di Castore e Polluce, incorporato nella chiesa di S. Paolo.
Man mano, poi, che il regime vice-regnale spagnuolo volgeva al tramonto, si vennero acuendo le lotte fra nobili e plebei, che ebbero particolare recrudescenza sotto il viceré Pietrantonio d’Aragona, benemerito – dice il Doria — per miglioramenti edilizi, ma nello stesso tempo spoliatore della città di opere d’arte. Allorché si verificò una gravissima rottura fra la nobiltà e il Viceré, il popolo stette dalla parte del governo. Avvenne, però, che, mentre, a Napoli, il Viceré minacciava fulmini e tuoni contro i nobili, i cui eletti si erano ritirati, per protesta, dall’amministrazione della città, a Madrid, la regina reggente approvava l’operato dei nobili.

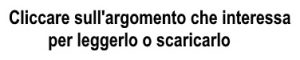

…e nel Settecento
E’ il secolo dei Borboni a Napoli, una dinastia che, si voglia o no, vi lasciò segni non perituri del suo passaggio. Gli storici disputano ancora sulla funzione politica che i borboni d’Italia si assunsero di svolgere, nel Settecento, nel reame napoletano e Ruggero Moscati, d’accordo col giudizio di Benedetto Croce, di Giustino Fortunato, del Paladini e di altri insigni storici, sostiene che la loro azione fu, anche per i loro rapporti con la corte di Roma, positiva, e, nel suo complesso, progressiva, fin quando le due maggiori potenze borbo-niche, Francia e Spagna, sostennero, in Europa, un ruolo di prima grandezza. Ma la loro crisi influì negativamente sulle minori potenze borboniche e, quindi, su Napoli, anche se qui, dopo due secoli, era tornato, coi Borboni, il regno.
Comunque è nel ‘700 che essa acquista quello splendore di metropoli europeistica, che attrasse e innamorò tanti uomini illustri, visitatori di eccezione, in cerca delle emozioni del bello naturale e artistico, come Miguel Cervantes che la esaltò in celebri versi.
Il regno indipendente — ci fa notare Gino Doria — la rese emula delle grandi capitali europee: Parigi, Madrid, Londra, Vienna. Io penso che, affermando ciò, il più appassionato storico della sua e nostra città abbia voluto intendere che Napoli, al pari di quelle capitali, pur cosmopolizzandosi, abbia saputo conservare l’originalità dello spirito della sua gente, che, insieme col fascino della incomparabile bellezza del suo ciclo, del suo mare, della sua terra, e lo splendore della sua arte, costituisce una delle attrattive più seducenti per i viaggiatori che vi approdano, come al porto del loro desiderio, soprattutto uomini di alta levatura artistica e intellettuale.
E questa originalità, come nello spirito del popolo, traluce nel pensiero dei geni napoletani, primo fra tutti G. B. Vico, che con la « Scienza nuova » chiude il passato e apre le porte dell’avvenire, alle scienze storiche, giuridiche, filosofiche e filologiche. L’evoluzione dei tempi, le idee nuove, che compiono il loro corso storico fatale, hanno avuto, certo, il loro effetto nella trasformazione di Napoli. Ma le idee nuove — si sa – per imporsi hanno bisogno di un propulsore umano; e questo propulsore umano fu Carlo III, fu il suo ministro liberale Bernardo Tanucci, il cui maggior vanto fu — come dice il grande storico meridionalista Giustino Fortunato – che « nullum vectigal imposuit ». Non si sarebbe attuato il cosmopolitismo di Napoli, se Carlo III avesse ostacolato il corso delle idee nuove e messo al bando Cartesio, Hobbes, Voltaire e Locke e avesse vietata al suo ministro ogni riforma in senso progressivo. Ingegni, invece, come il Gravina, l’Argento, il De Gennaro, il Filangieri, l’Intieri, il Genovesi, il Brogia, il Galiani, il Doria, il Galanti, il Giannone, il Signorelli, poterono liberamente esporre il loro pensiero d’avanguardia, su tutti i problemi politici, economici, religiosi, morali. Non condivido, perciò, l’opinione del Doria su Carlo III, del quale lo storico tende a diminuire la personalità e a ridimensionare i meriti, che, a mio avviso, non si limitano a quelli edilizi, giacché egli si fece anche promotore della cultura e dell’arte. La fondazione dell’Accademia Ercolanense valse a far sorgere una schiera di illustri archeologi; finanche i nobili si convertirono alla cultura ed espressero il Filangieri e il Palmieri. E il clero, ignorante e più dedito agli acquisti di beni terreni che di grazie celesti, e che aveva, perciò, materializzato la fede, tornò agli studi e alla pietà religiosa, di cui divennero esempi luminosi S. Alfonso Maria dei Liguori e Padre Rocco, il famoso correttore del popolo napoletano, per le suppliche del quale Carlo III si decise, nel 1751, a costruire il reale « Albergo dei Poveri » su disegno di Ferdinando Fuga; grandioso edificio, la cui mole noi ancora ammiriamo. Padre Rocco fondò pure l’asilo di Vincenzo della Sanità, per le giovani pericolanti; e a lui, preoccupato degli sconci morali, degli agguati, delle rapine e degli assassini, che avvenivano, di notte, nel buio delle strade, si deve il primo saggio di illuminazione cittadina. Sorsero anche altri istituti di assistenza. E per quanto qualche sociologo abbia sostenuto che istituzioni del genere fomentavano l’ozio e il vagabondaggio, non si può negare che il benefìcio che esse arrecarono ai poveri di Napoli fu immensamente superiore agli inconvenienti, che si poterono lamentare.
La cultura si rinnovò, si estese a strati più larghi della società. E, quel che è veramente significativo, specie a Napoli, dove le donne erano ancora considerate a tutt’altro destinate che alla cultura, vi si dedicarono, con entusiasmo e successo, alcune patrizie, anche se costituirono un’eccezione. Si noti che, come nella antica Roma, anche ai tempi di Terenzio, era considerato mestiere da schiavi, per un nobile, darsi alle lettere e alle scienze, così il fanatico pregiudizio era ancora vivo nel ‘700 a Napoli.
Si coltivava, invece, molto la musica, specie quella melodrammatica che trovò il suo tempio nel San Carlo.
Durante i primi anni del suo regno e finché visse Filippo V, Carlo III fu sotto la tutela autoritaria del padre. Tanto che, scoppiata, nel 1749 la guerra tra Austria e Spagna e avendo Filippo V, per volere della moglie Elisabetta, inviato un esercito in Italia, impose al figlio di rinforzarlo con truppe napoletane. Ma l’Inghilterra spedì una flotta nel golfo di Napoli, e re Carlo fu costretto a ritirarsi dalla guerra, per timore di perdere il regno. Solo alla morte del padre divenne sovrano di fatto e potè manifestare la sua vera personalità. La madre Elisabetta gli fece sposare, a 22 anni, la bellissima quattordicenne Maria Amalia di Sassonia, figlia del re di Polonia, ma la cui bellezza rimase deturpata, più tardi, dal vaiolo, che le lasciò quella sua caratteristica butteratura. Quando lui e la moglie, al ritorno dalla luna di miele, entrarono in Napoli, accoltovi festosamente, istituì l’ordine di S. Gennaro e fece coniare delle monete d’oro, dette onze, e delle monete d’argento, dette « mezze pezze » donde la parola «pezza» del dialetto napoletano, corruzione di « pesos » per dire danaro in genere.
Gli nacque l’erede al trono, Filippo, nel 1747, fra il tripudio suo e della madre. Ma il ragazzo, malaticcio e triste, campò male fino a 30 anni, allorché morì e fu sepolto in Santa Chiara, dove la lapide, apposta al sepolcro, lamenta pateticamente che fu anche minorato di mente.
Carlo III fu un uomo di costumi severi; forte e sano di costituzione, amava molto la caccia e la pesca. Per questi suoi passatempi, egli fece costruire il parco di Capodimonte, col gran bosco, ricco di cacciagione pregiata, cervi, caprioli, cinghiali, fagiani, beccafichi ecc., nel 1735; ricostruì la casina di caccia che già c’era e, poi, nel 1738 la reggia del Medrano, ove sistemò le collezioni d’arte farnesiane e le fabbriche delle famose ceramiche e porcellane, che vi fondò. Anche la regina Maria Amalia fu presa dalle attrattive della caccia, sull’esempio del marito.
Il re aveva il senso del grandioso e il gusto raffinato del bello artistico. Tutto quello che costruì ne reca, perciò, l’impronta. Tra l’altro, era felicissimo nella scelta dei luoghi, dove far sorgere gli edifici. Il palazzo reale di Capodimonte e quello di Caserta, con l’incantevole parco, alle falde di monte Taburno, col quale volle emulare e superare il castello di Versailles dei re di Francia e la reggia di Schonbrun degli Asburgo, affidandosi al genio del Vanvitelli, perché realizzasse il suo proposito davvero degno di un grande monarca, ne sono la prova. Carlo III ampliò pure il palazzo reale di Napoli e un altro ne costruì a Castellammare, anch’esso cinto da bosco per la caccia. Nel 1737, mise mano al tempio musicale della Napoli settecentesca, creandovi il « San Carlo » uno dei più belli e famosi teatri lirici del mondo. A proposito del « San Carlo » si racconta un aneddoto, di cui non si può garantire l’autenticità. Si dice che il Carasale, costruttore ed impresario del teatro, si fosse recato ad invitare il re e la regina, perché si degnassero di intervenire alla serata inaugurale. E che il re si fosse lamentato con lui perché non aveva pensato a un passaggio interno fra la reggia e il teatro. Il Carasale uscì mortificato; ma, qualche ora più tardi, tornò dal re ad annunziargli che il passaggio interno era stato approntato e che le loro Maestà potevano, con ogni comodità, accedere per via interna al teatro. L’impresario aveva radunato d’urgenza il maggior numero possibile di operai e di tecnici; e, una volta scavato il corridoio, ne aveva tappezzato la volta, le pareti, il pavimento con arazzi e tappeti, sicché i sovrani vi passarono come attraverso una serie di fantasmago-riche sale, illuminate da torce e candele. A torto — a me pare – Carlo III è stato accusato di aver creato a Napoli soltanto un’edilizia di lusso, per i propri gusti voluttuari. E l’Albergo dei Poveri? Ma c’è ancora il grande acquedotto, insigne opera d’arte, che egli fece costruire nella Valle di Maddaloni e le cui arcate grandiose gareggiano, per la arditezza della costruzione, con quelle degli antichi acquedotti romani. Un’altra accusa: per le sue costruzioni, Carlo III si sarebbe servito di galeotti, di prigionieri e di schiavi musulmani, senza curarsi, per risparmiare il danaro dello Stato, di cui era custode gelosissimo, di giovare ai disoccupati locali.
E’ probabile che il re si sia valso degli uni e degli altri. Anche per le fabbriche di Capodimonte, lo si incolpa di aver fatto venire maestranze e tecnici dalla Sassonia, la patria della regina. Ma è da ritenere che ciò si sia verificato solo in un primo tempo, finché non si formarono le maestranze locali. Quell’arte, era del tutto nuova per Napoli. Non va dimenticato, inoltre, che Carlo III compì molte opere di pura utilità pubblica: oltre all’« Albergo dei Poveri » e allo acquedotto di Maddaloni, già ricordati, fece eseguire importanti lavori al Molo, aprì le strade della Marinella e di Mergellina, costruì l’edificio dell’Immacolatella.
E, nel 1757, dette inizio all’emiciclo al largo del Mercatello (l’odierna Piazza Dante) su progetto del Vanvitelli, compiuto, poi, da Ferdinando IV, nel 1765. Napoli cambiò volto: ma, per i difetti organici dei suoi successivi ingrandimenti e abbellimenti, a meravigliose aree monumentali, come quella — per citarne una — difficilmente riscontrabile in altre grandi città, tra piazza Municipio, il Maschio Angioino, la Galleria, il « San Carlo », la reggia del Fontana, la Basilica di S. Francesco di Paola e Piazza Plebiscito, si contrappongono angusti meandri stradali e case e palazzi oscuri e cadenti, che fanno lamentare l’assoluta deficienza di un piano regolatore di integrale sventramento e ricostruzione, come quello messo in opera, con vantaggio enorme per il decorso cittadino, con l’abbattimento di quella fungaia malsana, covo di malavita, che era tutto il vecchio rione fra la Corsea e i Guantai Vecchi. Non si può, dunque, far torto a Carlo III se non costruì secondo un razionale piano regolatore, soprattutto se si consideri che anche oggi, nonostante tutti i progressi delle tecniche edilizie, un piano regolatore veramente razionale Napoli non l’ha, come dimostrano le caotiche costruzioni dei nuovi quartieri residenziali di Posillipo alto e, forse, per un complesso di cause, che non è qui opportuno enumerare, non lo avrà mai. Ma dovunque Carlo III ha costruito ha creato delle zone monumentali, che destano l’ammirata attenzione degli stranieri e danno luce e gloria alla città.
A Carlo III successe Ferdinando IV, re tipicamente napoletano che si trovò a vivere avvenimenti più grandi di lui, come la Rivoluzione francese e le invasioni napoleoniche.
A Carlo III successe Ferdinando IV, che curò molto lo sviluppo della marina napoletana: il primo si dedicò particolarmente a quella mercantile, il secondo alla marina militare. Si potè formare quella scuola marinaresca napoletana, da cui uscirono insigni uomini di mare, come l’audace e leggendario Capitano Pepe, (il Martinez), distintosi nella lotta contro i corsari, l’eroico ammiraglio Francesco Caracciolo, sacrificato dall’odio di Maria Carolina alla vendetta di Nelson, il Bausan ed altri. L’aumento dei commerci marittimi fu enorme, specie per effetto dell’abolizione dei privilegi di bandiera e l’istituzione di una compagnia di assicurazioni marittime. E la città ne beneficiò.
Il popolo ottenne da Ferdinando IV l’abolizione del monopolio sui tabacchi, con gran giubilo dei fumatori. Ma, in compenso, nel 1774, egli istituì il gioco del lotto — la bonificiata — a cui il popolo napoletano era ed è rimasto appassionatissimo, tanto da avervi creato su tutto un sistema cabalistico, e che rendeva allo Stato oltre 560.000 ducati annui. Arte raffinata di cavar danari al popolo senza farlo strillare.
Carlo III regnò dal 1737 al 1759. Ferdinando IV dal 1759 al 1790; ritornò sul trono, dopo la fuga in Sicilia, nel 1791 e vi rimase fino al 1806. In questo anno, nonostante le sciocche vanterie del generale russo Lascy, divenuto comandante in capo dell’esercito napoletano, che aveva promesso al re di umiliare Napoleone, il 14 febbraio, i francesi giunsero alle porte di Napoli, sicché a Ferdinando e a Maria Carolina non rimase altro da fare che ritornarsene in Sicilia. Pietro Colletta descrive vivamente la confusione e lo sgomento di quelle giornate: « Chi fuggia, chi nascondevasi, chi andava incontro al vincitore ».
Ma Ferdinando IV ritornò ancora a Napoli, dopo il brevissimo regno di Giuseppe Bonaparte (1806-1808) e la avventura, conclusasi tragicamente, di Gioacchino Murat, che vi regnò dal 1808 al 1815, l’anno fatale del tramonto definitivo dell’astro di Napoleone. Per Ferdinando IV, il tramonto fu placido, ma senza gloria. Dal 1815 al 1825, sopravvisse come l’ombra di se stesso; non fu granché amareggiato dai lutti familiari: la morte del fratello e quella della moglie Maria Carolina, per la quale, anzi, parve tirare un respiro di sollievo, come chi si scarica di un grosso peso. Ebbe, però, tempo di infamarsi, rinnegando, al convegno di Lubiana coi sovrani della Santa Alleanza, la costituzione ch’egli aveva concesso dopo i moti rivoluzionari del 1821 e giurata solennemente sul Vangelo nella chiesa dello Spirito Santo. Morì il 3 gennaio 1825, all’improvviso, a 76 anni di età, dopo 65 di regno. Fu sepolto in Santa Chiara.