Nella parte occidentale del Peloponneso, in territorio dell’Elide, sorgeva — e oggi non ne abbiamo che le rovine — il centro religioso di Olimpia. Era situato in una valle sulla riva destra del fiume Alfeo, vicino alla confluenza del Cladeo, a circa dieci chilometri dal mare.
Il culto degli dei vi era tradizionale. Le cerimonie religiose, con i rituali giuochi, vennero introdotte — secondo varie leggende — da Pelope o da Ercole. Di Pelope si racconta che era figlio di Tantalo, quello famoso del supplizio, il quale era stato punito dagli dei appunto perché aveva voluto mettere a prova la loro onniscienza offrendo in pasto nientedimeno che il figliuolo. Gli dei naturalmente se ne accorsero. Punirono Tantalo con una continua sete e una incessante fame pur avendo vicinissime — ma senza poterle raggiungere — acqua e frutta; e risuscitarono Pelope. Questi sposò Ippodamia, della vicina città di Pisa, dopo aver vinto il padre di lei Enomao in una corsa con i cavalli. Fu però una vittoria ottenuta con la corruzione, e Pelope ne pagò le conseguenze con le tragiche vicende di cui saranno poi protagonisti i suoi figli.
Ercole (o Eracle) è il celeberrimo eroe delle dodici fatiche e dalla straordinaria forza. La leggenda narra che fondò i giuochi sacri di Olimpia dopo la sua settima fatica, cioè la pulizia delle stalle di Augia. Compiuta l’opera, non aveva ottenuto dal re Augia il compenso pattuito. Allora tornò con un esercito, devastò il territorio, uccise Augia con tutti i suoi figliuoli, dopo di che ringraziò Zeus olimpico con l’istituzione delle gare, alle quali parteciparono la prima volta, fra gli altri, anche gli dei Apollo e Marte. Ciò nonostante per alcuni secoli i giuochi caddero in oblio, finché — dietro suggerimento dell’oracolo di Delfo e con l’aiuto del re spartano Licurgo — il re di Elide, Ifito, ripristinò la manifestazione, con l’intento di salvaguardare la neutralità della sua patria. La manifestazione fu chiamata Olimpiade. Ancora al tempo di Pausania, illustre storico e geografo del II secolo dopo Cristo, che per noi moderni costituisce l’insostituibile fonte per la storia delle antiche Olimpiadi, si mostrava in Olimpia un disco di bronzo (il cosiddetto « disco di Ifito ») sul quale era incisa la prescrizione che sarebbe stata dettata dal re e che imponeva una tregua sacra da osservarsi durante lo svolgimento della festa.
Secondo taluni calcoli, la prima Olimpiade venne fatta disputare da Ifito nell’anno 776 a.C. Abbiamo anche il nome del vincitore dell’unica gara che fu disputata : la corsa dello stadio. Si chiamava Koroibos (Corébo), ed era di Elide.
In realtà sembra che, sia Pelope sia Ippodamia, fossero divinità arcaiche, venerate cioè dalle popolazioni achee prima dell’ultima invasione dorica. In onore di tali divinità si celebravano cerimonie simili a quelle di Creta o di Micene: giovani che disputavano competizioni per ricordare Pelope, e fanciulle che danzavano e tessevano stoffe in omaggio ad Ippodamia.
Con la venuta dei Dori, il culto di Ippodamia venne sostituito da quello di Era, venerata da vergini che offrivano ogni quattro anni alla dea un prezioso peplo (la veste femminile). Più a lungo resistette il culto di Pelope, ma anch’esso dovette poi cedere alla più importante delle divinità doriche, Zeus (Giove). Questi aveva — secondo le credenze greche — la sua sede sulla vetta del monte Olimpo. Perciò fu chiamato Giove Olimpico; e forse per questo, il luogo dove il suo culto ottenne la più difficile vittoria venne denominato Olimpia.
L’onore di accendere il fuoco del sacrificio a Zeus dovette forse venire assegnato al giovane che prima degli altri suoi coetanei riusciva a raggiungere l’ara sacra tenendo accesa la fiaccola durante la rapida corsa. Tale usanza acquistò poi i caratteri del rito e intorno ad essa fiorirono gli altri giuochi. Certo è che la corsa veloce rimase sempre al centro delle celebrazioni di Olimpia, celebrazioni che, per essere state le prime in onore della più forte figura della mitologia dorica, assursero al più alto grado di dignità.
Il luogo di Olimpia fu a lungo disputato fra gli Elei ed i Pisati, finché ebbero la meglio i primi guidati dal leggendario re Ifito, aiutato dal non meno leggendario re spartano Licurgo. A ricordo di tale vittoria, appunto intorno al 776 a.C, i giuochi sacri di Olimpia vennero riorganizzati sulla base di costumi e tradizioni d’un tempo (il periodo quadriennale in ricordo dell’offerta del peplo ad Era, la corsa veloce, ecc.), ed iniziarono la loro multisecolare storia. I Greci aggiunsero poi che erano stati fondati da Ercole per dar loro una patente di nobiltà.
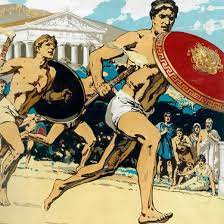
Per la sua natura di luogo sacro, Olimpia non era una città vera e propria. Vi risiedevano i custodi e alcuni sacerdoti. Ma per il resto, si popolava solo nel periodo delle feste e dei giuochi. Era costituita da una zona sacra, l’Attìs, che era un quadrilatero irregolare, lungo in tutto 200 metri e largo circa 175.
Nell’Attìs si elevavano i templi più famosi, il principale dei quali era dedicato appunto a Zeus. Trecento anni dopo l’inizio diciamo così ufficiale dei Giuochi Olimpici, il tempio di Zeus venne ricostruito su disegno di Libone di Elide: in fondo alla navata centrale, su alta base e protetta da un artistica balaustrata, dominava la colossale e preziosa statua del dio, opera magistrale dello scultore Fidia.
Invece sulle pendici della collina a nord venivano innalzati i tempietti che le città, i cui atleti vincevano ad Olimpia, dedicavano a Zeus con altri doni, e che erano chiamati « tesori ». Gli scavi hanno messo in luce undici di questi tempietti, dedicati da Gela, Mégara, Metaponto, Selinunte, Cirene, Sibari, Bisanzio, Epidauro, Siracusa, Samo e Sidone.
Oltre ai templi, v’erano ad Olimpia edifici per gli alloggi dei sacerdoti, per i giudici delle gare, per le riunioni e per i banchetti. Lungo il lato occidentale dell’Attìs sorgeva la palestra, che era un imponente edificio a pianta quadrata con un grande cortile centrale il cui lato misurava ben 41 metri e tutto chiuso dentro un colonnato dove si aprivano locali restrostanti che servivano agli atleti.
Fuori del recinto sacro, all’angolo nord-est, si stendeva lo stadio. Questo stadio di Olimpia è stato famoso per decine di secoli ma non era altro che una spianata rettangolare lunga 212 metri e larga 32 con tutta intorno una grandinata che non era di pietra ma di semplice terra battuta. Qui si disputarono il massimo onore agonistico dell’antichità nelle corse a piedi i più celebrati atleti di Grecia. Vi trovavano posto 40.000 persone.
Le corse con i cavalli venivano invece disputate più a sud, nell’ippodromo; e anch’esso non aveva nulla di speciale.
Dopo la definitiva vittoria degli Elei sui Pisati, Olimpia fu considerata sacra, chiusa agli eserciti durante il periodo in cui si svolgeva la festa. Messaggeri si recavano un mese prima in tutte le contrade dell’Eliade per annunciare la tregua sacra e per invitare i cittadini a partecipare alle cerimonie e alle gare. Di quadriennio in quadriennio il prestigio delle manifestazioni liturgiche e sportive di Olimpia andò sempre aumentando. Mentre in principio vi partecipavano solo gli abitanti delle zone vicine, poi vi accorsero le genti del Peloponneso, ed infine convennero delegati e atleti di tutto il mondo greco e poi romano.
Durante le prime Olimpiadi, le gare si riducevano alle sole corse a piedi. Da quella del 776 a.C. a quella (13^) del 728 a.C. veniva disputata unicamente la corsa dello « stadio », una gara di velocità della lunghezza appunto dello stadio, sulla misura di 192 metri. Dopo la i4a Olimpiade si disputò anche il «diaulo» o corsa del doppio stadio, che costituiva una vera e propria velocità prolungata essendo di 384 metri. Si correva sulla sabbia, e perciò sia lo «stadio» che il «diaulo» erano particolarmente duri.
Poi, a mano a mano che crebbero l’importanza delle Olimpiadi e il numero delle città e degli atleti partecipanti, si aggiunsero altre gare. Già nella quindicesima Olimpiade veniva introdotto il «dolico» o corsa di resistenza: anch’essa disputata sulla sabbia, variava dai sette ai ventiquattro stadi, cioè da poco meno di un chilometro e mezzo a quasi cinque chilometri. Per lo più veniva disputata su quest’ultima distanza.
Con la 18^ Olimpiade (708 a. C.) la corsa non costituì più l’unica specialità agonistica delle Olimpiadi. Le vennero affiancati il pentatlo e la lotta. Del pentatlo così scrisse Aristotele: «Chi sa slanciarsi rapidamente in avanti con i piedi e resistere è un buon corridore. Chi ha la forza di schiacciare un avversario e di resistere alla sua pressione è un lottatore. Chi sa tener lontani con i propri colpi gli avversari è un pugilatore. Chi sa fare l’una cosa e l’altra è campione nel Pancrazio. Ma chi è campione in tutte queste prove è un pentatleta».
Il pentatlo fu suggerito dal desiderio di ridurre i pericoli biologici di una eccessiva specializzazione. Esso comprendeva una gara di salto, una di corsa, il lancio del disco e del giavellotto, e una competizione di lotta. Gli studiosi non si sono ancora messi d’accordo sul modo usato dagli antichi per compilare la classifica del pentatlo. Venivano disputate eliminatorie in ciascuna gara, e i vincitori venivano ammessi alla prova successiva? Cioè, dopo le gare di corsa disputate in varie batterie, i vincitori di ogni eliminatoria erano ammessi a quelle di salto, e poi successivamente al disco, e poi ancora al giavellotto sino a disputare la finalissima con la lotta? Oppure ogni atleta ne incontrava un altro in tutte e cinque le prove, e una volta battutolo si misurava sempre nelle cinque prove con il vincitore di un’altra eliminatoria e così via sino a restare unico vincitore? Non si sa. Certo è che gli antichi non adoperavano il moderno sistema a punti, anche perché non potevano porre in relazione i tempi (non c’erano i cronometri) con il punteggio.
Quanto alla lotta, essa veniva disputata allo stadio. Era una specialità in cui lo stile e la tecnica erano avanzatissimi. Mentre nella corsa a piedi, pur con assidui allenamenti, molto veniva lasciato all’istinto, invece nella lotta (e anche nel pugilato) v’era tutta una elaborazione di istruzioni e di suggerimenti. I lottatori greci e romani conoscevano tutte le prese e tutte le schivate oggi a noi note; persino il « ponte » veniva praticato. Era però consentito ciò che oggi è vietato: uno dei due contendenti poteva gettarsi addosso all’avversario e cercare di abbatterlo con il peso e con l’impeto della propria persona. A sua volta, l’altro poteva rispondere con uno sgambetto e tentare di prendere l’antagonista per la gola fin quasi a soffocarlo. La lotta veniva iniziata in piedi. Non era necessario far toccare all’avversario il terreno con tutte e due le spalle, come si conviene oggi, per ottenere la vittoria. Occorreva che il rivale fosse gettato a terra tre volte oppure che si dichiarasse vinto. Il torneo olimpico era disputato a eliminatorie e veniva proclamato vincitore colui che avesse battuto tutti quelli che gli erano stati successivamente posti di fronte. Il trionfatore era definito «anefedro». Ma il titolo più ambito era quello di «aconita» (cioè «senza polvere») e veniva attribuito a chi vinceva per la rinuncia dell’avversario che riconosceva la propria inferiorità prima di combattere.
Il pugilato fu introdotto nella 23a Olimpiade (688 a.C). La tecnica non era molto diversa da quella di oggi. Le gare erano però assai più pericolose. Oggi si usano i guantoni che, bene o male, attutiscono la violenza del pugno. Ai tempi di Olimpia invece le mani e l’avambraccio erano ravvolti da strisce di cuoio rafforzate da piastrine di piombo. I colpi erano duri, talvolta mortali. Per fortuna erano molto ricercati lo stile e l’abilità. La più bella vittoria era considerata quella ottenuta senza aver dato o ricevuto colpi gravi, ma solo stancando l’avversario con un lungo giuoco di finte e di parate.
Più tremendo era il « pancrazio », introdotto a partire dalla 33a Olimpiade (648 a.C). Comprendeva lotta e pugilato insieme, senza esclusione di colpi. Vi partecipavano solo pochi atleti ed erano frequenti i casi di «aconiti», cioè di atleti che vincevano «senza impolverarsi», perché non trovavano un antagonista.
Il programma di Olimpia continuò ad arricchirsi nella 25^ Olimpiade (680 a.C.) con la corsa delle quadrighe, cioè un carro a due ruote tirato da quattro cavalli. Questa gara, che si disputava sulla lunghezza dell’ippodromo da percorrersi dodici volte per una distanza complessiva di circa 14 chilometri, divenne presto una delle prove più entusiasmanti delle antiche Olimpiadi. Era una gara più di resistenza che di velocità. Solo negli ultimi metri i cavalli iniziavano un galoppo serrato fra le urla incitatrici degli spettatori. Non vi erano eliminatorie, ma le quadrighe partivano tutte insieme. Una volta se ne allinearono alla partenza ben 41.
Visto il successo delle corse ippiche, il programma di Olimpia accolse altre gare: delle bighe, delle quadrighe con i puledri, delle bighe con giumente, ecc. Non tutte però ebbero successo. Più interesse suscitarono le corse al galoppo, anche queste divise per cavalli, puledri, muli (questi ultimi, però, presto scomparvero), ecc.. La distanza per tali gare era di sei ippodromi, quindi di circa 9 chilometri.
Vincitore delle gare ippiche era proclamato non l’auriga o il fantino, ma il proprietario del cavallo (un po’ come avviene adesso per le scuderie). A lui toccava l’incoronazione, a lui venivano tributati gli onori del trionfo. Si intendeva così premiare non l’abilità della guida, ma la capacità e la cura dell’allevamento. Questo spiega perché fra i vincitori di Olimpia, nelle corse ippiche, figurano i nomi di famosi uomini politici, di imperatori e persino di donne che appartenevano a famiglie illustri e ricche, e quindi proprietarie di cavalli da corsa.
L’ultimo tipo di gare introdotte ad Olimpia fu l’oplite o oplìtodromo. Era una corsa a piedi disputata da atleti rivestiti da pesante armatura. Ciò avvenne nella 65^ Olimpiade (520 a.C). Più tardi fu stabilito che i concorrenti dovessero correre anche con lo scudo. Non esistevano categorie di pesi, come accade oggi per il pugilato e la lotta, oppure dilettanti o professionisti, ma vigeva solo una distinzione di età. Infatti, a partire dalla 37^ Olimpiade (632 a.C.) si disputarono le gare anche per i «ragazzi», per coloro cioè che avevano un’età fra i 17 ed i 20 anni. Da principio ad essi vennero riservate solo le gare di corsa e di lotta; più tardi anche il pugilato e, solo in casi eccezionali, il pentatlo e il pancrazio. Se i giudici constatavano che un giovane era dotato di particolare robustezza fisica, questi veniva ammesso a gareggiare con gli adulti, coloro cioè che avevano più di venti anni e avevano già superato la «docimasia».
La giuria era composta dagli Hellanodìkai (Ellanodici) o «giudici dei Greci». Da principio furono uno o due, poi salirono di numero fino a diventare dieci ed infine dodici. Giudicavano le iscrizioni alle gare (scartavano cioè coloro che risultavano palesemente inabili a determinati sforzi), raccoglievano il giuramento degli atleti di attenersi alle regole delle gare, assegnavano i premi, cercavano che le statue dei vincitori con le relative epigrafi fossero scolpite e collocate nella maniera prescritta. Al primo degli Ellanodici spettava di deporre la corona sul capo del vincitore. A lato degli Ellanodici stavano gli Aiutai che costituivano una specie di polizia della manifestazione e che, dietro ordine dei loro superiori, reprimevano e punivano tutto ciò che non fosse conveniente o che risultasse offensivo.
Fino al 472 a.C. (77^ Olimpiade) le Olimpiadi duravano una sola giornata. A partire dal 468 a.C. la durata delle gare fu portata a cinque giorni. Si svolgevano, come s’è detto, ogni quattro anni nel periodo centrale dell’estate durante il plenilunio fra luglio ed agosto. Può sorprendere che sia stato scelto un periodo così caldo (particolarmente nel Peloponneso). Ma oltre a motivi di carattere liturgico, v’era il fatto che si potevano sfruttare molte ore fresche all’alba e al tramonto.
Un mese prima della celebrazione olimpica, dicemmo, gli araldi andavano in giro per le città greche ad annunciare la prossima festa. Quindi conveniva ad Olimpia il personale addetto al luogo sacro. Era poi il turno degli atleti. Primi giungevano coloro che non avevano mai partecipato alle gare perché dovevano essere esaminati dagli Ellanodici che giudicavano inappellabilmente sulle ammissioni. Quindi cominciavano ad arrivare gli spettatori. Taluni di essi si erano messi in viaggio da settimane e persino da mesi poiché provenivano dalle lontane colonie. Ultime giungevano le delegazioni ufficiali delle città e delle colonie elleniche con sfarzo di abbigliamenti, con le insegne e con gli araldi.
La prima giornata era dedicata ai riti religiosi. Veniva effettuato il solenne sacrificio di alcuni buoi prima a Zeus e poi sulle are degli altri dei. Nell’edificio destinato alle autorità gli Ellanodici giuravano di giudicare secondo giustizia, e gli atleti di competere secondo le regole dei giuochi, con lealtà e con onore (per i ragazzi giuravano i parenti). Infine venivano esaminati ragazzi e puledri per vedere quali potessero eventualmente concorrere con gli adulti.
Il secondo giorno era riservato alle gare dei ragazzi. Il terzo segnava l’inizio delle competizioni più importanti. Fin dall’alba gli Ellanodici prendevano il loro posto, ammantati di rosse vesti con ai lati gli araldi. Facevano poi il loro ingresso nello stadio gli atleti, dopo il V secolo completamente nudi e col capo ed il corpo spalmati d’olio. Il programma si apriva con le corse dello stadio, del diaulo e del dolico. Se i concorrenti erano molti, venivano disputate le eliminatorie e le finali. Si svolgevano le gare di pugilato e la giornata si chiudeva con il tremendo Pancrazio. Qui accadeva sovente che alcuni atleti non si presentassero perché spossati dalle prove precedenti. Venivano allora multati perché avevano osato presumere troppo dalle loro forze. Le Olimpiadi, non dimentichiamolo, erano riservate solo agli «eletti».
Il quarto giorno veniva dedicato alle gare ippiche e, nel pomeriggio, al pentatlo e alle corse con le armi. Molto più tardi vennero inserite nel programma anche le gare per i trombettieri e gli araldi. In serata cominciavano i primi banchetti in onore di coloro che avevano vinto, sebbene non fossero ancora stati proclamati ufficialmente olimpionici.
L’ultimo giorno era quello del tripudio e del trionfo per i vincitori, per i loro familiari e per i concittadini. Su indicazione degli Ellanodici, gli araldi gridavano il nome dell’olimpionico facendolo seguire da quello del padre e della città natale. Il primo Ellanodico posava sul capo del trionfatore una corona d’olivo selvatico che un nobile fanciullo aveva tagliato con un falcetto d’oro da una pianta precedentemente indicata dall’oracolo. Questa incoronazione costituiva la più alta gloria e la massima onorificenza che un atleta antico potesse conseguire, in tutto il mondo greco. Il più bravo di tutti i vincitori veniva infine definito l’eponimo dei giuochi, cioè l’olimpionico per eccellenza, colui che dava il nome all’Olimpiade.
Terminata la cerimonia della proclamazione e dell’incoronazione, tutti gli atleti tornavano a sacrificare a Zeus come atto di ringraziamento. Seguiva la processione del trionfo ed infine si dava luogo ai banchetti che erano di una solennità sfarzosa per ricchezza di vesti, abbondanza e generosità di cibi. Ogni città cui apparteneva il vincitore offriva doni, e questi doni venivano collocati in speciali tempietti che, come s’è detto, erano chiamati «tesori».
Dopo il VI secolo a.C. i vincitori avevano diritto ad una statua da erigersi in Olimpia. Venivano invitati a banchetto nel palazzo del Consiglio degli Elei ed ascoltavano un poeta che recitava un epinicio in loro onore. Molte volte il poeta era un mediocre verseggiatore, ma accadde anche che l’epinicio fosse composto da grandi artisti come Pindaro, Simonide e Bacchilide.
Pindaro è rimasto il più famoso. Prendeva spunto da una vittoria olimpica per divagare poi nella storia e nel mito, con ricchezza di suggestive immagini e di elevate parole. Tali digressioni furono poi definite «voli pindarici» e divennero proverbiali. Pindaro, nato nel 518 a.C. e morto dopo il 446 a.C, vedeva negli atleti vincitori dei giuochi gli eroi forti, valorosi e felici, prediletti dagli dei e perciò immuni dal doloroso dramma della vita e della morte. Per questo la vittoria di Olimpia è quanto di più alto si possa desiderare. «Come l’acqua è il migliore degli elementi, come l’oro è il maggior tesoro dei mortali, come la luce del sole supera ogni cosa per splendore e calore, così non vi è vittoria più nobile di quella di Olimpia». «Egli vinse in Olimpia, — continuava Pindaro — e Olimpia è madre di canzoni divine che fregiano le imprese degli eroi, quando — seguendo il divino rito di Ercole e l’usanza degli antichi agoni — il severo giudice eleo pone sul loro capo l’onore del glauco olivo di Grecia ». Sugli olimpionici « che anelano a nutrire l’anima di gran virtù con sovrano ardire e che dopo il faticoso giuoco agonale, cinti dall’olivo, chiedono dolce riposo» il dio Zeus, che «impenna al fulmin l’ale», «stenda benefico amica mano».
Simonide era un po’ meno solenne, forse perché non gli riusciva più di vedere nei vincitori delle gare olimpiche ciò che invece, a suo parere, nobilitava coloro che per la patria non s’erano accontentati di gareggiare, ma avevano dato la vita alle Termopili. Suo nipote Bacchilide (l’uno e l’altro conobbero e osteggiarono Pindaro) amava narrare l’impresa olimpica con una sottile vena di malinconia che trapelava sempre quando si trattava di esaltare il momento solenne e culminante della vittoria.
Gli altri cantori di olimpionici erano assai meno artisti. In compenso ci hanno lasciato definizioni ancor oggi adoperate da mediocri cronisti : « rapido come la folgore », « così veloce da non poggiare mai il piede per terra », « vigoroso come un leone », « si slanciò con la furia della tempesta », ecc. ecc..
Terminate le feste, i vincitori si rimettevano in viaggio per le loro città su di un carro tirato da bianchi cavalli. Li attendevano — come fu detto da uno storico — «onori non minori di quelli che Roma riservava ai suoi trionfatori che le conquistarono il mondo». E, ben presto, alla simbolica corona d’olivo si aggiunsero doni più concreti e preziosi, dalle medaglie alle vesti e quindi sonanti monete.
Per i primi cento anni, gli spettatori furono cittadini molto devoti o molto appassionati alle gare. In seguito si affermò l’abitudine, da parte di letterati, artisti, poeti e filosofi, di farsi vedere ad Olimpia durante le gare, anche per procurarsi un po’ di pubblicità. Erodoto vi lesse una parte delle sue storie. Talete vi morì di insolazione. In ogni caso, la presenza di illustri personaggi conferiva altro splendore alle Olimpiadi.
Escluse erano però le donne. Alle gare non potevano assistere — sotto pena di morte — le maritate, fatta eccezione per la sacerdotessa di Demetra che aveva un posto a lei riservato. Potevano invece intervenire le ragazze, ma furono poche quelle che usufruirono di tale concessione. Queste disposizioni sancivano un aspetto non edificante della civiltà greca: l’inferiorità della donna e la separazione di essa dalla vita effettiva della nazione.
Dalla prima all’ultima Olimpiade dell’era antica corrono oltre undici secoli (776 a.C. – 393 d.C). Non possiamo perciò pensare che il loro spirito sia rimasto sempre lo stesso. Le vicende politiche e il mutar dei costumi esercitarono una profonda influenza. B vero che durante i giuochi si sospendevano le guerre e si stabiliva — meno qualche rara eccezione — una tregua sacra. Ma i Greci che gareggiarono nelle prime Olimpiadi, quando in ogni città dell’Elide vigeva un regime aristocratico, avevano una mentalità assai diversa da coloro che poi subirono l’influsso della democrazia ateniese. E mutarono quindi con il predominio di Sparta e quello di Tebe. E cambiarono ancora con il controllo macedone e infine sotto i Romani.
Durante queste secolari vicissitudini la celebrazione delle Olimpiadi esternamente sembrava sempre la stessa, meno qualche variazione al programma. Un condottiero romano, Lucio Emilio Paolo, sei secoli dopo la prima edizione dei giuochi, di ritorno dalla conquista della Macedonia, ebbe motivo di affermare: «Sebbene la fama di Olimpia sia grande, la vista di essa supera ogni attesa».
Ma l’iniziale fervore religioso e patriottico, la concezione del vincitore come perfetto esemplare delle genti elleniche e perciò prediletto dagli dei, cedevano a poco a poco il posto all’ammirazione per un uomo che aveva saputo ben prepararsi, che era cosciente del suo vigore fisico e sapeva trarne i dovuti vantaggi. L’atleta-eroe divenne gradatamente il forte guerriero e quindi il campione, cioè l’essere eccezionale che dava spettacolo e che scendeva nello stadio per farsi applaudire perché questa era la sua ragione di vita.
(A. Fugardi, Storia delle Olimpiadi, C.O.N.I.)
